da Amedeo Furfaro | 23/Feb/2023 | I nostri CD, News, Primo piano, Recensioni
Il 4et, nel jazz, è una formazione intermedia fra solisti/ combo e gruppi più nutriti nonché ensembles ed orchestre. Una “centralità” che garantisce sia snellezza che ricchezza di suoni oltre comunque ad una completezza che dipende dalla gamma strumentale e dalle caratteristiche dei musicisti. A seguire segnaliamo una sestina di nuovi dischi di “band dei quattro” dai quali emerge varietà di proposte e combinazioni. Il 4 non sarà un numero perfetto ma a guardare la storia del jazz verrebbe da pensare che certi postulati sulla presunta imperfezione sono … imperfetti. Oltretutto il quattro in numerologia simboleggia realtà concretezza solidità nonché la precisione del quadrato e il senso del moto che dà il quadrilatero; ed ancora i quattro punti cardinali est ovest nord sud i quali orientano tanto jazz in circolazione.
 Del Piano/Olivieri/Mazza/Marini, Double 3, Caligola Records
Del Piano/Olivieri/Mazza/Marini, Double 3, Caligola Records
L’album Double 3 (Caligola) è a nome di quattro musicisti in quanto trattasi per così dire di un disco-matrioska. Dalla quaterna di jazzisti che vi concorrono infatti vengon fuori due trii avant-garde dalla stessa asse (più che sezione) ritmica, con Roberto Del Piano al basso elettrico e Alberto Olivieri alla batteria nonché all’ alto e voce Cristina Mazza nei brani “Cane di sabbia”, “Forgotten Names”, “Beauty is A Rare Thing” di Ornette Coleman e “Double Moon”nonché il baritono/flauto/piano di Bruno Marini in “Endemic”, “Yogi”, “Brazz!”, “Flute and Cats”, “Sunset Enigma”. Nelle esecuzioni non si avverte più di tanto l’alternanza dei cambi che non vanno a mutare l’ossatura dell’insieme. C’è poi che le composizioni sono firmate da chi vi partecipa. Verrebbe quasi da pensare che tre più tre potrebbe fare quattro se non ci fosse la matematica ad ostacolarne l’addizione e l’opinione. O più semplicemente che non c’è 3 senza 4et in questo lavoro di frammischi fra volute (in)esattezze infiorate dagli sminuzzamenti metrici della batteria e dai voli di calabrone del baritono, dalle acrobazie del basso e dai volteggi vocali della sassofonista.
 Canova Trio feat. Fulvio Sigurtà, Agata, Filibusta Records
Canova Trio feat. Fulvio Sigurtà, Agata, Filibusta Records
Agata, pietra della famiglia dei quarzi, è l’azzeccato nome di battesimo scelto per l’album del Canova Trio. Secondo la pianista e vocalist Elisa Marangon tale minerale ha qualità vicine alla musica grazie a geometrie e tonalità che spaziano dal bianco al verde, dal muschiato al pizzo blu. E’ così pensando che lei leviga un iridato e irradiato intaglio jazzistico assieme alla bassista Roberta Brighi ed al batterista Massimiliano Salina. Al trio si aggiunge talora il trombettista Fulvio Sigurtà in qualità di ospite, apprezzato da chi scrive in “Circles in the Sand” di Svensson e Castle. Altri pezzi – “Very Early” di Bill Evans e “Footprints” di Shorter – sono eseguiti utilizzando, della tavolozza timbrica, le marcature più calde e brillanti. Due composizioni di Jobim – “Chovendo na roseira” e “Falando de Amor” – valorizzano la trasparenza della voce della Marangon che dà il massimo, a livello di scrittura, in “Les Trois Soeurs à la plage”, uno degli originals (su undici complessivi) di cui quattro da lei firmati e due cofirmati con i colleghi del trio (plus guest). La folgorazione deriva dal dipinto “Las Tres Hermanas en la playa” del pittore spagnolo Joachim Sorolla, impressionista dal tratto luminista. Per una musica che, nel riprodurne i lineamenti, si insinua, nei contrasti ombra-luce, en plein air.
 Giovanni Benvenuti , An Hour Of Existence, AMP Music & Records
Giovanni Benvenuti , An Hour Of Existence, AMP Music & Records
Il tenorista senese Giovanni Benvenuti nell’album An Hour Of Existence (AMP) coinvolge la propria band composta di altri tre musicisti: il pianista tedesco Christian Pabst, il contrabbassista Francesco Pierotti e il batterista Dario Rossi. Il lavoro discografico si rifà ad un racconto di fantascienza in cui uno dei protagonisti, non più in vita, si materializza per un’ora all’anno. In quel breve lasso di tempo deve scegliere come muoversi, se viverlo semplicemente o imprimervi in qualche modo una svolta. Un po’ come nel film “Momenti di trascurabile felicità” di Daniele Luchetti in cui Pif torna sulla terra, dal paradiso, per poco più di un’ora, per risolvere le pendenze sospese ovvero riassaporare momenti felici. Dal canto suo Benvenuti, in un’ora circa di musica, si gioca bene le carte a disposizione. I sette brani originati da questa visione fra new age e science fiction, per quanto immaginifici siano – come “King’s Mustache” o “General Krottendorf” – e per quanto risentano di influssi extrajazzistici – le scale arabeggianti del n.5, quello che dà titolo al cd – si muovono in un contemporary che malassa materiali vari dallo svolgimento ritmico mosso e plurilineare nella modulazione melodica del sax. Il disco avvicina storia e fantascienza sul terreno jazzistico per come già emerso nel precedente album Paolina and The Android, accolto favorevolmente dalla critica. Lì due androidi avveravano il mancato incontro di un paio di secoli prima fra il poeta Keats e la Bonaparte. Nel nuovo album i personaggi sono vari come la narrazione. Così come la musica del 4et.
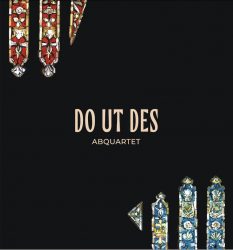 ABQuartet, Do Ut Des, Red & Blue.
ABQuartet, Do Ut Des, Red & Blue.
Guido D’Arezzo, dopo aver inventato attorno al Mille la moderna notazione musicale, nell’assegnare i nomi alle note, non avrebbe immaginato che nel 1972 un gruppo di rock progressivo come i New Trolls avrebbe chiamato un proprio l.p. Ut, termine che, oltre all’avverbio affinché, indica il Do nell’ars musica. Ancor meno il teorico avrebbe pensato che, nel terzo millennio, un quartetto jazz come l’ABQuartet avrebbe approntato un album con sostrato latino (non latin, si badi bene) intitolandolo Do Ut Des per indicare non tanto il significato comune di interscambio bensì il Do Do Re bemolle (traduzione del detto in gradi della scala temperata in base alla denominazione latino-germanica). La frase, volendo, potrebbe riferirsi al rapporto fra i musicisti che “donano” invenzioni allo spettatore che li ricambia con il proprio (ap)plauso. Od anche potrebbe simboleggiare il “contratto” che i musicisti stipulano nel formare un gruppo o addirittura rimandare ad un’idea di interplay come “obbligazione” e cioè musica praticata in forma pattizia in cui ogni strumento “dà il la” ad un altro aspettando una risposta per generare nell’insieme un’armonia complessiva. Il pianista Antonio Bonazzo, il clarinettista Francesco Chiapperini, il contrabbassista Cristiano Da Ros e il batterista/percussionista Fabrizio Carriero hanno realizzato sette brani circondati da tale aura medievale già a partire da titoli come “Ut Queant Laxis” dove la prima sillaba Ut è la prima delle note di un metà verso (emistichio, non metaverso) seguita da Resonare Fibris/Mira gestorum/Famili tuorum/Solve polluti/ Labii reatum/Sancte/Iohannes (Ut/Re/Mi/Fa/Sol/La/S/I). Da altri brani come “Lux Originis” e “Dies Irae” si percepiscono i frequenti cambi di registro acustico e di gamma modale che i “trovieri” adattano, girellando fra l’alleluiatico ed il melismatico, compenetrando, in tal guisa, la storia della musica all’attuale vita artistica “mondana”.
 Zhu Quartet, GINKGO, Workin’ Label.
Zhu Quartet, GINKGO, Workin’ Label.
Il ricordo di una pianta di ginkgo biloba che Alberto Zuanon, contrabbassista, osserva oramai cresciuta, nella stagione dell’autunno, fa da stimolo iniziale all’album Ginkgo, inciso per Workin’ Label con lo Zhu Quartet: Michele Polga, saxtenorista, Paolo Vianello, pianista, Stefano Cosi, batterista e ovviamente il leader contrabbassista. Piant’antica, la ginkgo biloba, che ha infuso di sé il title-track del cd, brano dalla forma-canzone che sa espandere un’idea di serenità. In “Creative Process” la mente dell’Autore (e quella degli Interpreti) procede, nel ristrutturare dati e impulsi di partenza, a trasformarli in flusso sonoro. “Sabato pomeriggio con Tommaso” è composizione delicata dedicata ad un allievo che nel confronto col maestro rivela tutta la propria curiosità e devozione. “Agitato” guarda al navigante che affronta il mare tempestoso, il che in musica è rappresentato dagli strumenti che alzano il livello e l’altezza delle proprie onde sonore, amplificando certi contrasti ritmica-piano/sax già ascoltati in “Costante”. Il più placido “2022” è un personalissimo “Le Quattro Stagioni” in sunto jazz impresse nell’anno che è appena tramontato. Chiudono la decade di titoli il nostalgico “Altri tempi”, l’atrabile “ Prima del sonno” e “Laguna”, ispirato dalla visione di quella veneta. Un lavoro, insomma, che si annuncia invitante già a partire dall’”Intro”, meritevole di essere diffuso anche in circùiti, ove attivati, di “disc/crossing”.
 Marco Vavassori feat. Lincetto/Smiderle/Uliana, Walking with Bob, Caligola Records.
Marco Vavassori feat. Lincetto/Smiderle/Uliana, Walking with Bob, Caligola Records.
Buone nuove dal North East jazzistico italiano. Ed è ancora Caligola Records a consegnarci novità discografiche che denotano l’ indubbia vitalità musicale in quell’area. E’ la volta del contrabbassista-compositore jesolano Marco Vavassori, con alle spalle brillanti studi al Conservatorio di Rovigo, che pubblica Walking with Bob, il suo primo album da leader.
Accanto a lui ben figurano tre musicisti legati da solido legame di amicizia e cioè il clarinettista Michele Uliana, il pianista Alberto Lincetto e il batterista Enrico Smiderle. Un quartetto, dunque, che fa già le dovute presentazioni con il primo degli otto brani in tracklist, il lirico “Hocking”, mettendo in scena un sound che impasta idee permeate di solare cantabilità. Il successivo “Sognando” ma ancor più l’alveo mediterraneo di “Shukran” e quello balcanico in “Kurkuma”, lasciano trasparire una certa sensibilità verso le arie folk. “Hare” si caratterizza perché a un certo punto contrabbasso e piano si dispongono a sezione “ritmica” nel supportare batteria e clarinetto mentre “InContra” ha tema ed impro insistenti su un giro di accordi iterante e crescente in intensità graduale nei circa otto e passa minuti di musica fiondante. In “J. Be Blues” il gruppo pare indossare un visore virtuale che guarda al passato, al tempo di Jimmy Blanton, antesignano di tanti contrabbassisti. Il conclusivo “Francesco’s Smile” ha risvolti nordeste, per rimanere al termine geografico già nominato. Insomma un walking, quello del contrabbasso, verso gli itinerari sonori più svariati ed imprevedibili.
Amedeo Furfaro
da Gerlando Gatto | 09/Feb/2023 | I nostri Eventi, News, Primo piano
Prosegue intensa l’attività del Latina Jazz Club con la sua stagione concertistica. Giovedì 18 febbraio in programma uno di quegli appuntamenti da non perdere. Di scena il trio di Giovanni Tommaso con Cinzia Gizzi al pianoforte e Marco Valeri alla batteria.

Giovanni Tommaso è uno dei “grandi” del jazz italiano avendo contribuito in maniera determinante al suo sviluppo e conseguente affermazione a livello internazionale. Lucchese, classe 1941, Tommaso si è ben presto affermato come contrabbassista e bassista di grande livello. Al suo attivo una carriera superlativa che l’ha ben presto posto ai vertici della musica jazz non solo nazionale. Tantissimi i riconoscimenti ottenuti che non vale la pena riassumere in questo spazio. Basti solo sottolineare la felicissima intuizione che nei primissimi anni ’70 lo portò alla costituzione del Perigeo assieme a Claudio Fasoli al sax, Tony Sidney alla chitarra, Franco D’Andrea alle tastiere e Bruno Biriaco alla batteria. Importante anche l’attività didattica dal momento che Tommaso è anche titolare della cattedra di musica jazz al Conservatorio di Perugia. Ultime, ma non certo in ordine d’importanza, la piacevolezza e la gentilezza dell’uomo doti che purtroppo oramai facciamo fatica a trovare anche nel nostro microcosmo jazz.
Cinzia Gizzi è pianista che non ha ottenuto, a nostro avviso, i meriti che il suo talento meriterebbe. Nella sua oramai lunga carriera figura, tra l’altro, un diploma in pianoforte e arrangiamento ottenuto nel 1990 negli Stati Uniti con il massimo dei voti; in questa occasione ha avuto modo di studiare anche con alcuni grandi della tastiera quali Jakie Byard e Charlie Banacos. Oltre a guidare propri gruppi, come sidewoman ha presto parte, nell’arco di una carriera lunga qualche decennio, a molti avvenimenti jazzistici con musicisti italiani e stranieri.
-

-
Giovanni Tommaso
-

-
Cinzia Gizzi
-

-
Marco Valeri
Marco Valeri viene unanimemente considerato uno dei migliori batteristi oggi sulla scena. Romano, classe 1978, si è definitivamente imposto all’attenzione di pubblico e critica nell’ultimo decennio grazie ad una squisita sensibilità ben coniugata con una solida preparazione tecnica acquisita durante gli anni di impegnativi studi. Dopo una parentesi negli States (2002-2003), al ritorno in Italia entra a far parte della band di Sandro Deidda. Anche per lui molte le partecipazioni a festival anche internazionali e assai numerose le collaborazioni con artisti quali Jd Allen, Amedeo Tommasi, Gary Smulian , Andy Gravish, Dado Moroni, Dave Liebman, Eddie Gomez, Benny Golson, Rick Margitza, George Garzone, Franco Ambrosetti, Steve Grossman…
Gerlando Gatto
da Amedeo Furfaro | 28/Gen/2023 | Novità, Primo piano, Recensioni
La seguente selezione di dieci album è un Decathlon fatta per “disciplina” di strumento dei leader di formazione. Ovviamente la scelta è un’istantanea hic et nunc, dettata dal momento. E’ un po’ come al Fantabasket od al Fantacalcio! Si individuano le individualità fra quelle più in forma, e si inseriscono a tavolino in una squadra virtuale che esiste solo sulla carta. Dopo un po’ è prevista una rotazione dei nomi, oltretutto quella proposta non è una classifica delle valenze ma una inquadratura parziale del materiale discografico che ci si ritrova in attesa di esaminarne dell’altro. Il team che ne vien fuori è un ipotetico ensemble di cd con sax/tromba/piano/tastiere/vibrafono/violino/contrabbasso/batteria/percussioni/musica d’insieme.
- Stefano Conforti Quintet, Different Moods. Omaggio a Yusef Lateef, Notami Jazz
 L’omaggio a Yusef Lateef (William Evans), grande tenorsassofonista flautista oboista e fagottista americano, come quello che Stefano Conforti ha prodotto per Notami Jazz è di quelli destinati a lasciare il segno. Intanto è un tributo, oggi a dieci anni dalla morte, ad un jazzista dal curriculum straordinario che annovera collaborazioni con Gillespie, Burrell, Grant Green, Mingus, Fuller, Cannonball e Nat Adderley, Lawson, Cecil McBee, ma soprattutto a chi ha sviluppato, dopo gli inizi bop, “different moods” di un “sound ricco e denso di growl “ (Barithel-Gauffre) con influssi mediorientali. Pur consapevole nella difficoltà ad accostarsi ad un siffatto polistrumentista il sassofonista-flautista-oboista italiano vi si è cimentato disinvoltamente nell’album “Different Moods. Omaggio a Yusef Lateef”, inciso per Notami Jazz, con la formazione che vede Doriano Marcucci a chitarra acustica trombone didgeridoo e percussioni, Tonino Monachesi alla chitarra elettrica, David Padella a basso elettrico e contrabbasso e Roberto Bisello alla batteria. Il quintet ha riproposto in tutto otto brani – fra i quali “Metaphor”, “Road runner”, “The Golden flùte”, “Belle isle”, “Spartacus” di Alex North – con buona resa specie se si pensa a certi tributi alla naftalina che capita di ascoltare qua e là. Le esecuzioni, se non sono calligrafiche sul piano filologico-musicale, lo sono a livello di sonorità estesa e tensione distesa nel segno di un musicista dalla narrazione inzeppata di riferimenti filosofici e poetici, espressi tramite una musica che lui stesso ha definito “auto-fisiopsichica”.
L’omaggio a Yusef Lateef (William Evans), grande tenorsassofonista flautista oboista e fagottista americano, come quello che Stefano Conforti ha prodotto per Notami Jazz è di quelli destinati a lasciare il segno. Intanto è un tributo, oggi a dieci anni dalla morte, ad un jazzista dal curriculum straordinario che annovera collaborazioni con Gillespie, Burrell, Grant Green, Mingus, Fuller, Cannonball e Nat Adderley, Lawson, Cecil McBee, ma soprattutto a chi ha sviluppato, dopo gli inizi bop, “different moods” di un “sound ricco e denso di growl “ (Barithel-Gauffre) con influssi mediorientali. Pur consapevole nella difficoltà ad accostarsi ad un siffatto polistrumentista il sassofonista-flautista-oboista italiano vi si è cimentato disinvoltamente nell’album “Different Moods. Omaggio a Yusef Lateef”, inciso per Notami Jazz, con la formazione che vede Doriano Marcucci a chitarra acustica trombone didgeridoo e percussioni, Tonino Monachesi alla chitarra elettrica, David Padella a basso elettrico e contrabbasso e Roberto Bisello alla batteria. Il quintet ha riproposto in tutto otto brani – fra i quali “Metaphor”, “Road runner”, “The Golden flùte”, “Belle isle”, “Spartacus” di Alex North – con buona resa specie se si pensa a certi tributi alla naftalina che capita di ascoltare qua e là. Le esecuzioni, se non sono calligrafiche sul piano filologico-musicale, lo sono a livello di sonorità estesa e tensione distesa nel segno di un musicista dalla narrazione inzeppata di riferimenti filosofici e poetici, espressi tramite una musica che lui stesso ha definito “auto-fisiopsichica”.
- Sean Lucariello, Despite It All, Caligola Records
 Gli editor italiani fanno sempre più scouting. Succede anche in campo discografico con label come Caligola Records che pubblica lavori di giovani e/o esordienti per rimpolpare di forze fresche il catalogo. Una politica editoriale che spesso viene premiata dagli ok di pubblico e critica, prospettiva che saremmo pronti a sottoscrivere per l’album Despite It All del trombettista-flicornista nonché compositore Sean Lucariello. E’ indubbio che questa coppia di strumenti principe del jazz ha sempre un fascino che seduce. Ed è di un camaleontismo unico il suo modificarsi a seconda della collocazione. Nel quintetto italo-spagnolo assortito da Lucariello che vede Edoardo Doreste Velasquez a sax soprano e alto, Sasha Lattuca al pianoforte, Francesco Bordignon al contrabbasso e Ignacio Ampurdanès Ruz alla batteria, la cornice è l’esatto contrario dello strepitio tanto è armonicamente sottile. E la tromba, il cui suono a momenti pare richiamare il Wheeler più compassato, vira sciolta la canna d’imboccatura in brani come l’introduttivo “Astral Conjunctions” scritto da Bordignon seguito da “Il Maestro e la Margherita” che il leader ha inteso dedicare a Bulgakov. L’attenzione letteraria è comune con il pianista, autore della suite “Tendre Est La Nuit”, chiaro il riferimento al romanzo di Fitzgerald, dove pare che la tastiera rincorra il silenzio, forse la vera e segreta aspirazione della musica, nonostante tutto. Lasciando scorrere il cd dall’ulteriore “notturno” “Song With No Title” si passa poi ad una atmosfera di taglio più nettamente bop in “The Beaty of Boredom” mentre In “Five”, pezzo di Matteo Nicolin, gli accenti si fanno più metropolitani grazie al piglio elettrico del Fender Rhodes di Lattuca.
Gli editor italiani fanno sempre più scouting. Succede anche in campo discografico con label come Caligola Records che pubblica lavori di giovani e/o esordienti per rimpolpare di forze fresche il catalogo. Una politica editoriale che spesso viene premiata dagli ok di pubblico e critica, prospettiva che saremmo pronti a sottoscrivere per l’album Despite It All del trombettista-flicornista nonché compositore Sean Lucariello. E’ indubbio che questa coppia di strumenti principe del jazz ha sempre un fascino che seduce. Ed è di un camaleontismo unico il suo modificarsi a seconda della collocazione. Nel quintetto italo-spagnolo assortito da Lucariello che vede Edoardo Doreste Velasquez a sax soprano e alto, Sasha Lattuca al pianoforte, Francesco Bordignon al contrabbasso e Ignacio Ampurdanès Ruz alla batteria, la cornice è l’esatto contrario dello strepitio tanto è armonicamente sottile. E la tromba, il cui suono a momenti pare richiamare il Wheeler più compassato, vira sciolta la canna d’imboccatura in brani come l’introduttivo “Astral Conjunctions” scritto da Bordignon seguito da “Il Maestro e la Margherita” che il leader ha inteso dedicare a Bulgakov. L’attenzione letteraria è comune con il pianista, autore della suite “Tendre Est La Nuit”, chiaro il riferimento al romanzo di Fitzgerald, dove pare che la tastiera rincorra il silenzio, forse la vera e segreta aspirazione della musica, nonostante tutto. Lasciando scorrere il cd dall’ulteriore “notturno” “Song With No Title” si passa poi ad una atmosfera di taglio più nettamente bop in “The Beaty of Boredom” mentre In “Five”, pezzo di Matteo Nicolin, gli accenti si fanno più metropolitani grazie al piglio elettrico del Fender Rhodes di Lattuca.
- Federica Lorusso, Outside Introspections, Zennez Records/Abeat
 Con un album inciso in Olanda per la Zennez Records, la Abeat Records presenta anche sul mercato italiano Outside Introspections, firmato dalla giovane pianista italiana Federica Lorusso. La musicista fa da calamita nell’ integrato interplay del 4et con Claudio Jr. De Rosa al tenore (e ad al clarinetto in “Take A Breath”), David Macchione al contrabbasso ed Egidio Gentile alla batteria. I jazzisti dimostrano singolarmente di poter vantare notevole “arte/fare” nei nove brani in cui il sax lascia sgolare una “voce” suasiva, il contrabbasso inchioda una probante cadenza nel timing, la batteria gioca costante sull’accentare e sincopare, la leader canta a mò di octaver, unisonica sulle note della tastiera: indizi che fanno la prova di un percorso agile per esporre, esplicare, esplicitare the hidden side of the music. Dall’inside all’extroversion, all’outside i vari gradi compositivi arricciolano un bijou di tracklist che gronda di “assorbimenti” stilistici che non vogliono essere, come il titolo del cd, degli ossimori stilistici – postbop-fusion, pop-classical – che poi tali non sono specie se innaffiati di quei semi creativi sparsi anche nella regione dei tulipani.
Con un album inciso in Olanda per la Zennez Records, la Abeat Records presenta anche sul mercato italiano Outside Introspections, firmato dalla giovane pianista italiana Federica Lorusso. La musicista fa da calamita nell’ integrato interplay del 4et con Claudio Jr. De Rosa al tenore (e ad al clarinetto in “Take A Breath”), David Macchione al contrabbasso ed Egidio Gentile alla batteria. I jazzisti dimostrano singolarmente di poter vantare notevole “arte/fare” nei nove brani in cui il sax lascia sgolare una “voce” suasiva, il contrabbasso inchioda una probante cadenza nel timing, la batteria gioca costante sull’accentare e sincopare, la leader canta a mò di octaver, unisonica sulle note della tastiera: indizi che fanno la prova di un percorso agile per esporre, esplicare, esplicitare the hidden side of the music. Dall’inside all’extroversion, all’outside i vari gradi compositivi arricciolano un bijou di tracklist che gronda di “assorbimenti” stilistici che non vogliono essere, come il titolo del cd, degli ossimori stilistici – postbop-fusion, pop-classical – che poi tali non sono specie se innaffiati di quei semi creativi sparsi anche nella regione dei tulipani.
- Enrico Solazzo, Perfect Journey, Millesuoni/ Via Veneto Jazz
 Se esiste una chiave per creare connessione autentica col pubblico quella è anzitutto la musica. Ed esiste un tipo di comunicazione musicale che avvicina perché la si avverte, semplicemente, coetanea. Il tastierista Enrico Solazzo ce ne dà un saggio con l’album Perfect Journey edito da Millesuoni (mai marchio fu più illuminante) della ViaVeneto Jazz. Vi sono esaltate le sue capacità di arrangiatore, oltre che di solista, unitamente a quelle di musical coach in quanto allenatore di un team che conta qualcosa come quaranta fuoriclasse. Riesce alquanto difficile elencarli tutti per ragioni di spazio. Qualche nome? Dennis Chambers, Gumbi Ortiz, John Pena, Kadir Gonzalez Lòpez, Niclas Campagnol, Baptiste Herbin, Lo Van Gorp fra gli stranieri. Roberto Gatto, Stefano Di Battista, Antonio Faraò, Fabiana Rosciglione, Tony Esposito, Gegè Munari fra gli italiani. Insomma un bel “gruppo misto” alle prese con una quindicina circa di brani fra originali e standard di musica internazionale. Tornando al discorso iniziale come fa un professionista, quale Solazzo, è a comunicare la propria musica nell’epoca dei podcast e del gaming? Intanto non basta esser maestri dell’ entertainment. E non è sufficiente riprendere alla grande hits tipo “Crazy” o “Caruso” per avvicinare l’audience. Ogni epoca ha suoni che le si confanno. Ad esempio le keyboards midi avevano un suono che oggi risulterebbe datato come un moog così come certi effetti campionati. La particolarità di questo disco, a parte il caleidoscopio di collaborazioni, sta nell’aver lo strumentario giusto per l’oggi, nell’averne saputo introiettare lo zeitgeist più positivo con gli arrangiamenti, nel trasmetterlo ad un ampio ventaglio di fasce d’ascolto come tappe di un viaggio perfetto, quello di Enrico Solazzo, di Brindisi: da brindisi!
Se esiste una chiave per creare connessione autentica col pubblico quella è anzitutto la musica. Ed esiste un tipo di comunicazione musicale che avvicina perché la si avverte, semplicemente, coetanea. Il tastierista Enrico Solazzo ce ne dà un saggio con l’album Perfect Journey edito da Millesuoni (mai marchio fu più illuminante) della ViaVeneto Jazz. Vi sono esaltate le sue capacità di arrangiatore, oltre che di solista, unitamente a quelle di musical coach in quanto allenatore di un team che conta qualcosa come quaranta fuoriclasse. Riesce alquanto difficile elencarli tutti per ragioni di spazio. Qualche nome? Dennis Chambers, Gumbi Ortiz, John Pena, Kadir Gonzalez Lòpez, Niclas Campagnol, Baptiste Herbin, Lo Van Gorp fra gli stranieri. Roberto Gatto, Stefano Di Battista, Antonio Faraò, Fabiana Rosciglione, Tony Esposito, Gegè Munari fra gli italiani. Insomma un bel “gruppo misto” alle prese con una quindicina circa di brani fra originali e standard di musica internazionale. Tornando al discorso iniziale come fa un professionista, quale Solazzo, è a comunicare la propria musica nell’epoca dei podcast e del gaming? Intanto non basta esser maestri dell’ entertainment. E non è sufficiente riprendere alla grande hits tipo “Crazy” o “Caruso” per avvicinare l’audience. Ogni epoca ha suoni che le si confanno. Ad esempio le keyboards midi avevano un suono che oggi risulterebbe datato come un moog così come certi effetti campionati. La particolarità di questo disco, a parte il caleidoscopio di collaborazioni, sta nell’aver lo strumentario giusto per l’oggi, nell’averne saputo introiettare lo zeitgeist più positivo con gli arrangiamenti, nel trasmetterlo ad un ampio ventaglio di fasce d’ascolto come tappe di un viaggio perfetto, quello di Enrico Solazzo, di Brindisi: da brindisi!
- Michele Sannelli & The Gonghers, Inner Tales, Wow Records.
 Mezzo secolo dopo i ’70 si può ancora suonare progressive? La risposta è affermativa se non ci si limita a frugare nel modernariato dei suoni vintage o nei mercatini del suono usato. Il prog, alla mezz’età, si presenta quale estetica musicale vigente, contermine a rock e jazz rock. Vero è che in alcuni casi si è assistito ad un ritorno regressivo all’infanzia e in altri la senescenza ne ha incanutito sembianze e portamenti baRock. Quando però capitano fra le mani album energici e briosi come Inner Tales, della Wow, inciso dal vibrafonista Michele Sannelli & The Gonghers, si ha cognizione di come quel “non genere” abbia ancora un carattere … progressivo. Della band, finalista al contest Jam The Future – Music For A New Planet di JazzMi nel 2019 e, nel 2022, prima al Concorso “Chicco Bettinardi” di Piacenza, fanno parte il chitarrista Davide Sartori, il tastierista Edoardo Maggioni, il bassista/contrabbassista Stefano Zambon e il batterista Fabio Danusso. Questo disco d’esordio rivela ad una platea potenzialmente più ampia dei palcoscenici che i musicisti già calcano una forgiata vis sperimentativa che è uno degli stampini del prog brand. Vi campeggiano due icone: Dave Holland in uno dei sette brani di Sannelli (“Uncle Dave”) eppoi c’è il richiamo in denominazione al gruppo space rock dei visionari Gong di Daevid Allen, fondatore degli psichedelici Soft Machine. Le “Storie interne” al compact, dalla romantica “Song for Chiara” all’iterativo “Circle”, dal marcato “Hard Times” al soffuso “Green Light”, dal dinamico “Run Mingo Run” al lirico “Just in Time to Say Goodbye”, vanno peraltro lette non solo in termini di rivisitazione di modelli esistenti bensì di riscoperta di quei modi di far musica d’insieme che risorgono ciclicamente, resistenti alle intemperie, “eterne modernità” per dirla alla Sironi.
Mezzo secolo dopo i ’70 si può ancora suonare progressive? La risposta è affermativa se non ci si limita a frugare nel modernariato dei suoni vintage o nei mercatini del suono usato. Il prog, alla mezz’età, si presenta quale estetica musicale vigente, contermine a rock e jazz rock. Vero è che in alcuni casi si è assistito ad un ritorno regressivo all’infanzia e in altri la senescenza ne ha incanutito sembianze e portamenti baRock. Quando però capitano fra le mani album energici e briosi come Inner Tales, della Wow, inciso dal vibrafonista Michele Sannelli & The Gonghers, si ha cognizione di come quel “non genere” abbia ancora un carattere … progressivo. Della band, finalista al contest Jam The Future – Music For A New Planet di JazzMi nel 2019 e, nel 2022, prima al Concorso “Chicco Bettinardi” di Piacenza, fanno parte il chitarrista Davide Sartori, il tastierista Edoardo Maggioni, il bassista/contrabbassista Stefano Zambon e il batterista Fabio Danusso. Questo disco d’esordio rivela ad una platea potenzialmente più ampia dei palcoscenici che i musicisti già calcano una forgiata vis sperimentativa che è uno degli stampini del prog brand. Vi campeggiano due icone: Dave Holland in uno dei sette brani di Sannelli (“Uncle Dave”) eppoi c’è il richiamo in denominazione al gruppo space rock dei visionari Gong di Daevid Allen, fondatore degli psichedelici Soft Machine. Le “Storie interne” al compact, dalla romantica “Song for Chiara” all’iterativo “Circle”, dal marcato “Hard Times” al soffuso “Green Light”, dal dinamico “Run Mingo Run” al lirico “Just in Time to Say Goodbye”, vanno peraltro lette non solo in termini di rivisitazione di modelli esistenti bensì di riscoperta di quei modi di far musica d’insieme che risorgono ciclicamente, resistenti alle intemperie, “eterne modernità” per dirla alla Sironi.
- Francesco Del Prete Violinorchestra, Controvento/Dodicilune.
 Fra musica e vino, dicono studi scientifici, esiste una relazione profonda. Il rapporto interessa anche i musicisti, si pensi all’opera (“Fin ch’han dal vino”, dal Don Giovanni di Mozart), ai walzer di Strauss (“Vino donna e canto”), agli standard jazz (“The Days of Wine and Roses”), al canto nero di Nina Simone (“Lilac Wine”), al blues di Amy Winehouse (“Cherry Wine”, coautore Nas), al soul/r&b di Otis Redding (“Champagne and Wine”), al pop di Adele (“Drink Wine”). Dalle nostre parti si ritrovano gli stornelli di Gabriella Ferri (“Osteria dei magnaccioni”), le note cantautoriali di Modugno (“Stasera pago io”), Gaber (“Barbera e champagne”), Guccini (“Canzone delle osterie di fuori porta”) con il rock di Ligabue (“Lambrusco e popcorn”) e Zucchero (“Bacco perbacco”) e la “chanson” di Sergio Cammariere (“Il pane il vino la visione”).
Fra musica e vino, dicono studi scientifici, esiste una relazione profonda. Il rapporto interessa anche i musicisti, si pensi all’opera (“Fin ch’han dal vino”, dal Don Giovanni di Mozart), ai walzer di Strauss (“Vino donna e canto”), agli standard jazz (“The Days of Wine and Roses”), al canto nero di Nina Simone (“Lilac Wine”), al blues di Amy Winehouse (“Cherry Wine”, coautore Nas), al soul/r&b di Otis Redding (“Champagne and Wine”), al pop di Adele (“Drink Wine”). Dalle nostre parti si ritrovano gli stornelli di Gabriella Ferri (“Osteria dei magnaccioni”), le note cantautoriali di Modugno (“Stasera pago io”), Gaber (“Barbera e champagne”), Guccini (“Canzone delle osterie di fuori porta”) con il rock di Ligabue (“Lambrusco e popcorn”) e Zucchero (“Bacco perbacco”) e la “chanson” di Sergio Cammariere (“Il pane il vino la visione”).
Dalla terra dei messapi si segnala, nella corrente annata discografica, l’album Rohesia di Francesco Del Prete con la Violinorchestra (Controvento/Dodicilune). Un lavoro non della serie jazz & wine, questo del violinista salentino gravitante anche in area jazz, essendo intriso di sonorità legate al territorio in cui si vendemmiano i cinque vini della Azienda Cantele a cui sono dedicati altrettanti brani. Scrive al riguardo Maria Giovanna Barletta che “in Rohesia Pas Dosè, Rohesia Rosso, Teresa Manara, Rohesia Rosè ed Amativo, ecco una diversità resistente che si riappropria attraverso l’arte poetica della melodia del qui e ora”. Il compact, nel cui progetto sono partecipi Lara Ingrosso (voce), Marco Schiavone e Anna Carla Del Prete (violoncelli), Angela Così (arpa), Emanuele Coluccia (piano) e Roberto “Bob” Mangialardo (chitarre), ha un booklet-winelist esplicativo sui “nettari degli dei” oggetto della selezione e sulla musica loro abbinata a mò di etichetta. Amalgamando pizzica e swing, elettronica ed echi mediterranei, a seconda del carattere e delle caratteristiche, non solo organolettiche, del vino da “sonorizzare”, Del Prete ha generato un prodotto originale che oltretutto fornisce un esempio di come la musica possa essere alleata di un’economia resa “circolare”. Da un disco.
- Marco Trabucco, X (Ics), Abeat Records
 X (Ics), a marchio Abeat Records, del contrabbassista Marco Trabucco, è album che trae spunto nel titolo dal numero decafonico dei ruoli musicali che vi figurano, appunto dieci (Scaramella, pf; Colussi, dr; Vitale, mar; Ghezzo, g.; Andreatta, v.; Dalla Libera, viola; Calamai, fl.; Pennucci, cor., oltre Trabucco nella doppia veste di compositore e strumentista). X, inoltre, rimanda, come scrive Paolo Cavallone nelle liner notes, “all’incognita che risulta dall’accostamento di sonorità cameristiche classiche con quelle del jazz”. X potrebbe stare anche per Pareggio vista l’equivalenza degli apporti fra legni-ottoni e jazz 4et di base con rivoli afrofolk a base di balanon (e marimba). I brani, in tutto cinque che è la metà di dieci (“One For Max”, “Open Space”, “Untitled”, “Meraki”, “Otranto”), scorrono limpidi come un ruscello alle falde di una montagna tant’è che non si avverte (di)stacco fra l’uno e l’altro. Segnale, questo, che la spinta inventiva ha origine da uno statuto creativo fondato su idee fluide sul come moltiplicare (ancora x) temi armonie timbri spazi improvvisativi sui due confini, classica e jazz, promossi a zona franca da etichettature di sorta. Un disco, inoltre, contrassegnato da atmosfere rarefatte e da un lessico talora minimalista – chissammai perché la mente va al film Dieci di Kiarostami – in cui il regista Trabucco da autore si cala appieno nel “personaggio” del musicista che sa trasmettere, agli/cogli altri interpreti, il gioco instabile, tipo playing 1X2 dove è sempre la X a funzionare da centro di gravità.
X (Ics), a marchio Abeat Records, del contrabbassista Marco Trabucco, è album che trae spunto nel titolo dal numero decafonico dei ruoli musicali che vi figurano, appunto dieci (Scaramella, pf; Colussi, dr; Vitale, mar; Ghezzo, g.; Andreatta, v.; Dalla Libera, viola; Calamai, fl.; Pennucci, cor., oltre Trabucco nella doppia veste di compositore e strumentista). X, inoltre, rimanda, come scrive Paolo Cavallone nelle liner notes, “all’incognita che risulta dall’accostamento di sonorità cameristiche classiche con quelle del jazz”. X potrebbe stare anche per Pareggio vista l’equivalenza degli apporti fra legni-ottoni e jazz 4et di base con rivoli afrofolk a base di balanon (e marimba). I brani, in tutto cinque che è la metà di dieci (“One For Max”, “Open Space”, “Untitled”, “Meraki”, “Otranto”), scorrono limpidi come un ruscello alle falde di una montagna tant’è che non si avverte (di)stacco fra l’uno e l’altro. Segnale, questo, che la spinta inventiva ha origine da uno statuto creativo fondato su idee fluide sul come moltiplicare (ancora x) temi armonie timbri spazi improvvisativi sui due confini, classica e jazz, promossi a zona franca da etichettature di sorta. Un disco, inoltre, contrassegnato da atmosfere rarefatte e da un lessico talora minimalista – chissammai perché la mente va al film Dieci di Kiarostami – in cui il regista Trabucco da autore si cala appieno nel “personaggio” del musicista che sa trasmettere, agli/cogli altri interpreti, il gioco instabile, tipo playing 1X2 dove è sempre la X a funzionare da centro di gravità.
- Andrea Penna, A New World, Workin’ Label.
 Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando Dvorjak dedicò al Nuovo Mondo la Sinfonia n. 9! Eppure l’aspirazione/ispirazione dettata dal desiderio, magari utopico, di un mondo diverso e migliore, affiora ancora fra i musicisti. Il batterista-compositore piemontese Andrea Penna, con il c.d. A New World (Workin’ Label), è uno dei pensierosi visionari che “usano” la musica per autoproiettarvi i riflessi interiori del proprio mondo in osservazioni (“It Was Just Like That”), ricordi (“Poki”, “In My Arms”), emozioni (“E Fuori piove”), ritratti (“1B My Dear”), flashes (“Tutto in un Momento”) ora raccolti e ordinati. Ah, ecco perché i dischi li chiamano album! Il relativo sound registra umori provenienti dalla memoria – richiami GRP, echi travel/metheniani, ibridismi similrock – nello sfarinare una tracklist di nove brani di fusion effusiva grazie alla formazione che vede Massimo Artiglia a piano e tastiere, Luca Biggio ai sax, Mario Petracca e Andrea Mignone alle chitarre, Umberto Mari al basso e voce, Antonio Santoro al flauto. Se è lecito esprimere una preferenza la scelta cade sul brano d’apertura, “Parlami Ancora”, “scritto immaginando il mare, il discorrere intenso e rilassato passeggiando sulla spiaggia, con qualche brivido di gioia ed una grande voglia di libertà”. Giusto e opportuno antecederlo per far assaporare da subito il gusto della scoperta dell’immaginifico New World di Andrea Penna.
Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando Dvorjak dedicò al Nuovo Mondo la Sinfonia n. 9! Eppure l’aspirazione/ispirazione dettata dal desiderio, magari utopico, di un mondo diverso e migliore, affiora ancora fra i musicisti. Il batterista-compositore piemontese Andrea Penna, con il c.d. A New World (Workin’ Label), è uno dei pensierosi visionari che “usano” la musica per autoproiettarvi i riflessi interiori del proprio mondo in osservazioni (“It Was Just Like That”), ricordi (“Poki”, “In My Arms”), emozioni (“E Fuori piove”), ritratti (“1B My Dear”), flashes (“Tutto in un Momento”) ora raccolti e ordinati. Ah, ecco perché i dischi li chiamano album! Il relativo sound registra umori provenienti dalla memoria – richiami GRP, echi travel/metheniani, ibridismi similrock – nello sfarinare una tracklist di nove brani di fusion effusiva grazie alla formazione che vede Massimo Artiglia a piano e tastiere, Luca Biggio ai sax, Mario Petracca e Andrea Mignone alle chitarre, Umberto Mari al basso e voce, Antonio Santoro al flauto. Se è lecito esprimere una preferenza la scelta cade sul brano d’apertura, “Parlami Ancora”, “scritto immaginando il mare, il discorrere intenso e rilassato passeggiando sulla spiaggia, con qualche brivido di gioia ed una grande voglia di libertà”. Giusto e opportuno antecederlo per far assaporare da subito il gusto della scoperta dell’immaginifico New World di Andrea Penna.
- Roberto Gatti, Amanolibera, Encore Music
 Quello delle percussioni è un mondo a sé stante con la propria storia, le riviste, i libri, le cattedre, i miti: Don Azpiazù, Ray Barretto, Alex Acuna, Airto Moreira, Chano Pozo, Mino Cinelu, Ralph MacDonald, James Mtume … Quello delle percussioni non è un mondo a sé stante in quanto legato a filo doppio con gli altri strumenti che ne valorizzano al meglio le peculiarità. Sono due affermazioni uguali e contrarie. E bisognerebbe aggiungerne una terza, sempre ambivalente, che le percussioni possono rappresentare un’idea ritmica della musica, il latin, ad esempio, in cui la collocazione solistica è al tempo stesso elemento funzionale spesso imprescindibile dell’ensemble. L’album Amanolibera di Roberto Gatti, percussionista, edito da Encore Music, con circa una trentina di musicisti coinvolti nel progetto – fra gli ospiti anche Horacio El Negro Hernandez, Paoli Mejias, Oscar Valdes, Roberto Quintero, Jhair Sala, Gabriele Mirabassi, Lorenzo Bisogno, Tetraktis – documenta quanto il percussionismo, in particolare quello di spanish tinge, ne sia elemento vitale appunto insostituibile. Gatti vi si è cimentato anche a livello compositivo ragionandoci sopra con un drum set di congas, bongos, cajon, timbales, voce, tessendovi sei brani degli otto in scaletta (“Gatti Song”, “Bombetta”, “Chachaqua”, “Roberto’s Jam”, “Rumba per Giovanni”, “Jicamo 2.0”) in alcuni casi cofirmati, recitando così free hand un rosario sonoro allargato in sincronia al Sudamerica ed in diacronia a figure storiche dell’afrocubanismo. “La Comparsa” di Lecuona e “Giò Toca” di Valdes sono i due pezzi che Gatti non ha assortito dalla collezione personale, consentendo a chi ascolta un ritorno a melodie già metabolizzate con le sue percussioni a far da sorelle siamesi di una batteria con cui dialogare fittamente, da minimo comun denominatore che diventa massimo comun divisore di microscansioni particellari e poliritmie a catena.
Quello delle percussioni è un mondo a sé stante con la propria storia, le riviste, i libri, le cattedre, i miti: Don Azpiazù, Ray Barretto, Alex Acuna, Airto Moreira, Chano Pozo, Mino Cinelu, Ralph MacDonald, James Mtume … Quello delle percussioni non è un mondo a sé stante in quanto legato a filo doppio con gli altri strumenti che ne valorizzano al meglio le peculiarità. Sono due affermazioni uguali e contrarie. E bisognerebbe aggiungerne una terza, sempre ambivalente, che le percussioni possono rappresentare un’idea ritmica della musica, il latin, ad esempio, in cui la collocazione solistica è al tempo stesso elemento funzionale spesso imprescindibile dell’ensemble. L’album Amanolibera di Roberto Gatti, percussionista, edito da Encore Music, con circa una trentina di musicisti coinvolti nel progetto – fra gli ospiti anche Horacio El Negro Hernandez, Paoli Mejias, Oscar Valdes, Roberto Quintero, Jhair Sala, Gabriele Mirabassi, Lorenzo Bisogno, Tetraktis – documenta quanto il percussionismo, in particolare quello di spanish tinge, ne sia elemento vitale appunto insostituibile. Gatti vi si è cimentato anche a livello compositivo ragionandoci sopra con un drum set di congas, bongos, cajon, timbales, voce, tessendovi sei brani degli otto in scaletta (“Gatti Song”, “Bombetta”, “Chachaqua”, “Roberto’s Jam”, “Rumba per Giovanni”, “Jicamo 2.0”) in alcuni casi cofirmati, recitando così free hand un rosario sonoro allargato in sincronia al Sudamerica ed in diacronia a figure storiche dell’afrocubanismo. “La Comparsa” di Lecuona e “Giò Toca” di Valdes sono i due pezzi che Gatti non ha assortito dalla collezione personale, consentendo a chi ascolta un ritorno a melodie già metabolizzate con le sue percussioni a far da sorelle siamesi di una batteria con cui dialogare fittamente, da minimo comun denominatore che diventa massimo comun divisore di microscansioni particellari e poliritmie a catena.
- No Profit Blues Band. Helpin’ Hands. 20th Anniversary LILT di Treviso.
 Musica e medicina. Un’arte e una scienza. Con tante applicazioni e “trasfusioni” dall’area sanitaria a quella musicale destinate a creare effetti benefici di vario ordine, a partire dalla musicoterapia. E sono tanti gli operatori del ramo che hanno coniugato Esculapio ed Euterpe. Pensiamo a medici-compositori come Borodin, ai cantautori Jannacci e Locasciulli, a uno stimato pianista jazz come Angelo Canelli, a trombettisti come il docente di ginecologia Nando Giardina della Doctor Dixie Jazz Band, a chitarristi come il radiologo Vittorio Camardese sperimentatore del tapping sulla seicorde, al medico-batterista Zbigniew Robert Prominski membro dei Behemoth (collaboratore degli Artrosis, tanto per rimanere in tema)… Fra gli stili il blues (e derivati) si evidenzia come una fra le più azzeccate medicine dell’anima. Sono vent’anni che lo sperimenta sul campo la No Profit Blues Band che, per il compleanno, presenta l’album Helpin’ Hands frutto della collaborazione con la LILT di Treviso. Dismessi camici e mascherine, messi nel cassetto bisturi e stetoscopi, la band di professionisti della sanità con pianoforte (Alberto Zorzi), chitarra (Maurizio Marzaro), batteria (Danilo Taffarello), basso (Matteo Gasparello), voci (Teo Pelloia, Jessica Vinci, Luisa Lo Santo, Elisabetta Monastero), saxes ( Giacomo “Jack” Berlese) e armonica (Mauro Erri) ha adoperato un altro tipo di attrezzatura per “radiografare” i dintorni del blues . Scopo dell’”operazione”? Far sorridere i pazienti della LILT trevigiana diffondendo pillole di buonumore con iniezioni di spensieratezza. Un ensemble, il loro, mosso esclusivamente dal piacere di offrire la loro musica come antidoto per quanti vi possano trovare motivo di distrazione. Va detto che i pezzi in scaletta sono stati scelti ed eseguiti con maestria e verve. In scaletta ci sono “Smile” di Chaplin (cavallo di battaglia del fisiatra Zorzi), “Mustang Sally” di Rice (si è in pieno r&b alla Pickett ), “Summertime” (Gershwin forever), “Route 66” di Troup (con versioni che vanno da Nat King Cole agli Stones), “Unchain My Heart” di Sharp (ripreso divinamente fra gli altri da Joe Cocker), “Hoochie Coochie Man” di Dixon (Muddy Waters uber alles), “I Got A Woman” e “Halleluja I Love Her So” di Ray Charles, “Let The Good Times Roll” hit di B.B. King … Musica angelica, macchè diabolica, per lenire le ferite dello spirito.
Musica e medicina. Un’arte e una scienza. Con tante applicazioni e “trasfusioni” dall’area sanitaria a quella musicale destinate a creare effetti benefici di vario ordine, a partire dalla musicoterapia. E sono tanti gli operatori del ramo che hanno coniugato Esculapio ed Euterpe. Pensiamo a medici-compositori come Borodin, ai cantautori Jannacci e Locasciulli, a uno stimato pianista jazz come Angelo Canelli, a trombettisti come il docente di ginecologia Nando Giardina della Doctor Dixie Jazz Band, a chitarristi come il radiologo Vittorio Camardese sperimentatore del tapping sulla seicorde, al medico-batterista Zbigniew Robert Prominski membro dei Behemoth (collaboratore degli Artrosis, tanto per rimanere in tema)… Fra gli stili il blues (e derivati) si evidenzia come una fra le più azzeccate medicine dell’anima. Sono vent’anni che lo sperimenta sul campo la No Profit Blues Band che, per il compleanno, presenta l’album Helpin’ Hands frutto della collaborazione con la LILT di Treviso. Dismessi camici e mascherine, messi nel cassetto bisturi e stetoscopi, la band di professionisti della sanità con pianoforte (Alberto Zorzi), chitarra (Maurizio Marzaro), batteria (Danilo Taffarello), basso (Matteo Gasparello), voci (Teo Pelloia, Jessica Vinci, Luisa Lo Santo, Elisabetta Monastero), saxes ( Giacomo “Jack” Berlese) e armonica (Mauro Erri) ha adoperato un altro tipo di attrezzatura per “radiografare” i dintorni del blues . Scopo dell’”operazione”? Far sorridere i pazienti della LILT trevigiana diffondendo pillole di buonumore con iniezioni di spensieratezza. Un ensemble, il loro, mosso esclusivamente dal piacere di offrire la loro musica come antidoto per quanti vi possano trovare motivo di distrazione. Va detto che i pezzi in scaletta sono stati scelti ed eseguiti con maestria e verve. In scaletta ci sono “Smile” di Chaplin (cavallo di battaglia del fisiatra Zorzi), “Mustang Sally” di Rice (si è in pieno r&b alla Pickett ), “Summertime” (Gershwin forever), “Route 66” di Troup (con versioni che vanno da Nat King Cole agli Stones), “Unchain My Heart” di Sharp (ripreso divinamente fra gli altri da Joe Cocker), “Hoochie Coochie Man” di Dixon (Muddy Waters uber alles), “I Got A Woman” e “Halleluja I Love Her So” di Ray Charles, “Let The Good Times Roll” hit di B.B. King … Musica angelica, macchè diabolica, per lenire le ferite dello spirito.
da Gerlando Gatto | 23/Dic/2022 | Editoriali, I nostri libri, News, Primo piano
Affrontare un nuovo anno è un po’ come prepararsi ad un’impresa impegnativa. In effetti occorrono diverse condizioni perché il futuro sia visto con un minimo di ottimismo. Innanzitutto, è indispensabile porsi degli obiettivi il più chiari possibile; in secondo luogo è sempre opportuno raffrontare tali obiettivi ai mezzi disponibili; terzo – ma non meno importante – avere un quadro chiaro della situazione appena trascorsa per individuarne eventuali lati deboli su cui agire. Insomma, a mio avviso, la conoscenza piena, compiuta, consapevole del passato è condizione indispensabile per affrontare il futuro.
Se fossi un imprenditore direi che la situazione è ancora molto ma molto pesante perché dopo la pandemia siamo dentro un contesto internazionale pesantissimo anche se i più recenti dati sull’economia italiana non sono malvagi.
Per fortuna non sono un imprenditore ma un giornalista professionista che dopo essersi occupato per trent’anni di economia, adesso segue la sua più grande passione: il jazz.
Ritornando al discorso di cui in apertura, qual è attualmente la situazione del comparto jazzistico nel nostro Paese? Indubbiamente pesante anche se ho la vaga impressione che si tenda a dimenticare quanto accaduto nel recente passato.
Ecco è proprio da questa esigenza, dall’esigenza che non si dimentichi quanto accaduto che ho deciso di scrivere il mio terzo libro che alcuni di voi già conoscono: “Il Jazz italiano in epoca Covid” (clicca sul link per acquistare la tua copia su Amazon)
 Siccome siamo un Paese di ‘scordarelli’ non vorrei che passasse facilmente nel dimenticatoio quello che per molti musicisti, specialmente i più giovani, è stato un periodo che definire terrificante è quasi un eufemismo. Musicisti per mesi senza lavoro, senza concerti, senza serate, con pochissime occasioni di registrare, hanno dovuto faticare parecchio per uscirne fuori… È ammesso poi che ciò sia accaduto. Ecco, il mio intento era e resta quello di offrire una testimonianza di questo periodo drammatico, una testimonianza non mia ma di quanti molto più di me hanno dovuto subire questa situazione.
Siccome siamo un Paese di ‘scordarelli’ non vorrei che passasse facilmente nel dimenticatoio quello che per molti musicisti, specialmente i più giovani, è stato un periodo che definire terrificante è quasi un eufemismo. Musicisti per mesi senza lavoro, senza concerti, senza serate, con pochissime occasioni di registrare, hanno dovuto faticare parecchio per uscirne fuori… È ammesso poi che ciò sia accaduto. Ecco, il mio intento era e resta quello di offrire una testimonianza di questo periodo drammatico, una testimonianza non mia ma di quanti molto più di me hanno dovuto subire questa situazione.
E devo constatare che l’obiettivo è stato raggiunto se molti dell’ambiente jazzistico, hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto.
Così, ad esempio, secondo Claudio Angeleri “È un libro da avere e leggere perché documenta un periodo difficile per tutti ma in particolare per i musicisti. E non dimenticare. Le testimonianze sono del marzo 2020. Sembra passato un secolo. Bravo per aver avuto questa idea e averla realizzata”.
Per Riccardo Scivales “Un libro importante per far capire a chi non lo sa cosa significa vivere di musica e le mille difficoltà e ostacoli posti ogni giorno a questa professione che non serve solo a far “divertire” la gente. Da avere assolutamente e grazie” a chi l’ha concepito e realizzato.
Dal canto suo Neri Pollastri scrive: “Un lavoro particolare, questo di Gerlando Gatto, nel quale si parla poco o niente di musica, più uno studio sociologico che un libro sul jazz; e tuttavia un lavoro non solo molto interessante, ma anche a suo modo necessario, per comprendere come davvero abbia vissuto la fase più acuta della pandemia (si spera, visto che oggi siamo di fronte a una forte recrudescenza) una delle categorie più colpite dalle sue conseguenze non sanitarie, ma esistenziali ed economiche, qual è quella dei musicisti jazz”.
Gerlando Gatto
da Gerlando Gatto | 15/Dic/2022 | I nostri CD, Primo piano, Recensioni
UNO SGUARDO ALL’ESTERO
 Wolfert Brederode – “Ruins and Remains” – ECM
Wolfert Brederode – “Ruins and Remains” – ECM
Questa suite per pianoforte, quartetto d’archi e percussioni, ha un preciso significato storico in quanto è stata composta da Wolfert Brederode nel 2018, in occasione del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale. Da quell’anno al 2021 quando la suite è stata registrata dal pianista Wolfert Brederode coadiuvato dal percussionista Joost Lijbart e dal gruppo d’archi olandese Matangi Quartet la composizione ha visto alcuni cambiamenti grazie alla stretta collaborazioni fra i musicisti. In effetti Brederode aveva avuto in passato occasione di collaborare sia con il Matangi Quartet sia con il percussionista presente nei suoi gruppi sin dal 2004. Lijbart è un esponente del “nuovo” jazz caratterizzato da una profonda e radicale improvvisazione ed è riuscito a portare questa cifra stilistica all’interno di composizioni che, pur privilegiando una certa ricerca melodica, non disdegnano di riservare spazi significativi all’improvvisazione. E, ad avviso di chi scrive, il pregio maggiore dell’album – e probabilmente del leader – è quello di aver saputo dare alla musica un’anima che riesce assai bene a coniugare l’espressività del pianoforte con il sound del quartetto e le capacità improvvisative di Lijbart. Ancora una volta, come fa rilevare Maria-Paula Majoor, componente del Matangi Quartet, fondamentale è risultato in sala di incisione il ruolo di Manfred Eicher, produttore nonché fondatore nel 1969 della ECM, il quale ha spinto sempre i musicisti a rimodellare la musica di modo che la transizione tra le parti improvvisate e quelle scritte fosse quasi impercettibile.
 Ali Gaggl – “A Piece of Art” – ATS
Ali Gaggl – “A Piece of Art” – ATS
Nonostante l’Austria abbia dato i natali a due grandissimi musicisti quali Joe Zawinul e Friedrich Gulda, negli ultimi anni poco conosciamo di quel che accade in quel Paese. Ben venga, quindi, l’ATS che ci presenta alcuni musicisti austriaci. Questo “A Piece Of Art” è l’ultimo album della vocalist e compositrice Ali Gaggl, vero nome Alberta Gaggl, nata il 15 Ottobre 1959 a Klagenfurt. Musicista a 360 gradi (ha studiato jazz e musica popolare al Conservatorio della città natale, specializzandosi in canto e in pianoforte oltre ad aver avviato una rilevante carriera didattica insegnando canto al Conservatorio di Trieste, alla Bruckner University di Linz e alla Summer Academy del Castello di Viktring) la Gaggl si è fatta ascoltare sia in Europa sia in Canada collaborando spesso con Kenny Wheeler e la Upper Austrian Jazz Orchestra. In quest’ultimo album, la Gaggl ha chiamato accanto a sé molti musicisti tra i quali il sassofonista Wolfgang Puschnig, la Upper Austrian Jazz Orchestra – UAJO e il quartetto d’archi Koehne; in programma un repertorio assai variegato in cui accanto a sue composizioni, figurano standard come “In a Sentimental Mood” (accompagnata dal quartetto d’archi) e “God Bless The Child” con l’UAJO, forse il brano meno riuscito. Il clima che si respira ascoltando per intero l’album è quello di un solido mainstream sostenuto dall’abilità di tutti i protagonisti e specialmente della vocalist che appare perfettamente in linea sia quando è accompagnata dal solo trio di pianoforte (“Stund Up”), sia che canti con l’orchestra, sia che interpreti brani più leggeri (“C’est ci bon”), sia che si trovi immersa in un contesto ritmico più marcato come nei casi della title track e di “African Child” uno dei brani più originali dell’intero album.
 Sverre Gjørvad – “Here Comes the Sun” – Losen
Sverre Gjørvad – “Here Comes the Sun” – Losen
È con vero piacere che presentiamo al pubblico italiano questo batterista norvegese in Italia sostanzialmente ancora sconosciuto, nonostante non sia più giovanissimo (classe 1966). Il musicista di Stathelle, cittadina nel comune di Bamble nella contea di Vestfold og Telemark, viceversa è ben noto in patria avendo collaborato con alcuni musicisti di rilievo come Live Maria Roggen, Ståle Storløkken, Mats Eilertsen e Nils-Olav Johansen. In questa nuova registrazione si ripresenta alla testa del suo gruppo storico completato da Herborg Rundberg piano, Dag Okstad basso, Kristian Svalestad Olstad chitarra cui si aggiunge Eirik Hegdal ai sax nel brano che conclude l’album, “Voi River”. Questo “Here Comes the Sun” chiude un ciclo di quattro CD dedicati alle quattro stagioni, registrati sempre con i medesimi musicisti. La stagione cui si riferisce questa volta è la primavera ed in effetti la musica rispecchia abbastanza bene il clima che si respira da quelle parti a partire da marzo, aprile. E questo è un discorso difficile da capire per chi non sia mai vissuto nel Nord Europa e non sia stato testimone di quello straordinario risveglio della natura che si registra in quel periodo. Così la musica del gruppo è vivace, sostenuta da un buon ritmo, con pianista e chitarrista in primo piano a supportare le concezioni del leader che si rispecchia appieno, anche come compositore, in tutte e trenta le composizioni attraverso cui sono declinati i quattro album di cui in precedenza.
 Rolf Kristensen – “Invitation” – Losen
Rolf Kristensen – “Invitation” – Losen
Eccellente chitarrista norvegese, nato a Kristiansand, nel 1961, ha già ottenuto in patria numerosi riconoscimenti di pubblico e di critica soprattutto come solista del gruppo Secret Garden. In questa nuova fatica discografica, Rolf ha chiamato accanto a sé molti musicisti tra cui alcuni vocalist da lui ritenuti tra i migliori del momento in Norvegia (Torun Eriksen, Hilde Hefte , Kari Iveland e Hilde Norbakken) e un altro celebre chitarrista Allen Hinds (The Crusaders, Roberta Flack, Randy Crawford, Natalie Cole)il quale, trovandosi in città durante la registrazione dell’album, accettò volentieri l’invito del leader ad unirsi al gruppo per incidere il classico di Corea “Crystal Silence” Per il resto il repertorio è di quelli che fanno tremare le vene ai polsi dal momento che si tratta di brani tutti tratti dal “Great American Songbook”. Ecco quindi uno dopo l’altro alcuni classici come “Blue in Green”, la title track…per chiudere con il già citato “Crystal Silence”. Si tratta, in buona sostanza, di una sfida che Rolf ha espressamente dichiarato di voler affrontare proprio per evidenziare in che modo la sua preparazione soprattutto la sua personalità gli consentono di affrontare questi brani apportando qualcosa di personale. Obiettivo raggiunto? Difficile dirlo…nel senso che sicuramente Kristensen interpreta assai bene tutti i brani, un po’ più difficile affermare che vi apporti qualcosa di veramente nuovo.
 Maja Jaku – “Soul Searching” – ATS
Maja Jaku – “Soul Searching” – ATS
Maja Jaku giunta al suo quarto album da leader, ha tutte le carte in regola per affermarsi nel pur vasto panorama del jazz europeo. Può innanzitutto vantare una solida preparazione di base avendo studiato, tra gli altri, con
Sheila Jordan, Mark Murphy, Jay Clayton e Andy Bey e nel suo curriculum figura la prestigiosa collaborazione con la band fusion di Gerd Schuller “Attack”. Questo nuovo album, creato tra San Diego e Vienna, si intitola significativamente “Soul Searching” ad indicare la precisa volontà della vocalist di rifarsi alle atmosfere tipiche della Blue Note anni ’70 declinando un repertorio abbastanza variegato. Principale responsabile il compositore e trombonista Dave Scott che ha scritto 3 composizioni mentre il trombettista americano Jim Rotondi ha contribuito agli arrangiamenti degli ottoni e due composizioni sono state co-scritte dalla stessa Maja Jaku. Il gruppo è completato da Sasa Mutic piano, Dusan Simovic basso e Joris Dudli batteria.
Per chi ama questo tipo di jazz l’album risulterà sicuramente interessante; per tutti gli altri detto che la Jaku ha molte carte da giocare, in alcuni passaggi si nota una qualche incertezza, una non perfetta padronanza della materia musicale che si può spiegare con la giovane età nella consapevolezza che in un futuro non lontano le cose non potranno che migliorare. Tra gli otto brani in programma particolarmente interessante “Be Real” mentre in “God Bless The Child” si apprezza una bella intro del trombettista Jim Rotondi. Un’ultima notazione: vi abbiamo presentato due vocalist austriache e ambedue hanno messo in repertorio quest’ultimo brano, scelta che non comprendiamo appieno data la difficoltà di interpretare al meglio una partitura entrata oramai nell’immaginario collettivo.
 Keith Jarrett – “Bordeaux Concert” – ECM
Keith Jarrett – “Bordeaux Concert” – ECM
Ascoltando album come questo si riaccende il rammarico per l’impossibilità di ascoltare nuove imprese di colui che a ben ragione può essere considerato uno dei massimi pianisti del secolo scorso. Questa volta Jarrett viene ripreso durante un concerto svoltosi all’Auditorium dell’Opera National di Bordeaux il 6 luglio del 2016, nell’ambito di quel tour europeo che aveva portato l’artista ad esibirsi, tra l’altro, a Budapest, Vienna e Monaco. Venendo a quest’ultimo album, dobbiamo confessare che recensirlo è impresa davvero ardua in quanto su Jarrett molto, moltissimo è stato scritto e “Bordeaux Concert” non fa altro che ribadire tutto ciò che già si conosceva. Vale a dire un artista straordinario sotto le cui dita il pianoforte assurge a vertici difficilmente raggiungibili. Jarrett suona con straordinaria lucidità e quindi con pieno controllo della materia sonora che si sviluppa seguendo una logica ben precisa, non ardua da individuare specialmente per chi ben conosce Jarrett. Ecco quindi la sua capacità di suonare frasi già conosciute ma in modo totalmente nuovo grazie soprattutto alla costante ricerca di nuove cellule melodiche. Quindi non è certo un caso che la stampa internazionale abbia accolto l’album con grande rilievo sottolineando a più riprese sia il carattere intimistico della musica sia la bellezza delle parti estese che si collocano in una dimensione altra lontana dallo spazio e dal tempo. Da sottolineare come l’album è declinato attraverso tredici parti senza titolo ma numerate con cifre romane, parti che si allacciano perfettamente l’una all’altra pur nella diversità d’ispirazione sì da costituire un lungo straordinario, entusiasmante e commovente discorso sonoro.
 Jean-Charles Richard – “L’ètoffe des reves” – La Buissonne
Jean-Charles Richard – “L’ètoffe des reves” – La Buissonne
Come l’album “Canto” più sopra recensito, anche questa nuova produzione del sopranista e baritonista Jean-Charles Richard può definirsi ‘jazz da camera’, ove con tale definizione si intenda riferirsi ad una musica organicamente costruita con pochi mezzi e soprattutto scritta con sobrietà ed eleganza. Oltre al sassofonista nell’album è possibile ascoltare il pianista Marc Copland, la vocalist Claudia Solal e il violoncellista Vincent Segal. E a nostro avviso è proprio Copland, unitamente al leader, a conferire una precisa cifra stilistica all’intero album declinato attraverso undici composizioni. I due dialogano sempre con empatia disegnando atmosfere che sembrano collocarsi al di fuori del tempo e dello spazio, una dimensione in cui il silenzio ha quasi la stessa importanza del suono; si ascolti, ad esempio “Giverny” o “Desquartes”… anche se in realtà queste caratteristiche si evidenziano in tutte le esecuzioni. Eccellente anche la prestazione della vocalist Claudia Solal moglie del sassofonista e figlia del celebre Martial; Claudia interpreta con pertinenza “Ophélie Death” (in cui si mette in musica i versi dell’Amleto) e la “Title track” (con testo tratto dalla Tempesta shakespeariana) ambedue porte in inglese e “Ophélie” (con versi di Rimbaud) cantata viceversa in francese.
Ma questi rimandi alla letteratura attraversano un po’ tutto l’album così come i richiami a musicisti di altre epoche quali Olivier Messiaen, Igor Stravinsky, Claude Debussy. L’album si chiude con “Weeping Brook” un pezzo di bravura del leader al sax baritono.
 Steve Tibbets – “Hellbound Train: An Anthology” – ECM 2CD
Steve Tibbets – “Hellbound Train: An Anthology” – ECM 2CD
Le antologie non figurano in cima alle nostre preferenze…a meno che non si tratti di qualcosa di particolare. Ed è proprio questo il caso dal momento che si tratta di un tributo riservato ad un artista tanto originale quanto riservato. Molti anni sono passati da quel lontano 1977 quando Steve pubblicò il suo primo album ma l’artista ha sempre tenuto fede a quelle che sin dall’inizio sono state le direttrici su cui ha impostato la propria ricerca: i continui riferimenti etnici, impiego di una strumentazione del tutto particolare ivi compresi i nastri magnetici, l’alternarsi di momenti estatici ad altri molto più terreni. In repertorio 28 brani tratti dagli album che l’artista ha realizzato per l’ECM in un lungo lasso di tempo. Ovviamente molti i musicisti che si ascoltano accanto al polistrumentista leader, ma la musica ruota sostanzialmente intorno a Steve che suona la chitarra, il dobro (o chitarra resofonica), la kalimba e le percussioni. Due le notazioni che si possono fare per rendere più agevole l’ascolto: la sequenza dei brani non è cronologica e i brani scelti rispecchiano assai bene la multiforme personalità del leader. Molti sarebbero i brani da segnalare all’attenzione del lettore, ma andremmo ben oltre i limiti che riserviamo ad ogni recensione per cui basti sottolineare come i curatori sono riusciti a tracciare un ritratto esaustivo dell’artista.
DUE NOTE DI CLASSICA
 Margherita Porfido – “Da Gesualdo a Piccinni – Musicisti del Sud Italia dal 1500 al 1700) DiG 2 CD
Margherita Porfido – “Da Gesualdo a Piccinni – Musicisti del Sud Italia dal 1500 al 1700) DiG 2 CD
Margherita Porfido – “Margherita’s Miniatures” – DiG
In questi due album, editi da DiG (Digressione) abbiamo l’opportunità di ascoltare e ammirare una delle più complete clavicembaliste italiane. Nata ad Altamura, Margherita Porfido comincia a studiare musica sin da giovanissima diplomandosi in pianoforte e clavicembalo. A partire dal 1983 si dedica completamente allo studio del clavicembalo soprattutto con riferimento alla musica Rinascimentale-Barocca ed a quella contemporanea, prediligendo il repertorio solistico e di solista con orchestra.
Nel primo album, “Da Gesualdo a Piccinni”, impreziosito da un esauriente libretto vergato da Alessandro Zignani, scrittore, musicologo e germanista di grande spessore, possiamo ascoltare una serie di brani che risultano assolutamente indispensabili per capire a fondo la musica tra ‘500 e ‘700 del meridione d’Italia. Il repertorio, infatti, comprende tra l’altro la “Canzon francese del principe” di Gesualdo Da Venosa, la “Salve Regina” di Rodio, composizioni di Giovanni Salvatore, Giovanni Maria Trabaci, i balli e le danze di Antonio Valente e Bernardo Storace, fino alle “Tre Sonate e Una Toccata” di Niccolò Piccinni. In buona sostanza si tratta di uno straordinario viaggio attraverso le note che ci conduce alla scoperta, o forse sarebbe meglio dire alla riscoperta, di autori purtroppo non particolarmente eseguiti ma che risultano fondamentali per lo sviluppo della musica colta nel nostro Paese.
 Diverso il secondo CD, “Margherita’s Miniatures”, in cui la clavicembalista affronta un repertorio variegato, molto diverso dal precedente, con autori non accademici, e con l’ausilio di un artista proveniente da altri ambiti quali Pino Minafra alla tromba e al didgeridoo. Ad onta di queste discrepanze, l’album mantiene una sua ben precisa unità di fondo data dal clavicembalo della Porfido che riesce ad interpretare tutte le partiture con maestria dimostrando come anche uno strumento oggettivamente “antico” possa misurarsi con linguaggi moderni. Ecco quindi che si parte con le “Danze popolari romene di Béla Bartok per approdare a “Les fastes de la grande et ancienne MXNXSTRXNDXSX” di François Couperin, in cui si ascolta il jazzista Pino Minafra al didgeridoo. In mezzo ancora un autore classico come Erik Satie ma soprattutto esponenti della musica moderna quali Eugenio Colombo, Fred Van Hopve, Keith Tippett, Livio Minafra, Michel Godard, Daniel Pinkham, Nino Rota e Gianluigi Trovesi. Ed è proprio al confronto con questi ultimi che si manifesta in tutta la sua bravura la Porfido che riesce ad adattare il suo strumento alle necessità espressive dei vari brani senza che gli stessi perdano un’oncia dell’originario fascino. Particolarmente suggestivo “Romeo e Giulietta” di Nino Rota anche per la presenza di Pino Minafra alla tromba, musicista che, come sottolinea Ugo Sbisà nelle note che accompagnano l’album, proprio in veste di trombettista si fa desiderare oramai da lunga, troppo lunga, pezza
Diverso il secondo CD, “Margherita’s Miniatures”, in cui la clavicembalista affronta un repertorio variegato, molto diverso dal precedente, con autori non accademici, e con l’ausilio di un artista proveniente da altri ambiti quali Pino Minafra alla tromba e al didgeridoo. Ad onta di queste discrepanze, l’album mantiene una sua ben precisa unità di fondo data dal clavicembalo della Porfido che riesce ad interpretare tutte le partiture con maestria dimostrando come anche uno strumento oggettivamente “antico” possa misurarsi con linguaggi moderni. Ecco quindi che si parte con le “Danze popolari romene di Béla Bartok per approdare a “Les fastes de la grande et ancienne MXNXSTRXNDXSX” di François Couperin, in cui si ascolta il jazzista Pino Minafra al didgeridoo. In mezzo ancora un autore classico come Erik Satie ma soprattutto esponenti della musica moderna quali Eugenio Colombo, Fred Van Hopve, Keith Tippett, Livio Minafra, Michel Godard, Daniel Pinkham, Nino Rota e Gianluigi Trovesi. Ed è proprio al confronto con questi ultimi che si manifesta in tutta la sua bravura la Porfido che riesce ad adattare il suo strumento alle necessità espressive dei vari brani senza che gli stessi perdano un’oncia dell’originario fascino. Particolarmente suggestivo “Romeo e Giulietta” di Nino Rota anche per la presenza di Pino Minafra alla tromba, musicista che, come sottolinea Ugo Sbisà nelle note che accompagnano l’album, proprio in veste di trombettista si fa desiderare oramai da lunga, troppo lunga, pezza
 Valentin Silvestrov – Maidan – ECM
Valentin Silvestrov – Maidan – ECM
Il significato di questo album va ben al di là del fatto squisitamente musicale in quanto si inserisce a pieno titolo nella più drammatica vicenda che il mondo sta vivendo dopo la Seconda guerra mondiale. Valentin Silvestrov, nato nel 1937 a Kyiv, è considerato il compositore più significativo in Ucraina e queste registrazioni, effettuate nel 2016 dal Kyiv Chamber Choir diretto da Mykola Hobodych, durante un concerto tenuto presso la cattedrale di San Michele, nella capitale ucraina, ne sono la palese testimonianza. La sua è una musica sobria, riflessiva, che rispecchia perfettamente l’anima di un popolo nel tentativo perfettamente riuscito di coniugare le cose semplici della vita con il senso più profondo della bellezza del mondo e degli umani sentimenti. In tal senso Silvestrov è sempre rimasto una sorta di cronista in musica della storia della sua terra. Ed è proprio in questo senso che l’album assume quella valenza di cui in apertura. In effetti il compositore, dopo i moti ucraini del 2004 (noti come la Rivoluzione arancione) e le proteste di Maidan (Majdan Nezaležnosti – Piazza Indipendenza, la piazza centrale di Kiev capitale dell’Ucraina) contro l’influenza russa nel 2014, si è rivolto più apertamente a temi politici e religiosi. Di qui una serie di pezzi raccolti sotto l’insegna “Maidan-2014”, per coro a cappella. (Il suo tredicesimo movimento è la “Preghiera per l’Ucraina”). Adesso la situazione per Silvestrov si è fatta davvero pesante: poco dopo l’invasione russa dell’Ucraina, ha dovuto lasciare la sua città natale e vive a Berlino da allora. Parallelamente dopo l’inizio della guerra, la musica di Silvestrov viene eseguita spesso al di fuori dell’Ucraina ottenendo sempre grandi successi di pubblico e di critica e portando la fama dell’autore a vertici mai raggiunti in precedenza. Dal punto di vista squisitamente artistico, la musica si fa apprezzare particolarmente per come riesce ad esprimere atmosfere assai diverse transitando da momenti corali maestosi ad altri in cui sembra prevalere una sensazione di dolorosa partecipazione, ad altri ancora in cui si avverte una grande dolcezza. Di qui anche le diverse strutture del coro che ora si avvale solo di alcune sezioni, ora interviene per intero nella sua maestosità, altre volte ancora si affida ad alcune voci soliste. Insomma, un piccolo capolavoro che va ascoltato con il massimo rispetto.
Gerlando Gatto
da Gerlando Gatto | 24/Nov/2022 | Primo piano, Recensioni
Sono solo quattro i concerti che ho potuto seguire nel corso dell’annuale Roma Jazz Festival, ma se il livello di tutte le manifestazioni è paragonabile a quello dei musicisti che ho ascoltato, bisogna dare atto a Ciampà e compagni di aver ancora una volta scelto assai bene gli artisti da presentare al pubblico romano.
Ma procediamo con ordine. C’è voluto molto tempo prima che alla Fusion venisse riconosciuta quella dignità che merita. Una delle band che maggiormente ha contribuito all’affermazione della Fusion è  stata Spyro Gyra, esibitasi all’Auditorium Parco della Musica il 12 novembre scorso. Siamo a New York a metà degli anni ’70 quando il sassofonista Jay Beckenstein, assieme al pianista Jeremy Wall, mette su un gruppo che curiosamente chiama Spyro Gyra da una famiglia di alghe, appunto le spirogire, la cui grafia viene cambiata dal gestore del locale dove si esibiscono per la prima volta. Nel 1978 viene inciso Spyro Gyra, ma il successo vero arriva l’anno dopo con Morning Dance che si piazza tra le quaranta migliori vendite di album negli Stati Uniti, con la title-track fra i singoli più venduti sempre negli USA. Da questo momento è tutto un susseguirsi di successi: oltre 10 milioni di album venduti, oltrepassati i 40 anni di attività, più di 30 album all’attivo. Ovviamente nel corso di tutti questi anni il gruppo ha cambiato spesso organico: Beckenstein, classe 1951, è rimasto a guidare il gruppo sino ad oggi condividendo la direzione della band con il pianista Jeremy Wall fino alla fine degli anni ’80. Ciò che è rimasto sostanzialmente invariato è la forza d’urto che questo gruppo sa esprimere sul palco: un cocktail di rhythm & blues, melodie popolari, riferimenti a ritmi caraibici in cui si innestano assolo di chiara impronta jazzistica. Ad interpretare questa formula vincente a Roma è un insieme di grandi musicisti che affiancano il leader ancora in gran spolvero: Tom Schuman, piano, Scott Ambush, basso, Julio Fernandez, chitarra e Lionel Cordew, batteria. Tutti sono apparsi assolutamente all’altezza del compito regalando agli spettatori alcuni momenti davvero spettacolari come un duetto, artisticamente pregevole, tra batteria e contrabbasso, alcuni momenti in cui il leader ha imbracciato contemporaneamente i suoi due strumenti sax alto e flauto, e un brano di chiara ispirazione cubana, De la Luz interpretato con sincera partecipazione dal chitarrista, per l’appunto cubano, Julio Fernandez che è membro di Spyro Gyra dal 1984.
stata Spyro Gyra, esibitasi all’Auditorium Parco della Musica il 12 novembre scorso. Siamo a New York a metà degli anni ’70 quando il sassofonista Jay Beckenstein, assieme al pianista Jeremy Wall, mette su un gruppo che curiosamente chiama Spyro Gyra da una famiglia di alghe, appunto le spirogire, la cui grafia viene cambiata dal gestore del locale dove si esibiscono per la prima volta. Nel 1978 viene inciso Spyro Gyra, ma il successo vero arriva l’anno dopo con Morning Dance che si piazza tra le quaranta migliori vendite di album negli Stati Uniti, con la title-track fra i singoli più venduti sempre negli USA. Da questo momento è tutto un susseguirsi di successi: oltre 10 milioni di album venduti, oltrepassati i 40 anni di attività, più di 30 album all’attivo. Ovviamente nel corso di tutti questi anni il gruppo ha cambiato spesso organico: Beckenstein, classe 1951, è rimasto a guidare il gruppo sino ad oggi condividendo la direzione della band con il pianista Jeremy Wall fino alla fine degli anni ’80. Ciò che è rimasto sostanzialmente invariato è la forza d’urto che questo gruppo sa esprimere sul palco: un cocktail di rhythm & blues, melodie popolari, riferimenti a ritmi caraibici in cui si innestano assolo di chiara impronta jazzistica. Ad interpretare questa formula vincente a Roma è un insieme di grandi musicisti che affiancano il leader ancora in gran spolvero: Tom Schuman, piano, Scott Ambush, basso, Julio Fernandez, chitarra e Lionel Cordew, batteria. Tutti sono apparsi assolutamente all’altezza del compito regalando agli spettatori alcuni momenti davvero spettacolari come un duetto, artisticamente pregevole, tra batteria e contrabbasso, alcuni momenti in cui il leader ha imbracciato contemporaneamente i suoi due strumenti sax alto e flauto, e un brano di chiara ispirazione cubana, De la Luz interpretato con sincera partecipazione dal chitarrista, per l’appunto cubano, Julio Fernandez che è membro di Spyro Gyra dal 1984.
Si inizia un po’ in sordina con Walk The Walk che fa parte del repertorio Spyro Gyra già dai primi anni ’90; la band sembra piuttosto freddina ma già con il secondo pezzo le cose cambiano. Groovin’ for Grover evidenzia un Tom Schuman in gran forma che sfodera un pianismo modale allo stesso tempo toccante e trascinante. Seguono in rapida successione altri brani tratti dai tantissimi album del gruppo: Captain Karma, Shaker Song che ritroviamo addirittura nel primo album inciso dalla band nel 1978, I Believe in You di Tom Schuman tratto da Alternating Currents, ottavo album in studio del gruppo pubblicato nel giugno 1985 e classificato al terzo posto dalla rivista settimanale statunitense Billboard per la categoria Top Jazz Album, il già citato De la Luz, l’originale versione di Tempted By The Fruit Of Another incisa dagli Squeeze nel 1981… Insomma un concerto che è andato in crescendo tra gli appalusi di un pubblico chiaramente appassionato del genere.
 Il giorno dopo altro appuntamento straordinario con la Mingus Big Band. Probabilmente a ben ragione la big-band è considerata da molti la quinta essenza del jazz dal momento che ne contiene tutti gli elementi fondamentali: scrittura, arrangiamenti, improvvisazione, senso del collettivo, bravura solistica. Purtroppo in questo periodo è sempre più difficile ascoltare una grande orchestra sia dal vivo sia su disco. È quindi con il massimo interesse che mi sono recato all’Auditorium Parco della Musica per ascoltare una delle orchestre più prestigiose di questi ultimi anni: la Mingus Big Band. Nata nel 1991 per la volontà di Sue Mingus di perpetuare il repertorio del genio di Nogales, celebrandone la musica in tutti i suoi molteplici aspetti, la band vanta attualmente undici album, di cui sei nominati per i Grammy, e nell’ottobre scorso ha pubblicato The Charles Mingus Centennial Sessions (Jazz Workshop) a 100 anni per l’appunto dalla nascita dell’artista; attualmente consta di quattordici elementi tra cui alcuni dei più grandi musicisti di New York, quali il trombonista Robin Eubanks, i trombettisti Alex Sipiagin e Philip Harper (dal 1986 al 1988 membro degli Art Blakey´s Jazz Messengers ) e Earl Mcintyre trombone basso, tuba, già a fianco dello stesso Mingus. Ben diretta dal contrabbassista russo Boris Kozlov, l’orchestra è in tournée per la prima volta dopo la morte di Sue Mingus a 92 anni nel dicembre scorso, e il successo è clamoroso ovunque si esibisce grazie all’elevato tasso artistico dei singoli musicisti. La loro musica si richiama espressamente allo spirito della musica mingusiana, un viaggio nell’affascinante universo del celebre contrabbassista e compositore. Gli elementi che hanno reso indimenticabile Mingus ci sono tutti: i repentini cambiamenti di ritmo, le melodie alle volte sghembe ma sempre affascinanti, i maestosi collettivi, gli assolo scoppiettanti, il potere trascinante, una miriade di sfaccettature che ben difficilmente si ritrovano in altre composizioni, la tensione che si riesce a trasmettere, l’immediatezza e l’universalità del linguaggio.
Il giorno dopo altro appuntamento straordinario con la Mingus Big Band. Probabilmente a ben ragione la big-band è considerata da molti la quinta essenza del jazz dal momento che ne contiene tutti gli elementi fondamentali: scrittura, arrangiamenti, improvvisazione, senso del collettivo, bravura solistica. Purtroppo in questo periodo è sempre più difficile ascoltare una grande orchestra sia dal vivo sia su disco. È quindi con il massimo interesse che mi sono recato all’Auditorium Parco della Musica per ascoltare una delle orchestre più prestigiose di questi ultimi anni: la Mingus Big Band. Nata nel 1991 per la volontà di Sue Mingus di perpetuare il repertorio del genio di Nogales, celebrandone la musica in tutti i suoi molteplici aspetti, la band vanta attualmente undici album, di cui sei nominati per i Grammy, e nell’ottobre scorso ha pubblicato The Charles Mingus Centennial Sessions (Jazz Workshop) a 100 anni per l’appunto dalla nascita dell’artista; attualmente consta di quattordici elementi tra cui alcuni dei più grandi musicisti di New York, quali il trombonista Robin Eubanks, i trombettisti Alex Sipiagin e Philip Harper (dal 1986 al 1988 membro degli Art Blakey´s Jazz Messengers ) e Earl Mcintyre trombone basso, tuba, già a fianco dello stesso Mingus. Ben diretta dal contrabbassista russo Boris Kozlov, l’orchestra è in tournée per la prima volta dopo la morte di Sue Mingus a 92 anni nel dicembre scorso, e il successo è clamoroso ovunque si esibisce grazie all’elevato tasso artistico dei singoli musicisti. La loro musica si richiama espressamente allo spirito della musica mingusiana, un viaggio nell’affascinante universo del celebre contrabbassista e compositore. Gli elementi che hanno reso indimenticabile Mingus ci sono tutti: i repentini cambiamenti di ritmo, le melodie alle volte sghembe ma sempre affascinanti, i maestosi collettivi, gli assolo scoppiettanti, il potere trascinante, una miriade di sfaccettature che ben difficilmente si ritrovano in altre composizioni, la tensione che si riesce a trasmettere, l’immediatezza e l’universalità del linguaggio.
Molti i brani celebri in programma: dall’esplosivo Jump Monk, al trascinante Sue’s Changes tratto dallo straordinario “Changes One” inciso nel 1975 da una bellissima formazione comprendente Jack Walrath alla tromba, George Adams al sassofono tenore, Don Pullen al piano e Dannie Richmond alle percussioni. Ma i brani forse più riusciti sono stati So Long Eric e Self-Portrait in Three Colors. Il primo è stato scritto da Mingus per invitare l’amico e collega Eric Dolphy a tornare nella band dopo che questi, a seguito di una fortunata tournée, aveva deciso, nel 1964, di rimanere in Europa; ironia della sorte la sera del 29 giugno dello stesso 1964, a Berlino Ovest durante un concerto Eric ebbe un malore determinato da una grave forma di diabete che lo condusse alla morte. Self-Portrait in Three Colors è uno dei pezzi più classici di Mingus: lo stesso contrabbassista amava descriversi così nell’incipit di Peggio di un Bastardo (la sua autobiografia), uno e trino allo stesso tempo. Insomma, tornando al concerto, una serata memorabile grazie ad una musica straordinaria eseguita da un gruppo di eccellenti musicisti.
Martedì 15 almeno a mio avviso la più bella sorpresa del Festival: il concerto del pianista e compositore azero Isfar Sarabski. Avevo già ascoltato qualche brano dell’artista tratto dall’album Planet del 2021 ma sentirlo all’opera dal vivo è tutt’altra cosa. Ben coadiuvato da Behruz Zeynal al tar (strumento a sei corde simile al liuto che viene suonato con un piccolo plettro d’ottone), Makar Novikov al contrabbasso e Sasha Mashin alla batteria, il pianista si è espresso su altissimi livelli meritandosi i convinti applausi del pubblico. In realtà il concerto non era iniziato nel migliore dei modi: affidato soprattutto alle capacità solistiche di Behruz Zeynal la serata sembrava indirizzata lungo i binari di quel mélange tra jazz e medio-oriente di cui abbiamo già molte testimonianze. Per fortuna dal secondo pezzo le atmosfere sono cambiate e siamo entrati prepotentemente su un terreno assolutamente originale e poco frequentato in cui è difficile distinguere le influenze che fluttuano l’una sull’altra, dall’etno al jazz propriamente detto, dal folk alla musica classica senza trascurare l’elettronica, il tutto in un contesto strutturale ben delimitato. In effetti tutti i pezzi erano costruiti allo stesso modo: una lunga introduzione affidata volta per volta ad un singolo strumento per poi lasciare il campo all’ensemble che per la maggior parte del tempo si è espresso nella formula del trio, senza Zeynal. Ed è così emersa la straordinaria figura del leader. Nato nel 1989 a Baku, in Azerbaijan, Isfar Sarabski si forma presso il Berklee College of Music di Boston, per poi vincere nel 2009 la Solo Piano Competition del Montreux Jazz Festival. Per il piccolo Isfar la musica è un elemento immediatamente familiare: il padre è un grande appassionato di musica, la madre insegna violino mentre il suo bisnonno era Huseyngulu Sarabski, figura leggendaria della musica azera. Evidentemente tutto ciò ha contribuito in maniera determinante a creare un artista assolutamente straordinario che ha voluto condividere con il pubblico romano buona parte del repertorio contenuto nel già citato album Planet; splendida la riproposizione di Clair de lune di Claude Debussy interpretata con rara delicatezza e totale partecipazione.
-

-
Isfar Sarabski
-

-
Steve Coleman Quintet
E veniamo alla serata finale del festival, il 19 scorso, con Steve Coleman alla testa dei suoi Five Elements, vale a dire Jonathan Finlayson alla tromba, Sean Rickman alla batteria, Rich Brown al basso elettrico e il rapper Kokayi con il quale Coleman collabora fin dal 1985. Illustri colleghi hanno scritto meraviglie di questo concerto, e, una tantum consentitemi di dissentire. Intendiamoci: nessuno, tanto meno chi scrive, mette in dubbio le capacità di Coleman che in tutti questi anni ha dato prova di essere un grande artista; nessuno contesta la sua abilità nel rifarsi a musiche dell’Africa occidentale e dell’Asia meridionale; nessuno nega la sua profonda conoscenza della cd. “street culture”. Ma tutto ciò produce un certo tipo di musica che non trova il mio personalissimo interesse: non mi trascina (tutt’altro) la ripetizione per parecchi minuti dello stesso frammento melodico, non mi appassiona la matericità della sua musica, non mi convincono gli interventi del rapper anche perché nel passato ci sono stati esempi ben più probanti di integrazione tra jazzisti e rapper. Assolutamente apprezzabile, viceversa, il richiamo alla tradizione testimoniato dalla citazione di Confirmation, cavallo di battaglia di un certo Charlie Parker. Comunque il pubblico, non numerosissimo, ha gradito e l’esibizione è stata salutata da scroscianti applausi.
Il Festival si è così concluso con un bilancio ancora una volta largamente positivo: oltre 5000 presenze in due settimane di programmazione fra l’Auditorium, la Casa del Jazz e il Monk, con il coinvolgimento di ben 115 artisti provenienti da tutto il mondo, dagli Stati Uniti all’Azerbaigian, dalla Gran Bretagna alla Romania, passando per il Bahrain. “In tante edizioni, raramente ho visto un così grande entusiasmo del pubblico in ogni concerto, sia per gli artisti più famosi che per le novità. – Ha commentato Mario Ciampà, direttore artistico del festival. – Un pubblico trasversale, bambini, giovani e adulti che hanno voglia di buona musica e nuove proposte. Un successo che ci incoraggia a proseguire ulteriormente sulle traiettorie che hanno segnato questa edizione: il dialogo fra musica e innovazione tecnologica, il protagonismo femminile, la programmazione dedicata ai più piccoli e l’equilibrio fra i nomi storici del jazz e gli artisti più in sintonia con il gusto delle nuove generazioni come gli esponenti della nuova scena british, e non solo”
Gerlando Gatto
 Del Piano/Olivieri/Mazza/Marini, Double 3, Caligola Records
Del Piano/Olivieri/Mazza/Marini, Double 3, Caligola Records Canova Trio feat. Fulvio Sigurtà, Agata, Filibusta Records
Canova Trio feat. Fulvio Sigurtà, Agata, Filibusta Records Giovanni Benvenuti , An Hour Of Existence, AMP Music & Records
Giovanni Benvenuti , An Hour Of Existence, AMP Music & Records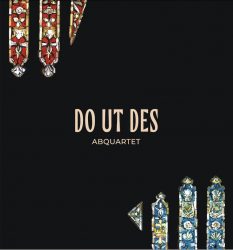 ABQuartet, Do Ut Des, Red & Blue.
ABQuartet, Do Ut Des, Red & Blue. Zhu Quartet, GINKGO, Workin’ Label.
Zhu Quartet, GINKGO, Workin’ Label. Marco Vavassori feat. Lincetto/Smiderle/Uliana, Walking with Bob, Caligola Records.
Marco Vavassori feat. Lincetto/Smiderle/Uliana, Walking with Bob, Caligola Records.














 Siccome siamo un Paese di ‘scordarelli’ non vorrei che passasse facilmente nel dimenticatoio quello che per molti musicisti, specialmente i più giovani, è stato un periodo che definire terrificante è quasi un eufemismo. Musicisti per mesi senza lavoro, senza concerti, senza serate, con pochissime occasioni di registrare, hanno dovuto faticare parecchio per uscirne fuori… È ammesso poi che ciò sia accaduto. Ecco, il mio intento era e resta quello di offrire una testimonianza di questo periodo drammatico, una testimonianza non mia ma di quanti molto più di me hanno dovuto subire questa situazione.
Siccome siamo un Paese di ‘scordarelli’ non vorrei che passasse facilmente nel dimenticatoio quello che per molti musicisti, specialmente i più giovani, è stato un periodo che definire terrificante è quasi un eufemismo. Musicisti per mesi senza lavoro, senza concerti, senza serate, con pochissime occasioni di registrare, hanno dovuto faticare parecchio per uscirne fuori… È ammesso poi che ciò sia accaduto. Ecco, il mio intento era e resta quello di offrire una testimonianza di questo periodo drammatico, una testimonianza non mia ma di quanti molto più di me hanno dovuto subire questa situazione. Wolfert Brederode – “Ruins and Remains” – ECM
Wolfert Brederode – “Ruins and Remains” – ECM Ali Gaggl – “A Piece of Art” – ATS
Ali Gaggl – “A Piece of Art” – ATS Sverre Gjørvad – “Here Comes the Sun” – Losen
Sverre Gjørvad – “Here Comes the Sun” – Losen Rolf Kristensen – “Invitation” – Losen
Rolf Kristensen – “Invitation” – Losen Maja Jaku – “Soul Searching” – ATS
Maja Jaku – “Soul Searching” – ATS Keith Jarrett – “Bordeaux Concert” – ECM
Keith Jarrett – “Bordeaux Concert” – ECM Jean-Charles Richard – “L’ètoffe des reves” – La Buissonne
Jean-Charles Richard – “L’ètoffe des reves” – La Buissonne Steve Tibbets – “Hellbound Train: An Anthology” – ECM 2CD
Steve Tibbets – “Hellbound Train: An Anthology” – ECM 2CD Margherita Porfido – “Da Gesualdo a Piccinni – Musicisti del Sud Italia dal 1500 al 1700) DiG 2 CD
Margherita Porfido – “Da Gesualdo a Piccinni – Musicisti del Sud Italia dal 1500 al 1700) DiG 2 CD Diverso il secondo CD, “Margherita’s Miniatures”, in cui la clavicembalista affronta un repertorio variegato, molto diverso dal precedente, con autori non accademici, e con l’ausilio di un artista proveniente da altri ambiti quali Pino Minafra alla tromba e al didgeridoo. Ad onta di queste discrepanze, l’album mantiene una sua ben precisa unità di fondo data dal clavicembalo della Porfido che riesce ad interpretare tutte le partiture con maestria dimostrando come anche uno strumento oggettivamente “antico” possa misurarsi con linguaggi moderni. Ecco quindi che si parte con le “Danze popolari romene di Béla Bartok per approdare a “Les fastes de la grande et ancienne MXNXSTRXNDXSX” di François Couperin, in cui si ascolta il jazzista Pino Minafra al didgeridoo. In mezzo ancora un autore classico come Erik Satie ma soprattutto esponenti della musica moderna quali Eugenio Colombo, Fred Van Hopve, Keith Tippett, Livio Minafra, Michel Godard, Daniel Pinkham, Nino Rota e Gianluigi Trovesi. Ed è proprio al confronto con questi ultimi che si manifesta in tutta la sua bravura la Porfido che riesce ad adattare il suo strumento alle necessità espressive dei vari brani senza che gli stessi perdano un’oncia dell’originario fascino. Particolarmente suggestivo “Romeo e Giulietta” di Nino Rota anche per la presenza di Pino Minafra alla tromba, musicista che, come sottolinea Ugo Sbisà nelle note che accompagnano l’album, proprio in veste di trombettista si fa desiderare oramai da lunga, troppo lunga, pezza
Diverso il secondo CD, “Margherita’s Miniatures”, in cui la clavicembalista affronta un repertorio variegato, molto diverso dal precedente, con autori non accademici, e con l’ausilio di un artista proveniente da altri ambiti quali Pino Minafra alla tromba e al didgeridoo. Ad onta di queste discrepanze, l’album mantiene una sua ben precisa unità di fondo data dal clavicembalo della Porfido che riesce ad interpretare tutte le partiture con maestria dimostrando come anche uno strumento oggettivamente “antico” possa misurarsi con linguaggi moderni. Ecco quindi che si parte con le “Danze popolari romene di Béla Bartok per approdare a “Les fastes de la grande et ancienne MXNXSTRXNDXSX” di François Couperin, in cui si ascolta il jazzista Pino Minafra al didgeridoo. In mezzo ancora un autore classico come Erik Satie ma soprattutto esponenti della musica moderna quali Eugenio Colombo, Fred Van Hopve, Keith Tippett, Livio Minafra, Michel Godard, Daniel Pinkham, Nino Rota e Gianluigi Trovesi. Ed è proprio al confronto con questi ultimi che si manifesta in tutta la sua bravura la Porfido che riesce ad adattare il suo strumento alle necessità espressive dei vari brani senza che gli stessi perdano un’oncia dell’originario fascino. Particolarmente suggestivo “Romeo e Giulietta” di Nino Rota anche per la presenza di Pino Minafra alla tromba, musicista che, come sottolinea Ugo Sbisà nelle note che accompagnano l’album, proprio in veste di trombettista si fa desiderare oramai da lunga, troppo lunga, pezza Valentin Silvestrov – Maidan – ECM
Valentin Silvestrov – Maidan – ECM







