da Beniamino Gatto | 16/Feb/2024 | Eventi, News, Primo piano, Recensioni
Dopo un’attesa di circa due mesi e mezzo, la fortunata serie L’Altra Metà del Jazz, a cura di Gerlando Gatto, è ricominciata alla Casa del Jazz con due valide artiste: la pianista Cinzia Gizzi e l’arpista e vocalist Noemi Nuti.
La prima parte della serata è dedicata appunto a Cinzia Gizzi, la cui intervista inizia con una riflessione sull’assenza del canto jazz nel Festival della Canzone Italiana di Sanremo, conclusosi pochi giorni prima dell’evento: riflessione da cui scaturisce l’amara considerazione di un confinamento del jazz in certe nicchie e ambienti definiti, nonostante l’attuale tendenza alla contaminazione tra generi.
-

-
Cinzia Gizzi, Gerlando Gatto
-

-
Cinzia Gizzi, Gerlando Gatto
Parla poi della sua carriera: partendo dal primo incontro con la musica che avvenne per caso durante i suoi studi universitari in una facoltà impostale dalla famiglia . Ma ben presto la musica ebbe la meglio e nell’arco di poco tempo si andò delineando la personalità di una grande artista che proseguì con il suo rapporto con il piano classico, che lei definisce fondamentale per una buona formazione jazzistica ma non indispensabile. Sulla musica classica tornerà in seguito, esprimendo la sua preferenza, tra i compositori, per Bach, genio capace di donare equilibrio a chi lo ascolta. Enumera quindi alcune delle sue collaborazioni più significative e di alto profilo come Harry “Sweets” Edison, Joe Newman, Sammy Davis e Tony Scott, dei quali ricorda con grande affetto l’aspetto umano oltre a quello artistico. E si arriva così al 1988, anno della svolta per la sua carriera: sarà infatti quello l’anno in cui vincerà una borsa di studio, grazie ad una sua amica che la convinse a presentare la domanda, che la porterà negli USA, a Berkeley; Cinzia ricorda questi tempi negli Stati Uniti come duri ma molto soddisfacenti. Altri incontri e collaborazioni l’hanno segnata: nello specifico con Chet Baker, Dizzy Gillespie e in particolare Jaki Byard, con cui ha studiato metodologia a seguito di un incontro presso il Mississippi Jazz Club, allora gestito dai fratelli Toth.
Racconta poi del suo ritorno in Italia e della pubblicazione del suo primo disco Trio and Sextet, nel 1991, con la collaborazione di musicisti come Flavio Boltro alla tromba, Piero Odorici al sassofono, Giovanni Tommaso al basso, Gianni Cazzola alla batteria e Mario Migliardi al trombone, e della sua carriera didattica di cui ricorda luci e ombre: tra le prime ricorda la soddisfazione dell’insegnamento, sottolineandone tuttavia la complessità; tra le seconde illustra le difficoltà affrontate a causa di un sistema che imponeva al detentore della cattedra unica l’insegnamento di sette materie in tutto il semestre ed anche del fatto che, in quanto donna, ha dovuto dimostrare più degli altri colleghi maschi. Da questo complessivo bagaglio di esperienze le deriva la forza e la capacità di scrivere due libri dedicati agli “Arrangiatori Jazz”.
Toccando infine gli aspetti più recenti della sua carriera, ricorda il premio alla carriera vinto nel 2017 nell’ambito del Premio Internazionale Profilo Donna, grazie alla segnalazione di Patricia Adkins Chiti, e conclude con una piccola riflessione sulla quasi totale assenza di jazz nella Rai, collegandosi alla prima domanda fatta durante l’incontro da cui si evince, secondo Cinzia, che i giovani d’oggi vengono bombardati da un determinato tipo di musica, mentre dovrebbero avere la possibilità di scegliere la musica che amano e la Rai – servizio pubblico, non dimentichiamolo – dovrebbe dare modo ai suoi ascoltatori, che pagano un canone, di seguire ogni genere musicale.
Come al solito non sono mancati interventi musicali: in questo caso Cinzia è stata accompagnata dal contrabbassista Pietro Ciancaglini e dal batterista Marco Valeri, e insieme hanno suonato I Keep Love in You di Bud Powell, Subconsciously di Lee Collins e Te Vojo Bene Assaje.
-

-
Noemi Nuti, Gerlando Gatto
-

-
Noemi Nuti, Andrew McCormack, Gerlando Gatto
-

-
Noemi Nuti
Dopo il consueto intervallo di cinque minuti, la serata è ripresa con l’arpista e vocalist Noemi Nuti che purtroppo, a causa di un problema tecnico con l’arpa, si è presentata solo nelle vesti di cantante, accompagnata dall’eccellente pianista Andrew McCormack, compagno non solo sulla scena ma anche nella vita.
La vita di Noemi è caratterizzata da numerosi viaggi e contatti con diverse culture: nasce infatti a New York da famiglia italiana e ci rimane fino agli otto anni; da quel momento si trasferisce in Italia dove passerà la tarda infanzia e l’adolescenza, per poi trasferirsi a Londra, dove tuttora risiede. Già fin dall’età di otto anni Noemi inizia a studiare l’arpa, di cui si è innamorata grazie alla copertina di una rivista che la raffigurava in tutto il suo splendore; comincia quindi con lo studio dell’arpa classica e folk (soprattutto celtica) fino all’ottavo grado, ma grazie al contatto con la musica di Kurt Rosenwinkel ed Ella Fitzgerald decide di passare alla musica jazz: ed è in questo ambito che nel 2012 si diplomerà al Trinity College di Londra, studiando con insegnanti del calibro di Anita Waddell, John Hendrix e Sammie Purcell.
Nella sua musica risulta evidente un vivo interesse per la musica brasiliana, soprattutto per l’unione, da lei illustrata, tra ricchi ritmi e melodie leggere, semplici solo all’apparenza ma che in realtà nascondono una complessità disarmante: questa passione la porterà a formare una band di samba che arriverà fino al celeberrimo Carnevale di Rio de Janeiro. A proposito del Brasile, Noemi lo descrive come un posto molto particolare: un luogo isolato e un porto allo stesso tempo, contemporaneamente un melting pot e un luogo legato alla propria cultura.
Un altro luogo di cui parla con molto affetto è la sua residenza attuale, ovvero Londra: facendo un paragone tra la scena musicale londinese e quella italiana Noemi nota un attaccamento al passato e alle tradizioni molto più presente in Italia che nel Regno Unito dove, al contrario, osserva una maggiore apertura all’innovazione e attenzione da parte del governo nei confronti delle arti. Sempre a proposito del jazz inglese, descrive l’influenza subita dalla musica sudafricana e le differenze dei ritmi afro-jazz presenti nelle varie regioni del mondo: da una chiacchierata con il pianista panamense Danilo Pérez nasce una maggiore attenzione alle casse e ai bassi nelle regioni del Sud America, mentre, al contrario, una predilezione nei confronti dei piatti e delle frequenze alte nel Regno Unito; a questo proposito ha citato la cantante britannica Norma Winstone e come un suo brano, Azimuth, sia tornato alla ribalta grazie ai celebri rapper Drake e Yeat e ai produttori Bnyx e Sebastian Shah, che l’hanno campionata nel loro IDGAF, uscito nello scorso ottobre. Conclude infine il suo intervento con un ulteriore elogio nei confronti di Londra, ovvero di come la scena inglese permetta un’ottima formazione a livello professionale e di affrontare a ogni sorta di pubblico e ambiente.
I brani proposti con il pianista Andrew McCormack sono stati “For What I See,” composizione originale di Noemi contenuta nel suo disco ‘Venus Eye’ uscito nel 2020 e ispirata da “Treme Terra” di Flora Purim e Airto Moreira con Joe Farrell (il disco si chiama “Three-Way Mirror”). A questa prima, trascinante esibizione hanno fatto seguito “Disfarça e Chora” di Cartola e “I Can’t Believe You’re In Love With Me” di Jimmy McHugh, interpretato anche da Billie Holiday.
In quanto a pubblico la serata è stata un successo, facendo registrare non solo un numero di spettatori tale da riempire quasi l’intera sala ma anche un entusiasmo e un gradimento che chi vi scrive non può che condividere.
Il prossimo appuntamento è in programma martedì 20 Febbraio alle 21 con Susanna Stivali e Chiara Viola. Clicca qui per info&tickets
Beniamino Gatto
da Amedeo Furfaro | 18/Gen/2024 | I nostri CD, News, Recensioni
Tutto si può dire dell’anno che si chiude, a livello di dischi jazz, tranne che sia stato monocorde e monotono. La varietà delle proposte ha infatti caratterizzato il 2023 in modo significativo grazie a lavori spesso di bradisistica vitalità. Le recensioni che seguono ne rappresentano una possibile campionatura fra le tante proposte meritevoli. Le affidiamo alla lettura per una riflessione su quanto espresso e sui destini possibili del jazz e della musica nell’anno che verrà.
 Federica Michisanti Quartet, “Afternoons”, Parco della Musica Records.
Federica Michisanti Quartet, “Afternoons”, Parco della Musica Records.
Il quartetto di Federica Michisanti featuring il clarinettista Louis Sclavis, il violoncellista Vincent Courtois e il batterista Michele Rabbia si cimenta nell’album Afternoons edito da Parco della Musica Records. Si tratta di una formazione cameristica che “illustra” musicalmente dei pomeriggi qualunque, quelli in cui il “presto” ed il “sostenuto” del ritmo mattutino cedono il passo al “moderato” e al “lento” tardopomeridiano. La musica della Michisanti si snoda in sette composizioni che la compositrice-contrabbassista romana ha definito mostrando di aver ancor più affinato la scrittura ora arricchita dalle cromie percussive che accompagnano la sottile trama arco-fiato. Il brano introduttivo “Two” espone un groove d’avanguardia che in “Sufi Loft” si mitiga in atmosfere soffuse, armonizzanti, che paiono richiamare sfondi bergmaniani. Il successivo “Not” ha strutture più decise specie quelle ritmiche di caffeinici frattali jazz. Tenero è il “Nocturne” con la libertà ispirata dal fascino delle tenebre e dai sogni, altrettanto dicasi per “Spot” contenuto nella stessa traccia. “Be4 PM” alterna momenti melodici a surplaces dialogici, un doppio registro che si rileva nella stessa “Floating”, in conclusione. L’approccio colto-europeo non deriva solo dalla anagrafe artistica della formazione ma è il portato di un vissuto musicale comune del 4et che conduce a superare moduli interpretativi fin troppo rodati per sondare nuovi orizzonti espressivi. In definitiva un album davvero degno d’attenzione come dimostrano i prestigiosi riconoscimenti ottenuti proprio n questo periodo.
 Adriano Clemente, “The Coltrane Suite and Other Impressions”, Dodicilune Records
Adriano Clemente, “The Coltrane Suite and Other Impressions”, Dodicilune Records
In piena era jazzistica d.C. (dopo Coltrane) esce un album destinato, c’è da giurarci, a rimanere nel tempo. Vi si rievoca, del grande sassofonista neroamericano, lo Spirito fattosi Suono, la Mistica divenuta Suite. E’ il multistrumentista leccese Adriano Clemente a presentarlo con The Coltrane Suite and Other Impressions, per i tipi di Dodicilune. Giganteggia, già nel primo dei due cd, la performance del saxtenorista David Murray assieme a The Akashmani Ensemble. E furoreggia alla batteria il galvanizzante Hamid Drake, in veste di riguardevole ospite di… riguardo. Personaggio complesso da affrontare, Trane. Ma Clemente è dotto ed edotto in materia per come già fatto con Mingus con la medesima label nel 2016. Già a partire da “Mother Africa” (inizio di una tracklist con 25 sue composizioni) ne compenetra pathos e l’alfabeto sin nella prima parte del lavoro, tirando fuori, nella seconda, Impressioni nelle quali si confermano imprescindibili i membri della Akashmani, Guidolotti e Sorrentino (sax), Pirone (tr.ne), Carucci e Buccella(pf), Pierotti e Scandroglio(cb), Aiello (cong.), Lanzini (cello), Makarovic (tr.). E naturalmente svetta il direttore Clemente con i suoi dieci e passa strumenti da maneggiare a seconda della situazione musicale.
 Christian Pabst, “The Palm Tree Line”, Jazz Sick Records.
Christian Pabst, “The Palm Tree Line”, Jazz Sick Records.
Musica di dove crescono le palme. E’ il pianista tedesco Christian Pabst a compilare una sua personale playlist dedicata a suoni di quei sud da cui è da sempre affascinato nell’album The Palm Tree Line (Jazz Sick). L’attacco è “Mambo” di Bernstein, da “West Side Story”, in un’esecuzione nervosa ed al tempo stesso seducente, con il Rhodes ad accentuare un certo suo modo di sincopare e “contratemporeggiare”. Il seguente “Amarcord” nell’alternare swing a beguine schiarisce, e non di poco, la nebbia felliniana impressa sul brano restituendogli luce solare. Nel terzo pezzo, all’ottimo combo che vede Francesco Pierotti al basso e Lorenzo Brilli a batteria e percussioni, interviene al canto Ilaria Forciniti ad intonare “Amara terra mia”, di Modugno, e con lei l’altro ospite Federico Gili, con la fisarmonica a coprire gli interstizi lasciati aperti dalla voce e a ritagliarsi, così come il pianoforte, un chorus per una impro breve quanto vibrante. Proseguiamo nel raccontare, in pillole, il disco, dando conto di “Un’ora sola ti vorrei” resa con delicato lirismo condiviso nel solo del contrabbasso di verve classicheggiante. Strano accostamento subito dopo quello dell’ “Alhambra” di Lecuona e, a marca Bongusto-Trovajoli di “‘O cielo ce manna ste cose”, a riprova di quanto possano essere vicine Granada e Napoli, accomunabili dalla musica oltre che dalla macchia mediterranea che arriva dalla Campania all’Andalusia. Alla fine, appena eseguita una tenera “Dèjame Llorar” di Oteo, Pabst offre un proprio acquerello sulla tastiera del “Tramonto”, per due minuti di tratteggio, andante per sensazioni sonore, del crepuscolo del sole che si addormenta.
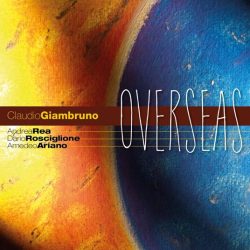 Claudio Giambruno, “Overseas”, Via Veneto Jazz
Claudio Giambruno, “Overseas”, Via Veneto Jazz
Swing, bebop, modale, jazz samba e tutto quanto ne è seguito con i relativi adeguamenti di grammatica, sintassi, vocabolario alle successive tendenze stilistiche. Claudio Giambruno è sassofonista che li ha conformate coniugandole alla propria sensibilità latina in Overseas (Via Veneto Jazz-Millesuoni). Nell’album parte innescando una marcia neohardbop alquanto light – e non è un ossimoro – essendo ciò dovuto alle due fonti “over seas” che avvicinano Mediterraneo ad Atlantico e Pacifico per addolcirsi poi in ballad ed evergreen come “ ‘Na voce ‘na chitarra e ‘o poco e ‘luna”. Nella traversata gli sono accanto il pianista Andrea Rea, il contrabbassista Dario Rosciglione e il batterista Amedeo Ariano, band di cui Seamus Blake ha elogiato il repertorio dalla modalità “thrilling and soulfull”, emozionante e pieno d’anima, declinata in nove fra standards ed originals. In questi ultimi si denota anche una netta autorialità di Giambruno, jazzista che non rinnega la tradizione semmai se ne serve come spioncino per scrutare nel futuro.
 Two Things of Gold, A.Ma Records
Two Things of Gold, A.Ma Records
Un duo, quello formato dalla vocalist Francesca Sortino e dal produttore dj romano nonché figlio della vocalist Diego Lombardo, che nell’album Two Things of Gold (A.Ma), perfeziona un originale confronto, su basi elettroniche, fra jazz e house – funk – soul in un lavoro inciso su ideale supporto di l. P. . Ne scaturiscono 14 tracce delle quali tre squisitamente jazzistiche – “Con Alma” di Gillespie, “Malachi” di Hill e “Where Flamingos Fly” successo di Gil Evans – con decollo da una piattaforma di musica internazionale per planare su lidi sonori e canori dinamici spazianti da toni duri a timbriche calate su linee melodiche più morbide nei passaggi di climax. Della Sortino è da rimarcare il desiderio di cimentarsi “atipicamente” rispetto a certe aspettative che vorrebbero le voci femminili jazz impegnarsi nella riproposizione dei capisaldi della materia o al massimo nell’esecuzione di originals che a quella tradizione si ispirano. L’affiancarsi a un giovane musicista come Lombardo dalle visioni innovative e rampanti risulta vincente. Da segnalare nella produzione gli ospiti Roberto Rossi, Alessandro Maiorino, Alberto Parmegiani, Mauro Beggio, Pierpaolo Bisogno.
 Minimal Klezmer, “Öt Minusz Kettò”, Caligola Records
Minimal Klezmer, “Öt Minusz Kettò”, Caligola Records
Album n. 3 (campeggia la sottrazione 5-2 all’interno della cover) per i Minimal Klezmer, al secolo Francesco Socal (cl.sax), Roberto Durante (keys, pf, acc.), Enrico Milani (cello), Pietro Pontini (v. viola) con Matteo Minotto al basson e percussioni. Il collettivo nato a Londra nel 2011 presenta Öt Minusz Kettò. prodotto unitamente a Caligola Records e presentato da Martin Tesnone. La musica ivi contenuta si rifà alla tradizione ebraica e dei paesi dell’Est (Romania, Russia, Anatolia , Grecia) nonché gitana. Ed in effetti i tredici brani, di cui quattro traditional, hanno in comune uno spirito yiddish errante che li porta a di/vagare fino al jazz. E’ questo elemento di fusione (non diciamo contaminazione) che caratterizza alquanto il gruppo e ne arricchisce il sound di componenti, come l’improvvisazione, che ci impediscono di catalogare il lavoro come etnomusicale sic et simpliciter . Ciò anche se la loro è a pieno titolo musica klezmer, genere musicale diffusosi anche grazie ad un duraturo revival, così pimpante di strumenti, scoppiettante di note che sprizzano melodia da tutti i pori, fra introversa meditazione e scena estroversa.
 Remedio, “Semillas”, Gutenberg Music.
Remedio, “Semillas”, Gutenberg Music.
Un “Real book” ispanomericano non potrebbe che annoverare, ab initio, miti iconici come il pajador argentino Atahualpa Yupanqui e la cantatrice cilena Violeta Parra. Hanno provato a inciderne una versione aggiornata i Remedio – Laura Vigilante (v.), David Beltran Soto Chero (chit. cuatro charango), Alberto Zuanon (cb), ospite Sergio Marchesini alla fisa – includendovi brani dello spagnolo Carlos Cano (Maria la portuguesa), della messicana Natalia Lafourcade (Hasta la raiz), di Manuel Raygada Ballesteros (Mechita), peruviano come Ramòn Ayala (El cosec hero), degli argentini Facundo Cabral (No soy de aqui ni soy de allà) e Natalia Doco (Respira), della statunitense Llhasa de Sela (El desierto), della band uruguagia Onda Vaga (Mambeado, Tataralì), del colombiano Gentil Montana (Porro). L’album Semillas che risulta dalla selezione, un lavoro “accalorato” anche dalla presa diretta della registrazione effettuata live al Piccolo Teatro Tom Benetollo di Padova, offre, della terra dei nostri cugini d’America, un “canto para una semilla” anzi semillas lanciate a mano aperta su quel terreno fertile da cui i musicisti hanno raccolto straordinari frutti liric-musicali. P.S. Di Yupanqui è eseguita “Luna tucumana”. Della Parra “La jardinera”.
 Gloria Trapani / Alessandro Del Signore, “InControVoce”, Filibusta Records
Gloria Trapani / Alessandro Del Signore, “InControVoce”, Filibusta Records
Ci sono voci il cui canto abbisogna di un tappeto orchestrale su cui guizzare. E ci sono ugole che, al contrario, si esaltano quando l’ambiente sonoro che le circonda è essenziale, secco, minimale. E’ il caso di Gloria Trapani che, nell’album InControVoce edito da Filibusta, si lascia accompagnare da basso e contrabbasso da Alessandro Del Signore in “clusters” di brani latini (“Vocè E Linda”, “Mais Clara Mais Crua”), standard di jazz classico e moderno (“Summertime”, “Nature Boy”, “In Walked Bud”), hits pop e caraibici (“Humane Nature”, “Redemption Song”). Fra un vocalizzo ed un altro emerge l’attitudine della voce ad elasticizzarsi smorzando, misurando altisonanza ed estensione e nel contempo lavorando di cesello su melismi e fioriture nonché sulla felpatura di timbro e smalto vocale. Del Signore si rivela dal canto suo jazzista a proprio agio nel ruolo, attento a non infrangere il “muro” del suono nel senso di non spaccare mai con tocchi eccessivi o fuori posto la magia costruita dal duo sul preesistente silenzio.
 Pietro Ciancaglini, “Consecutio”, GleAm Records
Pietro Ciancaglini, “Consecutio”, GleAm Records
Si va bene ma la consecutio temporum? Eccolo lì il tallone d’Achille di tanti che scrivono usando male i verbi. In musica, a voler fare un parallelo, la mancata concordanza fra principali e subordinate ha mietuto diverse vittime. Meno male che anche nel jazz ci sono maestri del coordinare secondo conseguenzialità logico-lineare un discorso musicale “corretto”. Sono, queste, delle considerazioni applicabili al nuovo album del bassista e contrabbassista Pietro Ciancaglini dal titolo Consecutio. Il lavoro, edito GleAM Records, con dieci sue composizioni, è un esempio di come il jazz debba saper coniugare le frasi che “pronuncia”. In tale operazione l’uso del basso elettrico da parte del musicista romano, al posto del contrabbasso, orienta l’approccio stilistico verso raffinate prospettive elettriche di fusion(e) fra hard bop e contemporary senza lasciarsi peraltro stregare da ammiccamenti mainstream. Il risultato più che apprezzabile è anche merito del pianista-tastierista Pietro Lussu, del batterista Armando Sciommeri e della vocalist Chiara Orlando. Le improvvisazioni, peraltro ben presenti, sono coerenti al tutto, e così le linee melodiche sono installate su armonizzazioni ricche e raffinate. E soprattutto “conseguenti”.
 Haiku, Sun Village Records
Haiku, Sun Village Records
Haiku, la forma poetica giapponese adottata da Rilke, Eluard e da poeti ermetisti, è anche il gruppo di jazz-funk italiano che licenzia l’ album omonimo per Sun Village Records. Trattasi di un 5et ben assortito, che annovera Federico ‘Privi” Privitera a tromba e piano elettrico, Andrea Salvato a flauto e sinth, Costanza “Skalli” Bortolotti alla chitarra, Vyasa Basili al basso e Alessandro Della Lunga alla batteria, capace di invenzioni che vanno dirette all’ orecchio dunque nient’affatto ermetiche. Il riferimento al format nipponico al riguardo andrebbe visto come tendenza alla sintesi, alla enunciazione breve non logorroica neanche nelle impro. Certo è che le otto tracce per una mezz’ora di musica del disco si sviluppano vischiosamente, col flauto che “inalbera” pindaricamente le note più alte, le tastiere lì a “strattonare” la sezione ritmica, la tromba pronta ad acute proiezioni liriche, la chitarra protesa ad imbellettare di riverberamenti il tutto.
 Nicole Johänntgen, “Labirinth”, Selmabid Records.
Nicole Johänntgen, “Labirinth”, Selmabid Records.
Gran bell’album Labirinth della sassofonista Nicole Johänntgen edito da Selmabird Records (Suisa)! Peraltro adatto a più palati musicali compresi quelli che adorano il funky e comunque i generi che abbiano una propulsione perloquale. Affidata in questo caso alla tuba di Jon Hansen ed alle percussioni di David Stauffacher, caricati del compito di dare adeguato sostegno ritmico a dieci brani. Vi svettano, come fra le montagne, gli alto e soprano della leader dalla bella voce blues ascoltabile in “Canyon wind”, il tutto arricchito dall’ospite Victor Hege al sousaphone in “Simplicity Curiosity” e “Straight Blues Baby Straight”. Nel labirinto della jazzista non è difficile muoversi, basta tenere stretto il filo d’Arianna disteso dal sax per essere condotti nel suo mondo dorato, un inno alla gioia del fare musica da proporre Coram populo affinché altri possano a loro volta appropriarsene.
 Gaetano Duca, “Bugiardi”, Abeat Records
Gaetano Duca, “Bugiardi”, Abeat Records
Lounge? No! Semmai è uno smooth dai sapori funk-fusion il jazz che propone il chitarrista Gaetano Duca nell’album Bugiardi (Abeat Records).
Un tocco, il suo, che apparirebbe bensoniano se non fosse per il fraseggio personale della propria “longa manus” esecutiva.
Il jazz “musica bugiarda”, lo diceva un suo vecchio maestro. Ma qui il riferimento si allarga all’epoca in cui viviamo, in cui si coltivano disvalori e illusorietà.
Dunque il titolo del disco va visto come un incipit, un’introduzione a… Anche perché siamo sinceri, le sue 11 “bugie” musicali sono vero jazz, E i Bugiardi, gli altrettanti brani numerati scaletta, non mentono sullo stato di salute di tale genere musicale, che è florido, nonostante tutto, e ne rappresentano una possibile cartina di tornasole. Se si considera poi la componente “etnea” insieme alla napoletanità acquisita dal leader siculo il mix appare “vulcanico”. Il risultato è merito anche dei Friends di Duca: Dario Paolo Picone (k.), Gaetano Diodato (b.), Mario Nasello (cb), Vittorio Riva e Santino Montesano (v.), Nico Roccamo (dr), EnzoTamburello (sax), Filippo/Piscitello (t.), Tonino Piscitello (t.ne).
Amedeo Furfaro
da Beniamino Gatto | 01/Dic/2023 | Eventi, I nostri Eventi, News, Primo piano, Recensioni
Dopo poco più di un mese di prolifiche serate, in cui il nostro direttore Gerlando Gatto, insieme alle sue ospiti, ha esplorato la situazione del jazz femminile in Italia, la serie L’Altra Metà del Jazz volge al termine, non prima però di aver regalato al pubblico un’ultima interessante serata, con una particolarità per quanto riguarda le due artiste: entrambe infatti sono state incoraggiate nella loro carriera musicale dallo stesso Gatto.
La prima parte è dedicata alla pianista calabrese, compositrice, arrangiatrice, didatta Stefania Tallini, impossibilitata suo malgrado a suonare dal vivo a causa di un infortunio ed ergo unica artista a presentare solo brani registrati, cosa di cui Stefania non manca di mostrare il proprio rammarico durante l’intervista. Intervista che parte appunto dalle origini del rapporto della pianista con il jazz, da ritrovare in un disco di Chet Baker ascoltato all’età di 17 anni, e che va in seguito a toccare il rapporto della musicista con le altre sfere artistiche di sua competenza, prima fra tutte la musica brasiliana. Da questo complesso universo musicale, la Tallini confessa di essere stata influenzata principalmente da Antônio Carlos “Tom” Jobim, per quanto riguarda la composizione e l’interpretazione pianistica e, altro universo di riferimento, dalla musica classica, ambito che la Tallini ha proficuamente frequentato, descrivendoli come “vasi comunicanti”, senza alcuna gerarchia tra i generi: in tal modo si rievoca il filo rosso che ha inconsapevolmente percorso tutte le artiste intervistate, ovvero quello del superamento di una concezione gerarchica tra generi musicali e di una sempre maggiore apertura alla contaminazione.
-

-
Stefania Tallini, Gerlando Gatto
-

-
Stefania Tallini, Gerlando Gatto
-

-
Stefania Tallini, Gerlando Gatto
-

-
Stefania Tallini, Gerlando Gatto
Tornando al Jazz propriamente detto, la conversazione va a vertere sul rapporto della musicista con gli standard jazzistici, e a questo proposito lei sottolinea l’anomalia del suo percorso rispetto a quello che è il canone accettato: lei prima inizia a suonare e comporre la propria musica e solo in seguito si dedica all’esecuzione degli standard, ma con il suo stile – non per presunzione, ci tiene a specificare, ma per una sua precisa esigenza espressiva; inoltre, Stefania ne approfitta per raccontare anche un aspetto più intimo di questo percorso, ovvero un costante senso di inadeguatezza che l’ha perseguitata per gran parte della sua carriera, fino a quando non ha imparato a considerare questa sua anomalia di percorso come il suo punto di forza. Parlando appunto della sua opera, il suo modus componendi è molto incentrato su un’improvvisazione del tutto libera, al contrario di quella che potrebbe essere quella in un pezzo jazz, legata inevitabilmente a schemi ritmici o giri armonici: è appunto in questa libera ed istintiva esplorazione del panorama sonoro che la Tallini trova ispirazione, comunque lontana da ispirazioni riconducibili alla corrente del free jazz.
L’intervista si conclude toccando altri due aspetti di Stefania: quello didattico, da insegnante, in cui esprime un quadro desolante per le generazioni presenti, ovvero una mancanza totale di sogni e aspirazioni per il futuro, ma al contempo non manca di precisare il suo orgoglio per i successi dei suoi alunni, e quello da esecutrice: parla infatti della sua formazione preferita al momento, ovvero il duo, che lei definisce terreno di scoperta continua e zenit del rapporto, della libertà e del dialogo. Al riguardo non si trova d’accordo con Gatto il quale ritiene che per suonare bene in duo occorre conoscersi bene; “Io – ribatte la Tallini, presentando la sua esperienza con il flautista spagnolo Jorge Pardo – nonostante non ci conoscessimo, siamo riusciti ad instaurare da subito una profonda sintonia”. Infine, rivela il suo sogno nel cassetto, ovvero poter registrare un progetto con una grande orchestra di archi.
I brani che come al solito hanno accompagnato l’intervista sono stati Riotango, tratto dall’album Brasita (2022) e registrato in collaborazione con i brasiliani Daniel Grossi all’armonica e Jaques Morelenbaum al violoncello, Silent Moon tratto dall’album E Se Domani (2023) registrato in collaborazione con il trombettista Franco Piana, presente peraltro in sala, e Uneven, estratto dall’album omonimo del quale purtroppo lamenta la mancata promozione a causa della pandemia e registrato in trio con il batterista Gregory Hutchinson e il contrabbassista Matteo Bortone.
-

-
Federica Michisanti, Simone Maggio, Gerlando Gatto
-

-
Federica Michisanti
-

-
Federica Michisanti, Simone Maggio
Nel secondo tempo a calcare il palco è stata la contrabbassista Federica Michisanti, che si avvicina al mondo del jazz anche lei in un secondo momento: partendo da origini più legate al progressive rock dei Led Zeppelin, dei Genesis e di Sting (con il quale, tra l’altro, ha confessato di voler collaborare come sogno nel cassetto); conosce il jazz quando, a 20 anni, inizia a suonare il basso elettrico in un gruppo di progressive rock. Ma allora come mai si è fatta conoscere, e si è presentata sul palco, come contrabbassista? La risposta la può dare il pianista Stefano Sabatini, suo insegnante, che l’ha convinta a studiare anche il contrabbasso, strada che le ha portato molta fortuna, non abbandonando mai tuttavia il basso elettrico. “Presentando” lo strumento che ha portato sul palco della Casa del Jazz”, Federica ha spiegato come lo stesso abbia un manico più lungo di quello che sarebbero le dimensioni standard in quanto ricavato da uno strumento tirolese di fine 800, e di avere un’anomalia nell’ultima nota di questo manico – anomalia sistemata dopo un intervento da parte di un liutaio.
Inoltre ha parlato della sua passione per il disegno, tanto da essere convinta di voler fare la disegnatrice fino ai 20 anni – e a chi vi scrive non può non venire in mente, riguardo al rapporto tra musica e arti visive, l’esempio del fumettista e disegnatore Jamie Hewlett, membro fondatore insieme a Damon Albarn dei Gorillaz, affermati da ormai più di due decenni come una delle realtà più influenti dell’hip hop alternativo.
Riguardo alla domanda sulle difficoltà riscontrate dalla Michisanti in ambiente jazz in quanto donna, lei racconta da una parte di un ambiente ancora non del tutto sviluppato in questo senso, dall’altra però ci tiene a specificare il fatto che è una situazione che cambia radicalmente da persona a persona.
Parlando di come lei stia vivendo la sua situazione attuale, nella quale viene molto apprezzata sia da pubblico che da critica, la musicista riferisce da parte sua una visione di questo momento come uno sprone a fare sempre meglio e a suonare sempre meglio: per quanto riguarda il suo modo di suonare, lei riferisce che all’inizio si esibiva in trio con il pianista Simone Maggio, che peraltro l’ha accompagnata durante la serata, e il batterista Rosario de Martino, ma che a seguito – purtroppo – della morte di quest’ultimo ha iniziato a suonare accompagnata dal sassofonista Emanuele Melisurgo, e da questo sodalizio è nata una predilezione da parte di Federica per una formazione a tre senza batteria, mancanza alla quale rimedia molte volte, in quanto a scansione ritmica, il piano di Maggio. Riguardo alle sue influenze lei cita tra i classici Chopin, Beethoven, Debussy, Stravinsky e la scuola austriaca, mentre tra i musicisti jazz mostra un’ammirazione particolare per Scott LaFaro, Gary Peacock e Dave Holland. Parlando invece della sua composizione, illustra un aspetto che la accomuna alla collega che l’ha preceduta sul palco, ovvero il basare le sue composizioni su improvvisazioni al pianoforte, aiutate nel suo caso da un programma musicale per avere un’anteprima sul risultato finale complessivo; per quanto riguarda la sua identità di ascoltatrice confessa invece che a colpirla sono soprattutto le dinamiche e fa inoltre notare come il contrabbasso, nonostante la sua sottovalutazione negli arrangiamenti complessivi, serva come vero e proprio collante tra le varie frequenze. Infine racconta della sua esperienza con Ornella Vanoni e di come la Signora sia riuscita, nonostante una frattura al femore e le raccomandazioni dei suoi medici, a portare avanti il suo tour (non a caso Federica la definisce “un’eroina”).
I brani suonati da Federica e Simone sono stati Before I Go e Reset, tratti entrambi dall’album Isk (2017), e infine un medley tra Qalb – Il verde, tratto da Jeux de Couleurs (2020), e Floathing (2023).
Beniamino Gatto
da Marina Tuni | 26/Nov/2023 | Eventi, I nostri Eventi, News, Primo piano, Recensioni
Il penultimo appuntamento della serie “L’altra metà del Jazz” si è tenuto lunedì 20 novembre in concomitanza con la partita di qualificazioni della Nazionale contro l’Ucraina, evento che però non ha impedito alla sala di gremirsi di interessati e attenti spettatori.
Calcisticamente parlando, il primo tempo della serata ha visto protagonista la cantante Marilena Paradisi, accompagnata dal pianista cosentino Carlo Manna, di cui non ha mancato più volte (a ragione! N.d.A) di tessere le lodi.
Analizzando le ospiti di questi incontri, Marilena può essere considerata una figura atipica sotto alcuni aspetti: innanzitutto la sua formazione di musicista jazz, avvenuta più tardi rispetto a molte altre artiste, dal momento che lei aveva intrapreso la carriera di ballerina di danza contemporanea; poi, a seguito di un viaggio a New York e all’ascolto di numerosi dischi di musica jazz, primo tra tutti Ballads di John Coltrane, arriva il colpo di fulmine e l’innamoramento verso questo genere. Una volta rientrata a Roma, prende per cinque anni lezioni di canto dalla cantante lirica Fausta Coppetti Corti: «l’unica capace di tirarmi fuori la voce!» – dichiara Marilena.
Altro aspetto di discontinuità rispetto alle ospiti precedenti è l’aver preferito iniziare la serata cantando e non già rispondendo alle domande di Gatto, perché cantare, dice, le dà energia, quell’energia creativa che in qualche modo temeva di disperdere se prima avesse dovuto parlare.
La serata, dopo i saluti del direttore della Casa del Jazz, Luciano Linzi e l’introduzione di Gerlando Gatto, inizia con la Paradisi, accompagnata al piano dall’ottimo Carlo Manna (una vera scoperta!), che intona la dolcissima ballad di McCoy Tyner You Taught My Heart to Sing declinata in riverberi di scat e vocalese.
C’è da dire che, al di là di questo inizio classico, la principale cifra stilistica della Paradisi è l’aver improntato gran parte della sua opera musicale sulla sperimentazione e sulla pura improvvisazione; in particolare Marilena ha raccontato della sua esperienza con la soprano nipponica (dalla timbrica eccezionale) Michiko Hirayama, icona del canto contemporaneo (nota anche per il suo stretto legame artistico con Giacinto Scelsi) e della registrazione congiunta del disco Prelude for Voice and Silence (2011): quasi un’ora di pura improvvisazione vocale e di geniali “silenzi sonori”, in cui, dato curioso, la Hirayama, alora ottantottenne, avrebbe dovuto partecipare solo a due tracce delle 34 registrate e delle 22 selezionate mentre in realtà è presente in otto.
Alla domanda del critico su quali siano stati i suoi riferimenti jazzistici, Paradisi non ha esitazione alcuna ad indicare Chet Baker, nella sua veste di cantante e non solo come trombettista, che collega ad Hellen Merril, due voci bianche caratterizzate dallo stesso minimalismo vocale. Di Chet, Marilena dice: «suona la voce come la tromba…».
La cantante ha poi illustrato la registrazione del disco The Cave (2013), realizzato in collaborazione con il percussionista Ivan Macera. Registrato all’interno del Teatro Il Cantiere di Roma, il disco è ispirato ad un articolo del musicologo Iégor Reznikoff che disquisiva sulla correlazione tra le pitture rupestri presenti nelle caverne preistoriche e la risonanza sonora; l’intenzione dell’album è appunto quella di trasportare l’ascoltatore in un’immaginaria caverna paleolitica dove ogni suono viene microfonato e amplificato. Un accenno anche al suo disco di improvvisazione testuale inciso con la pianista Stefania Tallini (peraltro ospite della prossima e ultima serata di mercoledì 29 novembre, N.d.A. – info qui). Paradisi spiega che improvvisare parole è un esercizio di “scavo” e definisce il suo metodo come piccoli momenti poetici, assimilabili a haiku giapponesi.
Infine, ricorda con particolare affetto la sua collaborazione con Eliot Zigmund, batterista di Bill Evans, nata da una mail mandata da Marilena al musicista americano, dalla quale la vocalist non si sarebbe mai aspettata una risposta, tantomeno positiva, e da cui, dopo un lavoro di organizzazione da parte della cantante durato circa quattro mesi, ha avuto origine il disco I’ll Never Be The Same (2002): di Zigmund ricorda soprattutto la generosità e il rispetto per le tradizioni che il batterista le ha saputo tramandare.
Dopo la citata You Taught my Heart to Sing, Marilena Paradisi è passata a Passion Dance sempre di Tyner e ad una stupefacente versione di Lawns – un omaggio alla grande Carla Bley – venuta a mancare recentemente – in una versione con l’arrangiamento vocale composto dalla stessa Paradisi, per finire con Would You Believe di Cy Coleman, brano reso famoso da Carmen McRae.
Nel secondo tempo della bella serata, al contrario degli attaccanti azzurri, la cantante e chitarrista molisana Erika Petti non ha mancato l’occasione avuta per presentarsi! L’intervista inizia parlando della sua formazione musicale e del fatto di essere cresciuta in una famiglia di musicisti: il padre è un trombettista, il fratello un fisarmonicista e la sorella pianista. Erika studia chitarra classica al conservatorio ma in realtà, per un periodo, la sua carriera musicale passa in secondo piano in favore dei suoi studi universitari e della sua laurea in lettere: la Petti ci confessa infatti che se non avesse scelto la musica probabilmente avrebbe studiato filologia medioevale. Così non è andata, per nostra fortuna, ed Erika intraprende un percorso di studi biennale con la cantante e didatta di grande valore Carla Marcotulli.
In merito alla sua musica, descrive il suo genere come un jazz contaminato da influenze derivanti da vari stilemi come il pop, la bossa nova, il samba e la canzone italiana, primo tra tutti Pino Daniele, del quale la musicista apprezza la vis compositiva in primis e le lunghe linee melodiche. A onor del vero, Erika cita tra i suoi riferimenti musicali, come esempi di contaminazione, anche gli Earth, Wind&Fire… e come darle torto? Queste caratteristiche appaiono evidenti nel suo album Sophisticated uscito proprio in questi giorni, un omaggio a grandi compositori quali Duke Ellington, Michel Legrand e Burt Bacharach, scomparso a febbraio di quest’anno. Parlando di queste commistioni, Erika enuncia quello che inconsapevolmente è diventato il filo rosso che collega tutte le musiciste invitate a queste serate, ovvero un unico tipo di distinzione tra buona e scarsa musica, senza discriminazione tra generi.
Inoltre, parlando dell’annoso tema delle difficoltà incontrate da una jazzista donna in un ambiente prevalentemente maschile, Erika racconta di aver incontrato alcuni ostacoli: tra questi l’impossibilità di suonare nella banda del suo paese natale in quanto donna, la sorpresa, da parte di alcuni, nel notare che la persona dietro ad un’abile esecuzione sia una donna e il fatto che in certi ambienti si sia ritrovata a dover citare uomini per qualificare un determinato ambiente di provenienza. E su questo postulato, la vostra redattrice rabbrividisce sdegnata… perché anche basta!
Infine, alla domanda postale da Gatto sullo stato della musica pop attuale in Italia, lei risponde invitando il pubblico a riflettere su come l’industria discografica possa influire pesantemente, per mere esigenze del mercato musicale, a conformare l’opera dei musicisti, a volte stravolgendola per adeguarla senza remore ai trend del momento…
I brani eseguiti dalla Petti, sono stati: Close To You di Bacharach in versione chitarra e voce e, nel celeberrimo riff finale, cantata anche dal pubblico in sala, e due pezzi di sua composizione, suonati insieme al pianista Pietro Caroleo: Amar y Vivir, con testo del poeta e cantante venezuelano José Carlos Morgana (accompagnandosi anche alla chitarra) ed E Tornerai, stavolta solo piano e voce.
Marina Tuni
ℹ️ INFO UTILI:
Casa del Jazz – Viale di Porta Ardeatina 55 – Roma
tel. 0680241281 –
La biglietteria è aperta al pubblico nei giorni di spettacolo dalle ore 19:00 fino a 40 minuti dopo l’inizio degli eventi
da Redazione | 18/Nov/2023 | I nostri Eventi, Interviste, News, Primo piano, Recensioni
Dopo una settimana di stop, mercoledì 15 novembre il nostro direttore Gerlando Gatto è tornato alla “Casa del Jazz” per il quarto appuntamento della sua serie L’altra metà del jJzz, in una sala particolarmente gremita, un po’ come avveniva nel lontano 2012 con le sue Guide all’Ascolto.
La prima ospite della serata è stata la rinomata pianista Rita Marcotulli, legata a Gatto da uno stretto rapporto di amicizia che dura ormai da più di mezzo secolo, quando il comune amico Mandrake, al secolo Ivanir do Nascimento, presentò al giornalista una giovanissima ma talentuosa Marcotulli; tanto talentuosa da venir chiamata già da giovane in tour con musicisti del calibro di Billy Cobham e Dewey Redman. Buona parte dell’intervista è stata costituita da un lungo excursus sulla sua vita e le sue opere: da un’infanzia vissuta a contatto con titani della musica e del cinema come Nino Rota, Ennio Morricone o Roman Polanski, grazie al lavoro di tecnico del suono del padre, alla sua carriera, ricca di soddisfazioni: infatti oltre ai tour con i già citati Redman e Cobham, si possono annoverare alcuni sodalizi con artisti italiani del calibro di Francesco de Gregori, Pino Daniele o Eugenio Bennato, la composizione della colonna sonora del film Basilicata Coast to Coast (2010) di e con Rocco Papaleo e la vittoria del David di Donatello come migliore musicista per il lavoro svolto in questo film (peraltro, prima donna a ricevere questo riconoscimento sin dalla sua istituzione nel 1975), il suo lavoro di rappresentanza dell’Italia a livello internazionale e il conferimento delle onorificenze di Ufficiale della Repubblica Italiana e Membro della Royal Swedish Academy of Music. Parlando della sua carriera, Rita non manca mai di sottolineare l’importanza di ogni singola esperienza vissuta: dallo stile cromatico di Redman al Jazz Rock/pop di Cobham, dalla musica leggera di Bennato e De Gregori a quella di Daniele: queste esperienze l’hanno aiutata a sviluppare una linea di pensiero per quanto riguarda i generi musicali non dissimile da quella espressa da altre musiciste nelle scorse puntate; infatti si schiera apertamente contro quello che lei chiama “snobismo” tra generi musicali, e propone invece solo un tipo di distinzione: quella tra buona musica e musica scarsa. Da questa affermazione si è aperto un dibattito sullo stato attuale della musica pop in Italia, e in questo caso Rita propone una riflessione applicabile alla musica, ma ad ogni genere di arte: in fin dei conti, i veri vincitori alla prova del tempo sono coloro che hanno il coraggio di innovare e di avere una propria originalità; pensiero condiviso appieno da chi scrive.
Infine il discorso è stato intervallato, come al solito, da tre brani straordinari composti dalla stessa Marcotulli: All Together, dedicata ad un amico che quella sera compiva gli anni, Indaco, e The Way It Is.
-

-
Rita Marcotulli, Gerlando Gatto
-

-
Rita Marcotulli, Gerlando Gatto
-

-
Gerlando Gatto
***
La seconda parte è stata dedicata all’arpista e cantante esordiente Ottavia Rinaldi, che racconta del suo percorso musicale: partendo dalla Sicilia (per la precisione da Messina) terra di origine della musicista dove ha sviluppato sin dall’età di sette anni e mezzo una passione per l’arpa, si è trasferita prima a Monopoli, poi a Como, e poi a Parma dove ha conseguito il master di II livello nello studio dell’arpa classica e jazz. Per diversi anni frequenta il corso di alto perfezionamento jazz presso la Filarmonica di Villadossola con Ramberto Ciammarughi verso il quale la Rinaldi ha parole di sincera stima e gratitudine per tutto ciò che le ha trasmesso nell’ambito del jazz.
-

-
Ottavia Rinaldi, Gerlando Gatto
-

-
Ottavia Rinaldi, Gerlando Gatto
-

-
Ottavia Rinaldi
Nel suo discorso Ottavia pone molto l’accento sul gusto di suonare insieme agli altri in orchestra: motivo per il quale non ha ancora sviluppato un progetto in solitaria, andando in controtendenza rispetto alla stragrande maggioranza degli arpisti jazz – e proprio in quanto arpista la Rinaldi riferisce di aver affrontato le maggiori sfide, soprattutto per quanto riguarda una mentalità a suo dire chiusa nell’ambiente musicale nei confronti degli arpisti. Dopo aver parlato di sé come musicista, Ottavia racconta del suo primo album Kronos, pubblicato da Alfa Music, contenente sette brani autografi ed la riarmonizzazione di uno standard (“Like Someone in Love” di Jimmy Van Heusen); da questo album sono tratti i tre pezzi che hanno intervallato la serata (in ordine Kronos a metà, Valzer delle Anime e Ciatu, unico brano cantato dei tre). L’album, uscito proprio in questi giorni, vede come protagonista l’HarpBeat Trio, costituito per l’appunto dalla Rinaldi all’arpa e canto, Carlo Bavetta al contrabbasso e Andrea Varolo alla batteria. Il trio evidenzia una notevole dose di empatia e non poteva essere altrimenti dato che i tre collaborano assieme sin dal 2017. Infine, si apre un dibattito sull’importanza dell’improvvisazione e sull’ambizione della musicista di rimanere attiva sia nel campo della musica classica – musica che, data la formazione ricevuta, non abbandona mai del tutto, come ripetuto più volte da lei stessa – che in quello del jazz.
Redazione
da Amedeo Furfaro | 13/Nov/2023 | Guide all'ascolto, News, Primo piano, Recensioni
Il falsetto nelle etno-musiche
Rock o barocco? Gospel o nenia hawaiana? E le musiche primitive dove le mettiamo in tema di falsetto? Alan Lomax ricorda, a proposito di voce umana, che ”in tutte le età dell’uomo, nel peregrinare attraverso il pianeta, nei vari stili di vita, età, avventure, ogni adattamento ha trovato eco nel guscio di conchiglia dello stile canoro” (Cantometrics, Univ. California, 1978). Ancor prima Roberto Leydi aveva specificato che “la musica africana è forse la più varia, la più ricca, la più imprevedibile del mondo. Il cantante (…) sa usare la sua voce in ogni timbro e in ogni possibilità espressiva; sa passare dai toni più gravi al falsetto” (Musica popolare e musica primitiva, ERI, 1959). Dal “canto” suo Curt Sachs ha descritto i Maori in Nuova Zelanda che “eseguono i canti di guerra rapidamente, in un falsetto sferzante, microtonico, che sembra quasi un pigolio eccitato” (Le sorgenti della musica, Bollati Boringhieri, 1962). E tracce di falsetto sono state rilevate presso i nativi americani e in altri contesti, ad esempio fra le genti del Caucaso così come nel teatro tradizionale cinese.
Questa tecnica vocale , oltre al canto in senso stretto, può investire il linguaggio in senso lato. Dal racconto di André Schaeffner: “trovandoci per la prima volta in Africa, in Camerun, i miei compagni di missione ed io fummo ricevuti da uno di quei piccoli sovrani negri che spesso non sono altro che la triste caricatura dei grandi imperatori africani dei secoli passati. Il principe si rivolse a noi con una strana voce in falsetto che ci fece pensare si trattasse di un evirato. In seguito avemmo la sorpresa di udirlo rivolgersi agli uomini del suo seguito con voce assolutamente normale. Egli ricorreva alla voce in falsetto soltanto nell’esercizio solenne delle sue funzioni regali” (cit., La musica africana dal deserto all’equatore, RaiTv, 1955). In La musica entre los pueblos primitivos, saggio tradotto apparso nel “Boletin Latino-americano de musica” a Montevideo nel 1941, il compositore Henry Cowell intravedeva l’importanza sociale della musica per l’uomo primitivo che “impara a interpretarla seriamente, come una necessità di vita”. Schaeffner, pioniere della critica jazz francese con Goffin e Panassié (cfr. L. Cugny, Di una ricezione del jazz in Francia, HAL Open Science, Rivista di studi sul Jazz e sulle Musiche Audiotattili, 2019) esplicita con vari esempi il contrasto fra voce naturale ed artificiosa, fra parlato profano e parlata rituale, quest’ultima legata ad una specifica funzione sociale e politica.
Allargando lo spettro visuale, sono vari i casi possibili nel campo delle musiche popolari, dallo yodel alpino al country yodel del West America, dallo huapango dei mariachi messicani e dei gruppi tipici huastechi centroamericani interpreti di petenera (sottogenere del flamenco) agli holler afroamericani, dalle musiche vocali di alcune tribù pigmoidi fino ai “canti a distesa” del giuglianese.
Per restare all’Italia, Giovanna Marini accenna a varianti vocali non “naturali” nella musica contadina in cui “la voce si permette degli spessori timbrici delle note roche di corda che nessuna voce impostata classicamente farebbe“ (Improvvisazione ed uso della voce, “I Giorni Cantati”, 2/3, 1981). Dopo la doverosa premessa antropomusicale su una tale “tecnica di canto che, sfruttando un naturale fenomeno di impiego parziale delle corde vocali, consente la produzione di suoni più alti rispetto all’estensione naturale del soggetto cantante in voce piena” (Della Seta, Breve Lessico Musicale, Carocci, 2009) eccoci a tratteggiare, del falsetto maschile, un sintetico resoconto storico, non tecnico, che prende le mosse dalla nascita del melodramma dischiudendo l’excursus a più aree musicali.
Tra Farinelli e Moreschi
Nel cinquecento la terra è più ricca di un continente, l’America. Intanto, al di qua del Nuovo Mondo, in Europa, lettere scienze ed arti registrano uno sviluppo tumultuoso. Nell’Italia del Rinascimento anche la musica fiorisce rigogliosa. Poi, nel Seicento, la monodia accompagnata subentra alla polifonia con la trasformazione di assetto della musica vocale da cui ha origine il melodramma. A Firenze, nell’erudita Camerata de’ Bardi, figura fra i propugnatori del “recitar cantando” Giulio Caccini, convinto che il linguaggio musicale debba constare di “favella, ritmo, suono”. Il valente musicista è contrario al falsettismo, cioè a quel tipo di canto artatamente mutato in timbro e altezza. Le voci “artificiali” di soprano o contralto intonate dai falsettisti sono da lui ritenute stridule. Nelle sue prefazioni “’l’intonazione delle parole era discussa nella relazione del loro contenuto” (A. Della Corte, La critica musicale e i critici, Utet, 1961) nel presupposto che “la grazia del cantare sia parte proveniente dalla natura e non dall’arte” (V. Giustiniani, Discorso sopra la musica, 1628). Va da sé che “nell’opera italiana il canto delle arie era un compito da musicisti virtuosi; ad esempio i famosi castrati, la cui carriera era lanciata da particolari arie che ne costituivano l’epitome” (R. Strohm, Aria e recitativo. Dalle origini all’Ottocento, Enc. Musica Einaudi/Il Sole 24 Ore, 2006, I). Nello Stato pontificio, la proibizione alle donne di esibirsi in scena, decretata da un editto del 1588, aveva aperto ampi spazi ai castrati. Questi ultimi, presenti già nei lavori del Monteverdi, possedevano una vocalità in “perfetto equilibrio fra lo sfoggio virtuosistico nell’improvvisazione e la sostanza profondamente espressiva della linea melodica” (P. Mioli, La musica nella storia, Calderini). Non c’era un unico registro espressivo e il vocalismo degli evirati era più acuto rispetto a quello “naturale” dei camerati fiorentini. E voce bianca, impiegata essenzialmente in parti femminili, era quella del famoso Farinelli, al secolo Carlo Broschi (Andria 1705 – Bologna 1782), a cui è dedicata la biografia di Cappelletto ed il film di Corbiau del 1994 con Stefano Dionisi. “Farinello”, allievo del Porpora e amico del Metastasio e di Domenico Scarlatti, soleva suscitare “stupore per il modo spavaldo con il quale gareggiava perfino con gli strumenti in passaggi virtuosistici. A Londra, circondato dal fanatismo degli ammiratori, fece registrare entusiasmi e commozione da lasciare interdetti sulla veridicità dei resoconti” (Storia dell’opera, UTET, III). Broschi ebbe successo anche a Vienna, Parigi e alla corte di Madrid quale “musico terapeuta” del malinconico re Filippo V sin dal 1737. Nell’arco di una permanenza ultraventennale vi fondò, nel 1750, una scuola di “bel canto” italiano sotto l’egida di Ferdinando VI. Dunque “la voglia di strabiliare, il divismo, la follia delle passioni e delle rivalità furono esaltate dall’irruzione dei castrati sui palcoscenici d’opera. La loro storia incominciò alla fine del Cinquecento e durò fino all’Ottocento, fu penosa e gloriosa, esaltante e sconcertante” (L. Arruga, Il teatro d’opera italiano, Feltrinelli). Finchè appunto nell’800 nasce “l’età del tenore, in cui non sono più le voci acute dei soprani e dei castrati a primeggiare nelle rappresentazioni teatrali bensì quelle dei tenori (A. Petroni, Gilbert Deprez e i “disumani entusiasmi” per la voce tenorile, framentirivista.it, 16/12/22) e il tenore romantico subentra al contraltista evirato. Ed è grazie alle registrazioni effettuate fra il 1902 e il 1903 direttamente dalla voce del falsettista Alessandro Moreschi (Montecompatri, 1858-Roma 1922) che sono stati ricavati una decina di dischi. Moreschi, definito l’Angelo di Roma, cantore presso la Cappella Sistina dal 1883 al 1913, fra gli ultimi cantanti evirati con Domenico Mustafà (cfr. Il segreto della “quarta voce” di Mustafà, Emma Calvè ed Enrico Caruso, belcantoitaliano, blogspotcom,1/5/2020) e il Sebastianelli, si esibì, nel 1900, al Pantheon, ai funerali di re Umberto I, traghettando di fatto il falsettismo nel Novecento, secolo che avrebbe peraltro registrato l’abbandono della pratica dell’evirazione, usanza barbara e atroce, frutto di fondamentalismo moralistico, praticata su persone divenute macchine per cantare mutilate nel corpo e nella mente “immolate sull’altare dell’arte a prezzo della drammatica perdita di identità” (La riproduzione sonora, www.amedeofurfaro.it). La loro eredità canora, quella non chirurgicamente modificata, sarebbe stata raccolta dai controtenori con in repertorio, ancora oggi, musiche di Porpora, Purcell, Haendel, Bach… Da sottolineare che nel primo Ottocento era comparso il falsettone (talora “rinforzato”), tecnica di emissione di note molto acute o sovracute adoperata da vari tenori in alcune partiture liriche di Rossini, Donizetti, Bellini (Credeasi, misera da “I Puritani”). Pagine su cui si sarebbero cimentate grandi ugole (ad es. YouTube Luciano Pavarotti sings A High E flat (!!) in Falsetto).
-

-
Bobby McFerrin – ph Carol Friedman
-

-
Bee Gees
Poliedrico Novecento!
Nel Novecento si “sventaglia” un uso poliedrico del falsetto in più ambiti musicali. Intanto il belcanto lirico, culla ideale per le voci “finte”, consegna agli annali della discografia incisioni di un Enrico Caruso solito durante le prove cantare “le note acute in un falsetto del tipo usato dai cantori sinagogali” (Rosa Ponselle & James A. Drake, “Ponselle. A singer’s life”, Doubleday, 1982) e andrebbe ricordato al riguardo Nicolai Gedda per il suo tipico effetto alla Braham, il grande tenore ottocentesco di origine ebraica. Torniamo all’America, al continente della cui scoperta si era accennato scrivendo del Cinquecento, ma con un salto di oltre quattro secoli (anche se andrebbe quantomeno approfondito il capitolo ottocentesco della musica corale), per ritrovarvi la tecnica della voce “feigned” in nuovi “lidi” stilistici come il blues. E’ del 1928 l’incisione di “Canned Heat Blues” di Tommy Johnson. Attorno ai 40s compaiono i primi gruppi di doo-wop proprio mentre formazioni come The Mills Brothers inseriscono il falsetto fra le pratiche vocali adoperabili. Detta tendenza vocale si estende nella seconda metà dei ’50 quando è il doo-wop dei Platters, con la voce solista di Tony Williams proveniente dal gospel, a dilagare. In area popular, oltre a menzionare il falsetto “eerie” di John Jacob Niles, decano dei folksingers, va ricordato che il successo dei Tokens, “The lion sleeps tonight,” del ’61, era una cover del sudafricano di etnia zulu Solomon Linda (Mbube, 1939). Fra i falsetti più personali emerge quello di Jimmy Jones con la hit “Handy Man” mentre nel vicino Messico si impone Miguel Aceves Mejia, “The Golden Falsetto”. E’ c’è in parallelo anche in Europa da segnalare il falsetto gipsy del romeno Dona Dumitru Siminica (cfr. Tom Huizenga, A suave rumanians sing the falsetto song, npr.org, 10/10/06). Fra le grandi personalità in U.S.A. eccelle Curtis Mayfield, esponente di r&b, soul, funk, la cui carriera inizia nel’58 con gli Impressions. Divenuto celebre nei ’70, grazie alla colonna sonora del film SuperFly, del genere cinematografico della blaxploitation che ha come target iniziale il pubblico di colore, Mayfield simboleggia col suo album “Superfly” la rivalsa della coscienza politica neroamericana dell’epoca. Il suo modo di cantare è connotato dall’uso preponderante del falsetto. (cfr. riccardofacchi.wordpress.com, Il falsetto “impegnato” di Curtis Mayfield, 21//17). Essendo tante le citazioni possibili al riguardo, è il caso di rinviare la lettura a qualche classifica presente in rete. Ad esempio, the topten.com, Top Ten Male Singers with Best Falsetto con Barry Gibb (Bee Gees), Prince, Jeff Buckley nelle prime postazioni ed a seguire artisti come Dimash Kudaibergen, Matt Bellamy (Muse), Justin Timberlake, Chris Martin (Coldplay), Michael Jackson, Brian Wilson (Beach Boys), Thom Yorke (Radiohead). Si prosegue con The Weeknd, Smokey Robinson, Roger Taylor, Frankie Valli (The Four Seasons), Freddie Mercury, Morten Harket (a-ha), King Diamond, Andy Gibb, Philip Bailey (Earth, Wind & Fire), Adam Levine, Bobby Debarge, Paul McCartney, Brendon Urie, John Lennon, Eddie Kendricks quest’ultimo di area soul, dopo la sequenza di rock heavy alternative e pop sia melodico che “spinto”. Il trend dunque si rafforza nei ‘60/70 laddove negli 80s dance e disco si affiancano con prepotenza al rock e ai suoi fratelli, con importanti diramazioni in direzione black music. Seguiranno picchi e sbalzi decrescenti “a ondate”, senza uscite di scena. Da visionare al riguardo su Listcaboodle.com la Playlist di The Best Falsetto Songs utile da consultare per verificare la collocazione temporale dei vari successi. Ecco, appresso, i primi cinque hits quivi riportati:
Night Fever (Bee Gees, 1977)
After the Gold Rush (Neil Young, 1970)
Got To Give It Up (Marvin Gaye, 1977)
Let’s Work (Prince, 1981)
Only The Lonely (Roy Orbison, 1961)
Seguono vari brani, spalmati su più anni (“September” di Earth Wind & Fire del 1978 –“ Don’t Worry Baby”, dei Beach Boys del 1964 ,”Emotional Rescue” dei Rolling del 1980 – “Don’t Stop ‘Til You Get Enough” di Michael Jackson del 1979 – “Just My Imagination” dei Temptations del 1971, “ Tracks of My Tears” di The Miracles, 1965 ), di fine secolo (“High And Dry” dei Radiohead del 1995) fino al più recenti “I’m Not The Only One” di Sam Smith del 2014 e “Redbone” di Gambino del 2016. Come si vede si tratta di selezioni che coprono un arco temporale di mezzo secolo da integrare con artisti come Silvester, Police, Judas Priest, Deep Purple, AC/DC, Kiss, Ted Neeley (Jesus Christ Superstar), Darkness …fino ai giorni nostri con Bruno Mars, Mika e il vintage soul di Aaron Frazer quindi i Maroon Five, Justin Bieber, Pharrell Williams, i sudcoreani BTS …
L’Italia ha qualcosa da dire al riguardo a partire dalla tradizione. Non disdegnavano gorgheggi o svolazzi “falsettati” Enrico Caruso (e si era a inizio 900) e Gill; quindi, nella seconda metà del secolo, voila Luciano Tajoli, Claudio Villa, Sergio Bruni, seguiti più avanti dal pop melodico di Flavio Paulin dei Cugini di Campagna e dal rock progressivo dei New Trolls, contemporanei dei Pooh (cfr. Massimo De Vincenzo, Storia del Falsetto. Dai castrati all’heavy metal, Youtube.com).
Discorso a parte meriterebbe Alan Sorrenti così come il semifalsetto di Mango e taluni interventi vocali dello stesso Battisti, senza parlare di Antonella Ruggiero per il semplice motivo che ci si sta occupando del falsetto maschile. Il quale anche in ambito classico ha continuato ad avere proseliti fino ad oggi, vedansi ad esempio il controtenore italiano Raffaele Pe sulla scia di Alfred Deller, David Daniels, Philippe Jaroussky, Jakub Jòzef Orlinski, il russo Vitas … (cfr. sull’argomento Alessandro Mormile, Controtenori, Zecchini Ed.).
La magnifica “ossessione”
Su “eartworm” quella del falsetto è definita una “obsession” per molti vocalist mentre su djrobblog.com si produce una playlist di The Best Falsetto Singers “A Men Only” Club aggiornata al 2015 su cui ritroviamo interessanti presenze Motown (Robinson), soul (Russell Thompkins) e comunque con propaggini nella musica neroamericana come nel caso di David Peaston ma sempre con prevalenza del pop e rock. Fatto è che se sul web artisti tipo Sam Smith, dal falsetto preponderante, viaggiano nel brano surricordato a colpi di un miliardo e mezzo di visualizzazioni, allora la cosa andrebbe in qualche modo attenzionata. Si è detto che il falsetto rincorre la leggiadria del canto infantile e la leggerezza di quello femminile ma forse ciò è riduttivo alla luce della sua diffusione. Intanto molti musicisti che lo possiedono accarezzano in fondo il sogno di una voce in grado di passeggiare sugli 88 tasti del pianoforte. E c’è pure Ligeti che ne ha scoperto il lato noir in “Le Grand Macabre” (1974) agli antipodi rispetto alla briosa teatralità settecentesca del musical “Falsettos” (1992), di William Finn e James Lapine, costituito dai due atti unici “March of the Falsettos” e “Falsettosland”.
A proposito di jazz soffermiamoci ora su un altro esperto della “voce di testa” cioè Bobby McFerrin, alla ribalta mondiale per “Don’t Worry. Be Happy” ma jazzista a tutto tondo. Le sue capriole vocali riescono a coniugare Bach e avanguardia a tribalismi africani con straordinaria naturalezza. Un simbolo vivente di come la musica jazz possa muoversi in libertà senza frontiere nel tempo o nello spazio. Ed ecco, in conclusione, una Playlist, del tutto soggettiva, con i “magnifici sette” jazzmen da noi preferiti fra coloro che vantano attrezzi vocali falsettofoni, con uso magari episodico, per un range più “espanso”. Nel jazz non è configurabile una categoria settoriale di vocalist “falsettisti” ma il falsetto od anche il “similfalsetto” (Scott) può far parte del bagaglio da cui trarre spunto nelle interpretazioni e improvvisazioni. I nomi seguenti rappresentano solo una (opinabile) delle scelte possibili, potenzialmente tante specie ove si faccia un’affacciata al soul e dintorni:
Bobby McFerrin
Mark Murphy
Kurt Elling
David Peaston
Alan Harris
Thomas Allen
Jimmy Scott
Si è affidata al jazz la chiusura di questa storia parziale del registro vocale più “ambiguo” che, partendo da etno-musica e lirica, ha attraversato do- wop, mainstream, disco, funk, dance-pop, R&B e hip hop (la suddivisione riprende quella di The Male Falsetto, cult-sounds.com). La pubblichiamo con il fondato dubbio che se oggi Farinelli rinascesse sarebbe ancora una superstar!
Amedeo Furfaro- Franco Sorrenti






 Federica Michisanti Quartet, “Afternoons”, Parco della Musica Records.
Federica Michisanti Quartet, “Afternoons”, Parco della Musica Records. Adriano Clemente, “The Coltrane Suite and Other Impressions”, Dodicilune Records
Adriano Clemente, “The Coltrane Suite and Other Impressions”, Dodicilune Records Christian Pabst, “The Palm Tree Line”, Jazz Sick Records.
Christian Pabst, “The Palm Tree Line”, Jazz Sick Records.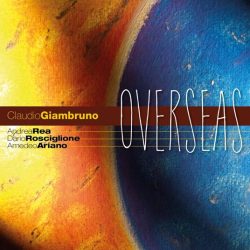 Claudio Giambruno, “Overseas”, Via Veneto Jazz
Claudio Giambruno, “Overseas”, Via Veneto Jazz Two Things of Gold, A.Ma Records
Two Things of Gold, A.Ma Records Minimal Klezmer, “Öt Minusz Kettò”, Caligola Records
Minimal Klezmer, “Öt Minusz Kettò”, Caligola Records Remedio, “Semillas”, Gutenberg Music.
Remedio, “Semillas”, Gutenberg Music. Gloria Trapani / Alessandro Del Signore, “InControVoce”, Filibusta Records
Gloria Trapani / Alessandro Del Signore, “InControVoce”, Filibusta Records Pietro Ciancaglini, “Consecutio”, GleAm Records
Pietro Ciancaglini, “Consecutio”, GleAm Records Haiku, Sun Village Records
Haiku, Sun Village Records Nicole Johänntgen, “Labirinth”, Selmabid Records.
Nicole Johänntgen, “Labirinth”, Selmabid Records. Gaetano Duca, “Bugiardi”, Abeat Records
Gaetano Duca, “Bugiardi”, Abeat Records






























