da Danilo Blaiotta | 15/Mag/2023 | News, Primo piano
Si dice che lo strumento musicale più vicino alla voce umana sia il violoncello. Questione di frequenze, di timbro, di oscillazione. Certamente. Un sassofono è un’altra cosa: non è dalle frequenze che si misura la voce umana del sassofono, ma dalla profondità e dall’intensità dell’espressione del linguaggio ad esso abbinato. Si comunica il cosa, che influenza certamente anche il come. Parlare Jazz, come parlare inglese, o spagnolo. Il jazz è l’idioma perfetto per la dolcezza e la sofferenza, per la morbidezza e l’urlo. I contrasti dell’Uomo del ‘900 ritrovano in questa musica una lingua imprescindibile, autentica, deliziosa-gentile-cattiva. Il demoniaco ed il paradisiaco in un corpo solo. Un po’ come ritroviamo in alcune partiture leggendarie dell’800 romantico. Certo. Cosa è cambiato dunque? Semplicemente questa volta non vi è premeditazione nella descrizione umana, vi è altresì estemporaneità, quella stessa del linguaggio parlato. Come facile deduzione di questo ragionamento, possiamo dunque parlare di rassomiglianza del romanticismo all’uomo riflessivo e forse scrivente, più che parlante. Il jazz sarebbe dunque lo strumento più straordinariamente simile alla parola, poiché essa stessa, in qualsiasi idioma, è frutto di miscellanea improvvisazione su di un bagaglio contenente gli strumenti necessari al linguaggio stesso.
Il sassofono non è dunque, per frequenze e timbro, lo strumento dal suono più simile all’umana dannazione. Il sassofono quando suona del jazz però, spesso lo è. Massimo Urbani quando soffia nel sax alto, lo è più di chiunque altro.
Nato a Roma nel quartiere di Monte Mario l’8 maggio 1957, ascolta la prima banda di paese in villeggiatura estiva nei pressi di Ladispoli, la Riccione degli anni ’60 per i romani. Secondo Maurizio Urbani, fratello di 4 anni più piccolo e grande tenorista, tutto partì da una di quelle vacanze con i nonni tant’è che, tornati a Roma, gli comprarono un clarinetto. Aveva 11 anni.
La serie di circostanze che accaddero da lì ai successivi 3 anni sembrano uscite da una sceneggiatura a metà tra il cinema neorealista e la follia felliniana. Massimo suona nella banda di Monte Mario, ascolta i racconti del suo parente Luciano Urbani (che grazie al padre in quel periodo assisteva alle mitiche edizioni di Jazz Concerto di Adriano Mazzoletti alla RAI), ascolta i dischi di Charlie Parker del padre (che non era musicista, faceva l’infermiere a Santa Maria della Pietà) e frequenta la casa del compianto sassofonista Tony Formichella, che gli fa ascoltare i primi dischi di rhythm’n’blues e di jazz e lo porta alle prime jam session romane.
Tutto torna? No, se il risultato è che, a soli 14 anni in un quartiere popolare di Roma, senza quasi sapere cosa fosse un conservatorio di musica, Massimo improvvisava come fosse stato la reincarnazione di Parker.
Roma degli anni ’70 viveva un fermento musicale di altissimo livello. Tra le tante iniziative che segnarono la vita di tutti i più importanti musicisti di allora e dei successivi decenni, voglio citarne due di fondamentale importanza: l’apertura nel 1971 del Music Inn da parte di Pepito e Picchi Pignatelli, e il corso sperimentale di Jazz che partì, grazie a Giorgio Gaslini, al Conservatorio Santa Cecilia. Gli esterni al Conservatorio potevano partecipare al corso solamente da uditori: in quel periodo Massimo Urbani e Maurizio Giammarco si iscrissero. Gaslini permise l’iscrizione agli esterni poiché affermò che, se avessero richiesto il diploma a Louis Armstrong o a Ella Fitzgerald, non avrebbero potuto partecipare ad un corso di jazz (comprendendo da subito dunque la difficile, già dal principio, coesistenza dello studio del jazz a livello accademico).
Gli albori di Massimo Urbani, fondamentali per capire le basi di tutta la sua vita musicale.
-

-
Massimo Urbani
-

-
Massimo Urbani
Max suonava dunque il bop come un demonio, ma frequentava l’avanguardia di Gaslini e il free di Mario Schiano con cui registrò ad esempio, a soli 16 anni, il suo primo album in studio. La fama di questo incredibile ragazzino vestito da bopper navigato arrivò al grande trombettista Enrico Rava, il quale andò a Roma apposta per sentirlo suonare. Nel 1976 lo portò in tour negli States. Intervistai Rava su Urbani qualche anno fa, il quale mi raccontò: “In tutte le jam session newyorkesi Massimo faceva fuori tutti gli altri sassofonisti uno dopo l’altro, non c’era partita”. Ma Max era pur sempre un ragazzo poco più che adolescente di Monte Mario. Celebre fu l’episodio in cui, pieno di vergogna per aver rotto un registratore in casa del trombettista, sparì per due notti dormendo al Central Park e tornò, poco prima di un’esibizione per la TV americana, con la febbre alta e senza vestiti da poter indossare. Massimo Urbani era un puro, non aveva filtri e non apparteneva di certo a quel mondo borghese che, volenti o nolenti, stava già risucchiando le energie della musica afroamericana trasformandola successivamente in qualcosa di eccessivamente elitario. Max incarnava la purezza di alcuni leggendari personaggi che avevano letteralmente segnato la storia di questa musica. Intendiamoci, non sto assolutamente cavalcando cliché sull’artista maledetto, sul genio squattrinato o incompreso, sulla rivalsa di questa musica come riscossa dei ceti popolari. Penso invece che la storia del jazz si sia attorniata di figure provenienti dal mondo popolare quanto da quello borghese e che sia stato proprio questo connubio, democraticamente, a far arrivare alle nostre orecchie capolavori senza tempo. Certamente però, oggigiorno, non possiamo far finta di non notare quanto questa musica si sia eccessivamente imborghesita, negli ambienti più che nelle note, perdendo talvolta uno spirito divulgativo e spensierato che si poteva ritrovare, ad esempio nel blues e nella musica nera, tra le fasce sociali più deboli.
La più celebre frase di Urbani, detta spontaneamente e senza giri di parole “L’avanguardia è nei sentimenti”, sintetizza tutto il mio discorso nel modo più alto e semplice possibile.
Tra la fine degli anni ’70 e per tutti gli anni ‘80 Massimo Urbani, pur rimanendo un ragazzo di quartiere, divenne dunque un sassofonista di successo richiesto in lungo e in largo, sia come leader che come sideman. Cresciuto nell’epoca della sperimentazione, la frase sopra citata è la sua risposta a chi gli chiede il motivo dell’essersi allontanato, all’apice della sua carriera, dal free e dalle cosiddette avanguardie che egli aveva ben conosciuto ad esempio con Rava o ancor di più con Schiano e Gaslini. Max riscopre il bop ma lo fa da musicista navigato e colmo di moltitudini di esperienze: oltre al suo ruolo nel periodo free lo ritroviamo ad esempio, seppur brevemente, a fianco degli Area nel jazz-rock come addirittura in un disco della Nannini. Non è il suo mondo però. Non lo è nemmeno il bop, in realtà. Massimo Urbani è Massimo Urbani.
Lo sanno bene anche i numerosi artisti internazionali con cui collabora (attorniato da tutti coloro che sono stati protagonisti attivi del periodo più incredibile della storia del jazz italiano). Qualche nome: da Chet Baker a Steve Grossman, da Mike Melillo a Red Rodney, da John Surman a Jack DeJohnette, da Lester Bowie a Kenny Wheeler, da Steve Lacy ad Art Farmer. Con Enrico Rava poi, lo ricordiamo accompagnato dalle ritmiche Hill/Astarita e dal celebre tandem norvegese Daniellson e Christensen negli stessi anni in cui registravano nel quartetto europeo di Keith Jarrett e Jan Garbarek.
Tra gli album a suo nome particolarmente di impatto vi sono certamente “Urlo” con Massimo Faraò, Pietro Leveratto e Gianni Cazzola e ancor di più “Easy to love” con Furio di Castri e Roberto Gatto alla ritmica ed un indimenticabile Luca Flores al pianoforte. Ricordando in un’intervista con Roberto Gatto questo album, Roberto mi faceva notare (a ragione) come Flores anticipi il modo di suonare di Brad Mehldau di almeno un decennio; fu un incontro tra solisti immensi, due giganti, che per uno strano scherzo del destino non abitano più entrambi su questa Terra.
Altri album che hanno destato la mia attenzione sono “Via G.T.” di Giovanni Tommaso del 1987 con Danilo Rea, Paolo Fresu e Roberto Gatto (da cui un celebre tour newyorkese) e “The Blessing”, ultimo disco in studio a suo nome registrato nel febbraio 1993, pochi mesi prima della sua scomparsa, praticamente con la stessa formazione di Via G.T. ad eccezione del solo Paolo Fresu e con l’aggiunta di Maurizio Urbani al sax tenore, prodotto dallo stesso Roberto Gatto.
L’epilogo arrivò nel giugno del 1993, dopo una storica settimana all’Alexander Platz Jazz Club di Roma per quelli che furono gli ultimi concerti ufficiali (ben documentati nel disco live che ne seguì) di Max, in compagnia di Andrea Beneventano, Dario Rosciglione, Gegè Munari e con ospite Red Rodney.
Fu proprio all’Alexander Platz che, nel marzo 2020, decisi di fare un grande omaggio a Massimo in quella che fu una storica diretta radiofonica di quasi 3 ore, con protagonisti racconti e musica partoriti da buona parte di coloro che collaborarono con lui. Per chi volesse riascoltare quella mitica puntata andata in onda sull’emittente Radio Città Aperta, mi permetto di allegare qui il podcast integrale.
https://www.radiocittaperta.it/podcast/speak-low-con-danilo-blaiotta-del-03-03-2020/
In questo sintetico ma sentito racconto della gigantesca carriera di Massimo Urbani, non ho volutamente citato i suoi noti problemi legati all’eroina, che portarono a quella maledetta notte tra il 23 e il 24 giugno 1993. Per chi avesse qualche dubbio, vorrei fortemente sottolineare che la musica di Max non è legata al suo essere alterato dagli effetti delle droghe. Massimo Urbani era libertà ma grande attinenza e precisione ritmica, era dotato di un orecchio bionico come di un senso del timing fuori dal normale. La musica di Max era lucida, limpida, oserei dire “nonostante” gli eccipienti, e non “grazie a”.
Il cliché del musicista che altera le proprie condizioni per suonare meglio ed in modo più ispirato la musica ed in particolare il jazz, è totalmente distante dall’universo di Urbani. Max era libero ma musicalmente lucido, come gran parte dei musicisti che hanno fatto uso di droghe, nel bop newyorkese dei favolosi anni ’40 come successivamente nell’Europa di fine anni ’60, e poi nel trentennio successivo.
Massimo Urbani era libero, limpido e brillava di luce luminosa: le note del suo sax alto scintillavano tanto su un fast quanto su un’improvvisazione libera. Alle volte gridava, si, con gli armonici, forse come avrebbe voluto gridare una sua qualche insicurezza legata alla vita reale? Non ci è dato saperlo e non ci deve nemmeno interessare. Che ci interessi, invece, l’emozione di quell’urlo come di quelle scale vorticose. Che ci interessi il canto meraviglioso dell’improvvisazione su ‘Lover Man’, uscito dal soffio di Max come dall’ugola di una Maria Callas vestita di ance e adornata di chiavi.
Vediamoci ciò che vogliamo, ma forse, più di ogni altra cosa, il sentimento di un artista profondo come pochi, vero come pochi, talentuoso come pochi, nella storia di questa straordinaria musica che tutti noi continuiamo a voler, imperterriti e forse anche un po’ contro ogni razionalità, portare avanti.
Danilo Blaiotta
da Marina Tuni | 10/Mag/2023 | Interviste, News, Primo piano
Si dice che nella botte piccola si conserva il vino più buono e in quel di Staranzano, piccola località di settemila anime in Friuli-Venezia Giulia, nella provincia di Gorizia, nella botte ci hanno messo appunto un delizioso e prezioso Festival dell’Acqua, con trenta appuntamenti in quattro giorni, dall’11 al 14 maggio, e di cui sentiremo sicuramente parlare a lungo (https://acquafestival.it/ ).
Tanti sono i motivi per pensare di collocare a Staranzano un concept-festival dedicato a questo prezioso elemento, principio ordinatore del mondo: in primis perché nel suo territorio s’incontrano armoniosamente le acque del mare, dei fiumi, della laguna e quindi perché non seguire il loro corso in un fluire di talk scientifici, performance teatrali, percorsi di ricerca, concerti, laboratori, eventi espositivi, escursioni e incontri letterari?
Detto fatto!
In questa prima edizione, trova spazio anche la musica jazz in una delle sue massime espressioni contemporanee: il grande pianista ed improvvisatore Danilo Rea, che si esibirà sabato 13 maggio (ore 21) alla Sala Pio X (ingresso libero su prenotazione al link: https://acquafestival.it/danilo-rea-in-concerto/ )
Di Danilo si potrebbero scrivere interi trattati, avendo egli suonato con il gotha del jazz, della classica, del pop, in una lunghissima carriera iniziata ai tempi del liceo classico con un gruppo dal bizzarro nome “Gigi sax e il suo complesso”! Celie a parte, dopo gli studi di pianoforte classico al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, un debutto nell’universo progressive rock con i New Perigeo e successivamente nel mondo del jazz, a partire dal 1975, con il Trio di Roma, Rea raggiunge una popolarità internazionale e collabora con artisti quali Chet Baker, Lee Konitz, Steve Grossman, Michael Brecker, Tony Oxley, Joe Lovano, Gato Barbieri, Aldo Romano, Brad Mehldau, Danilo Pérez, Luis Bacalov (e sono solo alcuni…) e in Italia con Mina, Pino Daniele, Claudio Baglioni, Gino Paoli, Domenico Modugno; senza dimenticare il sempervirens progetto Doctor 3, un unicum nel panorama musicale italiano per aver saputo rileggere il pop in chiave jazz con grande sapienza (Pietropaoli, Rea, Sferra, recentemente intervistati per noi da Daniele Mele http://www.online-jazz.net/?s=doctor+3 ).
A Staranzano, il pianista romano eseguirà un affascinante repertorio dedicato all’acqua, in piano solo. Comunque, trattati a parte, se desiderate scoprire chi è davvero Danilo Rea, leggete il suo bellissimo libro-biografia “Il Jazzista Imperfetto”, scritto a quattro mani con Marco Videtta (Rai Libri).
–MT: parto innanzitutto con una mia curiosità personale: posto che non ho dubbi che il repertorio da te scelto e dedicato all’acqua rappresenterà – almeno per me – una “sovrapposizione sensoriale”: hai presente la sinestesia… ascoltare la tua musica e udire un colore, insomma… sensazioni così? Mi viene in mente “La Mer” di Debussy con quegli accordi che si rincorrono e gli occhi che si riempiono di tutte le sfumature del blu… e vedi il movimento ininterrotto delle onde del mare, fino a sentirlo dentro di te.
Puoi anticipare ai nostri lettori che cosa hai elaborato per raccordare l’elemento sonoro a questo elemento naturale, così prezioso per la vita sulla terra?
DR: Il tuo riferimento a Debussy mi sembra di grande ispirazione, non a caso qualche anno fa registrai per prova una improvvisazione pianistica proprio su quel brano.
Si l’acqua, la marea, il suono della pioggia, delle onde che si infrangono, è Musica! Spesso mi addormento con suoni d’acqua…
Per il concerto di Staranzano ho in mente una serie di temi come Moon River di Mancini, Wave di Jobim, Caruso e 4/3/1943 di Dalla, Sapore di Sale dell’amico Gino Paoli, per continuare con Bridge over Troubled Water di Simon e Garfunkel e tanti altri.
Vedremo come riuscirò a legarli insieme durante l’improvvisazione nel concerto stesso.
–MT: la melodia è un po’ come l’acqua, va lasciata libera di scorrere perché il suo movimento è evoluzione, apertura mentale e desiderio di conoscenza. Tu sei un poeta dell’improvvisazione e conosco pochi musicisti che come te rispettano la melodia anche nel processo improvvisativo; inoltre hai creato un nuovo idioma espressivo nel piano solo. Forse il tuo segreto è che tu non suoni mai in modo auto-referenziale ma unicamente per suscitare emozioni in chi ti ascolta?
DR: si, suono per scambiare emozioni con chi mi ascolta, altrimenti non ci sarebbe motivo per suonare!
Suono giocando sempre attorno alla melodia, proprio perché nel piano solo godo di totale libertà e posso uscire dal concetto di tema e conseguente assolo.
Entro ed esco dal brano in piena libertà, come in un sogno, una cascata di note che partono sempre da un tema a me caro, forse caro anche a chi ascolta.
-

-

–MT: attraverso la tua musica hai la rara capacità di raccontare storie sorprendenti; il tuo è un pianismo che, se me lo concedi, definirei antinomico… ovvero fatto di continui contrasti, dolcezza e irruenza, lirismo e carattere, il calore della passione e la precisione della tecnica e ogni qualvolta io abbia ascoltato un tuo concerto, partendo da un’idea che mi ero fatta su quello che avrei potuto sentire, puntualmente, alla fine, mi sono sempre ritrovata piacevolmente spiazzata. Passi dai Beatles a Verdi, da Chopin ai Rolling Stones, da Bernstein a De André ed è strano, perché si ha la netta impressione che quei brani siano stati composti ad hoc per il tuo pianoforte.
Cos’è? Forse la conseguenza del tuo modo estemporaneo – e mai asservito ad alcuna imposizione stilistica – di approcciarti alla musica?
DR: credo che dai contrasti esca la musica, che non esista un pianissimo senza un fortissimo e che nell’improvvisare un intero concerto ci sia bisogno di avere una capacità di regia estemporanea, in maniera tale da creare tensione e rilassamento, per calmarsi, sognare e poi ripartire al galoppo.
Un buon improvvisatore non deve accontentarsi di essere bravo nella struttura dell’improvvisazione, deve andare oltre, guardare il brano come parte di un mosaico che dura l’intero concerto, come un racconto nel quale la melodia guida le emozioni. È come se tutta la musica del mondo avesse una matrice comune, Beatles, Puccini, De Andrè, prendendo le loro melodie e suonandole al pianoforte a modo mio, nel bene e nel male, si ritrovano unite.
–MT: tempo fa lessi una tua intervista dove dicevi che i grandi musicisti classici del passato erano soliti improvvisare e che tu e Ramin Bahrami (insieme hanno realizzato il meraviglioso album “Bach is in the Air – N.d.A) non vi siete limitati a rileggere Bach né l’avete toccato ma avete “aggiunto”. Vista la già incredibile complessità dell’armonia bachiana e le sue invenzioni contrappuntistiche, ci spieghi che cosa tu e Bahrami avete inteso per “aggiungere”?
DR: con Bahrami è venuto tutto naturale, grazie alla sua fiducia nelle mie improvvisazioni che lui definisce in stile Bachiano: lui suona ed interpreta la partitura originale.
In pratica abbiamo aggiunto l’improvvisazione alla partitura, cosa credo mai fatta. In genere i jazzisti hanno sempre portato la musica di Bach a tempo di swing, quindi riarrangiandola completamente…
Questa operazione è molto delicata, tenendo conto della perfezione della scrittura di Bach, ma l’abbiamo fatta nel rigoroso rispetto della musica del Maestro di Lipsia.
D’altronde Bach era un grande improvvisatore e forse non sarebbe male se i giovani musicisti classici ripristinassero nel loro corso di studi l’arte dell’improvvisazione.
–MT: cosa pensi di quanti, con riferimento ad alcuni cantanti di musica leggera che hanno voluto in qualche modo rivolgersi al jazz, criticano questa scelta ritenendola opportunistica e priva di qualsivoglia motivazione artistica?
DR: rispondo che sono anni che mi criticano per questo, ma seguo il cuore; improvviso su ciò che mi piace, senza preconcetti, ovvero, intendo dire che io stesso ho avuto critiche nel senso opposto, perché amavo improvvisare su un repertorio pop… trovo invece che sia una scelta reciprocamente utile, perché c’è tanto da imparare da ambo le parti!
–MT: infine, so che sei un grande appassionato di motociclette, credo di aver letto che ne possiedi una decina. Verrai nella mia meravigliosa terra di acque, vento, arte, vini e cibi eccellenti con quel mezzo?
Scherzo, naturalmente, sebbene sia convinta che tu potresti anche farlo! Ti è rimasto qualcosa delle volte in cui sei venuto in Friuli-Venezia Giulia? Ricordo vividamente le tue performance a Udine con Tavolazzi e a Grado con Biondini.
DR: verrò in treno ma spesso viaggio verso i concerti in moto.
Il contatto con l’esterno, con l’aria, con la pioggia che cambia l’odore dell’asfalto, il caldo, il freddo, li puoi godere e subire solo in moto… però sono sensazioni forti che restano dentro, come d’altronde la vostra bellissima Regione.
Marina Tuni ©
da Didier Pennequin | 29/Mar/2023 | News, Primo piano
Leïla Olivesi, Samara Joy et Diunna Greenleaf sono state insignite, nelle diverse categorie, del “Grand Prix” 2022 dell’Académie du jazz en France nel corso della solita prestigiosa cerimonia tenutasi all’inizio di marzo nel club Pan Piper à Paris. Questa tradizionale cerimonia annuale della prestigiosa istituzione che il prossimo anno festeggerà i suoi70 anni di esistenza, era presieduta per l’ultima volta da François Lacharme che, dopo 18 anni di leale servizio, lascia il posto a Jean-Michel Proust, sassofonista nonché direttore artistico di vari festival tra cui Jazz au phare sur l’île de Ré e Paris Guitar Festival à Montrouge, nella banlieue parigina.
Venendo allo svolgimento della cerimonia, il premio Django Reinhardt (con il sostegno della Fondation BNP Paribas) che viene attribuito al (alla) musicista francese dell’anno è stato attribuito alla pianista, direttrice d’orchestra e compositrice Leïla Olivesi. In tal modo la Olivesi diventa la sesta jazz-woman insignita di questo prestigioso riconoscimento dopo Airelle Besson (tromba – 2014), Cécile McLorin Salvant (voce – 2017), Sophie Alour (saxophone – 2020), Géraldine Laurent (sax – ex-æquo en 2008) et Sophia Domancich (piano – 1999).
Una meritatissima conferma per la giovane new-yorkese di 23 anni Samara Joy che dopo aver vinto quest’anno due Grammy Awards (migliore nuova artista e miglior album di jazz vocale), ha ottenuto anche il premio francese relativo al Jazz vocale per il suo album “Linger Awhile” votato da una cinquantina di membri dell’Académie già dalla fine dello scorso anno, quindi ben prima dei Grammy.
-

-
Diunna Greenleaf – Francois Lacharme
©Sophie Le Roux
-

-
Leila Olivesi – Francois Lacharme
©Sophie Le Roux
-

-
Samara Joy – Francois Lacharme
©Sophie Le Roux
Infine, ultima rappresentante del genere femminile, la cantante di Blues Diunna Greenleaf, venuta espressamente da Houston (Texas) e immediatamente ripartita con in tasca il “premio Blues” per il suo album “I Ain’t Playin” (Little Village). Nonostante gli evidenti impegni, la Diunna ha trovato il tempo di esibirsi in un mini-concerto di grande spessore.
Nelle categorie puramente strumentali il “Gran Premio” per il miglior disco dell’anno è andato al magnifico quartetto composto da Joshua Redman, Brad Mehldau, Christian McBride e Brian Blade grazie all’album “Long Gone” (Nonesuch/Warner Music).
Il premio per il miglior disco registrato da musicista di casa è andato al contrabbassista Stéphane Kerecki per l’album “Out Of The Silence” (Outnote/Outhere Distribution) ; il premio per il miglior inedito è stato attribuito a Mal Waldron per “Searching In Grenoble : The 1978 Solo Piano Concert” (Tompkins Square Records) mentre quello per il Jazz classico a Dany et Didier Doriz/Michel e César Pastre per il loro omaggio familiare “Fathers & Sons – The Lionel Hampton/Illinois Jacquet Ceremony” (Frémeaux & Associés).
Se il premio al miglior musicista europeo è andato al trombonista tedesco Nils Wogram che che suona regolarmente con Michel Portal, un nuovo premio denominato “Prix Evidence” è stato istituito per mettere in primo piano dei giovani talenti, premio andato questa prima volta alla formazione del chitarrista svizzero d’origine honduregna Louis Matute, grazie al suo disco “Our Folklore” (Neuklang).
Didier Pennequin
Membro dell’Académie du Jazz en France
da Gerlando Gatto | 11/Mar/2023 | I nostri CD, Primo piano, Recensioni
Dopo le numerose escursioni di Amedeo Furfaro intorno al jazz italiano, questa volta soffermiamo la nostra attenzione sulle novità che arrivano dall’estero.
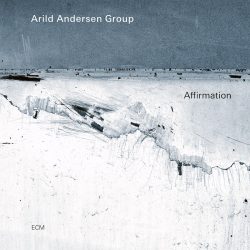 Arild Andersen Group – “Affirmation” – ECM
Arild Andersen Group – “Affirmation” – ECM
Arild Andersen, contrabbassista norvegese, è uno di quei rari musicisti che non sbaglia un colpo. Ogni suo album è frutto di lunga meditazione quindi di sicura riuscita…almeno dal punto di vista artistico, ché come sappiamo il gradimento del pubblico è altra cosa. Ad accompagnarlo in questa nuova impresa musicisti quasi tutti molto più giovani: il pianista quarantasettenne Helge Lien, l’altro quarantasettenne Hakon Mjaset Johansen alla batteria e il trentaseienne Marius Neset al sax. Il repertorio è suddiviso in due parti, ciascuna delle quali comprende alcuni momenti numerati – quattro per la Part I e tre per la Part II; a chiudere l’unica composizione “scritta” dallo stesso Andersen, “Short Story”. A questo punto avrete già capito che l’album si basa su una lunga improvvisazione di gruppo che, però, nulla ha a che vedere con le infocate sedute del free storico. Qui l’atmosfera è completamente diversa, intimista, meditativa con i quattro musicisti che dimostrano di conoscersi assai bene, districandosi come meglio non potrebbero nelle pieghe di una tessitura tanto lieve quanto complessa, in cui le pause, il silenzio hanno un loro perché. L’ultimo brano, “Short Story”, si basa su una melodia splendidamente scritta dal leader e altrettanto splendidamente eseguita dai quattro, con sassofonista e pianista in primissimo piano.
 Onur Aymergen Quintet – “Lunar” – Losen
Onur Aymergen Quintet – “Lunar” – Losen
E’ con vero piacere che vi presentiamo questo gruppo proveniente dalla Turchia e composto da Onur Aymergen leader alla chitarra, Can Çankaya piano, Tolga Bilgin tromba, Apostolos Sideris contrabbasso, Turgut Alp Bekoğlu batteria. Anche se ancora poco noto nel nostro Paese, Onur Aymergen può già vantare una solida preparazione: ha cominciato a studiare chitarra classica con Özhan Gölebatmaz approfondendo anche il flamenco classico con Suat Demirkıran, fino a quando ha deciso di convogliare i suoi interessi verso il rock, il funk e il jazz. In questo suo album d’esordio, Onur dimostra di avere le carte in regola per un futuro luminoso: intendiamoci, nulla di trascendentale, ma un musicista che conosce assai bene lo strumento, il linguaggio che adopera, il patrimonio musicale del suo Paese che ogni tanto fa capolino dalle linee esposte dal gruppo. E non a caso si è citato il gruppo in quanto, nei suoi sapidi arrangiamenti, il leader ha lasciato ad ogni compagno d’avventura lo spazio per porsi in evidenza. E quanto sin qui detto appare evidente sin dal primo brano in programma, “Yeditepe”, scritto, così come gli altri sette pezzi in repertorio, dal leader che evidenzia, in tal modo, una notevolissima capacità di scrittura.
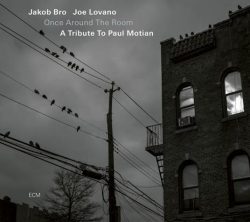 Jakob Bro, Joe Lovano –“Once Around The Room” – A Tribute to Paul Motian” – ECM
Jakob Bro, Joe Lovano –“Once Around The Room” – A Tribute to Paul Motian” – ECM
Il chitarrista Jakob Bro e il tenorsassofonista Joe Lovano sono i cofirmatari di questo album esplicitamente dedicato a Paul Motian, già loro compagno in tante avventure. Ad assecondare i due, i contrabbassisti Larry Grenadier e Thomas Morgan, Anders Christensen al basso elettrico e i due batteristi Joey Baron e Jorge Rossi. Un organico anomalo, quindi, per una musica che di anomalo nulla propone data la maestria dei singoli e quindi dell’intera formazione. Lovano e Motian hanno collaborato per una decina d’anni e personalmente ricordiamo di averli ascoltati, tra l’altro, a Stavanger in Norvegia nei primissimi anni ’80. E ciò potrebbe spiegare assai bene il perché di questo album. Quanto poi all’immediata ricerca del drumming di Motian nella musica dell’album, si tratta di operazione, come al solito, assai difficile anche perché soprattutto Lovano non ha alcuna intenzione di scrivere una pagina calligrafica. Anzi! Ed è lo stesso sassofonista a spiegare cosa per lui significhi questo album: “Con Motian suonavamo degli standard ma cercavamo in ogni modo di farli nostri. Ecco noi suonavamo con fiducia con attitudine, con un approccio che potesse rendere al massimo le nostre intenzioni. Ecco è proprio questo stesso feeling che ho tenuto durante la registrazione dell’album”. Diverso l’atteggiamento di Jakob Bro che ha scritto due brani di sapore quasi opposto in cui si avverte chiaramente una profonda malinconia, una tristezza di fondo per la scomparsa di Motian. Qui il gruppo abbandona lo spirito improvvisativo che ha caratterizzato i primi tre pezzi, per immergersi nella scrittura di Bro che trova sia in “Song To An Old Friend” sia in “Pause” una dolce melodia. Chitarra e sassofono dialogano soavemente ben sostenuti da bassi e batterie. Nel brano conclusivo particolarmente apprezzabile il lavoro del chitarrista che disegna con delicatezza una splendida e toccante linea melodica. Ad intervallare i due brani, l’unica composizione di Paul Motian, “Drum Music”, caratterizzata da una lunga intro disegnata dai due batteristi che lasciano il posto a sax e chitarra, quest’ultima con una sonorità assi vicina a quella del sax per effetto dell’elettronica.
 Eik Trio – “Eik Trio” – Losen
Eik Trio – “Eik Trio” – Losen
Sempre prodotto dalla norvegese “Losen” ecco questo nuovo trio composto dal pianista Ole Fredrik Norbye, dalla vocalist Elisabeth Karsten e dal contrabbassista John Børge Askeland, cui si aggiungono alcuni dei migliori jazzisti norvegesi ed europei quali il sassofonista Bendik Hofseth al sax tenore in tre brani, il trombettista Nils Petter Molvaer nel celeberrimo “I Love Paris” e il fisarmonicista Heine Bugge in “For Once in My Life”, mentre quasi tutti gli arrangiamenti sono curati da Fredrik Norbye. Dai titoli citati avrete forse già capito che tutto l’album è incentrato sulla riproposizione di standard, dieci pezzi che davvero hanno fatto la storia della musica che ci piace, interpretati senza alcuna voglia di sperimentalismo ma con il massimo del rispetto che meritano. Ferma restando la capacità della cantante di rendere al massimo ogni linea melodica, ogni più piccolo risvolto di queste immortali melodie, tra i brani siamo rimasti particolarmente colpito dal già citato “I Love Paris” per il fraseggio del pianista Ole Fredrik Norbye e il maiuscolo apporto di Nils Petter Molvaer
 Mette Henriette – “Drifting” – ECM
Mette Henriette – “Drifting” – ECM
Trio di grande spessore quello che si ascolta in “Drifting”: a guidarlo è la sassofonista Mette Henriette coadiuvata da Johan Lindvall al pianoforte e Judith Hamann al violoncello. In repertorio quindici brani tutti scritti dalla sassofonista (l’ultimo in collaborazione con Lindvall). Dopo l’album d’esordio, registrato sempre per ECM nel 2013 ma pubblicato due anni dopo, la sassofonista norvegese torna sempre in compagnia del pianista ma con l’aggiunta della validissima violoncellista Judith Hamman. L’atmosfera è quanto mai rarefatta con i tre che letteralmente distillano ogni singola nota che acquista così un peso specifico. I brani si susseguono legati da un filo ben preciso che si snoda attraverso le sapienti mani dei tre musicisti. Così se l’impianto melodico è spesso affidato alla leader, il pianoforte si incarica di sottolinearne le parti salienti con il violoncello impegnato in una non facile operazione di ricucitura. Il tutto a disegnare un quadro difficilmente classificabile: certo non si tratta di jazz nell’accezione più usata del termine, né di musica classica tout court…piuttosto di una sorta di esplorazione sonora che induce anche l’ascoltare a guardarsi dentro, a lasciarsi andare alle sensazioni che la musica gli propone. Senza preoccuparsi di capire dove la pagina scritta lascia il posto all’improvvisazione. E se anche chi ci legge seguirà questa metodologia, siamo sicuri che l’album risulterà di notevole interesse.
 Anders Jormin, Lena Willemark – “Pasado en claro” – ECM
Anders Jormin, Lena Willemark – “Pasado en claro” – ECM
Album molto impegnativo questo “Pasado en claro” in cui il contrabbassista svedese Anders Jormin, in collaborazione con la vocalist, violinista e violista Lena Willemark guida un quartetto completato da Karin Nakagawa al koto e Jon Fält alla batteria, già con il leader nel trio di Bobo Stenson. La complessità di cui in apertura è determinata dal fatto che il leader ha voluto trarre ispirazione da una serie di poeti tra i più diversi della letteratura mondiale: ecco quindi testi da antiche fonti cinesi e giapponesi, accanto a poeti scandinavi contemporanei, senza per questo trascurare lo scrittore messicano Octavio Paz (dalla cui opera è tratto il titolo dell’album) e il “nostro” Francesco Petrarca. Insomma un panorama di riferimento da far apparire impossibile una qualsivoglia unità dell’album E invece il quartetto ci riesce grazie soprattutto all’interpretazione della vocalist. Su un tappeto costituito da una valida struttura sonora ben scritta e altrettanto ben arrangiata, ricca di nuances, Lena Willemark si produce in una prova di grande maturità alternando l’uso della voce all’altro strumento a sua disposizione (il violino); esemplare al riguardo “Tho Woman of the Long Ice” musica e testo della stessa Willemark . Insomma è come se nella voce di Lena si ritrovasse allo stesso tempo, il passato, il presente e il futuro di una musica il cui flusso mai si interrompe.
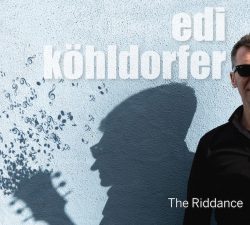 Edi Köhldorfer – “The Riddance” – Ats Records
Edi Köhldorfer – “The Riddance” – Ats Records
Personaggio sicuramente interessante questo chitarrista austriaco Edi Köhldorfer il quale, dopo aver studiato chitarra classica, ha intrapreso la strada del musicista professionista suonando nei contesti più vari, dalle orchestre classiche al folk, dal funk al pop…fino al jazz collaborando con alcuni artisti di fama mondiale come Biréli Lagrène, Dee Dee Bridgewater, Stephane Grappelli. Di qui una personalità compiuta non solo a livello musicale, esplicitata appieno in questo album che risponde ad una grande esigenza di fondo: evidenziare quanto può accadere quando musicisti di provenienza diversa si riuniscono per un comune progetto, e soprattutto liberarsi dalla schiavitù di una pandemia che ha costretto all’immobilismo moltissimi artisti. Per raggiungere questo obbiettivo, Edi ha contattato 26 musicisti di 4 continenti e nessuno si è tirato indietro dando vita ad una produzione assai particolare. Ascoltando l’album, in effetti, non si può non rilevare la gioia, la forza, l’entusiasmo il dinamismo che promana da questi brani cosicché è davvero arduo sceglierne qualcuno in particolare. Tuttavia dobbiamo ammettere che ci hanno particolarmente colpiio “Goodbye Armando” un sentito omaggio a Chick Corea con un fantastico assolo del pianista Ui Datler richiamante “La Fiesta” e “Midwest” impreziosito da un lungo e centrato assolo del bassista colombiano Juan Garcia-Herreros meglio noto come “The Snow Owl”, che suona un basso elettrico personalizzato a sei corde; all’età di 37 anni, Juan ha ottenuto una nomination, per il Latin Grammy Award nella categoria Best Latin Jazz Album, per il suo terzo CD intitolato “Normas”.
 Benjamin Lackner – “Last decade” – ECM
Benjamin Lackner – “Last decade” – ECM
Probabilmente il pianista tedesco Benjamin Lackner non è molto noto al pubblico italiano anche se può già vantare un’invidiabile carriera che lo porta ad esordire oggi in casa ECM. Lackner è tornato da poco a Berlino, dopo un lungo periodo trascorso negli Stati Uniti dove ha avuto modo di studiare con “maestri” quali Charlie Haden e Brad Mehldau. Per questo album il pianista è affiancato da tre grandi artisti: il trombettista Mathias Eick, il batterista Manu Katché e il contrabbassista Jérôme Regard, già con Lackner dal 2006. Il risultato c’è ed è a tutto tondo. In effetti appare chiaro sin dalla primissime note come l’intendimento principale del trio sia quello di proporre una musica caratterizzata dalla ricerca della linea melodica. Una linea che risulti dolce, fors’anche accattivante, ma non per questo banale o scontata. Di qui un repertorio di nove brani (tutti composti dal leader ad eccezione di “Emile” scritta da Jérôme Regard) in cui la musica scorre in perenne equilibrio fra i quattro, con nessuna voglia particolare del leader di mettersi in luce ché anzi molto spesso ascoltiamo in primo piano la bella voce della tromba di Eick sempre sorretta da una sezione ritmica assolutamente funzionale all’intento del leader. Tra i brani particolarmente suggestivo e sofisticato è “Hang Up on That Ghost” tutto giocato su un fitto dialogo tra pianoforte, batteria e contrabbasso mentre Mathias alterna la sua voce a quella della tromba con effetti di estrema delicatezza.
 Ieremy Lirola – “Mock the Borders” –
Ieremy Lirola – “Mock the Borders” –
Dopo “Uptown Desire” il contrabbassista francese si ripresenta al pubblico con questo “Mock the Borders” in cui è possibile ascoltare anche il piano di Maxime Sanchez, il sax di Denis Guivarc’h e la batteria di Nicolas Larmignat, questi ultimi due già presenti nel citato lavoro “Uptown Desire”.
Il titolo è quanto mai esplicativo: “Ridicolizza il confine” appare come una sorta di manifesto programmatico che dovrebbe informare il senso dell’album. Ma è davvero così? Francamente non ci sembra che l’artista abbia voluto andare oltre la lezione di Coleman; piuttosto la sua idea, conclamata in musica, è quella di una libertà che prescinda dalle etichette, dalle mode, per dare pieno diritto di cittadinanza ad ogni forma espressiva. Insomma per Lirola la musica tonale può coesistere con escursioni nel mondo del free. Di qui un album dai colori cangianti, dalle atmosfere variegate in cui si avverte l’urgenza di nulla trascurare delle passate esperienze: guadare avanti non significa necessariamente trascurare ciò che c’è stato e che continua ad esserci. Insomma una visione oserei dire filosofica e non solo musicale che informa questo interessante lavoro. Tra i vari brani eccellente l’apertura con “Mock the lines” impreziosito dal lavoro del sassofonista. Ma nello svolgimento dell’album il leader lascia ampio spazio ai compagni d’avventura che hanno così modo di esprimere appieno le proprie potenzialità.
 Stephan Micus – “Thunder” – ECM
Stephan Micus – “Thunder” – ECM
Nessuna sorpresa per questo ennesimo ottimo album di Stephan Micus, un vero ricercatore di note che abbiamo imparato ad ammirare oramai nel corso di lunghi anni. Questa volta il suo interesse si focalizza, come da lui stesso sottolineato, sulla musica dei monasteri tibetani, meta di molte visite da parte del musicista. Stephan rimane particolarmente colpito dal particolare strumento che si usa in queste cerimonie, il dung-chen, una sorta di tromba lunga circa quattro metri, cui affianca il ki kun ki, uno strumento a fiato – ci spiega lo stesso Micus – molto semplice, costruito con un unico stelo ligneo che cresce in alcune foreste siberiane del lontano Oriente e il nahkan, una specie di flauto di provenienza giapponese. Mescolate questi straordinari elementi e la ricetta è pronta: una musica ancora una volta affascinante, dai suoni allo stesso tempo primordiali e di attualità che ci trasportano in un mondo virtuale apparentemente alla nostra portata ma che mai riusciamo ad abbracciare davvero. E credo sia questo il segreto di Micus: sintetizzare gli universi musicali più disparati per ricondurli ad una unità senza spazio, senza tempo ove solo il suo credo ha diritto di cittadinanza. Per tornare al contenuto dell’album è comunque lo stesso Micus a fornirci una chiave di lettura ove afferma che l’album è dedicato alla grande famiglia delle divinità dei tuoni cui hanno creduto intere popolazioni con la speranza che il loro distruttivo potere possa in qualche modo essere placato dalla musica.
 Arvo Pärt – “Tintinnabuli” – Billant Corners
Arvo Pärt – “Tintinnabuli” – Billant Corners
Con il termine “Tintinnabuli” ci si intende riferire allo stile compositivo creato dal compositore estone Arvo Pärt, introdotto nella sua “Für Alina” (1976) e riutilizzato in “Spiegel im Spiegel” (1978). Caratteristiche che ritroviamo appieno in questo splendido album che vede come protagonisti Jeroen van Veen al piano, Joachim Eijlander al violoncello e in un brano la moglie di Jeroen, Sandra van Veen, anch’essa pianista. L’album è una sorta di summa delle caratteristiche che hanno sempre connotato la musica di Arvo Pärt, vale a dire la quiete estatica e il saper racchiudere lo spirito dei tempi grazie anche alle esperienze mistiche con la musica dei canti religiosi. Risultato: composizioni senza tempo che appaiono in egual misura antiche e contemporanee, religiose e profane, non immuni da una marcata influenza da parte del movimento minimalista. L’album si apre con “Fratres” cui fa immediatamente seguito uno dei brani più importanti di Arvo, quel “Für Alina” cui si è già fatto cenno. “Ukuaru Valss” ci fa conoscere un lato più “leggero” della personalità di Pärt mentre il conclusivo lungo “Partomania” è preceduto da “Spiegel im Spiegel” anch’esso citato in precedenza quale pietra miliare nel percorso compositivo dell’artista estone: ascoltandolo ancora oggi, dopo tanto tempo, impressiona il modo in cui le note sono letteralmente distillate una dopo l’altra a conferma di una maestria compositiva difficilmente eguagliabile.
 Sebastian Rochford, Kit Downes – “A Short Diary” – ECM
Sebastian Rochford, Kit Downes – “A Short Diary” – ECM
Ecco un album non facile da recensire in quanto gli usuali strumenti che si adoperano per illustrare una produzione discografica, in questo caso non sono sufficienti. In ballo ci sono, infatti, motivazioni che vanno ben al di là del fatto musicale e che coinvolgono direttamente i sentimenti più profondi di Rochford, non a caso compositore di tutti i brani in programma. In effetti l’album è una appassionata e sentita dedica che il cinquantenne batterista scozzese rivolge al padre, Gerard Rochford, grande poeta morto nel 2019. Alla luce di questa realtà, la musica assume una valenza tutta particolare. E’ facile immaginare come l’autore, nello scrivere, si sia lasciato andare ai ricordi della sua infanzia, degli anni trascorsi con il padre e di ciò che questo ha voluto dire per la sua crescita. Di qui l’originalità di un discorso che ha una sua compiutezza dall’inizio alla fine, ben sorretto dal partner di Rochford, ovvero Kit Downes che in precedenti occasioni aveva evidenziato tutto il suo talento. Talento che qui si manifesta nell’aver saputo mirabilmente arrangiare il tutto costruendo un coinvolgente percorso melodico-armonico in cui non esageriamo affermando che sotto alcuni aspetti ascoltare questo album è come sfogliare un album le cui pagine sono costituite dai ricordi dolcemente custodite da Sebastian. Quanto ai brani particolarmente significativo “Our Time Is Still”: un pezzo essenziale, scarnificato fino al limite massimo, tutto giocato sulla sottrazione ma con una carica di tristezza, di emozionalità, di sentimento davvero toccante.
 Rubber Soul Quartet – “Something” – Losen
Rubber Soul Quartet – “Something” – Losen
E’ ancora possibile eseguire in chiave jazzistica un repertorio ‘beatlesiano’ senza scadere nel già sentito, nello scontato? Certo che sì, ma si tratta sicuramente di un’impresa estremamente complessa dato che i brani dei Beatles oramai da molti anni sono entrati nel repertorio di grandi jazzisti. A provarci, adesso, sono quattro musicisti norvegesi, Bård Helgerud chitarra e vocale, Håvard Fossum sax, flauto, clarinetto, Andreas Dreier contrabbasso e e vocale, Torstein Ellingsen batteria e percussioni. In cartellone, come già accenato, undici composizioni dei Beatles per un viaggio all’indietro che si preannuncia tanto entusiasmante quanto colmo di insidie. Il quartetto cerca di evitare gli scogli proponendo una chiave di lettura originale: combinare le melodie ben note con arrangiamenti che si rifanno espressamente alla lezione dei grandi jazzisti made in USA, il tutto condito da una forte carica di swing e una buona dose di improvvisazione. Obiettivo raggiunto? Francamente non del tutto in quanto, indipendentemente dall’arrangiamento, la carica melodica dei brani è troppo forte cosicché resta lì, a farla da padrona e quindi a spedire in secondo piano esecuzione e arrangiamento, a meno che non si tratti davvero di grandi musicisti quali, tanto per fare due soli nomi, Brad Mehldau e Sarah Vaughan
 Salon Odjilà – “TangoRomaBalkanJazz” – ATS Records
Salon Odjilà – “TangoRomaBalkanJazz” – ATS Records
Un’elegante mistura di oriente e occidente, di jazz e folk, di euforia e malinconia definisce il clima di questo album interpretato da un quartetto di assoluto livello: Wolfgang e Werner Weissengruber sono multistrumentisti che oramai da anni si dedicano con passione al jazz, Manuela Kloibmüller è fisarmonicista che frequenta con assiduità sia i terreni classici sia quelli jazz nonché vocalist di riconosciuto spessore, Matthias Eglseer è batterista fantasioso e preciso (lo si ascolti, ad esempio, in “Cetvorno Sopsko Horo”). In repertorio tre classici di Piazzolla, un originale di Wolfgang Weissengruber e sei ‘traditional’. Ciò premesso la musica rispetta perfettamente le premesse contenute nel titolo vale a dire un tango ma con quel forte imprinting che caratterizza la musica balcanica. Ciò grazie ad arrangiamenti particolarmente indovinati che riescono a valorizzare appieno l’originalità del gruppo anche quando si avventura su pezzi non sempre consigliabili. E’ il caso dei tre brani di Piazzolla e in particolare di “Libertango” il brano forse più celebre del compositore argentino: introdotto dal contrabbasso, il brano prende man mano spessore con la Kloibmüller che si produce in un vibrante assolo ben sostenuta da tutto il gruppo per una interpretazione convincente.
 Solis String Quartet & Sarah Jane Morris – “All You Need Is Love” – Irma
Solis String Quartet & Sarah Jane Morris – “All You Need Is Love” – Irma
E dopo il cd del Rubber Soul Quartet ecco un altro album interamente dedicato ai Beatles. Ad interpretare le melodie di John Lennon e Paul McCartney è però questa volta una delle voci, a nostro avviso, più belle e convincenti dell’intero panorama vocale internazionale. Oramai sulla cresta dell’onda da molti anni, la Morris mai delude; chi scrive l’ha sentita in concerto svariate volte e ha sempre trovato un’artista straordinariamente generosa, capace di interpretare ogni brano alla sua maniera andando a visitare anche le più intime pieghe delle melodie senza trascurarne la valenza ritmica. E la stessa cosa accade anche questa volta: la vocalist affronta ogni tema con gande rispetto ma allo stesso tempo con la sicurezza che le deriva da tanti anni di carriera. Di qui interpretazioni che senza alcunché togliere all’originale fascino, rivestono i brani di una veste originale. Il che, non sarebbe stato possibile, se la vocalist non fosse stata adeguatamente supportata da uno straordinario Solis String Quartet, al secolo Vincenzo Di Donna e Luigi De Maio, violini, Gerardo Morrone viola e Antonio Di Francia cello e chitarra, con quest’ultimo impegnato in una preziosa opera di ri-arrangiamento che non ha fatto sentire la mancanza di quella sezione ritmica, viceversa tanto importante nella produzione originale. Tra i brani particolarmente riuscita la versione di “The Fool on The Hill” che resta una delle più belle composizioni dei Beatles.
Gerlando Gatto
da Redazione | 06/Dic/2022 | Interviste, Primo piano
Il “Salotto Rosso” è la rubrica di interviste a cura di Daniele Mele: esponenti del Jazz italiano e internazionale parlano della propria visione musicale e del loro percorso artistico. In questa puntata, Roberto Bottalico racconta l’Alter&Go Project e il suo nuovo album: Il Favoloso Mondo di Wayne Lo Strambo.
– Roberto, a che età hai iniziato a studiare sassofono?
“Fine liceo, 17-18 anni, a scuola. Il Jazz non sapevo neanche cosa fosse, all’inizio ascoltavo Progressive: Genesis, King Crimson…”.
– Classica e progressive? O solo progressive?
“No, classica dopo. Rock, progressive… comunque avevo 17 anni. Il percorso è stato Pearl Jam, Nirvana, The Doors, Led Zeppelin. Poi mi sono diplomato al liceo e ho iniziato Lettere a indirizzo Spettacolo all’università. Non era per me”.
– Indirizzo Spettacolo perché c’era già un’indole artistica?
“Sì, sempre andato a vedere concerti. E iniziavo a suonicchiare… e ad ascoltare Jazz, Blues. Ho iniziato ad andare a lezione da Deidda, Sandro”.
– Il fratello di Dario e Alfonso
“Sì. Dopo un po’ di tempo ho pensato di voler fare uno studio più accademico del sassofono, e lui mi indirizzò verso il Conservatorio (classico allora, non c’era Jazz). Io non conoscevo niente del mondo dei Conservatori, a casa mia non c’era una gran cultura musicale, al massimo si ascoltava Battisti. La prima volta che sono andato al Conservatorio mi hanno iniziato a parlare di orari di segreteria e di esami, ma io avevo bisogno di parlare con un docente. Un giorno mi sono presentato con il sassofono, ho detto che avevo lezione con il Maestro e son salito da lui. E lui mi ha detto “Ok, entra da me” “.
– Ah così è andata?
“Sì, selvaggio proprio! (si ride) È che lui mi disse: “Sei troppo grande, al Santa Cecilia non hai possibilità, ci sono tre posti, prendono i minorenni” e io avevo questo sassofono da duecento euro. “A Perugia ci sono più cattedre, per te che suoni il tenore è più semplice”. Faccio l’ammissione ed entro con Mario Raia, la svolta della mia vita. Se non avessi incontrato lui, io non avrei fatto il musicista”.
– Ah sì?
“Mi ha insegnato che dipendeva solo da me, se volevo migliorare. È stata dura, sia psicologicamente che praticamente, perché ero solo con me stesso e questo rapporto interiore mi devastava… e io studiavo come un matto ma non bastava, 10 ore nette al giorno, le cronometravo e cercavo sempre di allungare i tempi degli esercizi. Il più grande insegnamento di Mario è stato il rispetto per la musica. Una volta mi disse: “Devi suonare il pezzo e cercare di comunicare sempre una sensazione, anche se è una Polka”. Non avrei capito molte cose senza di lui… anche perché sono entrato al Conservatorio già grande, a 23 anni. Mi ha salvato. Alla fine ho apprezzato il suo modo di fare, mi è stato dietro anche in momenti difficili. Mi ha fatto diventare un musicista”.
– E il recente percorso di studi ti ha portato al biennio a Santa Cecilia.
“Sì, e lì ho avuto una conferma che le cose che scrivevo piacevano. Potevo fare quello che volevo, e ho iniziato ad osare di più”.
– Ma tu già suonavi Jazz, anni prima, e pure parecchio bene.
”Sì sì, però lì mi sono realizzato completamente… soprattutto a livello compositivo. Al Conservatorio ho avuto dei riconoscimenti, in occasione della mia tesi, in cui ho portato un libro che ho scritto su Shorter e sui suoi principi compositivi e da cui nasce quest’ultimo disco “Il Favoloso Mondo di Wayne lo Strambo”. Anche grazie agli insegnanti che ho incontrato, in primis Pietro Leveratto che mi ha dato molta fiducia e molte idee, Fabio Zeppetella e Alfredo Santoloci, ho capito che nella musica potevo essere sincero con me stesso. Prima andavo alle Jam e studiavo il linguaggio, linguaggio, linguaggio… certo, la tradizione mi è servita, ma adesso suono come voglio. E non è che io sia innovativo, perché hanno fatto tutto, però mi sento libero di suonare come suono. Ho iniziato un percorso di elaborazione improvvisativa prima del conservatorio e qui ho capito che avevo delle particolarità che potevo sfruttare”.
– Ti sei accorto che tanto più eri spontaneo tanto più eri apprezzato.
“È quello! Ho sempre fatto un lavoro sugli accordi, su idee armoniche personali che escono quando improvviso. Ci inculcano che dobbiamo essere sempre simili a qualcuno, ma io non posso suonare frasi di altri. Anche io mi ispiro ai grandi del jazz da cui prendo idee, non se ne può fare a meno, ma un conto è prendere, capire e rielaborare e un conto è l’imitazione. Non posso suonare solo standards”.
– Perché no? Perché sono stati già fatti troppo bene da troppi musicisti?
“Ma sì, li devo stravolgere, come se fosse un gioco. O sei Brad Mehldau, oppure… Per me gli standards vanno studiati, sono la tradizione che va prima conosciuta e da cui successivamente ci si può allontanare. Sono un veicolo per comunicare con gli altri, a sei vai a suonare a un festival importante ti devi presentare con un’idea tua, personale”.
– Certo. E preferisci esporti con pezzi originali piuttosto che con i soliti standards che tutti conoscono.
”Suonerei sempre pezzi originali se possibile, anche non miei volendo”.
– E in tal senso, ci sono dei musicisti che ti ispirano o che ti hanno ispirato a seguire questo “modo di fare musica”?
“Che sono in vita? In Italia… Manlio Maresca, lui fa tipo Punk-Jazz e secondo me ha moltissimo da dire. Anche Daniele Tittarelli è un grande, ma ce ne sono tanti altri… però ci sono altri che sono bravissimi, ma non hanno niente da dire”.
– Sono d’accordo, ma non basta.
“Non basta. Ormai chiunque suona è bravissimo, il sistema non premia chi è spontaneo ma premia chi si sa muovere, e ovviamente i talenti veri, che escono anche se non parlano con nessuno”.
– Che tipo di ascolti fai oggi?
“Io ascolto il Jazz che si ispira ai dischi Blue Note degli anni ’60. Coltrane, Hancock, Shorter… Shorter mi ha detto che potevo fare quello che volevo, basta che avesse un senso”.
– Sembra una cosa semplice. (si ride)
“Eh, certo. Scrivo dei brani a volte che armonicamente non si capiscono. Basta II-V-I, basta il V che va al primo, basta. Si gioca con gli accordi, è divertente, è artistico. Uso diversi metodi per unire gli accordi che non sono quelli del jazz standard, come il legame delle note guida, dare importanza alle singole note che insieme creano accordi e melodie, cercando di trovare un suono giusto completando la qualità degli accordi”.
– Quando devo scrivere una canzone Pop, io personalmente mi avvicino prima alla chitarra. Quando devo scrivere un tema strumentale, passo per il pianoforte. C’è una sorta di canovaccio che segui per la realizzazione di un brano, o di un album? Come si arriva alla fine?
“A volte non c’è niente. A volte c’è solo un’idea, ed è armonica. E passa sempre prima per il pianoforte, infatti i miei temi non sono mai tecnicamente difficili, perché inizio a comporre sulla tastiera e sono tecnicamente scarso. Sul disco ci sono due brani intitolati Giant Half Steps, e non c’entrano niente con Giant Steps, anche se gli accordi vengono da lì. Sono un esercizio, un lavoro mio fatto su quegli accordi. E nel comporre mi interessa più il lavoro “di concetto” che “di estetica”. Questi brani, per esempio, si chiamano così perché il tema è una sperimentazione cromatica sul giro armonico di Giant Steps. Parte sempre tutto da un’idea, un concetto con uno sviluppo in musica: così mi piace. Alter Shorter, il terzo brano, è stato scritto perché volevo approfondire gli accordi maj7(#11), senza accordi di dominante, tutto con quel suono. Ho scelto un suono, il tema è lento e melodico, e si ripete, tipo Nefertiti di Shorter stesso. Io scrivo molto dissonante, ma i temi sono melodici, creo un movimento che prepara all’ascolto”.
– E passi per il sassofono solo alla fine, in questo processo.
“Alla fine sì, se serve”.
– La parte compositiva è al piano. Perché sulla tastiera hai una visione “geometrica” del pezzo, oppure…?
“Il tema completa sempre gli accordi. Poi, prendo il sassofono per vedere come è in velocità, e improvviso, e qualcosa cambia”.
– Al sassofono si concretizza la parte più creativa. Quella più… autentica?
“Sì. Non è “bella questa frase, ora ci faccio un pezzo” quanto “bello questo giro, ora ci faccio un pezzo”. Voglio fare un pezzo “con questo suono”, voglio sviluppare quest’idea/concetto in musica”.
– Molto interessante Roberto. La melodia viene dopo, è a funzione del brano. Pensi che questo posso contribuire a rendere le melodie più interessanti? Perché, dal mio punto di vista, se parti dalla melodia ti incaselli, anche se comunque seguendo il tuo gusto musicale, in una sorta di “catologo di idee melodiche” già preconfigurato. Invece, partire da un suono che ti stuzzica e poi “forzarsi” a costruire una linea che faccia da collante…
“Esatto. Così sei costretto a trovare delle soluzioni diverse. Shorter ci ha detto tutto eh: la struttura, per esempio, non viene prima. La struttura viene col pezzo. Vuoi farla durare 7, 8, 13? Ha senso? E va bene, se l’artista vuole farsi capire trova un modo efficace per comunicare quella spigolosità”.
– Roberto volevo chiederti: quanto è durata la scrittura dell’album?
“I brani li ho scritti velocemente. Tre-quattro brani erano fatti, il resto è venuto in tre giorni. Alter Shorter è, secondo me, il pezzo più bello che abbia mai scritto in vita, e l’ho scritto in un due ore. Un pezzo puro, spontaneo. Anche se, ovviamente, il lavoro di studio delle sonorità è durato molto tempo”.
– E il tempo di produzione?
“Due-tre giorni, mi sono visto con il gruppo e gli ho dato temi e accordi. Alcuni brani sono cambiati in quei giorni, perché i ragazzi hanno dato il loro contributo. Non ho detto loro come si dovevano comportare, ed è stato meglio così”.
– Un bel lavoro di gruppo. Due parole sui musicisti?
“Augusto Creni mi completa, accompagna con la chitarra in un modo molto pianistico, mi asseconda a seconda del mio fraseggio come un pianista ma in modo meno “invadente” di un pianista. Il bassista Alessandro Del Signore e il batterista Massimo Di Cristofaro, sempre pronti a prendere delle idee e rinnovarle, sono, oltre che musicisti eccezionali, grandi amici ormai grazie alle molte prove che abbiamo fatto. Sono molto contento”.
Splendido. Grazie Roberto per l’intervista.
Daniele Mele
da Gerlando Gatto | 28/Apr/2022 | Eventi, News, Primo piano
Udin&Jazz ritorna nel suo luogo naturale: il capoluogo friulano ospiterà dal 12 al 16 luglio la 32° edizione di “Udin&Jazz”, a cura di Euritmica, la gloriosa manifestazione che nel corso degli anni ha assunto un’importanza sempre crescente nel pur vastissimo panorama dei festival italiani dedicati alla musica afro-americana.
Viene così archiviata la parentesi, per altro più che positiva, di GradoJazz, che per tre anni, anche in tempi di pandemia, ha portato in regione grandi stelle della musica nazionale e internazionale (King Crimson, Paolo Conte, Stefano Bollani, Gonzalo Rubalcaba, Paolo Fresu, Dee Dee Bridgewater, Brad Mehldau e molti altri…) e il successo delle due edizioni invernali di Udin&JazzWinter al Teatro Palamostre di Udine.
Ma, a mio avviso, un festival che si chiama “Udin&Jazz” trova il suo perché anche per la località in cui si svolge. In effetti molte volte mi è capitato di sottolineare come oggi un Festival del Jazz assume rilievo solo se soddisfa determinate condizioni. In primo luogo essere strettamente legato al territorio in cui si svolge, sì da valorizzarne i contenuti cultuali ed economici (prodotti tipici); in secondo luogo se, contrariamente ai “grandi festival” non si inseguono i grandi nomi solo per fare cassetta (poco importa se poi con il jazz poco o nulla hanno a che vedere) e viceversa si dà il giusto spazio ai musicisti locali. E sotto questo specifico aspetto tutte le regioni italiane potrebbero benissimo dare spazio ai tanti talenti locali solo che a Udine si fa da sempre e in molti altri posti purtroppo no.
Ciò, ovviamente, nulla toglie che si dia ampio rilievo alle stelle di primaria grandezza e più in generale a quei musicisti che si esprimono su alti livelli qualitativi. E anche da questo punto di vista Udin&Jazz non ha mai deluso, cosa che accadrà anche quest’anno visto le prime notizie che si hanno sul programma il cui dettaglio verrà presentato a breve.
In effetti si sa già che la chiusura del Festival sarà affidata sabato 16 luglio 2022 alle 21, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, ad una delle band più acclamate dello scenario del nuovo jazz contemporaneo mondiale, gli Snarky Puppy. Guidato da Michael League, il collettivo, con circa 25 musicisti in rotazione, si muove tra jazz, funk e R&B, musica scritta e improvvisazione totale e ritorna nel 2022 con un nuovo album live appena inciso, “Empire Central”, il quattordicesimo, una lettera d’amore a Dallas, il luogo dove l’avventura è iniziata nel 2004. “Empire Central”, per loro stessa ammissione, è il progetto più ambizioso e comunicativo di sempre, e arriva dopo quasi 2.000 spettacoli, 13 album, 4 premi Grammy, 8 premi JazzTimes e Downbeat e centinaia di masterclass presso istituzioni educative in tutto il mondo.
Ovviamente appena sarà varato il calendario completo avrete modo di leggerlo su questo stesso spazio.
U&J è ideato e organizzato dall’Associazione Culturale Euritmica e gode del sostegno di: Regione FVG, Fondazione Friuli, Reale Mutua Assicurazioni Udine Franz&Dilena, Banca di Udine, oltre agli importanti partenariati con Radio 1 Rai, Radio 3 Rai e Rai FVG. Udin&Jazz è altresì gemellato con alcuni tra i più prestigiosi festival jazz europei, come quello di Vienne in Francia, di cui è partner nell’organizzazione della 3a edizione di JazzUp.
Gerlando Gatto










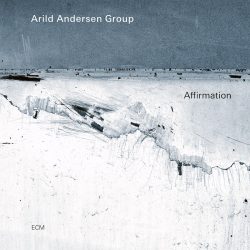 Arild Andersen Group – “Affirmation” – ECM
Arild Andersen Group – “Affirmation” – ECM Onur Aymergen Quintet – “Lunar” – Losen
Onur Aymergen Quintet – “Lunar” – Losen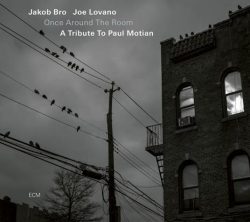 Jakob Bro, Joe Lovano –“Once Around The Room” – A Tribute to Paul Motian” – ECM
Jakob Bro, Joe Lovano –“Once Around The Room” – A Tribute to Paul Motian” – ECM Eik Trio – “Eik Trio” – Losen
Eik Trio – “Eik Trio” – Losen Mette Henriette – “Drifting” – ECM
Mette Henriette – “Drifting” – ECM Anders Jormin, Lena Willemark – “Pasado en claro” – ECM
Anders Jormin, Lena Willemark – “Pasado en claro” – ECM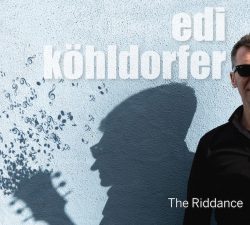 Edi Köhldorfer – “The Riddance” – Ats Records
Edi Köhldorfer – “The Riddance” – Ats Records Benjamin Lackner – “Last decade” – ECM
Benjamin Lackner – “Last decade” – ECM Ieremy Lirola – “Mock the Borders” –
Ieremy Lirola – “Mock the Borders” –  Stephan Micus – “Thunder” – ECM
Stephan Micus – “Thunder” – ECM Arvo Pärt – “Tintinnabuli” – Billant Corners
Arvo Pärt – “Tintinnabuli” – Billant Corners Sebastian Rochford, Kit Downes – “A Short Diary” – ECM
Sebastian Rochford, Kit Downes – “A Short Diary” – ECM Rubber Soul Quartet – “Something” – Losen
Rubber Soul Quartet – “Something” – Losen Salon Odjilà – “TangoRomaBalkanJazz” – ATS Records
Salon Odjilà – “TangoRomaBalkanJazz” – ATS Records Solis String Quartet & Sarah Jane Morris – “All You Need Is Love” – Irma
Solis String Quartet & Sarah Jane Morris – “All You Need Is Love” – Irma










