da Gerlando Gatto | 12/Lug/2022 | Eventi, News, Primo piano
Varie produzioni in esclusiva europea e prime assolute per un totale di ben 10 produzioni orchestrali, 6 Direttori d’Orchestra, 110 concerti dislocati in 4 luoghi diversi tra il Teatro di Verdura, il Real Teatro Santa Cecilia, il Complesso Santa Maria dello Spasimo e il Palazzo Chiaramonte, conosciuto come Steri, sede dell’Università cittadina: questa, in poche ma eloquenti cifre, la carta d’identità del Sicilia Jazz Festival che in dodici giorni (dal 24 giugno al 5 luglio) ha trasformato Palermo in una sorta di mecca del jazz.
La capitale della Sicilia è stata come invasa da un’ondata di musica che ha interessato migliaia e migliaia di spettatori che hanno ascoltato con interesse i tanti concerti proposti. Peccato che nessuno di noi possegga il dono dell’ubiquità in quanto, ad esempio, avrei assistito assai volentieri alle performances di Dino Rubino, Giacomo Tantillo, Giuseppe Milici…tanto per fare qualche nome.
-

-
Snurky Puppy
-

-
Simona Molinari
Altra caratteristica del Festival: il ruolo dato all’ Orchestra Jazz Siciliana che ha avuto l’onore e l’onere di accompagnare alcuni dei grandi solisti presenti al Festival, e la possibilità fornita ai giovani musicisti dei conservatori siciliani di esibirsi finalmente in pubblico. Ed è proprio questa attenzione ai talenti locali che rende un Festival del Jazz degno di essere pensato, realizzato e sostenuto con fondi pubblici. In effetti il Festival, organizzato dalla Regione Siciliana – Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo – con il coordinamento artistico affidato alla Fondazione The Brass Group, istituita con legge del 1° febbraio 2006, n. 5, si avvale della preziosa collaborazione del Comune di Palermo, dell’Università di Palermo, delle produzioni originali del Brass Group e degli apporti dei Dipartimenti jazz dei Conservatori “Alessandro Scarlatti” di Palermo, “Arcangelo Corelli” di Messina, “Antonio Scontrino” di Trapani, “Arturo Toscanini” di Ribera e dell’Istituto superiore di studi di musica “Vincenzo Bellini” di Catania. L’obiettivo: come si accennava, coinvolgere in una concreta sinergia strutturale le istituzioni didattiche regionali, i musicisti del territorio e le maestranze locali.
Ma veniamo adesso al lato più strettamente musicale.
Per motivi di lavoro ho potuto assistere solo agli ultimi cinque concerti, tutti comunque di spessore e tutti svoltisi nel magnifico scenario del “Teatro di Verdura”
Ma procediamo con ordine. Il primo luglio è stata di scena la vocalist Dianne Reeves con il suo quintetto completato da John Beasley al piano, Romero Lubambo alla chitarra, Itaiguara Brandao al basso e Terreon Gully alla batteria. A parere di chi scrive, la Reeves è oggi una delle voci più interessanti, suggestive, personali del mondo del jazz e tutto ciò è stato ampiamente evidenziato anche durante il concerto palermitano. Ben supportata dal gruppo, la Reeves ha sciorinato un repertorio godibile dalla prima all’ultima nota in cui le parole lasciavano spesso campo libero a vocalizzi che richiamavano la grande tradizione del canto afro-americano. A conferma della versatilità di un’artista che oltre a vincere vari Grammy Awards (gli ultimi nel 2006, per la colonna sonora del film “Good night, and good luck” diretto da George Clooney, e nel 2015, per l’album “Beautiful life” dopo i precedenti quattro conquistati nel 2001, 2002, 2003 e 2006), in questo ultimo scorcio di tempo si è maggiormente concentrata, come si diceva, sul solco tracciato da voci leggendarie quali quelle di Billie Holiday, Ella Fitzgerald e, soprattutto, di Sarah Vaughan, cui tempo fa ha dedicato un intenso omaggio discografico. Tra le interpretazioni più convincenti le originali versioni di “Morning has broken” scritta da Cat Stevens e “Talk” di Pat Metheny. Insomma un concerto straordinario, sicuramente tra i migliori ascoltati a Palermo, che resterà sicuramente nel cuore e nella mente di chi, come il sottoscritto, ha avuto il piacere di parteciparvi.
-

-
Dianne Reeves
-

-
Ivan Lins e Jane Monheit
Il giorno dopo grande attesa per il concerto di Ivan Lins con Jane Monheit e l’Orchestra Jazz Siciliana, diretta dal maestro Riina. Ora, fermo restando il piacere di aver riascoltato dopo un po’ di tempo Ivan Lins, devo confessare che sono rimato un po’ deluso dall’andamento del concerto. Ed il perché è presto detto: Ivan Lins ha scritto vagonate di musica e quindi mi sarei aspettato di ascoltarlo quasi totalmente in brani di sua composizione. Invece ci ha offerto versioni di brani già iper-noti come “Dindin”, “Insensatez”, “Garota de Ipanema”, “Check to check” che nulla tolgono ma nulla aggiungono alla statura di un artista che, come si diceva, si caratterizza per essere non solo un grande performer ma anche – e forse soprattutto – per le sue straordinarie capacità compositive. Ovviamente non sono mancate sue composizioni ma non abbastanza.
Bene Jane Monheit che ha messo in mostra una bella voce, ben intonata ed equilibrata, accompagnata da una sicura presenza scenica. Altro elemento positivo, il ruolo dato ad alcuni solisti dell’orchestra quali Gaetano Catiglia e Fabio Riina alle trombe, Francesco Marchese e Alex Faraci al sax tenore, Claudio Giambruno e Orazio Maugeri al sax alto, Salvo Pizzo al trombone, Elisa Zimbardo alla chitarra.
Durante l’esibizione di Ivan Lins un siparietto simpaticamente comico: mentre il cantante brasiliano intonava la sua “Ai, Ai, Ai, Ai, Ai” il maestro Riina scivolava senza alcuna conseguenza ma dando così corposa consistenza al titolo del pezzo.
Eccellente prova il 3 luglio della vocalist Simona Molinari accompagnata dall’Orchestra Jazz Siciliana, diretta dal maestro Vito Giordano. A mio avviso la Molinari matura di giorno in giorno in quanto riesce sempre meglio ad attare le sue notevolissime capacità vocali al repertorio che ha scelto di presentare. Un repertorio che sembra fatto apposta per accontentare sia il pubblico del jazz (con una serie di straordinari pezzi quali “Fly Me To The Moon”, “All Of Me”, “The Look Of Love”, “Summertime”) alternate con pezzi più vicini ai giorni d’oggi come “Fragile”. Ma intendiamoci: ciò nulla toglie alla cantante che anzi, come si accennava, evidenzia una versatilità che sicuramente le gioverà nel corso di una carriera già luminosa. Non a caso il suo concerto a Palermo è stato tra i più applauditi con numerose richieste di bis.
Il 4 luglio un mostro sacro del jazz, Christian Mc Bride; quando si parla di questo artista è difficile definirlo dal momento che si tratta di un grande virtuoso del contrabbasso, ma allo stesso tempo di un grande compositore, grande arrangiatore, eccellente didatta e, ciliegina sulla torta, direttore artistico del Newport Jazz Festival. Nato a Filadelfia il 31 maggio 1972, in soli 50 anni ha avuto una carriera davvero incredibile. E come i grandi artisti, fuori dal palco è una persona estremamente gentile e disponibile concedendomi una lunga intervista che pubblicherò nei prossimi giorni.
-

Venendo al concerto di Palermo, McBride ha evidenziato tutti gli aspetti della sua variegata personalità, suonando magnificamente il contrabbasso ma allo stesso tempo presentando alcune sue composizioni da lui stesso arrangiate per big band e dediche particolarmente sentite: è il caso di “Killer Joe” di Benny Golson, del sempre splendido “Spain” di Chick Corea, “Full House” di Wes Montgomery, “I Should Care” di Axel Stordahl, Paul Weston e Sammy Cahn mentre l’altro hit, “Come Rain or Come Shine” è stato interpretato con bella pertinenza dalla moglie di Christian, Melissa Walker. Quasi inutile sottolineare come la performance di McBride sia stata salutata con applausi a scena aperta da parte dal numeroso pubblico che, d’altro canto, non ha fatto mancare il proprio supporto ai numerosi solisti dell’orchestra che grazie agli arrangiamenti di McBride hanno avuto l’opportunità di mettersi in luce.
Gran finale il 5 luglio con Snarky Puppy ovvero la band del momento. Nato nel 2004 come progetto estemporaneo di un gruppo di studenti di un college del Texas, il collettivo statunitense che ruota attorno al perno costituito dal bassista, compositore e produttore Michael League (la formazione è variabile e a volte comprende anche alcune dozzine di musicisti) ha consolidato il percorso artistico non solo con dischi accolti assai bene da pubblico e critica, ma soprattutto attraverso un’attività live che sembra costituire la loro dimensione ideale. Dimensione che è stata pienamente confermata dal concerto palermitano in cui il gruppo si è presentato in nonetto. Ma questo appuntamento è risultato particolarmente interessante in quanto il gruppo ha presentato tutta musica nuova, una serie di brani che andranno a costituire il prossimo lavoro discografico. Come al solito la loro musica è risultata coinvolgente essendo il risultato di una ricerca che riesce a mescolare jazz, fusion, funk, prog e rhythm’n blues in una miscela con cui hanno rapidamente scalato le classifiche discografiche di questi ultimi tre lustri, conquistando anche vari Grammy Awards.
Gerlando Gatto
da Redazione | 04/Apr/2022 | Interviste, News, Primo piano
È con vero piacere che “A proposito di jazz” accoglie tra i suoi collaboratori un giovane musicista appena laureato con 110 e lode al Conservatorio di Latina. Il suo nome: Daniele Mele. Daniele, classe ’97, inizia a studiare pianoforte all’età di 13 anni. Dopo una doverosa formazione classica con il M. Ilaria Liberati intraprende gli studi Jazz presso il Conservatorio “O. Respighi” di Latina sotto la guida del M. Andrea Beneventano, dove, come si diceva si diploma con lode. Approfondisce gli studi con Andrea Rea, Roberto Bottalico, Ignasi Terraza, Kevin Harris, e si forma seguendo masterclass di Jazz e di musica classica in tutta Italia (Berklee, Siena Jazz, Arcevia Jazz, etc.).
L’inizio di questa collaborazione con il nostro blog è di quelli che lasciano il segno: si tratta, infatti, di una approfondita intervista con Kenny Barron, pianista e compositore tra i più importanti ancora sulla scena.
Nato a Filadelfia, il 9 giugno 1943, Kenny si esibisce da quando aveva quindici anni e in tutto questo arco di tempo ha saputo sviluppare uno stile personale che lo colloca tra i grandi della tastiera di tutti i tempi: ancora oggi le sue registrazioni con Stan Getz nulla hanno perso dell’originario fascino così come quelle del gruppo Sphere di cui nel 1980 fu uno dei fondatori, con Charlie Rouse (sax), Buster Williams (basso) e Ben Riley (batteria).
E, alla grandezza dell’artista, si è sempre accompagnata una statura umana di straordinaria dolcezza: chi scrive queste note ha avuto l’opportunità di intervistarlo oramai parecchi anni fa e ne conserva un ricordo bellissimo dovuto proprio alla gentilezza e alla disponibilità dell’uomo. Gentilezza e disponibilità che dimostra appieno in questa intervista che pubblichiamo qui di seguito. (G.G.)
-

-
Kenny Barron, Daniele Mele
-

-
Kenny Barron
Ore 9:00 (New York) il giorno 25/04/2021.
-Sono molto emozionato in questo momento e la ringrazio per avermi concesso quest’intervista.
“Oh, è un piacere”.
–Prima parlavo con mio padre, gli stavo dicendo che credo ci sia una grande differenza tra musica jazz e musica pop: se voglio parlare con un “nome importante” del Jazz posso avere qualche possibilità di farlo, mentre credo che se volessi parlare con un idolo del pop avrei maggiori difficoltà.
“Sì, lo penso anch’io”. (ride)
-Sì… il jazz è più popolare del pop!
“È vero”.
–Mi fa piacere sapere che sta bene. Vorrei chiederle della vaccinazione, perché so che si è vaccinato: è andato tutto bene?
“Oh sì, ho avuto due dosi di Moderna. Due dosi, quindi… ora sono a posto”.
-Benissimo. Questo è un periodo assurdo!
“Sì, lo è”.
-Se non le spiace, parleremo di alcuni punti che mi interessano particolarmente. So che ha suonato in Italia ad Umbria Jazz con numerosi musicisti, e mi piacerebbe sapere quale fu la sua prima volta qui e perché.
“La prima volta in Italia fu… wow… nel 1963? ’63 o ’64, ero con Dizzy Gillespie. Sì, eravamo a Milano”.
-Era una tappa del tour che faceste in giro per il mondo?
“Sì, suonammo in Piazza Duomo e la cattedrale è incredibilmente bella. Quella fu la prima volta”.
-Le piace l’Italia?
“La amo. La gente, il popolo… non si può mangiare male in Italia. È veramente difficile!”.
–È vero. E invece cosa mi dice del suo rapporto con la musica italiana? Per esempio, io sono di Napoli, nel Sud Italia. Sono cresciuto ascoltando “O sole mio” e “Tu sì ‘na cosa grande”. Conosce queste canzoni?
“Oh sì, le ho sentite tante volte. Non ho mai saputo i nomi dei compositori, ma le ho sentite tante volte”.
-Ok! Ha qualche aneddoto particolare dell’Italia, o ci sono musicisti di sua conoscenza qui?
“Ah… beh, ovviamente una delle mie persone preferite è Dado (Moroni, NdT). Abbiamo suonato insieme in duo, e numerose volte abbiamo fatto dei tour suonando la musica di Monk, eravamo quattro pianisti. A dire il vero abbiamo un progetto insieme per il prossimo anno, penso a Budapest… ho suonato con lui tante volte, e gli voglio bene. La prima volta che ho incontrato Dado è stata ad un seminario in una città vicino Genova, Nervi.
-Stava partecipando ad un seminario su di lei?
“No no, in realtà era il mio interprete!”.
-Ah, bello! (si ride)
“Siamo diventati presto amici, e lì l’ho sentito suonare per la prima volta. In realtà c’era una jam session ogni sera lì al club. Andai per sentirlo suonare e ne rimasi affascinato, è un musicista incredibile… anche con contrabbasso e batteria!
-Oh… non lo sapevo!
”Oh sì, lo assumerei! Per suonare il contrabbasso, e lo assumerei anche per suonare la batteria”.
-Interessante…
“E ho fatto una registrazione con Stefano, Stefano Di Battista, alcuni anni fa. E il contrabbassista, di cui non ricordo il nome ora…”
-Forse Rosciglione? Giorgio o Dario Rosciglione?
“Oh, no. Li conosco, padre e figlio. Era un musicista più giovane. Comunque tutti bravi musicisti”.
-Bene. Adesso mi piacerebbe parlare con lei dei tre album che amo. Il primo è “Canta Brasil”. Lo adoro! Sa, ballo salsa e bachata con la mia fidanzata…
“Ah-ah, wow!”.
–Sì, ballavo prima del Covid ovviamente, ora è tutto chiuso. Ma mi piace, perciò quando ascolto questo tipo di ritmi inizio a ballare e a muovermi. Mi è davvero piaciuto quell’album, e sbaglio se affermo che è iniziato tutto con L’uomo, Dizzy Gillespie?
“Oh, più o meno; in realtà non suonavamo così tanti pezzi brasiliani… ma quell’esperienza è stata d’introduzione alla musica brasiliana: suonavamo “Desafinado”, “Samba De Uma Nota So”. Tuttavia, ciò che davvero mi avvicinò alla musica brasiliana fu ascoltare “Brasil ‘65”, sai… nel 1965! Stavo ascoltando la radio a San Francisco, quando passarono proprio quell’album e ne rimasi folgorato. C’erano chitarre eccezionali, poi Wanda De Sah, e il pianista, era il leader, Sergio Mendes… fu il gruppo che mi portò alla musica brasiliana. Da quel momento in poi ho lavorato con Stan Getz, che suonava molto questo tipo di musica, e poi ho fatto ricerche e ascoltato musica Brasiliana più datata, quella della scuola del Samba. Poi ho conosciuto Nilson Matta, Duduka da Fonseca e Romero Lubambo, e iniziammo a suonare e suonare insieme. Mi insegnarono molti ritmi differenti, e da dove provenivano… questi ritmi vengono dal Nord del Brasile, questi altri dal Sud. Iniziai a lavorare con loro. E così fondammo la band, Canta Brasil”.
-Mi scusi ma vorrei sapere qualcosa di più su Gillespie. Com’era al di fuori del mondo musicale? Ho iniziato a studiare il jazz un po’ di tempo fa, e lui è uno di quei grandi nomi che si devono necessariamente studiare, e da cui si deve prendere il più possibile.
“Fuori dal mondo musicale? Era un grande, davvero una persona cortese, anche molto divertente… fuori dal mondo musicale”.
-Non lo era durante la musica?
“Oh sì, era egualmente divertente! Ma molte persone pensavano che fosse solo apparenza, invece lui era così anche fuori dal palco. Era divertente, molto cortese e molto rispettoso”.
– Quindi il vostro tour mondiale si è tenuto tra il ’62 e il ’66. Che cosa mi dice rispetto alle tappe? Mi ha parlato di Milano, nel ’63.
“Sì, in Italia. Ma abbiamo suonato anche in altri posti: Copenaghen, in Svezia, Varsavia in Polonia, che al tempo era ancora comunista”.
-E fuori dall’Europa?
“Non abbiamo suonato fuori dall’Europa. Abbiamo fatto solo un tour europeo, e quella fu la prima volta che andai in Europa. Fu un inizio fantastico per me!”.
-Sì, posso immaginarlo! (si ride) Parliamo del secondo album, si intitola “Two as One”, l’album con Buster Williams.
“Oh Buster!”.
-E questo lavoro è di particolare importanza per gli italiani, perché è stato registrato a Perugia al Teatro Morlacchi.
“Sì”.
– Ricordo “All of You” e “Someday My Prince Will Come”, e l’ostinato di Buster… 40 secondi forse sul fa, e poi tutto il sound che si apre quando suona il Re basso e con tutte quelle frequenze che arricchiscono la musica. Meraviglioso!
“Certo”(ride)
-E Buster Williams? Com’è?
“Io amo suonare con Buster Williams. In effetti ho appena visto un video su di lui… non so se avete Amazon Prime in Italia”.
-Ce l’abbiamo.
“Si intitola “Bass To Infinity”. È tutto sulla sua vita, ci sono alcune interviste con Herbie Hancock, Lenny White… tutti suonavano insieme a Buster. Dura un’ora, è molto interessante. Sai lui è buddista, perciò parla della sua pratica e di molte altre cose. Ci conosciamo dal 1958, quando eravamo entrambi adolescenti a Philadelphia. Lo conosco da molto tempo, abbiamo lavorato molto insieme… è uno dei miei contrabbassisti preferiti in tutto il mondo”.
-Ho letto che ha suonato con… c’è qualcuno con cui non ha suonato? Ha suonato davvero con tutti!
“Sì, tutti. Le cantanti lo amano, ha lavorato con Nancy Wilson per molto tempo, e anche Sarah Vaughan. Questo video racconta anche delle prime volte in cui uscì per esibirsi, appena terminata la scuola superiore, con Gene Ammons e Sonny Stitt, e di quando ha dovuto avere il permesso da sua madre… dagli un’occhiata!”.
-Senz’altro. Sa… l’inizio della mia tesi di laurea contiene una frase su Philadelphia, e sul fatto che tutti i grandi musicisti sono di lì. È una specie di magia. (ridono)
“Non tutti, ma molti sono di lì! Io penso che una delle ragioni, prima di tutto, è che è molto vicina a New York, a solo due ore di guida. Perciò Philadelphia era una delle tappe principali per i musicisti che provenivano da New York, e io ricordo di aver visto Kenny Dorham e molte altre persone che semplicemente scendevano per andare a fare un concerto a Philly. E si può arrivare a Philadelphia per una sera, e poi tornare indietro quando il concerto è finito. Ai tempi aveva due Club principali che presentavano musicisti di fama mondiale, uno si chiamava Pep’s e l’altro Showboat. Vedevo ‘Trane, Yusef Lateef e Miles suonare lì, e molti altri. Philly era un luogo dove si lavorava, e penso sia per questa ragione che c’erano molti giovani musicisti, incluso me, che poi migliorarono con tutta quella musica attorno.
-Capisco.
“Philly aveva anche molti posti di lavoro per questi giovani musicisti, ci sono molti club in cui ho lavorato. Ed era una gran cosa, avere posti in cui suonare. Questo mi ha aiutato nella crescita, c’erano altri giovani musicisti con cui ho socializzato che sono ancora in giro! C’erano Sonny Fortune, beh lui è venuto a mancare ora, siamo cresciuti insieme… e Buster come sai. Philly era proprio un gran posto”.
-Il prossimo musicista di cui vorrei parlare è anche lui di Philly, e ora mi riferisco al terzo album, che è anche il mio preferito: sto parlando di “People Time”.
“Oh, Stan!”.
-Sì, questo album è la ragione per cui ho iniziato a studiare la sua musica e il suo modo di suonare il pianoforte. È vero che lui la considerava l’altra metà della mela, in senso musicale?
“Ehm, non lo so… così diceva! (ride) Beh, credo che per dirlo lo pensasse davvero. Musicalmente eravamo… empatici? Avevamo un approccio alla musica simile, la melodia era importante”.
-Sì! Sa Kenny, ho sempre l’impressione che quando Stan smette di suonare lei continui a suonare il sassofono ma usando il piano, e viceversa.
“Ah!” (ride)
– È incredibile! Davvero, mi sembra che siate come connessi.
“Sì, lo credo anch’io. Entrambi amavamo la liricità, e questo è importante. Stan poteva suonare una ballad e farti piangere, con il suo sound e le sue idee e la sua creatività. Quello fu un concerto interessante, specialmente in duo, lui era… beh, sono sicuro che conosci la storia”.
-La conosco.
“Era malato al tempo, quando registrammo in duo. Aveva una sorta di tumore del sangue, perciò sentiva molto dolore. Dovevamo registrare per tre sere, ma andammo avanti soltanto per due, lui non riuscì a finire l’ultima sera. Avemmo solo un altro concerto insieme dopo quell’episodio, a Parigi, e non riusciva a suonare molto. Lui suonava la melodia e io feci la maggior parte dei soli al pianoforte, e quella fu l’ultima volta che lo vidi”.
-Mi dispiace molto.
“Era marzo e io lo chiamai un mese più tardi, per sapere come stesse. Mi disse che stava bene e che avrebbe suonato per il prossimo tour, e poi a giugno… è venuto a mancare. Abbiamo perso una bella persona.
-Sì. Secondo me Stan Getz e Paul Desmond sono due grandi sassofonisti che rimarranno nella storia del jazz
“Davvero?”.
-Sì, mi piacciono davvero tanto. Sicuramente c’è anche Charlie Parker, e tutti quei sassofonisti formidabili che sono fuori da ogni sorta di classificazione. Ma mi piacciono molto Paul e Stan per il modo che hanno di suonare.
“Quindi tu ami… il loro sound?”.
-Sì.
“Lo apprezzo. Paul aveva un sound molto morbido e snello, tenero. E una delle prime registrazioni che ho ascoltato era di Dave Brubeck e Paul Desmond, era ‘Jazz Goes To College’”.
-Sì, me la ricordo. Forse anni ’60?
“In realtà tardi anni ’50, perché ancora vivevo a Philly. Questo era uno dei miei pezzi preferiti”.
– Solo un’ultima cosa su Stan Getz… in quale occasione iniziò a collaborare con lui, a quanti anni? Ha mai rimpianto di non averlo conosciuto prima?
“Rimpiango sempre di non aver conosciuto prima le persone, ma sono lieto quando le conosco! Ricevetti una chiamata per lavorare con lui, per sostituire Chick Corea. Allora aveva una band con Stanley Clarke, Tony Williams e Chick. Mi chiamò e mi chiese di prendere il suo posto, questa fu la prima volta che lavorai con Stan. Era incredibile, suonavamo tutta la musica di Chick Corea. Penso si chiamasse “Captain Marvel Band” o qualcosa del genere. Era un piccolo tour, suonammo per poche serate soprattutto in Sud Carolina e a Baltimora. Quando partimmo Stan mi disse: “Sei davvero un musicista con esperienza”, e per me quello era un grande complimento. Per un po’ non l’ho più sentito, e poi pochi mesi dopo mi chiamò per un posto alla Stanford University”.
-Ho capito.
“Artist-in-residence. Mi chiamò per chiedermi di andare lì e suonare in alcuni concerti con lui. Da quel momento iniziammo ad andare in Europa durante l’estate perché io insegnavo alla Rutgers University e lui a Stanford, perciò non potevamo provare molto durante l’anno accademico. Ma in estate andammo a tutti i grandi festival d’Europa. Aveva una buona band, con Victor Lewis e Rufus Reid. Facemmo un paio di registrazioni a Montmartre con il quartetto, e un paio in duo. Sempre grande musica, grande scrittura. Registrammo un pezzo elettronico dal titolo “Apasionado”, in California. Mi piaceva, per me era qualcosa di diverso! C’erano gli archi e tutti i tipi di strumenti elettronici. Una grande esperienza che non avevo mai fatto prima”.
-Ok. Dato che lo ha accennato, mi piacerebbe parlare dell’insegnamento. Lei era un insegnante di pianoforte alla Rutgers University, e poi alla Julliard, la vecchia Manhattan School.
“Esatto”.
-Insegna ancora? O ha lasciato?
“No, mi sono congedato”.
-Perché, se posso chiedere?
“Beh, sto invecchiando! (ride) A un certo punto senti che hai bisogno di imparare qualcosa, ed io avevo bisogno di imparare altro. Avevo bisogno di ascoltare altre persone suonare, in un certo senso di “istruirmi”. Gli studenti erano bravi, intendo bravi davvero… che cosa avevo da dare loro? A Manhattan c’erano Gerald Clayton, Aaron Parks, era uno dei miei studenti, e molti altri… alla Julliard avevo Jonathan Batiste, alla Rutgers Terence Blanchard, Harry Allen. E tutti loro suonavano benissimo il pianoforte!”.
-Com’era un sua lezione tipo? Cosa faceva durante l’ora?
“Sostanzialmente suonavamo insieme. Ho sempre avuto due pianoforti nella mia aula. Suonavamo insieme perché questo mi permetteva di capire cosa effettivamente sapessero o non sapessero suonare. Insomma, erano al punto in cui io non avevo bisogno di dire loro “questo è un accordo di Do”, non avevano bisogno di questo da me: sapevano già come come suonare. Eravamo interessati a sottigliezze e rifiniture, e idee su tocco, frasi, cose del genere”.
-Quindi le sue lezioni erano come delle performance dal vivo, ma guidate?
“Sì, una cosa di questo tipo! Suonavamo e poi ci fermavamo, e dicevo “Ok, qui stiamo suonando una ballad, non dovete suonare così rigidamente, non c’è bisogno di suonare così tante note in questa ballad… lasciate spazio, anche il silenzio è parte della musica”, cose così. E penso che la prendessero molto seriamente”.
-Quindi… ha dei suggerimenti per diventare un buon insegnante? C’è un ingrediente speciale?
“No, non penso. Certo dipende, le persone hanno diversi modi di insegnare. Il mio modo di insegnare era quello di ascoltare i musicisti e sentire costa potevano fare, e sfidarli. Prendevamo una canzone e la suonavamo per 30 minuti, e poi facevamo un botta e risposta, per fare esercizio. E poi provavamo a sfidarci l’un l’altro, ed è un bene quando gli studenti provano a sfidare anche te. (si ride) Ho imparato molto anch’io”.
-Ok.
“Non è tipo “sono il tuo insegnante e tu fai quello che dico”, a quel livello non è così. È più uno scambio di idee. Imparo da loro, loro imparano da me”.
-Certo, grazie mille. Parliamo adesso di composizione. Lei ha composto molto: adoro “Until Then e Sunshower”, in particolare. Quanto pensa sia importante scrivere pezzi originali, che abbiano la propria firma?
“Penso sia importante, e che si debba scrivere il più possibile. Quello che cerco nella scrittura, quello che cerco di raggiungere nella composizione è… la semplicità. Non scrivo cose in 11/8, 9… non scrivo cose in tempi strani. Non sento la musica in quel modo! Alcuni musicisti lo fanno comodamente e mi piace ascoltarli, ma il mio approccio è più che altro fatto di melodie semplici, armonie che forse qualche volta sono ingannevoli… o forse non qualche volta! Per me funziona la semplicità”.
-Sì. Stavo pensando… lei reputa questo un passaggio fondamentale? Un passaggio che un musicista deve fare per sentirsi completo? O pensa che si possa saltare?
“Intendi saltare la scrittura?”.
-Sì.
“Beh, non tutti i musicisti sono compositori, alcuni di loro non scrivono. Ma, come dice qualcuno, l’improvvisazione è composizione, solo che non è scritta”.
-Infatti.
“Un musicista Jazz compone tutto il tempo… quando inizia a scrivere, quella è una composizione! (si ride) Ma molti musicisti semplicemente non sono per la scrittura, e li capisco. Io penso che sia un altro aspetto di te che dovresti esplorare”.
-Ok. Guardi, una volta ho frequentato una masterclass di Billy Childs. Secondo me è un grande compositore.
“Sì, lo è.”
-E ha detto qualcosa che io ritengo incredibile. Ha detto: “Il segreto del comporre è creare qualcosa di sorprendente, e allo stesso tempo inevitabile”.
“Sì, ok”.
-Mi suona come qualcosa del tipo: “Devi creare musica che ha dei legami con il passato, in modo che ascoltandola tu sappia dove sta andando, ma che abbia anche qualcosa di sorprendente che ne cambia la direzione”, no?
“Sì, sì, sì”.
-È d’accordo?
“Sono d’accordo. E ho ascoltato abbastanza musica di Billy Childs, è un compositore brillante”.
-Lei ricorda un buon consiglio che qualcuno le ha dato recentemente o nel passato, o un evento particolare che ha cambiato il suo modo di comporre e suonare?
“Ehm… sì! Qualcuno una volta mi diede un’idea che io poi ho provato ad applicare: prova a suonare il tuo solo nello spazio di una quinta perfetta. Tutte le tue parti di improvvisazione. Ovviamente non puoi farlo chorus dopo chorus dopo chorus, ma fai una prova. Quanto puoi suonare solo in quel piccolo spazio di una quinta perfetta?”.
-Non ho capito bene, Mr. Barron…
“Sul pianoforte, una quinta perfetta, da Do a Sol. E stai suonando una canzone, qualunque essa sia, prova a suonare tutto all’interno di quella quinta perfetta, cromaticamente”.
-Ok!
“E vedi come va. È qualcosa che puoi provare… potresti restare sorpreso. Perché qualsiasi nota tu metta insieme funzionerà contro qualsiasi accordo suonerai. Deve essere risolto, ma funziona. Questo è un consiglio che qualcuno mi diede e che ho provato. È qualcosa da ricordare”.
-Ok, ora… l’ultima parte. Oltre la musica, sono curioso rispetto alla giornata tipica di Kenny Barron. Ci sono delle cose particolari che ama fare nel tempo libero, se non suona?
“Mi piace leggere molto. Mi piace leggere romanzi”.
-Che tipo di romanzi?
“Mi piace James Patterson, romanzi gialli e cose di questo tipo”.
-Sì! Le piace Zafon? Carlos Ruiz Zafon?
“Oh, non lo conosco”.
-No? È bravo! E Dan Brown?… quello de “Il Codice Da Vinci”.
-“Oh sì sì l’ho letto! (ridono di gran gusto) L’ho letto. In realtà ho anche visto il film”.
-Sì… mi scusi, l’ho interrotta.
“No, non fa niente. Stavo dicendo che durante il Covid non c’è molto altro da fare, perché altrimenti andrei da qualche parte, ascolto musica o cose di questo tipo. Perciò questo è ciò che faccio, leggo e provo anche a cucinare!”.
-Cosa cucina?
“Schnitzel… bistecca! Cose del genere”.
-Le piace la pizza?
“La amo. E a Napoli ho mangiato la migliore pizza della mia vita.”
-Wow! Si ricorda il posto?
“No, ma era così fina… con l’aglio…non ricordo perché mi ci hanno portato. Quella fu la migliore pizza che io abbia mai mangiato. E amo anche mangiare! (si ride) Che è un male!
-No. Non è un male! Sa, quest’anno mi ha fatto realizzare appieno che ci sono anche altre cose oltre alla musica. E se si usano queste cose per nutrire il proprio “appetito musicale”, ci si sentirà più rilassati nel suonare e meglio in generale.
“Lo penso anch’io. Bisogna essere una persona a tutto tondo, il che significa fare tutto nella vita, non solo musica. Ci sono persone ossessionate dalla musica, è tutto ciò che fanno: 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ascoltano e praticano musica, scrivono musica 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Vorrei essere una di queste persone, ma non lo sono. Ci sono altre cose che catturano la mia attenzione, come la politica o quanto accade nel mondo. Ora c’è il processo di Minneapolis (per la morte di George Floyd, NdT) che mi interessa”.
-Sì, anche a me.
“Succedono anche altre cose. Possono ispirare la tua musica, in un certo qual modo”.
-Sono d’accordo. Quali sono i suoi piani per il futuro? Ci sono nuovi album in cantiere, nuovi progetti?
“Non al momento. C’è un sassofonista, Greg Abate. Ha fatto delle registrazioni di… circa 15 miei pezzi, con il trio. Suona il sassofono contralto, e ha sovrainciso il sassofono e scritto una sorta di sezione di sax in alcuni dei pezzi. È abbastanza interessante! Ma penso che l’unica cosa che vorrei fare prossimamente è un solo, e poi forse un duo, con batteria o percussioni o… un violoncello! Sì qualcosa del genere. Ed è economico da produrre perché non devo pagare me stesso. (ride)”.

Kenny Barron, Udine, Teatro Palamostre, 10.04.2018 Note Nuove
-Verrà in Italia?
“Ci sono dei piani, non so se verranno cancellati o no a questo punto. Penso che a Perugia o Pescara ci potrò essere”.
-Lo spero!
“Lo spero anch’io! E ci sono altre cose… ce n’è una in una città chiamata… Merano? Non Milano, Merano”.
-Sì, nel nord Italia.
“Sì, non sono sicuro che accadrà. Ma penso che per luglio o agosto le cose miglioreranno almeno un po’, lo spero”.
-Sì, ed io sarò lì ad aspettarla! Vaccinato ovviamente, spero di poterla conoscere e abbracciarla nella vita reale.
“Ok! Grazie molte”.
–Le sono molto grato, grazie mille.
“È stato un piacere!”.
–Ci vediamo presto allora.
“Ok, ciao!”.
-Grazie, arrivederci!
Daniele Mele
da Gerlando Gatto | 08/Nov/2021 | I nostri CD, Primo piano, Recensioni

ACT
Nils Landgren Funk Unit – “Funk is my Religion” – ACT
Nils Landgren – “Nature Boy” – ACT
 Nils Landgren, personaggio di punta del jazz, è ben noto anche ai lettori di queste note avendo in passato recensito alcune sue significative produzioni. Adesso lo riascoltiamo in due differenti contesti: nel primo album Nils è alla testa della suo celebrata “Funk Unit” mentre nel secondo abbiamo modo di apprezzarlo come arrangiatore e strumentista dal momento che suona da solo.
Nils Landgren, personaggio di punta del jazz, è ben noto anche ai lettori di queste note avendo in passato recensito alcune sue significative produzioni. Adesso lo riascoltiamo in due differenti contesti: nel primo album Nils è alla testa della suo celebrata “Funk Unit” mentre nel secondo abbiamo modo di apprezzarlo come arrangiatore e strumentista dal momento che suona da solo.
Ma procediamo con ordine. “Funk is my Religion” è l’undicesimo album registrato dalla pregiata ditta “Funk Unit” da quando venne creata nel 1994 ed ha avuto una vita piuttosto travagliata per vedere la luce: in effetti tutto era pronto per essere registrato nell’isola di Maiorca ma la cosa non fu possibile a causa del Covid; allora si virò verso il distretto di Redhorn in Bad Meinberg ma anche questa volta, sempre a causa del virus, non se ne fece alcunché. Ultima ratio l’Ingrid Studio di Stoccolma in cui l’album venne effettivamente registrato dal 3 al 7 novembre del 2020 per uscire in Germania il 28 maggio scorso. Come spesso sottolineato, capita raramente che il titolo di un album abbia un qualche effettivo collegamento con la musica che propone: in questo caso non poteva esserci titolo più azzeccato dal momento che effettivamente oramai da anni Nils Landgren va predicando questa sua passione per il Funk. Così, anche questa volta, il sestetto si muove sulle coordinate di una musica piacevole, orecchiabile, spesso trascinante in cui se è vero che non si avverte alcuna novità è altresì vero che non sempre nuova musica equivale a buona musica…e viceversa. All’interno dei dieci brani proposti, particolarmente riuscita l’interpretazione di “Play Funk” disegnata dalla bella voce di Magnum Coltrane Price.
 Del tutto diverso “Nature Boy”; abbandonate le tinte forti del Funk, Lindgren si concede un esperimento tanto ardito quanto affascinante: presentare ben quattordici brani in solitudine. L’album prende il nome da un brano famoso, quel “Nature Boy” scritto da Eden Ahbez e registrato per la prima volta da Nat King Cole con l’orchestra diretta da Frank DeVol il 22 agosto del 1947. Ma, a parte questo brano, l’album è incentrato sulla musica tradizionale del proprio paese, una strada già percorsa da Landgren quando alla fine degli anni ’90 in duo con il pianista Esbjörn Svensson incise due album incentrati sulla folk music , “Swedish Folk Modern” e “Layers Of Light”. Questa volta la prova è più difficile in quanto Landgren si trova ad affrontare un repertorio oggettivamente ostico da solo con il proprio trombone. Risultato: viste le premesse si può ben dire che l’artista svedese si conferma musicista di prim’ordine, in grado di eseguire con sincera partecipazione partiture che molto si allontanano dal linguaggio prettamente jazzistico. Ottima, infine, la resa sonora grazie anche all’acustica della Ingelstorps Church dove è stato registrato l’album nel febbraio di questo 2021.
Del tutto diverso “Nature Boy”; abbandonate le tinte forti del Funk, Lindgren si concede un esperimento tanto ardito quanto affascinante: presentare ben quattordici brani in solitudine. L’album prende il nome da un brano famoso, quel “Nature Boy” scritto da Eden Ahbez e registrato per la prima volta da Nat King Cole con l’orchestra diretta da Frank DeVol il 22 agosto del 1947. Ma, a parte questo brano, l’album è incentrato sulla musica tradizionale del proprio paese, una strada già percorsa da Landgren quando alla fine degli anni ’90 in duo con il pianista Esbjörn Svensson incise due album incentrati sulla folk music , “Swedish Folk Modern” e “Layers Of Light”. Questa volta la prova è più difficile in quanto Landgren si trova ad affrontare un repertorio oggettivamente ostico da solo con il proprio trombone. Risultato: viste le premesse si può ben dire che l’artista svedese si conferma musicista di prim’ordine, in grado di eseguire con sincera partecipazione partiture che molto si allontanano dal linguaggio prettamente jazzistico. Ottima, infine, la resa sonora grazie anche all’acustica della Ingelstorps Church dove è stato registrato l’album nel febbraio di questo 2021.
ATS
Raphael Kafers Constellation Project – “Retrospection” – ATS
 Album d’esordio nella scuderia ATS per il giovane chitarrista austriaco Raphael Käfer che nell’occasione si presenta sotto l’insegna “Raphael Käfer’s Constellation Project”. A coadiuvarlo nella non facile impresa alcuni tra i migliori jazzisti austriaci come Tobias Pustelnik sax, Urs Hager piano, Philipp Zarfl basso e Matheus Jardim batteria. In programma sei brani originali del leader più il celebre standard “How Deep Is The Ocean” di Irving Berlin. L’album si fa apprezzare particolarmente per l’eccellente equilibrio raggiunto tra i cinque: il leader non si ritaglia alcuno spazio in più rispetto ai “colleghi” e nei suoi brani (tutti ben scritti e altrettanto ben arrangiati) c’è posto per tutti. Così ognuno ha un proprio spazio per evidenziare le proprie potenzialità, che non sono di poco conto. Per quanto concerne il linguaggio, siamo nell’ambito di un jazz mainstream contemporaneo – se mi consentite il termine – vale a dire un jazz nell’alveo della tradizione, ma al contempo attuale che pur senza alcuna pretesa di sperimentare alcunché di nuovo esprime la consapevolezza di raccontare compiutamente il proprio essere. Di qui la godibilità della musica che interessa tutto l’album cosicché riesce davvero difficile segnalare un singolo brano. Comunque qualche parola mi sento di spenderla sull’unico standard: presentare un brano celebrato come “How Deep Is The Ocean” non è facile anche perché i modelli con cui confrontarsi sono molti ed eccelsi; ebbene Käfer e compagni se la sono cavata egregiamente con una esecuzione pienamente rispettosa delle originali caratteristiche del brano.
Album d’esordio nella scuderia ATS per il giovane chitarrista austriaco Raphael Käfer che nell’occasione si presenta sotto l’insegna “Raphael Käfer’s Constellation Project”. A coadiuvarlo nella non facile impresa alcuni tra i migliori jazzisti austriaci come Tobias Pustelnik sax, Urs Hager piano, Philipp Zarfl basso e Matheus Jardim batteria. In programma sei brani originali del leader più il celebre standard “How Deep Is The Ocean” di Irving Berlin. L’album si fa apprezzare particolarmente per l’eccellente equilibrio raggiunto tra i cinque: il leader non si ritaglia alcuno spazio in più rispetto ai “colleghi” e nei suoi brani (tutti ben scritti e altrettanto ben arrangiati) c’è posto per tutti. Così ognuno ha un proprio spazio per evidenziare le proprie potenzialità, che non sono di poco conto. Per quanto concerne il linguaggio, siamo nell’ambito di un jazz mainstream contemporaneo – se mi consentite il termine – vale a dire un jazz nell’alveo della tradizione, ma al contempo attuale che pur senza alcuna pretesa di sperimentare alcunché di nuovo esprime la consapevolezza di raccontare compiutamente il proprio essere. Di qui la godibilità della musica che interessa tutto l’album cosicché riesce davvero difficile segnalare un singolo brano. Comunque qualche parola mi sento di spenderla sull’unico standard: presentare un brano celebrato come “How Deep Is The Ocean” non è facile anche perché i modelli con cui confrontarsi sono molti ed eccelsi; ebbene Käfer e compagni se la sono cavata egregiamente con una esecuzione pienamente rispettosa delle originali caratteristiche del brano.
Upper Austrian Jazz Orchestra – “Crazy Days: UAJO Plays The Music Of Ed Puddick” – ATS
 Di carattere completamente diverso il secondo album targato ATS che vede all’opera la Big Band Upper Austrian Jazz Orchestra (UAJO). In effetti l’album è la risultante di una visita in Austria del trombonista, compositore e arrangiatore inglese Ed Puddick poco tempo prima del lockdown nei primi giorni del gennaio 2020. La UAJO nei suoi 28 anni di attività si è affermata sulla scena europea grazie alla sua duttilità che le consente di collaborare con musicisti di estrazione assai diversa passando così da Kenny Wheeler, a Johnny Griffin, da Mike Gibbs a Maria Joao… a Slide Hampton. In questo nuovo album il cui repertorio è firmato e arrangiato da Ed Puddick, c’è la conferma di quanto detto in precedenza: l’orchestra si adatta perfettamente sia a quegli arrangiamenti in cui Puddick si rifà esplicitamente ad un jazz più tradizionale sia a quei pezzi in cui la musica dell’inglese vira decisamente verso lidi più moderni evidenziando una diretta discendenza da Mike Gibbs. Seguendo questo schema si può affermare che i primi tre pezzi “Crazy Days”, “An Ocean of Air” e “Forum Internum”, appartengono alla prima categoria con in evidenza le sezioni di ottoni e di sassofoni. Di converso l’influenza di Mike Gibbs è particolarmente evidente in “Slow News Day” e “New Familiar” con il chitarrista Primus Sitter in primo piano. Tra gli altri solisti occorre ricordare il pianista Herman Hill, i sassofonisti Andreas See e Christian Maurer e il trombettista Manfred Weinberger.
Di carattere completamente diverso il secondo album targato ATS che vede all’opera la Big Band Upper Austrian Jazz Orchestra (UAJO). In effetti l’album è la risultante di una visita in Austria del trombonista, compositore e arrangiatore inglese Ed Puddick poco tempo prima del lockdown nei primi giorni del gennaio 2020. La UAJO nei suoi 28 anni di attività si è affermata sulla scena europea grazie alla sua duttilità che le consente di collaborare con musicisti di estrazione assai diversa passando così da Kenny Wheeler, a Johnny Griffin, da Mike Gibbs a Maria Joao… a Slide Hampton. In questo nuovo album il cui repertorio è firmato e arrangiato da Ed Puddick, c’è la conferma di quanto detto in precedenza: l’orchestra si adatta perfettamente sia a quegli arrangiamenti in cui Puddick si rifà esplicitamente ad un jazz più tradizionale sia a quei pezzi in cui la musica dell’inglese vira decisamente verso lidi più moderni evidenziando una diretta discendenza da Mike Gibbs. Seguendo questo schema si può affermare che i primi tre pezzi “Crazy Days”, “An Ocean of Air” e “Forum Internum”, appartengono alla prima categoria con in evidenza le sezioni di ottoni e di sassofoni. Di converso l’influenza di Mike Gibbs è particolarmente evidente in “Slow News Day” e “New Familiar” con il chitarrista Primus Sitter in primo piano. Tra gli altri solisti occorre ricordare il pianista Herman Hill, i sassofonisti Andreas See e Christian Maurer e il trombettista Manfred Weinberger.
ECM
Andrew Cyrille – “The News” – ECM
 Gli anni passano ma sembrano non incidere più di tanto sull’arte del veterano Andrew Cyrille (classe 1939). Ecco quindi il terzo album prodotto dal celebre batterista per la casa tedesca, un “The News” che, manco a dirlo, non tradisce le attese. Ben completato da Bill Frisell alla chitarra, David Virelles piano e sin e Ben Street contrabbasso, il quartetto si muove in maniera empatica dimostrando di aver ben assorbito la perdita di Richard Teitelbaum venuto a mancare nel 2020. Il sostituto David Virelles si è perfettamente integrato nella logica del gruppo anzi è riuscito in un tempo relativamente breve a costituire una straordinaria intesa con il leader ché i due costituiscono adesso l’asse portante della formazione. Certo Frisell e Ben Street non sono dei comprimari e il loro ruolo è di assoluta importanza per la riuscita del tutto. Al riguardo non si può non sottolineare ancora una volta la straordinaria personalità di Cyrille che superata la soglia degli 80 resta validamente in sella non solo come insuperabile strumentista ma anche come compositore originale. Non è certo un caso che in repertorio figurino tre suoi brani di cui uno, “Dance of the Nuances”, scritto in collaborazione con Virelles. Gli altri pezzi sono opera di Bill Frisell, di David Virelles e di Adegoke Steve Colson (“Leaving East of Java”) brano tra i meglio riusciti grazie alla perfetta intesa evidenziata dal gruppo che alterna con assoluta naturalezza parti scritte a parti improvvisate.
Gli anni passano ma sembrano non incidere più di tanto sull’arte del veterano Andrew Cyrille (classe 1939). Ecco quindi il terzo album prodotto dal celebre batterista per la casa tedesca, un “The News” che, manco a dirlo, non tradisce le attese. Ben completato da Bill Frisell alla chitarra, David Virelles piano e sin e Ben Street contrabbasso, il quartetto si muove in maniera empatica dimostrando di aver ben assorbito la perdita di Richard Teitelbaum venuto a mancare nel 2020. Il sostituto David Virelles si è perfettamente integrato nella logica del gruppo anzi è riuscito in un tempo relativamente breve a costituire una straordinaria intesa con il leader ché i due costituiscono adesso l’asse portante della formazione. Certo Frisell e Ben Street non sono dei comprimari e il loro ruolo è di assoluta importanza per la riuscita del tutto. Al riguardo non si può non sottolineare ancora una volta la straordinaria personalità di Cyrille che superata la soglia degli 80 resta validamente in sella non solo come insuperabile strumentista ma anche come compositore originale. Non è certo un caso che in repertorio figurino tre suoi brani di cui uno, “Dance of the Nuances”, scritto in collaborazione con Virelles. Gli altri pezzi sono opera di Bill Frisell, di David Virelles e di Adegoke Steve Colson (“Leaving East of Java”) brano tra i meglio riusciti grazie alla perfetta intesa evidenziata dal gruppo che alterna con assoluta naturalezza parti scritte a parti improvvisate.
Mathias Eick – “When We Leave” – ECM
 Non sono certo molti i musicisti che suonano bene sia il pianoforte sia la tromba. In Italia abbiamo l’eccellente Dino Rubino; in Norvegia c’è questo Mathias Eick che oltre ai due su citati strumenti si fa apprezzare anche al basso, al vibrafono e alla chitarra. Nato in una famiglia in cui la musica è di casa (i due fratelli Johannes e Trude sono anch’essi musicisti) Mathias ancora non è troppo noto dalle nostre parti anche se può già vantare un curriculum di tutto rispetto avendo già collaborato, tra gli altri, con Chick Corea, Iro Haarla, Manu Katché e Jacob Young. In questa sua nuova fatica discografica, Eick suona con Håkon Aase al violino, Andreas Ulvo al piano, Audun Erlien al basso, i due batteristi Torstein Lofthus e Helge Norbakken nonché Stian Casrtensen alla pedal steel guitar. Eick appartiene di diritto a quella folta schiera di musicisti nordici che pur suonando jazz si rifanno in modo più o meno esplicito alle radici folk della loro musica. Ecco quindi, in organico, un eccellente violinista quale Håkon Aase che il leader inserisce nei suoi brani proprio per dare alle esecuzioni quella particolare coloratura cui si accennava. Così Aase divide con il leader e con il pianista Andreas Ulvo il ruolo di prim’attore in un repertorio declinato attraverso sette brani
Non sono certo molti i musicisti che suonano bene sia il pianoforte sia la tromba. In Italia abbiamo l’eccellente Dino Rubino; in Norvegia c’è questo Mathias Eick che oltre ai due su citati strumenti si fa apprezzare anche al basso, al vibrafono e alla chitarra. Nato in una famiglia in cui la musica è di casa (i due fratelli Johannes e Trude sono anch’essi musicisti) Mathias ancora non è troppo noto dalle nostre parti anche se può già vantare un curriculum di tutto rispetto avendo già collaborato, tra gli altri, con Chick Corea, Iro Haarla, Manu Katché e Jacob Young. In questa sua nuova fatica discografica, Eick suona con Håkon Aase al violino, Andreas Ulvo al piano, Audun Erlien al basso, i due batteristi Torstein Lofthus e Helge Norbakken nonché Stian Casrtensen alla pedal steel guitar. Eick appartiene di diritto a quella folta schiera di musicisti nordici che pur suonando jazz si rifanno in modo più o meno esplicito alle radici folk della loro musica. Ecco quindi, in organico, un eccellente violinista quale Håkon Aase che il leader inserisce nei suoi brani proprio per dare alle esecuzioni quella particolare coloratura cui si accennava. Così Aase divide con il leader e con il pianista Andreas Ulvo il ruolo di prim’attore in un repertorio declinato attraverso sette brani
tutti scritti dal leader e tutti accomunati da quella struggente malinconia che spesso caratterizza le composizioni dei musicisti del Nord Europa, in special modo norvegesi.
Marc Johnson – “Overpass” – ECM
 Gli album per contrabbasso solo non sono frequenti e la cosa è perfettamente spiegabile dal momento che lo strumento è nato e si è sviluppato in funzione di accompagnamento del gruppo. Certo, nel corso degli anni, proprio nel jazz, il contrabbasso ha trovato la possibilità di elevarsi, da strumento di mero accompagnamento e sostegno armonico, a vero e proprio strumento solista, ma di qui ad essere il protagonista solitario di un concerto o di un disco ce ne corre. Non stupisce quindi, come si diceva in apertura, che gli album per solo contrabbasso siano relativamente pochi: tra questi si ricorda “Journal violone” di Barre Phillips del ’68 (probabilmente il primo del genere), e poi nel corso degli anni, tanto per citare qualche nome, Larry Grenadier, Larry Ronald, Lars Danielsson, John Patitucci, Daniel Studer… mentre in Italia si sono misurati con questa pratica, tra gli altri, Jacopo Ferrazza, Roberto Bonati, Furio Di Castri e Enzo Pietropaoli. Adesso arriva questo album di Marc Johnson e si tratta di un CD davvero strepitoso. Marc Johnson è in gran forma e d’altronde non è certo una sorpresa dato tutto ciò che questo artista ha già realizzato.Gli appassionati di jazz lo conoscono e con questo “Overpass” Marc si ripropone come uno dei principali artefici della modernizzazione che ha interessato il linguaggio contrabbassistico. L’album è declinato attraverso otto brani di cui cinque composti dallo stesso Marc cui si affiancano “Freedom Jazz Dance” di Eddie Harris, “Nardis” di Miles Davis e il tema d’amore della colonna sonora del film “Spartacus” di Alex North. Marc affronta questo impegnativo repertorio con assoluta padronanza del proprio strumento evidenziando la solita cavata possente, la consueta maestria tecnica sia al pizzicato sia con l’archetto, la ben nota capacità di valorizzare i contenuti tematici del pezzo come accade, ad esempio, in “Samurai Fly”, composizione che dall’inizio con archetto riprende il tema di “Samurai Hee Haw” tratto dall’album “Bass Desires” che il contrabbassista registrò nel 2018 con Bill Frisell, John Scofield e Peter Erskine.
Gli album per contrabbasso solo non sono frequenti e la cosa è perfettamente spiegabile dal momento che lo strumento è nato e si è sviluppato in funzione di accompagnamento del gruppo. Certo, nel corso degli anni, proprio nel jazz, il contrabbasso ha trovato la possibilità di elevarsi, da strumento di mero accompagnamento e sostegno armonico, a vero e proprio strumento solista, ma di qui ad essere il protagonista solitario di un concerto o di un disco ce ne corre. Non stupisce quindi, come si diceva in apertura, che gli album per solo contrabbasso siano relativamente pochi: tra questi si ricorda “Journal violone” di Barre Phillips del ’68 (probabilmente il primo del genere), e poi nel corso degli anni, tanto per citare qualche nome, Larry Grenadier, Larry Ronald, Lars Danielsson, John Patitucci, Daniel Studer… mentre in Italia si sono misurati con questa pratica, tra gli altri, Jacopo Ferrazza, Roberto Bonati, Furio Di Castri e Enzo Pietropaoli. Adesso arriva questo album di Marc Johnson e si tratta di un CD davvero strepitoso. Marc Johnson è in gran forma e d’altronde non è certo una sorpresa dato tutto ciò che questo artista ha già realizzato.Gli appassionati di jazz lo conoscono e con questo “Overpass” Marc si ripropone come uno dei principali artefici della modernizzazione che ha interessato il linguaggio contrabbassistico. L’album è declinato attraverso otto brani di cui cinque composti dallo stesso Marc cui si affiancano “Freedom Jazz Dance” di Eddie Harris, “Nardis” di Miles Davis e il tema d’amore della colonna sonora del film “Spartacus” di Alex North. Marc affronta questo impegnativo repertorio con assoluta padronanza del proprio strumento evidenziando la solita cavata possente, la consueta maestria tecnica sia al pizzicato sia con l’archetto, la ben nota capacità di valorizzare i contenuti tematici del pezzo come accade, ad esempio, in “Samurai Fly”, composizione che dall’inizio con archetto riprende il tema di “Samurai Hee Haw” tratto dall’album “Bass Desires” che il contrabbassista registrò nel 2018 con Bill Frisell, John Scofield e Peter Erskine.
Craig Taborn – “Shadow Plays” – ECM
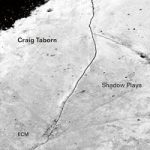 Ecco un’altra preziosa incisione di Craig Taborn registrato in splendida solitudine durante un concerto tenuto nel marzo del 2020 alla Wiener Konzerthaus. L’album si articola su sette brani tutti composti dallo stesso Taborn cha ha da poco superato la soglia dei 50 anni. La cifra stilistica del pianista, organista, tastierista e compositore statunitense è oramai ben nota: un pianismo assolutamente originale, spesso improvvisato (come nell’album qui proposto) in cui suono e silenzi scandiscono un trascorrere del tempo caratterizzato dal fatto che fantasia e preparazione tecnica, dinamiche perfettamente controllate, intrecci poliritmici, ricorso sapiente al contrappunto, improvvise cascate di note coesistono a formare una musica sempre nuova, affascinante, spesso trascinante. Taborn è assolutamente padrone della materia; non c’è un solo momento in cui si avverte la pur minima sensazione che l’artista non sia in grado di padroneggiare ciò che sta suonando: tutto resta ancorato ad una visione che l’artista svela all’ascoltatore man mano che il concerto procede. E nel prosieguo dell’ascolto si può avvertire come l’arte di Taborn affondi le proprie radici nella migliore tradizione del piano jazz, riconoscendo tra i suoi numi ispiratori i nomi di Ellington, Monk, Cecil Taylor, Sun Ra, Abdullah Ibrahim, Ahmad Jamal in un perfetto connubio tra modernità e classicismo. Ma non basa ché tra le fonti ispiratrici di Craig bisogna annoverare anche il cinema, la pittura e tornando alla musica una folta schiera di musicisti che non appartengono al jazz quali Debussy, Glass, Ligeti.
Ecco un’altra preziosa incisione di Craig Taborn registrato in splendida solitudine durante un concerto tenuto nel marzo del 2020 alla Wiener Konzerthaus. L’album si articola su sette brani tutti composti dallo stesso Taborn cha ha da poco superato la soglia dei 50 anni. La cifra stilistica del pianista, organista, tastierista e compositore statunitense è oramai ben nota: un pianismo assolutamente originale, spesso improvvisato (come nell’album qui proposto) in cui suono e silenzi scandiscono un trascorrere del tempo caratterizzato dal fatto che fantasia e preparazione tecnica, dinamiche perfettamente controllate, intrecci poliritmici, ricorso sapiente al contrappunto, improvvise cascate di note coesistono a formare una musica sempre nuova, affascinante, spesso trascinante. Taborn è assolutamente padrone della materia; non c’è un solo momento in cui si avverte la pur minima sensazione che l’artista non sia in grado di padroneggiare ciò che sta suonando: tutto resta ancorato ad una visione che l’artista svela all’ascoltatore man mano che il concerto procede. E nel prosieguo dell’ascolto si può avvertire come l’arte di Taborn affondi le proprie radici nella migliore tradizione del piano jazz, riconoscendo tra i suoi numi ispiratori i nomi di Ellington, Monk, Cecil Taylor, Sun Ra, Abdullah Ibrahim, Ahmad Jamal in un perfetto connubio tra modernità e classicismo. Ma non basa ché tra le fonti ispiratrici di Craig bisogna annoverare anche il cinema, la pittura e tornando alla musica una folta schiera di musicisti che non appartengono al jazz quali Debussy, Glass, Ligeti.
Marcin Wasilewski Trio – “En Attendant” – ECM 2677
 La ECM ci ripropone una delle formazioni europee più significative degli ultimi anni. Il trio polacco del pianista Marcin Wasilewski con Sławomir Kurkiewicz al contrabbasso e Michał Miśkiewicz alla batteria. Tanto per sottolineare la cifra artistica del gruppo, basti considerare che i tre hanno talmente entusiasmato il trombettista Tomasz Stańko da collaborare assieme per oltre 20 anni. Il fatto è che i tre suonano in trio dall’oramai lontano 1993 per cui hanno sviluppato un idem sentire, una fluidità di suono, una compattezza non facilmente riscontrabile in altri gruppi seppur di chiara fama. Tutti questi elementi li ritroviamo nell’album in oggetto che accanto alle composizioni del leader e del trio ci presenta una rivisitazione di “Variation 25” tratta dalle “Godberg Variations” di Bach, “Vashka” di Carla Bley e “Riders On The Storm” dei Doors. Evidenziare un brano piuttosto che un altro è impresa quanto mai ardua, comunque se si volesse avere un’idea ben chiara di come i tre siano davvero accomunati da una intesa speciale suggeriremmo di ascoltare le tre improvvisazioni del trio (“In Motion Part I,II,III”): sarà facile capire come Wasilewski e compagni non si adagino su pattern o punti di riferimento precostituiti, ma si avventurino su terreni totalmente improvvisati in cui i tre strumenti cambiano di ruolo, giocando anche su dinamiche spesso inattese. A chiudere forse non è inutile
La ECM ci ripropone una delle formazioni europee più significative degli ultimi anni. Il trio polacco del pianista Marcin Wasilewski con Sławomir Kurkiewicz al contrabbasso e Michał Miśkiewicz alla batteria. Tanto per sottolineare la cifra artistica del gruppo, basti considerare che i tre hanno talmente entusiasmato il trombettista Tomasz Stańko da collaborare assieme per oltre 20 anni. Il fatto è che i tre suonano in trio dall’oramai lontano 1993 per cui hanno sviluppato un idem sentire, una fluidità di suono, una compattezza non facilmente riscontrabile in altri gruppi seppur di chiara fama. Tutti questi elementi li ritroviamo nell’album in oggetto che accanto alle composizioni del leader e del trio ci presenta una rivisitazione di “Variation 25” tratta dalle “Godberg Variations” di Bach, “Vashka” di Carla Bley e “Riders On The Storm” dei Doors. Evidenziare un brano piuttosto che un altro è impresa quanto mai ardua, comunque se si volesse avere un’idea ben chiara di come i tre siano davvero accomunati da una intesa speciale suggeriremmo di ascoltare le tre improvvisazioni del trio (“In Motion Part I,II,III”): sarà facile capire come Wasilewski e compagni non si adagino su pattern o punti di riferimento precostituiti, ma si avventurino su terreni totalmente improvvisati in cui i tre strumenti cambiano di ruolo, giocando anche su dinamiche spesso inattese. A chiudere forse non è inutile
sottolineare come questo album sia il primo, dopo 10 anni, registrato dal trio in studio (La Buissonne, nel sud della Francia), senza ospiti, e il settimo pubblicato dalla etichetta discografica di Manfred Eicher.
LOSEN RECORDS
La norvegese Losen Records, proseguendo nelle sue proposte di qualità, ci presenta due trii, il primo guidato dal batterista tedesco Frederik Villmow coadiuvato da due norvegesi: il pianista Vigleik Storaas e il bassista Bjørn Marius Hegge; il secondo dal pianista Christian Jormin con Magnus Bergström basso e Adam Ross batteria.
Frederik Villmow Trio – “Motion” – Losen Records
 L’album comprende oltre a quattro original, tre standard, scelti ognuno dai componenti del trio: “A Lovely Way to Spend an Evening” di Jimmy McHugh, “Blame It On My Youth” di Oscar Levant e “Like Someone In Love” di Jimmy Van Heusen. Un repertorio, quindi, abbastanza variegato ma capace di farci apprezzare da un lato anche le capacità compositive del leader, dall’altro le possibilità esecutive del combo che si muove perfettamente a proprio agio anche sui terreni così battuti come quelli rappresentati dai citati standard. In effetti i tre possono contare su una ottima intesa cementata da precedenti esperienze e il tutto viene declinato attraverso un giusto equilibrio tra parti improvvisate e parti scritte. Insomma siamo sul terreno del classico jazz-trio che, ad onta di qualsivoglia sperimentazione, rimane sempre un organico di tutto rispetto…sempre che, ovviamente, sia composto da musicisti di livello come questi che si ascoltano nel CD in oggetto. In particolare Willmow pur essendo nato a Colonia ha studiato e sviluppato la sua attività in Norvegia dove ha avuto modo di collaborare con alcuni prestigiosi jazzisti del Nord Europa e non solo tra cui Vigleik Storaas (NO), Bjørn Alterhaug (NO), Tore Brunborg (NO), Bendik Hofseth (NO), Alan Skidmore (UK), Cappella Amsterdam (NL), Mats Holmquist Big Band (SWE), Metropole Orkest Academy diretta da Vince Mendoza (NL). Ma è proprio all’interno del trio presente in “Motion” che sembra aver trovato la giusta collocazione. Comunque lo si attende a prove ancora più impegnative.
L’album comprende oltre a quattro original, tre standard, scelti ognuno dai componenti del trio: “A Lovely Way to Spend an Evening” di Jimmy McHugh, “Blame It On My Youth” di Oscar Levant e “Like Someone In Love” di Jimmy Van Heusen. Un repertorio, quindi, abbastanza variegato ma capace di farci apprezzare da un lato anche le capacità compositive del leader, dall’altro le possibilità esecutive del combo che si muove perfettamente a proprio agio anche sui terreni così battuti come quelli rappresentati dai citati standard. In effetti i tre possono contare su una ottima intesa cementata da precedenti esperienze e il tutto viene declinato attraverso un giusto equilibrio tra parti improvvisate e parti scritte. Insomma siamo sul terreno del classico jazz-trio che, ad onta di qualsivoglia sperimentazione, rimane sempre un organico di tutto rispetto…sempre che, ovviamente, sia composto da musicisti di livello come questi che si ascoltano nel CD in oggetto. In particolare Willmow pur essendo nato a Colonia ha studiato e sviluppato la sua attività in Norvegia dove ha avuto modo di collaborare con alcuni prestigiosi jazzisti del Nord Europa e non solo tra cui Vigleik Storaas (NO), Bjørn Alterhaug (NO), Tore Brunborg (NO), Bendik Hofseth (NO), Alan Skidmore (UK), Cappella Amsterdam (NL), Mats Holmquist Big Band (SWE), Metropole Orkest Academy diretta da Vince Mendoza (NL). Ma è proprio all’interno del trio presente in “Motion” che sembra aver trovato la giusta collocazione. Comunque lo si attende a prove ancora più impegnative.
Christian Jormin Trio – “See The Unseen” – Losen Records
 “See The Unseen” vede all’opera lo svedese Christian Jormin al piano con i già citati Magnus Bergström e Adam Ross. Si tratta del debutto di Jormin da leader in casa Losen e l’esordio è più che positivo. Registrato il 22 e 23 luglio 2020, quindi in pieno lockdown, presso la Concert Hall Sjostromsalen at Artisten in Gothenburg, l’album presenta dieci composizioni firmate dal leader e scritte appositamente per il trio. In realtà il nocciolo duro del combo era costituito da Jormin e Bergstrom che, incontratisi con Adam Ross, hanno pensato bene di allargare il duo costituendo il trio che stiamo ascoltando. L’album prende spunto dal fatto di voler reagire, in qualche modo, all’isolamento che ci era stato imposto. Così, attraverso, la musica le distanze sono abolite e l’interazione è assicurata. In effetti, anche in questo caso, una delle maggiori qualità del trio è proprio l’intesa che si avverte: i tre si muovono in modo spontaneo ma perfettamente consapevole che i compagni d’avventura non solo seguiranno lungo il percorso scelto ma saranno in grado di proseguire il discorso in maniera coerente e consapevole. Le dieci tracce sono tutte innervate da armonie ben congegnate e da un certo minimalismo all’interno di strutture molto ben disegnate, strutture che consentono a tutti e tre i musicisti di esporre compiutamente il proprio potenziale. Tutti godibili i brani con una preferenza per “Mola Mola”.
“See The Unseen” vede all’opera lo svedese Christian Jormin al piano con i già citati Magnus Bergström e Adam Ross. Si tratta del debutto di Jormin da leader in casa Losen e l’esordio è più che positivo. Registrato il 22 e 23 luglio 2020, quindi in pieno lockdown, presso la Concert Hall Sjostromsalen at Artisten in Gothenburg, l’album presenta dieci composizioni firmate dal leader e scritte appositamente per il trio. In realtà il nocciolo duro del combo era costituito da Jormin e Bergstrom che, incontratisi con Adam Ross, hanno pensato bene di allargare il duo costituendo il trio che stiamo ascoltando. L’album prende spunto dal fatto di voler reagire, in qualche modo, all’isolamento che ci era stato imposto. Così, attraverso, la musica le distanze sono abolite e l’interazione è assicurata. In effetti, anche in questo caso, una delle maggiori qualità del trio è proprio l’intesa che si avverte: i tre si muovono in modo spontaneo ma perfettamente consapevole che i compagni d’avventura non solo seguiranno lungo il percorso scelto ma saranno in grado di proseguire il discorso in maniera coerente e consapevole. Le dieci tracce sono tutte innervate da armonie ben congegnate e da un certo minimalismo all’interno di strutture molto ben disegnate, strutture che consentono a tutti e tre i musicisti di esporre compiutamente il proprio potenziale. Tutti godibili i brani con una preferenza per “Mola Mola”.
*****
B.I.T. – Danielle Di Majo e Manuela Pasqui – “Come Again” – Filibusta
 E’ un duo al femminile quello che ci propone la Filibusta Records in questo album: protagoniste Danielle Di Maio ai sassofoni e Manuela Pasqui al pianoforte. La sassofonista avevamo già avuto modo di apprezzarla, tra l’altro, negli album di Ajugada Quartet e della vocalist Antonella Vitale mentre la Pasqui ha già firmato un album come leader (“Il filo dell’aquilone”) oltre ad aver collaborato con numerosi jazzisti di vaglia. Questo per dire che le due artiste sono ben note nell’ambiente del jazz, godendo di una meritata stima. Stima che viene confermata dall’album in oggetto che si articola su nove brani declinati sia sul versante prettamente jazzistico grazie a due original firmati rispettivamente dalla sassofonista (“Cagnaccio”) e dalla pianista (“Della mancanza e dell’amore”) sia, soprattutto, sulla rielaborazione di brani tratti dal repertorio “colto”, arrangiati dalla Pasqui che da sempre si caratterizza per questa sua capacità di attingere dal repertorio classico per rivitalizzarlo con il linguaggio dell’improvvisazione. Ecco quindi in scaletta Thibaut, John Dowland, Claudio Monteverdi, Franz Schubert, Johann Pachelbel. A mio avviso il pregio maggiore dell’album consiste nel fatto che, ascoltando i brani (tutti eseguiti magistralmente), non si avverte nessuno iato tra pezzi che traggono ispirazione da due mondi così diversi, eppure così vicini nella considerazione dell’Amore quale elemento, forse l’unico, che può aiutarci a vivere.
E’ un duo al femminile quello che ci propone la Filibusta Records in questo album: protagoniste Danielle Di Maio ai sassofoni e Manuela Pasqui al pianoforte. La sassofonista avevamo già avuto modo di apprezzarla, tra l’altro, negli album di Ajugada Quartet e della vocalist Antonella Vitale mentre la Pasqui ha già firmato un album come leader (“Il filo dell’aquilone”) oltre ad aver collaborato con numerosi jazzisti di vaglia. Questo per dire che le due artiste sono ben note nell’ambiente del jazz, godendo di una meritata stima. Stima che viene confermata dall’album in oggetto che si articola su nove brani declinati sia sul versante prettamente jazzistico grazie a due original firmati rispettivamente dalla sassofonista (“Cagnaccio”) e dalla pianista (“Della mancanza e dell’amore”) sia, soprattutto, sulla rielaborazione di brani tratti dal repertorio “colto”, arrangiati dalla Pasqui che da sempre si caratterizza per questa sua capacità di attingere dal repertorio classico per rivitalizzarlo con il linguaggio dell’improvvisazione. Ecco quindi in scaletta Thibaut, John Dowland, Claudio Monteverdi, Franz Schubert, Johann Pachelbel. A mio avviso il pregio maggiore dell’album consiste nel fatto che, ascoltando i brani (tutti eseguiti magistralmente), non si avverte nessuno iato tra pezzi che traggono ispirazione da due mondi così diversi, eppure così vicini nella considerazione dell’Amore quale elemento, forse l’unico, che può aiutarci a vivere.
Enzo Favata – “The Crossing “ – Niafunken
 Conosco Enzo favata da molti anni e credo di poter dire che questo è uno dei migliori album da lui realizzato nel corso di una oramai lunga e prestigiosa carriera. Il musicista sardo, in questa occasione al sax, theremin, samples è coadiuvato da Pasquale Mirra al vibrafono, marimba midi e Fender Rhodes, Rosa Brunello al Fender Bass, Marco Frattini, batteria e percussioni, cui si aggiungono in qualità di ospiti Ilaria Pilar Patassini voce, Salvatore Maiore cello, Maria Vicentini violino e viola e il chitarrista Marcello Peghin, già accanto a Favata in numerose avventure. Una tantum il titolo dell’album così come dei vari brani non è occasionale ma deriva compiutamente dalla musica proposta. Così, ad esempio, “The Crossing” (“Attraversamento, incrocio”) sta a significare proprio l’intenzione di Favata di proporre una musica che testimoni l’incrocio di più culture. Non a caso il brano d’apertura, “Roots”, di Jan Carr dei Nucleus, segnala una profonda attenzione verso il jazz-rock così come “Salt Way” dello stesso Favata ci riporta alla mente quella via del sale che attraversava il deserto della Dancalia grazie ad una musica orientaleggiante, ricca di umori, sapori così sapientemente speziati mentre particolarmente toccante è “Black Lives Matter”. Il brano, composto a più mani da Favata, Brunello, Mirra e Frattini vuole esprimere lo sdegno presente ancora in tutti noi per un episodio inaccettabile, con il sax di Favata a enfatizzare il clima del pezzo, su un tappeto sonoro che sembra richiamare i grandi paladini, musicisti e non, dell’eguaglianza dei neri negli States…e non solo; particolarmente adatto il campionamento delle voci di Steve Biko, Fela Kuti e Malcom X.
Conosco Enzo favata da molti anni e credo di poter dire che questo è uno dei migliori album da lui realizzato nel corso di una oramai lunga e prestigiosa carriera. Il musicista sardo, in questa occasione al sax, theremin, samples è coadiuvato da Pasquale Mirra al vibrafono, marimba midi e Fender Rhodes, Rosa Brunello al Fender Bass, Marco Frattini, batteria e percussioni, cui si aggiungono in qualità di ospiti Ilaria Pilar Patassini voce, Salvatore Maiore cello, Maria Vicentini violino e viola e il chitarrista Marcello Peghin, già accanto a Favata in numerose avventure. Una tantum il titolo dell’album così come dei vari brani non è occasionale ma deriva compiutamente dalla musica proposta. Così, ad esempio, “The Crossing” (“Attraversamento, incrocio”) sta a significare proprio l’intenzione di Favata di proporre una musica che testimoni l’incrocio di più culture. Non a caso il brano d’apertura, “Roots”, di Jan Carr dei Nucleus, segnala una profonda attenzione verso il jazz-rock così come “Salt Way” dello stesso Favata ci riporta alla mente quella via del sale che attraversava il deserto della Dancalia grazie ad una musica orientaleggiante, ricca di umori, sapori così sapientemente speziati mentre particolarmente toccante è “Black Lives Matter”. Il brano, composto a più mani da Favata, Brunello, Mirra e Frattini vuole esprimere lo sdegno presente ancora in tutti noi per un episodio inaccettabile, con il sax di Favata a enfatizzare il clima del pezzo, su un tappeto sonoro che sembra richiamare i grandi paladini, musicisti e non, dell’eguaglianza dei neri negli States…e non solo; particolarmente adatto il campionamento delle voci di Steve Biko, Fela Kuti e Malcom X.
Karima – “No Filter” – Parco della Musica
 E’ da molto tempo che seguo Karima la cui carriera, a mio avviso, non è stata finora adeguata alle sue effettive possibilità. Ma andiamo indietro nel tempo. Karima è stata, a mio sommesso avviso, l’unico vero talento che sia emerso dalla trasmissione “Amici”. Quell’anno, però, non vinse e la cosa mi fece talmente arrabbiare che smisi di vedere il programma. Adesso di anni ne sono passati, ma Karima stenta ad emergere nonostante il suo talento sia stato riconosciuto da personaggi di assoluto livello come Burt Bacharach, che ha scritto per lei dei brani e prodotto, nel 2010, il suo primo album dal titolo “Karima”. Questo nuovo album, che arriva dopo sei anni dall’ultima fatica discografica, rende giustizia, anche se non del tutto, delle due qualità: bellissima voce, ottime dosi interpretative, capacità di affrontare con sapienza un repertorio certo non facile. In effetti la vocalist presenta in rapida successione tutta una serie di successi della musica internazionale, per la precisione ben undici, tra cui i celebri “Walk on the Wild Side” di Lou Reed prima traccia del disco e anche primo singolo accompagnato dal videoclip che narra la recording session dell’album pubblicato come anticipazione sulla pagina Facebook di Karima, “Feel Like Making Love” di George Benson e Roberta Flack, “Come Together” e “Blackbyrd” dei Beatles. Ad accompagnare Karima, Gabriele Evangelista al basso, Piero Frassi al pianoforte e arrangiamenti, e la Piemme Orchestra diretta da Marcello Sirignano.
E’ da molto tempo che seguo Karima la cui carriera, a mio avviso, non è stata finora adeguata alle sue effettive possibilità. Ma andiamo indietro nel tempo. Karima è stata, a mio sommesso avviso, l’unico vero talento che sia emerso dalla trasmissione “Amici”. Quell’anno, però, non vinse e la cosa mi fece talmente arrabbiare che smisi di vedere il programma. Adesso di anni ne sono passati, ma Karima stenta ad emergere nonostante il suo talento sia stato riconosciuto da personaggi di assoluto livello come Burt Bacharach, che ha scritto per lei dei brani e prodotto, nel 2010, il suo primo album dal titolo “Karima”. Questo nuovo album, che arriva dopo sei anni dall’ultima fatica discografica, rende giustizia, anche se non del tutto, delle due qualità: bellissima voce, ottime dosi interpretative, capacità di affrontare con sapienza un repertorio certo non facile. In effetti la vocalist presenta in rapida successione tutta una serie di successi della musica internazionale, per la precisione ben undici, tra cui i celebri “Walk on the Wild Side” di Lou Reed prima traccia del disco e anche primo singolo accompagnato dal videoclip che narra la recording session dell’album pubblicato come anticipazione sulla pagina Facebook di Karima, “Feel Like Making Love” di George Benson e Roberta Flack, “Come Together” e “Blackbyrd” dei Beatles. Ad accompagnare Karima, Gabriele Evangelista al basso, Piero Frassi al pianoforte e arrangiamenti, e la Piemme Orchestra diretta da Marcello Sirignano.
Roberto Magris – “Suite!” – 2 CD JMOOD
Roberto Magris, Eric Hochberg – “Shuffling Ivories“ JMOOD
 Roberto Magris è uno dei non moltissimi jazzisti italiani che abbia oramai acquisito una statura effettivamente internazionale come dimostrano i due album in oggetto.
Roberto Magris è uno dei non moltissimi jazzisti italiani che abbia oramai acquisito una statura effettivamente internazionale come dimostrano i due album in oggetto.
Il primo – “Suite”- è il diciassettesimo album in studio registrato negli Stati Uniti da Roberto Magris per la casa discografica JMood di Kansas City. È il primo disco inciso da Magris a Chicago, assieme a musicisti della scena jazz Chicagoana, per la cronaca Eric Jacobson tromba, Mark Colby tenor sax, Eric Hochberg basso, Greg Artry batteria, Pj Aubree Collins voce, con l’aggiunta di Spoken word in alcuni brani, e con alcuni pezzi incisi in piano solo, provenienti da una successiva session discografica tenutasi a Miami. Il programma è prevalentemente basato su brani e testi originali, con alcune rivisitazioni di standard del jazz e due brani pop degli anni ‘70 come “In the Wake of Poseidon” dei King Crimson e “One with the Sun” dei Santana con la ripresa di “Imagine” di John Lennon. Da evidenziare come sotto molti aspetti si tratti di un coincept album dal momento che nei pezzi scritti dallo stesso Magris è molto presente il richiamo alla pace, alla fratellanza. In altre parole con questa splendida realizzazione il pianista triestino vuole veicolare un messaggio di speranza e lo fa con i mezzi a sua disposizione. Di qui un linguaggio che è una sorta di summa delle più significative correnti che hanno attraversato il jazz degli ultimi decenni mentre nei brani per piano solo ritroviamo il Magris sensibile, introspettivo che abbiamo imparato a conoscere in questi anni.
 Pubblicato nel 2021 sempre per la JMood di Chicago, il secondo album – “Shuffling Ivories“- presenta il pianista triestino in duo con il contrabbassista Eric Hochberg in un programma dedicato interamente da un canto al piano jazz, da Eubie Blacke ad Andrew Hill, dall’altro alle più profonde radici del jazz statunitense da cui provengono echi di blues e ragtime, di gospel, di free. Il tutto intervallato da original dello stesso Magris. Quasi inutile dirlo, ma il pianista ancora una volta fa centro, grazie ad una sorta di ispirazione che pervade ogni sua esibizione. Il suo pianismo, anche in questo caso scevro da qualsivoglia tentativo di stupire l’ascoltatore, si sofferma sulla necessità espressiva di creare un fitto dialogo con il suo partner, dialogo che venga recepito appieno dall’ascoltatore. E così accade anche perché il contrabbassista dimostra di condividere appieno gli intendimenti del compagno di strada. Di qui un dialogo che si sviluppa fitto, impegnativo, mai banale con i due impegnati ad ascoltarsi e rispondersi sull’onda di un’intesa che non conosce tentennamenti. Ad avvalorare quanto sin qui detto, citiamo alcuni dei titoli contenuti nell’album: “Memories of You” di Blake, “Laverne” di Hill”, “I’ve Found A New Baby” di Palmer e Williams, “The Time Of This World Is At Hand” scritto dal pianista e compositore Billy Gault, “Quiet Dawn” di Cal Massey vero e proprio cavallo di battaglia di Archie Shepp che lo incluse nel celebre album “Attica Blues” del ’72.
Pubblicato nel 2021 sempre per la JMood di Chicago, il secondo album – “Shuffling Ivories“- presenta il pianista triestino in duo con il contrabbassista Eric Hochberg in un programma dedicato interamente da un canto al piano jazz, da Eubie Blacke ad Andrew Hill, dall’altro alle più profonde radici del jazz statunitense da cui provengono echi di blues e ragtime, di gospel, di free. Il tutto intervallato da original dello stesso Magris. Quasi inutile dirlo, ma il pianista ancora una volta fa centro, grazie ad una sorta di ispirazione che pervade ogni sua esibizione. Il suo pianismo, anche in questo caso scevro da qualsivoglia tentativo di stupire l’ascoltatore, si sofferma sulla necessità espressiva di creare un fitto dialogo con il suo partner, dialogo che venga recepito appieno dall’ascoltatore. E così accade anche perché il contrabbassista dimostra di condividere appieno gli intendimenti del compagno di strada. Di qui un dialogo che si sviluppa fitto, impegnativo, mai banale con i due impegnati ad ascoltarsi e rispondersi sull’onda di un’intesa che non conosce tentennamenti. Ad avvalorare quanto sin qui detto, citiamo alcuni dei titoli contenuti nell’album: “Memories of You” di Blake, “Laverne” di Hill”, “I’ve Found A New Baby” di Palmer e Williams, “The Time Of This World Is At Hand” scritto dal pianista e compositore Billy Gault, “Quiet Dawn” di Cal Massey vero e proprio cavallo di battaglia di Archie Shepp che lo incluse nel celebre album “Attica Blues” del ’72.
Sade Farina Mangiaracina – “Madiba” – Tuk Music
 La pianista siciliana (in un brano anche al Fender Rhodes) si ripresenta in trio con il bassista Marco Bardosica e il batterista Gianluca Brugnano cui si aggiunge Zid Trablesi al loud in tre pezzi. E già quindi da questo organico si può comprendere quali siano le intenzioni di Sade, intenzioni rese ancora più esplicite dal titolo dell’album. In buona sostanza l’artista intende dedicare questa musica ad un eroe dei nostri tempi, Nelson Mandela, del quale narrare la storia. Impresa ovviamente al limite del possibile data l’annosa polemica sulla semanticità o meno della musica. Comunque, a parte queste considerazioni, non c’è dubbio che questo album riesce a far riflettere chi lo ascolta, dipingendo un contesto in cui la storia di Mandela può trovare giusta collocazione. La Mangiaracina sfoggia ancora una volta un pianismo oramai maturo che esprime compiutamente le sue idee. Così, ad esempio, in “Winnie”, dedicato alla moglie del leader sudafricano, il ritmo si fa incandescente come a voler sottolineare le difficoltà incontrate dalla donna nello stare accanto a Nelson. Ma questo è solo un episodio ché in tutti i brani si ritrova qualcosa di interessante non disgiunta dal tema centrale. Ecco quindi, per fare un altro esempio, la ripresa del brano “Letter From A Prison”, una splendida ballad con Bardoscia in grande spolvero. Ma, citato Bardoscia, non si possono dimenticare gli altri componenti il gruppo, tutti perfettamente all’altezza di un compito certo non facile.
La pianista siciliana (in un brano anche al Fender Rhodes) si ripresenta in trio con il bassista Marco Bardosica e il batterista Gianluca Brugnano cui si aggiunge Zid Trablesi al loud in tre pezzi. E già quindi da questo organico si può comprendere quali siano le intenzioni di Sade, intenzioni rese ancora più esplicite dal titolo dell’album. In buona sostanza l’artista intende dedicare questa musica ad un eroe dei nostri tempi, Nelson Mandela, del quale narrare la storia. Impresa ovviamente al limite del possibile data l’annosa polemica sulla semanticità o meno della musica. Comunque, a parte queste considerazioni, non c’è dubbio che questo album riesce a far riflettere chi lo ascolta, dipingendo un contesto in cui la storia di Mandela può trovare giusta collocazione. La Mangiaracina sfoggia ancora una volta un pianismo oramai maturo che esprime compiutamente le sue idee. Così, ad esempio, in “Winnie”, dedicato alla moglie del leader sudafricano, il ritmo si fa incandescente come a voler sottolineare le difficoltà incontrate dalla donna nello stare accanto a Nelson. Ma questo è solo un episodio ché in tutti i brani si ritrova qualcosa di interessante non disgiunta dal tema centrale. Ecco quindi, per fare un altro esempio, la ripresa del brano “Letter From A Prison”, una splendida ballad con Bardoscia in grande spolvero. Ma, citato Bardoscia, non si possono dimenticare gli altri componenti il gruppo, tutti perfettamente all’altezza di un compito certo non facile.
Germano Mazzocchetti Ensemble – “Muggianne” – Alfa Music
 Germano Mazzocchetti è uno di quei pochi musicisti che mai delude; questo grazie anche al fatto che entra in sala di incisione solo quando ritiene di avere qualcosa di importante e di nuovo da dire. E quest’ultimo suo CD non fa eccezione alla regola. “Muggianne” è un album che si ascolta con interesse dalla prima all’ultima nota, soffuso com’è, specie nei primi brani, da un sottile velo di malinconia. Il tutto eseguito magistralmente da un gruppo coeso dalla lunga militanza e che comprende Francesco Marini al sassofono e ai clarinetti, Paola Emanuele alla viola, Marco Acquarelli alla chitarra, Luca Pirozzi al contrabbasso e Valerio Vantaggio alla batteria. E già la struttura dell’organico e i nomi dei musicisti dicono molto circa la statura artistica di Mazzocchetti: il fisarmonicista e compositore abruzzese, nel suo personalissimo bagaglio culturale, può vantare una passione per il jazz, una conoscenza approfondita della musica colta nelle sue varie declinazioni, nonché una approfondita conoscenza del musical e una ricca frequentazione del teatro di prosa: non a caso Germano è anche uno dei più apprezzati autori di musiche di scena. Questa miscela la si ritrova compiutamente nella sua musica che quindi risulta difficilissima da classificare, ammesso poi che la cosa sia importante! Quel che viceversa risulta importante è la qualità di ciò che propone, sempre originale, mai banale e soprattutto sempre coinvolgente. Un’ultima notazione: molti si saranno chiesti che significa ‘Muggianne’; la risposta ce la fornisce lo stesso Mazzocchetti: ”Il titolo Muggianne è una parola che nel dialetto del mio paese significa ‘Sta zitto e non parlare più’” come a dire, forse (ma questa è una nostra personalissima interpretazione) che la musica non ha bisogno di essere spiegata per entrare nei nostri cuori.
Germano Mazzocchetti è uno di quei pochi musicisti che mai delude; questo grazie anche al fatto che entra in sala di incisione solo quando ritiene di avere qualcosa di importante e di nuovo da dire. E quest’ultimo suo CD non fa eccezione alla regola. “Muggianne” è un album che si ascolta con interesse dalla prima all’ultima nota, soffuso com’è, specie nei primi brani, da un sottile velo di malinconia. Il tutto eseguito magistralmente da un gruppo coeso dalla lunga militanza e che comprende Francesco Marini al sassofono e ai clarinetti, Paola Emanuele alla viola, Marco Acquarelli alla chitarra, Luca Pirozzi al contrabbasso e Valerio Vantaggio alla batteria. E già la struttura dell’organico e i nomi dei musicisti dicono molto circa la statura artistica di Mazzocchetti: il fisarmonicista e compositore abruzzese, nel suo personalissimo bagaglio culturale, può vantare una passione per il jazz, una conoscenza approfondita della musica colta nelle sue varie declinazioni, nonché una approfondita conoscenza del musical e una ricca frequentazione del teatro di prosa: non a caso Germano è anche uno dei più apprezzati autori di musiche di scena. Questa miscela la si ritrova compiutamente nella sua musica che quindi risulta difficilissima da classificare, ammesso poi che la cosa sia importante! Quel che viceversa risulta importante è la qualità di ciò che propone, sempre originale, mai banale e soprattutto sempre coinvolgente. Un’ultima notazione: molti si saranno chiesti che significa ‘Muggianne’; la risposta ce la fornisce lo stesso Mazzocchetti: ”Il titolo Muggianne è una parola che nel dialetto del mio paese significa ‘Sta zitto e non parlare più’” come a dire, forse (ma questa è una nostra personalissima interpretazione) che la musica non ha bisogno di essere spiegata per entrare nei nostri cuori.
Enrico Rava – “Edizione Speciale” – ECM
 Siamo nell’estate del 2019 e si festeggiano due compleanni importanti: i 50 anni della ECM e gli 80 di Enrico Rava. Il gruppo del trombettista e flicornista si esibisce ad Antwerp, Belgio, con l’abituale organico completato da Francesco Diodati alla chitarra elettrica, Gabriele Evangelista al contrabbasso ed Enrico Morello alla batteria, cui si aggiungono due ospiti “eccellenti” quali Francesco Bearzatti al sax tenore e Giovanni Guidi al pianoforte. Il concerto viene registrato ed eccolo qui a disposizione di tutti noi. Rava è universalmente riconosciuto come uno dei musicisti più creativi ed originali che il jazz europeo abbia conosciuto, grazie ad una versatilità che nel corso di una carriera oramai molto lunga gli ha permesso sia di restare fedele alla tradizione, sia di elaborare un linguaggio melodico consono alla tradizione italica, il tutto senza trascurare le innovazioni dettate dal free di Ornette Coleman e le suggestioni ritmiche della musica sud americana nelle sue varie declinazioni. A ciò si aggiunga il fatto che Rava ha lanciato diversi giovani musicisti come quelli che compongono il suo attuale quartetto. Per questa “Edizione speciale” Rava ha voluto ripercorrere il suo repertorio proponendo pezzi che vanno dal 1978 al 2015, anno di pubblicazione di “Wild Dance”, più nuove versioni di “ Once Upon A Summertime” , un classico di Michel Legrand e di “Quizás, Quizás, Quizás”, celebre brano di musica cubana. Come suo solito Rava si ritaglia spazi solistici ma lascia ampia libertà d’azione ai compagni di viaggio e così in particolare Diodati, Guidi e Bearzatti hanno modo di evidenziare ancora una volta quel talento che tutti riconosciamo loro. Insomma un disco davvero da “Edizione speciale”.
Siamo nell’estate del 2019 e si festeggiano due compleanni importanti: i 50 anni della ECM e gli 80 di Enrico Rava. Il gruppo del trombettista e flicornista si esibisce ad Antwerp, Belgio, con l’abituale organico completato da Francesco Diodati alla chitarra elettrica, Gabriele Evangelista al contrabbasso ed Enrico Morello alla batteria, cui si aggiungono due ospiti “eccellenti” quali Francesco Bearzatti al sax tenore e Giovanni Guidi al pianoforte. Il concerto viene registrato ed eccolo qui a disposizione di tutti noi. Rava è universalmente riconosciuto come uno dei musicisti più creativi ed originali che il jazz europeo abbia conosciuto, grazie ad una versatilità che nel corso di una carriera oramai molto lunga gli ha permesso sia di restare fedele alla tradizione, sia di elaborare un linguaggio melodico consono alla tradizione italica, il tutto senza trascurare le innovazioni dettate dal free di Ornette Coleman e le suggestioni ritmiche della musica sud americana nelle sue varie declinazioni. A ciò si aggiunga il fatto che Rava ha lanciato diversi giovani musicisti come quelli che compongono il suo attuale quartetto. Per questa “Edizione speciale” Rava ha voluto ripercorrere il suo repertorio proponendo pezzi che vanno dal 1978 al 2015, anno di pubblicazione di “Wild Dance”, più nuove versioni di “ Once Upon A Summertime” , un classico di Michel Legrand e di “Quizás, Quizás, Quizás”, celebre brano di musica cubana. Come suo solito Rava si ritaglia spazi solistici ma lascia ampia libertà d’azione ai compagni di viaggio e così in particolare Diodati, Guidi e Bearzatti hanno modo di evidenziare ancora una volta quel talento che tutti riconosciamo loro. Insomma un disco davvero da “Edizione speciale”.
Santi Scarcella – “Da Manhattan a Cefalù” –
 Il più jazzista dei cantautori italiani. Così è stato definito Santi Scarcella, definizione da condividere in toto dopo aver ascoltato l’album “Da Manhattan a Cefalù”, dedicato alla memoria di Nick La Rocca, un emigrante siciliano a cui, per convenzione, si deve la registrazione del primo disco di jazz nel 1917. Partendo da un repertorio di quattordici brani di cui ben dodici scritti dallo stesso Scarcella da solo o in compagnia di Viscuso o Mesolella, con l’aggiunta del traditional “Vitti na crozza” di Li Causi e lo standard di chiusura “Some Day My Prince Will Come”, Scarcella sfodera uno stile tanto arguto quanto personale. Mescolando il dialetto siciliano con l’italiano ma anche con lo spagnolo e l’inglese, nonché differenti stili come il samba, il mambo, passando attraverso il rag time, lo ska, Santi prepara una ricetta assolutamente fruibile…anche se farà storcere la bocca ai puristi del jazz. Tuttavia a beneficio di questi ultimi forse non è inutile sottolineare in primo luogo che il progetto di Scarcella, partito dai canti di lavoro siciliani, è riuscito a trovare elementi in comune con il blues americano e, proprio per questo, è stato approvato dalla statunitense Uconn University e in secondo luogo che sotto la veste dell’allegria, l’album tratta temi molto ma molto seri come l’emigrazione, l’integrazione, il glocalismo, patologie gravi come l’Asperger.
Il più jazzista dei cantautori italiani. Così è stato definito Santi Scarcella, definizione da condividere in toto dopo aver ascoltato l’album “Da Manhattan a Cefalù”, dedicato alla memoria di Nick La Rocca, un emigrante siciliano a cui, per convenzione, si deve la registrazione del primo disco di jazz nel 1917. Partendo da un repertorio di quattordici brani di cui ben dodici scritti dallo stesso Scarcella da solo o in compagnia di Viscuso o Mesolella, con l’aggiunta del traditional “Vitti na crozza” di Li Causi e lo standard di chiusura “Some Day My Prince Will Come”, Scarcella sfodera uno stile tanto arguto quanto personale. Mescolando il dialetto siciliano con l’italiano ma anche con lo spagnolo e l’inglese, nonché differenti stili come il samba, il mambo, passando attraverso il rag time, lo ska, Santi prepara una ricetta assolutamente fruibile…anche se farà storcere la bocca ai puristi del jazz. Tuttavia a beneficio di questi ultimi forse non è inutile sottolineare in primo luogo che il progetto di Scarcella, partito dai canti di lavoro siciliani, è riuscito a trovare elementi in comune con il blues americano e, proprio per questo, è stato approvato dalla statunitense Uconn University e in secondo luogo che sotto la veste dell’allegria, l’album tratta temi molto ma molto seri come l’emigrazione, l’integrazione, il glocalismo, patologie gravi come l’Asperger.
Giovanni e Jasmine Tommaso – “As Time Goes By” – Parco della Musica
 Non è inusuale che membri della stessa famiglia collaborino nella realizzazione di un album ma ciò non ci impedisce di salutare con simpatia questo album che vede l’uno accanto all’altra il papà Giovanni Tommaso e la figlia Jasmine Tommaso in quintetto con Claudio Filippini al piano e Fender Rhodes, Andrea Molinari alla chitarra e Alessandro “Pacho” Rossi alla batteria. Sgombriamo subito il campo da qualsivoglia equivoco: Jasmine non è solo la figlia di un gigante del jazz quale Giovanni Tommaso, ma è una vocalist che ha tutte le carte in regola per intraprendere una brillante carriera; da anni stabilita a Los Angeles, può vantare un intenso percorso accademico speso tra la School of the Arts di South Orange e l’Università della California e gli studi in ambito jazz presso il Berklee College of Music di Boston. A ciò si aggiungono collaborazioni di rilievo con Stefano Bollani, Danilo Rea, Tia Fueller, Kim Thompson e Fabrizio Bosso. Questo album arriva al momento giusto per certificare l’avvenuta maturazione dell’artista. Jasmine interpreta bene un repertorio variegato in cui accanto a brani dal sapore prettamente jazzistico quali “Once Upon A Dream” di Sammy Fain e Jack Lawrence, “Lullaby Of Birdland” di George Shearing e la successiva “Someone To Watch Over Me” di George Gershwin, possiamo ascoltare una suggestiva versione di “Marinella” di Fabrizio De André nonché alcuni original scritti dalla stessa Jasmine con Lorenzo Grassi e dallo stesso leader.
Non è inusuale che membri della stessa famiglia collaborino nella realizzazione di un album ma ciò non ci impedisce di salutare con simpatia questo album che vede l’uno accanto all’altra il papà Giovanni Tommaso e la figlia Jasmine Tommaso in quintetto con Claudio Filippini al piano e Fender Rhodes, Andrea Molinari alla chitarra e Alessandro “Pacho” Rossi alla batteria. Sgombriamo subito il campo da qualsivoglia equivoco: Jasmine non è solo la figlia di un gigante del jazz quale Giovanni Tommaso, ma è una vocalist che ha tutte le carte in regola per intraprendere una brillante carriera; da anni stabilita a Los Angeles, può vantare un intenso percorso accademico speso tra la School of the Arts di South Orange e l’Università della California e gli studi in ambito jazz presso il Berklee College of Music di Boston. A ciò si aggiungono collaborazioni di rilievo con Stefano Bollani, Danilo Rea, Tia Fueller, Kim Thompson e Fabrizio Bosso. Questo album arriva al momento giusto per certificare l’avvenuta maturazione dell’artista. Jasmine interpreta bene un repertorio variegato in cui accanto a brani dal sapore prettamente jazzistico quali “Once Upon A Dream” di Sammy Fain e Jack Lawrence, “Lullaby Of Birdland” di George Shearing e la successiva “Someone To Watch Over Me” di George Gershwin, possiamo ascoltare una suggestiva versione di “Marinella” di Fabrizio De André nonché alcuni original scritti dalla stessa Jasmine con Lorenzo Grassi e dallo stesso leader.
da Redazione | 09/Ago/2021 | News, Primo piano, Recensioni
di Flaviano Bosco –
Concepire, progettare e realizzare una rassegna musicale nei mesi passati poteva sembrare una follia assoluta, un azzardo, un vero colpo di dadi. Qualche volta però anche la pazzia è necessaria ed è proprio vero quello che dicevano gli antichi: “La fortuna aiuta gli audaci” o un po’ più volgarmente: “Chi non risica non rosica”; non sempre è vero ma questa volta si! E non è stato solo il favore della dea bendata.

In lingua friulana si dicono bonariamente “Cjastrons” i testardi irriducibili, quelli che contro tutto e contro tutti continuano dritti per la loro strada, a qualunque costo, anche se sembra che non abbiano alcuna possibilità di riuscire. Preferiscono continuare a sbattere la testa contro gli ostacoli pur di non cedere ai compromessi e soprattutto osano perdere e piuttosto di genuflettersi si spezzano.
“Cjastrons” di successo, in questo senso, sono sicuramente Giancarlo Velliscig e i suoi collaboratori di Euritmica che da 31 anni organizzano Udin&Jazz, la manifestazione che da tre anni ha partorito Grado Jazz che si aggiunge ad altre stagioni musicali e teatrali (Onde Mediterranee, Borghi Swing, Teatro Pasolini di Cervignano, Note Nuove, MusiCarnia ecc.)
In tutti questi anni gli è di certo capitato di sbattere il capo ma la scommessa è stata davvero vincente e i numeri e la qualità di quest’ultima edizione di Grado Jazz lo dimostrano. In accordo con la lungimirante amministrazione comunale dell’Isola d’oro è stato approntato e portato a termine un programma davvero succulento che ha fatto divertire, commuovere, emozionare, rilassare, eccitare gli spettatori spesso tutto nello stesso momento.
Ecco di seguito una mia selezione dei momenti più significativi, tra i tanti del festival, che ho seguito dalla seconda serata alla fine.
-

-
Claudio Cojaniz – ph Luca A. d’Agostino/Phocus Agency©
-

-
Claudio Cojaniz – ph Luca A. d’Agostino/Phocus Agency©
-

-
Claudio Cojaniz – ph Luca A. d’Agostino/Phocus Agency©
-

-
Bandakadabra – ph Angelo Salvin©
-

-
Bandakadabra – ph Luca A. d’Agostino/Phocus Agency©
-

-
Bandakadabra – ph Angelo Salvin©
Claudio Cojaniz “Black Water Music”. Quella dei concerti all’alba è diventata ormai una piacevole consuetudine di festival e rassegne, è un modo per riappropriarsi o per esplorare in musica momenti della giornata che normalmente non consideriamo. Accompagnare l’alba con le note del pianoforte di fronte all’orizzonte marino con il sole che sorge direttamente dalla laguna nel silenzio di una città che ancora dorme è un’esperienza quasi religiosa, un rito pagano. Se poi a suscitare le note sono le dita di un pianista come Cojaniz capace di un grande lirismo e sconfinati orizzonti non si può sbagliare. Provare per credere!
Bandakadabra: all’insegna del divertimento stradaiolo più verace e disimpegnato i “ragazzi” di Torino sanno davvero come far sorridere la gente e non c’è niente di più divertente che il vedere una band scatenata in mezzo alla folla che la segue in processione per tutta la città al ritmo del tamburo. Frizzanti, scoppiettanti, leggeri, clowneschi, saltimbanchi del jazz, una street marching band senza troppe pretese se non l’allegria propria e del pubblico. Momenti come questo contribuiscono a fare della rassegna una festa per tutta la città e non solo un evento elitario per i tanti appassionati. Bene hanno fatto gli organizzatori a voler disseminare in giro per la città balneare alcune iniziative, il grande favore riscontrato dal pubblico significa che la strada è quella giusta.
-

-
Dee Dee Bridgewater – ph Luca A. d’Agostino/Phocus Agency©
-

-
Dee Dee Bridgewater – ph Luca A. d’Agostino/Phocus Agency©
-

-
Dee Dee Bridgewater – ph Luca A. d’Agostino/Phocus Agency ©
-

-
Dee Dee Bridgewater – ph Luca A. d’Agostino/Phocus Agency©
-

-
Dee Dee Bridgewater – ph Angelo Salvin©
-

-
Dee Dee Bridgewater – ph Angelo Salvin©
Dee Dee Bridgewater. Una vera Lady con la voce intatta nonostante non sia più una fanciulla in fiore. Con un gruppo di giovani musicisti italiani tra i quali spiccavano la contrabbassista Rosa Brunello e la batterista Evita Polidoro. La cantante ha proposto dal suo sconfinato song book soprattutto brani del periodo con Stanley Clarke e Chick Corea; alla memoria di quest’ultimo era dedicato l’intero concerto. Visibilmente divertita, la Bridgewater ha “giocato” con la propria voce e con i musicisti, ridendo, ballando, raccontando gustosi aneddoti sulla sua lunga carriera fatta di incontri straordinari ma soprattutto incantando il pubblico con le sue doti canore strabilianti in grado di passare in un battito di ciglia dai toni più gravi, sporchi e bluesy fino ai più verticali acuti con estrema naturalezza e senza artifici accademici.
Daniele D’Agaro con i suoi sax e i suoi clarinetti ha saputo intrattenere i passanti proprio nel cuore della città lagunare in un luogo dalle architetture straordinarie e dalle antichissime testimonianze: il sagrato comune tra due basiliche paleocristiane, una a fianco dell’altra (Santa Eufemia e Santa Maria delle Grazie). Le sue ance sembravano riempire il balzo temporale tra quell’estrema antichità e il “presente fatto di attimi e settimane enigmistiche” come dice il poeta. D’Agaro sa essere evocativo e immaginifico sulle sue chiavi ma spesso risulta meditativo e distante, per un sassofonista non sono certo difetti. La sua performance solitaria è stata affascinante ma anche piacevolmente ermetica e astratta.
-

-
Brad Mehldau Trio – ph Luca A. d’Agostino/Phocus Agency©
-

-
Brad Mehldau Trio – ph Luca A. d’Agostino/Phocus Agency©
-

-
Brad Mehldau Trio – ph Luca A. d’Agostino/Phocus Agency©
-

-
Brad Mehldau Trio – ph Luca A. d’Agostino/Phocus Agency©
-

-
Daniele D’Agaro – ph Luca A. d’Agostino/Phocus Agency©
-

-
Daniele D’Agaro – ph Luca A. d’Agostino/Phocus Agency©
Brad Mehldau trio. Molti musicisti tra gli spettatori, il gotha dei jazzisti locali e di oltre confine con l’aggiunta di moltissimi appassionati, critici e giornalisti che aspettavano l’apparizione di quello che ormai è considerato un gigante della musica contemporanea senza definizioni di genere. L’attesa non è stata vana, Mehldau ha presentato il suo ultimo lavoro con un’esibizione convincente e maiuscola nonostante una piccola ferita al pollice che si era procurato tagliando un limone a poche ore dal concerto. Romantico e lirico, lontano dalle iper-virtuosistiche prestazioni di inizio carriera, mantiene una certa predisposizione ad un pop colto e “pettinato” che gli permette gli usuali sconfinamenti e crossover musicali appropriandosi, come in questo caso, di canzoni del tutto eterodosse come “Friends” dei Beach Boys. Ottimo l’interplay con i propri musicisti Grenadier al contrabbasso e Ballard alla batteria.
Mirko Cisilino: Tromba, trombone, Tuba in fa e una moltitudine di sordine, con queste armi si è presentato il trombettista in una delle vie centrali dello “struscio” serale di Grado. La sua esibizione ha colpito e affascinato molti ma ha ugualmente reso perplessi e forse anche indifferenti altri. Non è facile improvvisare davanti ad un pubblico a passeggio. Di recente anche Paolo Fresu travestito da barbone è stato completamente ignorato in un concerto improvvisato in piazza Navona a Roma, era successo alcuni anni fa anche a Joshua Bell, genio del violino, in una stazione della metropolitana a New York. Spesso siamo troppo distratti e non poniamo sufficientemente attenzione a ciò che ci circonda, a volte ci impediamo di scoprire autentici tesori come quelli che Cisilino soffiava nei propri labiofoni, da improvvisazioni su melodie classiche a quelle free form e rumoristiche. Tra gli spettatori più attenti, due bambini che leccavano il loro gelatone guardavano divertiti e perplessi qualcosa che forse non capivano del tutto ma che destava la loro curiosità. E’ proprio quello l’atteggiamento che tutti dovremmo sforzarci di avere. La vera musica è sempre Bellezza e Mistero.
-

-
Danilo Rea&Luciano Biondini – ph Angelo Salvin ©
-

-
Danilo Rea&Luciano Biondini – ph Luca A. d’Agostino/Phocus Agency ©
-

-
Danilo Rea&Luciano Biondini – ph Luca A. d’Agostino/Phocus Agency ©
-

-
Danilo Rea&Luciano Biondini – ph Luca A. d’Agostino/Phocus Agency ©
-

-
Danilo Rea&Luciano Biondini – ph Luca A. d’Agostino/Phocus Agency ©
-

-
Danilo Rea&Luciano Biondini – ph Angelo Salvin ©
Danilo Rea&Luciano Biondini: intrattenimento elegante fatto di classici della canzone italiana rivisitati in jazz in un’atmosfera da piano bar; c’è da chiedersi se abbia ancora senso un progetto del genere dopo che il revival jazzato sulle canzoni “leggerissime” della tradizione anni ‘60 si fa da decenni in tutte le salse e dopo che l’ottimo pianista Bollani ci ha costruito sopra una carriera trentennale. Anche il progetto che i due da anni portano in scena (Cosa sono le nuvole) che rivisita i brani più famosi della canzone italiana comincia ad essere una replica di se stesso, nostalgia di nostalgia. Certo entrambi sono ottimi musicisti, al pubblico continuano a piacere moltissimo, lo si è visto al Parco delle Rose e non si può certo rimproverare nessuno, il jazz cinquant’anni fa era fatto anche di questo.
Jazz Portraits. Fotografo ufficiale del festival e di tante altre avventure, Luca A. D’Agostino con i propri collaboratori segue il festival da trentun’anni. Una splendida esposizione, da egli stesso curata, con significativi scatti suoi e di altri eccellenti fotografi AFIJ (Associazione Fotografi Italiani di Jazz) per ciascuna edizione faceva bella mostra di sé nel centro della cittadina balneare durante la rassegna. Tra le tante meravigliose immagini, tutte in un rigoroso, evocativo bianco e nero di veri e propri giganti della musica ospitati dalla manifestazione (Elvin Jones, Ornette Coleman, B.B King ecc.) ne spiccava uno del presente che è già proiettato nell’immediato futuro. Shabaka Hutchings, il geniale tenor sassofonista, che fu a Udine nel 2017 con i suoi The Ancestors, è immortalato in chiaroscuro nella cornice di una porta proprio mentre si sta accingendo a entrare in palcoscenico, imbracciando il proprio strumento. E’ un attimo sospeso in perfetto equilibrio tra quello che non c’è ancora e quello che sarà che da l’idea di che cosa sia oggi la musica dentro e intorno il jazz.
-

-
Mostra Jazz Portraits – Foto Luca A. d’Agostino/Phocus Agency ©
-

-
Mostra Jazz Portraits – Foto Luca A. d’Agostino/Phocus Agency ©
-

-
Mostra Jazz Portraits – Foto Luca A. d’Agostino/Phocus Agency ©
-

-
Mostra Jazz Portraits – ph Alessandra Freguja ©
-

-
Mostra Jazz Portraits – ph Alessandra Freguja©
-

-
Mostra Jazz Portraits – ph Luca A. d’Agostino/Phocus Agency ©
A Proposito di Jazz ringrazia i fotografi Luca A. d’Agostino Phocus Agency, Alessandra Freguja, Angelo Salvin (AFIJ) e l’ufficio stampa di GradoJazz/Euritmica
da Cinzia Sabbatini | 24/Giu/2021 | Comunicati stampa
Il bassista John Patitucci, il sassofonista Chris Potter e il batterista Brian Blade, uniti insieme in un unico trio jazz, saranno ospiti il 14 luglio all’anteprima della XXIII edizione del Corinaldo Jazz che si svolgerà nel suggestivo anfiteatro dell’antica città di Suasa alle ore 21:15.
Le tre star non hanno certo bisogno di presentazione, vantano così tante collaborazioni che, per menzionarle tutte, avremmo bisogno di troppo spazio.
John Patitucci è nato a Brooklyn, New York, nel 1959 e ha iniziato a suonare il basso elettrico all’età di dieci anni, cimentandosi successivamente con il basso acustico e il pianoforte. Passa rapidamente dal suonare soul e rock al blues, al jazz e alla musica classica: i suoi gusti eclettici gli hanno fatto esplorare tutti i generi musicali come musicista e compositore. Le sue sei registrazioni da solista per la GRP Records e le sue registrazioni successive gli hanno portato due Grammy Awards e oltre quindici nomination. Come strumentista Patitucci ha suonato in tutto il mondo con grandi esponenti della musica come Chick Corea, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Stan Getz, Wynton Marsalis, Joshua Redman, Freddie Hubbard e molti altri. Chris Potter è un sassofonista, compositore e polistrumentista jazz americano. Potter è diventato famoso come sideman con del trombettista Red Rodney, prima di esibirsi con il batterista Paul Motian, il bassista Dave Holland, il trombettista Dave Douglas e altri. Brian Blade è batterista e compositore il cui nome è legato alla lunga collaborazione con Joshua Redman. È membro stabile del quartetto di Wayne Shorter dal 2000 e ha collaborato al di fuori del panorama jazz con Bob Dylan.
Posto unico € 20 con prevendita online e su tutte le rivendite della piattaforma vivaticket (numero posti limitati).
In caso di maltempo il concerto sarà annullato e il biglietto rimborsato. Tutte le info su www.corinaldojazz.com e pagine social del Festival.
In occasione dell’evento, le porte del parco archeologico dell’Antica città di Suasa verranno aperte e sarà possibile effettuare una visita guidata alla Domus.Il costo del biglietto è di soli € 2 e le visite saranno effettuate in gruppi di massimo 15 persone rispettando tutte le norme previste dalle disposizioni in vigore. Orario visite: ore 20:00 e 20:30, con prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni sulla visita, chiamare 353 300 4077 o consultare il sito www.corinaldojazz.com.
Il concerto è organizzato in collaborazione con il Comune di Corinaldo,Assessorato alla Cultura ,Spaziomusica/Ancona Jazz e Comune di Castelleone di Suasa.
Gli altri due appuntamenti della XXIII edizione del Corinaldojazz sono previsti nella tradizionale Piazza Il Terreno a Corinaldo, il 4 e il 5 agosto alle 21:15, con rispettivamente il nuovo progetto di ZEPPETELLA-BOSSO in quintetto e il LANZONI-MORGAN-McPHERSON trio.
Tutte le informazioni sul sito www.corinaldojazz.com
da Gerlando Gatto | 21/Mar/2021 | I nostri CD, Primo piano, Recensioni

Pierluigi Balducci – “L’equilibrista” – Dodicilune
 Una prima notazione tutt’altro che secondaria: “questo lavoro – afferma lo stesso Balducci – vede la luce ad otto anni dal mio precedente disco, “Blue from Heaven”, e a tre anni da “Evansiana”, pubblicato nel 2017. Lo dedico a John Taylor, che in questi due dischi è presente: punto di riferimento sia per me che per tanti altri musicisti europei, John mi ha onorato della sua presenza nel mio quartetto fino alla sua scomparsa, nel 2014”. Ebbene, nell’intento di omaggiare cotanto artista, il bassista/compositore pugliese Pierluigi Balducci, ben coadiuvato da Robert Bonisolo (sax tenore), Fabrizio Savino (chitarra) e Dario Congedo (batteria) ha realizzato questo eccellente album con sette brani originali tutti composti dal leader. Inquadrato l’album nelle sue linee generali, occorre aggiungere che il titolo rispecchia appieno la musica che si ascolta. Un equilibrio tra forma e contenuto, un bilanciamento apprezzabile tra parti scritte e improvvisate, un giusto alternarsi di atmosfere tra energico groove e avvolgente melodia, il tutto condito da una ricerca sul sound che ha dato frutti copiosi. In particolare si fa apprezzare il dialogo a più voci che vede impegnati alle volte Balducci e sezione ritmica, altre volte Balducci e Bonisolo; ciò senza trascurare il peso degli assolo che si ascoltano nei vari brani: particolarmente apprezzabile, ad esempio, il chitarrista nella title-track con il suo incedere elegantemente descrittivo mentre il sax di Bonisolo s’impone alla generale attenzione già a partire dalle primissime note del brano d’apertura “Blackarera” caratterizzato da un coinvolgente andamento ritmico.
Una prima notazione tutt’altro che secondaria: “questo lavoro – afferma lo stesso Balducci – vede la luce ad otto anni dal mio precedente disco, “Blue from Heaven”, e a tre anni da “Evansiana”, pubblicato nel 2017. Lo dedico a John Taylor, che in questi due dischi è presente: punto di riferimento sia per me che per tanti altri musicisti europei, John mi ha onorato della sua presenza nel mio quartetto fino alla sua scomparsa, nel 2014”. Ebbene, nell’intento di omaggiare cotanto artista, il bassista/compositore pugliese Pierluigi Balducci, ben coadiuvato da Robert Bonisolo (sax tenore), Fabrizio Savino (chitarra) e Dario Congedo (batteria) ha realizzato questo eccellente album con sette brani originali tutti composti dal leader. Inquadrato l’album nelle sue linee generali, occorre aggiungere che il titolo rispecchia appieno la musica che si ascolta. Un equilibrio tra forma e contenuto, un bilanciamento apprezzabile tra parti scritte e improvvisate, un giusto alternarsi di atmosfere tra energico groove e avvolgente melodia, il tutto condito da una ricerca sul sound che ha dato frutti copiosi. In particolare si fa apprezzare il dialogo a più voci che vede impegnati alle volte Balducci e sezione ritmica, altre volte Balducci e Bonisolo; ciò senza trascurare il peso degli assolo che si ascoltano nei vari brani: particolarmente apprezzabile, ad esempio, il chitarrista nella title-track con il suo incedere elegantemente descrittivo mentre il sax di Bonisolo s’impone alla generale attenzione già a partire dalle primissime note del brano d’apertura “Blackarera” caratterizzato da un coinvolgente andamento ritmico.
Dal canto suo il leader, oltre a fornire un irrinunciabile supporto armonico per tutta la durata dell’album (si ascolti a mò di esempio “Kosmos and Chaos”) si produce anche in notevoli assolo come nel caso di “Monet” probabilmente il pezzo migliore dell’album. Fra gli altri brani più significativi “Fino a prova contraria”, una lunga ballad esposta con sapienza narrativa da Robert Bonisolo e con i notevoli assolo della chitarra di Savino e del basso elettrico del leader.
Luiz Bonfà – “Plays & Sings Bossa Nova + The Gentle Rain” – Aquarela do Brasil
 Siamo nei primissimi anni ’60, per la precisione nel 1962, quando viene registrato un lp dal sassofonista Stan Getz con il chitarrista Charlie Byrd: è l’inizio del fenomeno ‘jazz samba’ (più tardi inteso come ‘bossa nova’) che tanto successo ebbe nel mondo del jazz. Tra i sacerdoti di questa nuova musica figura certamente il chitarrista e vocalist Luiz Bonfà (Rio de Janeiro, 17 ottobre 1922 – Rio de Janeiro, 12 gennaio 2001) che nello stesso 1962 fu tra i protagonisti dello storico spettacolo di bossa nova che si tenne alla Carnegie Hall. A testimonianza delle sue frequentazioni con il mondo del jazz restano le incisioni con Stan Getz, Quincy Jones, Frank Sinatra, Eumir Deodato. Moltissime le composizioni di Bonfà – oltre un centinaio – molte celebri, tra cui ricordiamo innanzitutto “Manhã de Carnaval” e “Samba de Orfeu” entrambi tratti dalla colonna sonora del film “Orfeo Negro”. In questo album si ascoltano due lp risalenti agli anni ’60. Nel primo, registrato a New York nel 1962, troviamo Bonfà a capo di un sestetto e una sezione d’archi arrangiata da Lalo Schifrin; il secondo – “The Gentle Rain” – è la colonna sonora dell’omonimo film in cui il chitarrista suona con un’orchestra arrangiata e diretta dall’amico Eumir Deodato, realizzata a Rio De Janiero nel 1966. Naturalmente in repertorio figurano altre perle targate Bonfà come il già citato “Manhã de Carnaval” e ancora “Samba de Duas Notas”, “Silencio do amor”, “Perdido de amor” registrato a Rio de Janeiro nel 1959 e porto come “bonus track”. Fornire un quadro esauriente dell’arte di Bonfà è opera davvero ardua dato l’enorme numero di registrazioni effettuate dall’artista tuttavia dall’ascolto di questo album si può ricavare un ritratto soddisfacente di quel che Bonfà ha rappresentato nel mondo della musica.
Siamo nei primissimi anni ’60, per la precisione nel 1962, quando viene registrato un lp dal sassofonista Stan Getz con il chitarrista Charlie Byrd: è l’inizio del fenomeno ‘jazz samba’ (più tardi inteso come ‘bossa nova’) che tanto successo ebbe nel mondo del jazz. Tra i sacerdoti di questa nuova musica figura certamente il chitarrista e vocalist Luiz Bonfà (Rio de Janeiro, 17 ottobre 1922 – Rio de Janeiro, 12 gennaio 2001) che nello stesso 1962 fu tra i protagonisti dello storico spettacolo di bossa nova che si tenne alla Carnegie Hall. A testimonianza delle sue frequentazioni con il mondo del jazz restano le incisioni con Stan Getz, Quincy Jones, Frank Sinatra, Eumir Deodato. Moltissime le composizioni di Bonfà – oltre un centinaio – molte celebri, tra cui ricordiamo innanzitutto “Manhã de Carnaval” e “Samba de Orfeu” entrambi tratti dalla colonna sonora del film “Orfeo Negro”. In questo album si ascoltano due lp risalenti agli anni ’60. Nel primo, registrato a New York nel 1962, troviamo Bonfà a capo di un sestetto e una sezione d’archi arrangiata da Lalo Schifrin; il secondo – “The Gentle Rain” – è la colonna sonora dell’omonimo film in cui il chitarrista suona con un’orchestra arrangiata e diretta dall’amico Eumir Deodato, realizzata a Rio De Janiero nel 1966. Naturalmente in repertorio figurano altre perle targate Bonfà come il già citato “Manhã de Carnaval” e ancora “Samba de Duas Notas”, “Silencio do amor”, “Perdido de amor” registrato a Rio de Janeiro nel 1959 e porto come “bonus track”. Fornire un quadro esauriente dell’arte di Bonfà è opera davvero ardua dato l’enorme numero di registrazioni effettuate dall’artista tuttavia dall’ascolto di questo album si può ricavare un ritratto soddisfacente di quel che Bonfà ha rappresentato nel mondo della musica.
Jakob Bro – “Uma Elmo” – ECM 2702
 E’ un trio di caratura internazionale quello che il chitarrista danese Jakob Bro, al suo quinto disco da leader per la ECM, presenta in questa occasione: al suo fianco sono, infatti, il trombettista norvegese Arve Henriksen e il batterista spagnolo Jorge Rossy. Ad onta del fatto che i tre mai avevano inciso prima, la formazione si dimostra assolutamente compatta, ben guidata dal leader e perfettamente in grado di svolgere la musica che Bro aveva immaginato. Nove brani tutti composti dal chitarrista caratterizzati da un’atmosfera profonda, intimista, fortemente evocativa, ricca di echi, di riverberi, con chitarra e tromba che dialogano continuamente e la batteria di Rossy a punteggiare e sostenere il tutto, pur concedendo davvero poco all’impianto ritmico. Nell’ambito del repertorio figurano tre espliciti omaggi, in cui, però, Bro continua ad evidenziare la sua poetica mantenendosi ad una certa distanza dagli artisti evocati. Non a caso l’album si apre con “Reconstructing a Dream” in ricordo di quel periodo (2007) in cui collaborava con la Paul Motian’s Electric Bebop Band. “To Stanko” è un tributo al trombettista polacco Tomasz Stanko con il quale Bro aveva collaborato per ben cinque anni incidendo, tra l’altro, nel 2009 l’album ECM “Dark Eyes” unitamente a Alexi Tuomarila piano, Anders Christensen chitarra basso e Olavi Louhivuori batteria; la linea melodica è dolcemente suggestiva ben lontana, quindi, dal clima arroventato proprio dell’artista polacco. L’altro jazzista omaggiato è Lee Konitz per il quale Bro ha scritto ed eseguito “Music For Black Pigeons”; nei confronti del sassofonista Bro dichiara una sorta di sincera devozione sorta negli anni in cui hanno suonato assieme durante le tournée effettuate in Islanda, Groenlandia, Norvegia, Danimarca. Il brano più interessante? Difficile da enucleare anche se mi ha particolarmente colpito “Housework” sia per il sound affatto particolare della tromba, sia perché è piuttosto complicato enucleare le parti improvvisate dall’intelligente scrittura.
E’ un trio di caratura internazionale quello che il chitarrista danese Jakob Bro, al suo quinto disco da leader per la ECM, presenta in questa occasione: al suo fianco sono, infatti, il trombettista norvegese Arve Henriksen e il batterista spagnolo Jorge Rossy. Ad onta del fatto che i tre mai avevano inciso prima, la formazione si dimostra assolutamente compatta, ben guidata dal leader e perfettamente in grado di svolgere la musica che Bro aveva immaginato. Nove brani tutti composti dal chitarrista caratterizzati da un’atmosfera profonda, intimista, fortemente evocativa, ricca di echi, di riverberi, con chitarra e tromba che dialogano continuamente e la batteria di Rossy a punteggiare e sostenere il tutto, pur concedendo davvero poco all’impianto ritmico. Nell’ambito del repertorio figurano tre espliciti omaggi, in cui, però, Bro continua ad evidenziare la sua poetica mantenendosi ad una certa distanza dagli artisti evocati. Non a caso l’album si apre con “Reconstructing a Dream” in ricordo di quel periodo (2007) in cui collaborava con la Paul Motian’s Electric Bebop Band. “To Stanko” è un tributo al trombettista polacco Tomasz Stanko con il quale Bro aveva collaborato per ben cinque anni incidendo, tra l’altro, nel 2009 l’album ECM “Dark Eyes” unitamente a Alexi Tuomarila piano, Anders Christensen chitarra basso e Olavi Louhivuori batteria; la linea melodica è dolcemente suggestiva ben lontana, quindi, dal clima arroventato proprio dell’artista polacco. L’altro jazzista omaggiato è Lee Konitz per il quale Bro ha scritto ed eseguito “Music For Black Pigeons”; nei confronti del sassofonista Bro dichiara una sorta di sincera devozione sorta negli anni in cui hanno suonato assieme durante le tournée effettuate in Islanda, Groenlandia, Norvegia, Danimarca. Il brano più interessante? Difficile da enucleare anche se mi ha particolarmente colpito “Housework” sia per il sound affatto particolare della tromba, sia perché è piuttosto complicato enucleare le parti improvvisate dall’intelligente scrittura.
James Booker – “The Ivory Emperor” – Soul Jam 806188
 Album da non perdere per gli appassionati di un certo tipo di jazz, molto vicino al blues. In effetti vi sono contenuti tutti i singoli che James Booker realizzò come leader all’inizio della sua carriera, tra il 1954 e il 1962, quando incideva per diverse etichette tra cui Imperial, Chess, Ace e Peacock. Il cd contiene inoltre brani di altri artisti in cui James Booker appare come sideman. E’ il caso, ad esempio, di “You’re On My Mind” e “The Nex Time” in cui suona accanto a Junior Parker (voce) e Arnett Cobb (sax tenore), e delle due tracce conclusive in cui collabora con il bluesman Earl King. Ma chi era James Booker domanda che probabilmente si staranno facendo i nostri più giovani lettori. Ebbene James Booker, (New Orleans, 17 dicembre 1939 – 8 novembre 1983), conosciuto come il Principe del piano di New Orleans, è stato uno dei musicisti più amati di Crescent City. Era un pianista eccellente, organista di livello (lo si ascolti ad esempio in “Cross My Heart”), vocalist e compositore che si era creato uno stile del tutto personale fondendo R&B, gospel, blues, boogie-woogie, jazz tradizionale e moderno attraverso un suono originale. Ma le sue conoscenze musicali andavano ben al di là rivolgendosi anche alla musica classica europea, così rivisitò in chiave blues il “Valzer del minuto” di Chopin e inserì una composizione dello stesso autore polacco in un brano boogie-woogie. Data l’importanza della sua musica nell’ambito della scena jazz-blues di New Orleans, la sua produzione fa parte dal 2008 degli archivi della Biblioteca del Congresso.
Album da non perdere per gli appassionati di un certo tipo di jazz, molto vicino al blues. In effetti vi sono contenuti tutti i singoli che James Booker realizzò come leader all’inizio della sua carriera, tra il 1954 e il 1962, quando incideva per diverse etichette tra cui Imperial, Chess, Ace e Peacock. Il cd contiene inoltre brani di altri artisti in cui James Booker appare come sideman. E’ il caso, ad esempio, di “You’re On My Mind” e “The Nex Time” in cui suona accanto a Junior Parker (voce) e Arnett Cobb (sax tenore), e delle due tracce conclusive in cui collabora con il bluesman Earl King. Ma chi era James Booker domanda che probabilmente si staranno facendo i nostri più giovani lettori. Ebbene James Booker, (New Orleans, 17 dicembre 1939 – 8 novembre 1983), conosciuto come il Principe del piano di New Orleans, è stato uno dei musicisti più amati di Crescent City. Era un pianista eccellente, organista di livello (lo si ascolti ad esempio in “Cross My Heart”), vocalist e compositore che si era creato uno stile del tutto personale fondendo R&B, gospel, blues, boogie-woogie, jazz tradizionale e moderno attraverso un suono originale. Ma le sue conoscenze musicali andavano ben al di là rivolgendosi anche alla musica classica europea, così rivisitò in chiave blues il “Valzer del minuto” di Chopin e inserì una composizione dello stesso autore polacco in un brano boogie-woogie. Data l’importanza della sua musica nell’ambito della scena jazz-blues di New Orleans, la sua produzione fa parte dal 2008 degli archivi della Biblioteca del Congresso.
Sam Cooke – “Wonderful World – The Hits” – Hoo Doo
 Questo è un album chiaramente divisivo: in effetti se amate il soul jazz e più in generale la soul music allora l’ascolto sarà più che gradevole; esattamente il contrario se vi sentite lontani da questo particolare genere. Il protagonista è un vocalist di assoluto rilievo, Sam Cooke, che può essere considerato uno dei padri fondatori della soul music essendo stato tra i primi a coniugare le tematiche gospel con input provenienti dalla vita reale. Nato a Clarksdale il 22 gennaio 1931 e scomparso a Los Angeles l’11 dicembre 1964, Sam sulla spinta del padre – il Reverendo Charles Cook della Chiesa Battista – si era già affermato da giovanissimo come leader del famoso gruppo gospel “teenage” “The Highway QC” che abbandonerà all’età di 19 anni per dedicarsi ad una musica “profana”. Nel corso della sua non lunga carriera, Sam collezionò una serie incredibile di successi, grazie ad un incredibile senso del ritmo e a straordinarie capacità vocali che gli consentivano di passare con disinvoltura da Gershwin (lo si ascolti in “Summertime” a classici del pop quale “Youn Send Me”, anch’esso presente in questa raccolta. E il pregio principale di questo CD consiste proprio nel fatto che nell’ambito delle 30 tracce, registrate tra il 1956 e il 1962, possiamo ascoltare tutti i più grandi successi del vocalist, da “Wonderful World” che apre la compilation a “Bring It On Home to Me”, da “Chain Gang” a “Twistin’ the Night Away” da “A Change Is Gonna Come” fino al conclusivo “Having a Party” per circa 78 minuti di musica. In queste numerose performances Sam Cooke è accompagnato anche da alcuni eccellenti jazzisti quali il pianista Hank Jones, Mike Pacheco (conga), Red Callender (basso).
Questo è un album chiaramente divisivo: in effetti se amate il soul jazz e più in generale la soul music allora l’ascolto sarà più che gradevole; esattamente il contrario se vi sentite lontani da questo particolare genere. Il protagonista è un vocalist di assoluto rilievo, Sam Cooke, che può essere considerato uno dei padri fondatori della soul music essendo stato tra i primi a coniugare le tematiche gospel con input provenienti dalla vita reale. Nato a Clarksdale il 22 gennaio 1931 e scomparso a Los Angeles l’11 dicembre 1964, Sam sulla spinta del padre – il Reverendo Charles Cook della Chiesa Battista – si era già affermato da giovanissimo come leader del famoso gruppo gospel “teenage” “The Highway QC” che abbandonerà all’età di 19 anni per dedicarsi ad una musica “profana”. Nel corso della sua non lunga carriera, Sam collezionò una serie incredibile di successi, grazie ad un incredibile senso del ritmo e a straordinarie capacità vocali che gli consentivano di passare con disinvoltura da Gershwin (lo si ascolti in “Summertime” a classici del pop quale “Youn Send Me”, anch’esso presente in questa raccolta. E il pregio principale di questo CD consiste proprio nel fatto che nell’ambito delle 30 tracce, registrate tra il 1956 e il 1962, possiamo ascoltare tutti i più grandi successi del vocalist, da “Wonderful World” che apre la compilation a “Bring It On Home to Me”, da “Chain Gang” a “Twistin’ the Night Away” da “A Change Is Gonna Come” fino al conclusivo “Having a Party” per circa 78 minuti di musica. In queste numerose performances Sam Cooke è accompagnato anche da alcuni eccellenti jazzisti quali il pianista Hank Jones, Mike Pacheco (conga), Red Callender (basso).
Chick Corea – “Plays” – Concord 2 CD
 E’ di poche settimane fa la dipartita di Chick Corea un artista che ha segnato la storia del jazz negli ultimi cinquant’anni. Ecco, quindi, questo pregevole doppio album della Concord che lumeggia uno dei tanti lati della complessa personalità artistica di Corea: quella del piano solo. Piano solo declinato attraverso una varietà di situazioni che testimonia, meglio di mille parole, da un lato l’incredibile conoscenza del repertorio pianistico, dall’altro la capacità di ben interpretarlo. Eccolo quindi alle prese con Mozart, con Gershwin, con Scarlatti, con Bill Evans, con Scriabin, con Antonio Carlos Jobim, con Monk, per chiudere con una serie di brani tratti da quell’inesauribile scrigno costituito dalle sue composizioni. In particolare il primo CD è dedicato a prezzi celebri che tutti conoscono mentre nel secondo è possibile ascoltare tutti brani di Corea eccezion fatta per “Pastime Paradise” di Stevie Wonder. I brani sono tratti da una serie di concerti svolti in vari Paesi europei e statunitensi e ovunque, dinnanzi ad un pubblico che lo acclama, Chick non si risparmia e affronta con disinvoltura i non facili confronti con gli autori su citati. Ma non basta ché Corea si lascia andare anche ad improvvisazioni che testimoniano la valenza di un artista che mai ha fatto ricorso al banale, al facile ascolto, ai cliché spesso di moda. Insomma ancora una volta Corea si concede senza limiti al suo pubblico, senza particolari modalità, fedele al suo motto più volte espresso secondo cui “a me piace – afferma il pianista – che il pubblico ai miei concerti si senta come se stessimo nel mio salotto a discutere del più e del meno”.
E’ di poche settimane fa la dipartita di Chick Corea un artista che ha segnato la storia del jazz negli ultimi cinquant’anni. Ecco, quindi, questo pregevole doppio album della Concord che lumeggia uno dei tanti lati della complessa personalità artistica di Corea: quella del piano solo. Piano solo declinato attraverso una varietà di situazioni che testimonia, meglio di mille parole, da un lato l’incredibile conoscenza del repertorio pianistico, dall’altro la capacità di ben interpretarlo. Eccolo quindi alle prese con Mozart, con Gershwin, con Scarlatti, con Bill Evans, con Scriabin, con Antonio Carlos Jobim, con Monk, per chiudere con una serie di brani tratti da quell’inesauribile scrigno costituito dalle sue composizioni. In particolare il primo CD è dedicato a prezzi celebri che tutti conoscono mentre nel secondo è possibile ascoltare tutti brani di Corea eccezion fatta per “Pastime Paradise” di Stevie Wonder. I brani sono tratti da una serie di concerti svolti in vari Paesi europei e statunitensi e ovunque, dinnanzi ad un pubblico che lo acclama, Chick non si risparmia e affronta con disinvoltura i non facili confronti con gli autori su citati. Ma non basta ché Corea si lascia andare anche ad improvvisazioni che testimoniano la valenza di un artista che mai ha fatto ricorso al banale, al facile ascolto, ai cliché spesso di moda. Insomma ancora una volta Corea si concede senza limiti al suo pubblico, senza particolari modalità, fedele al suo motto più volte espresso secondo cui “a me piace – afferma il pianista – che il pubblico ai miei concerti si senta come se stessimo nel mio salotto a discutere del più e del meno”.
Così il suo pianismo conserva intatta la sua originalità e soprattutto quel tocco che lo ha reso celebre. Come ho molte volte sottolineato, quello che trasforma un buon musicista in un grande artista è la riconoscibilità e in un pianista detta riconoscibilità si sostanzia nella originalità del tocco, nel caso di Corea un tocco sublime e straordinariamente controllato.
Daniele Germani – “A Congregation of Folks” – Gleam Records 7004
 Album d’esordio per questo alto-sassofonista originario di Frosinone ma di stanza a Brooklyn, NY, ben coadiuvato dal pianista originario dell’Oregon Justin Salisbury, dal bassista Giuseppe Cucchiara e dal batterista sudcoreano Jongkuk Kim. In programma tredici composizioni tutte scritte dal sassofonista che si è fatto le ossa suonando al Wally’s Jazz Cafe, il leggendario jazz club di Boston; in questa città Germani si è trasferito nel 2013 avendo ottenuto una borsa di studio per frequentare il Berklee College of Music. Mentre era lì, è stato ammesso al prestigioso Berklee Global Jazz Institute di Danilo Perez, dove ha studiato sotto la guida di Terri Lyne Carrington, Joe Lovano e del suo mentore, George Garzone. Avendo alle spalle tanti anni di studio e con maestri talmente prestigiosi, Germani si presenta al pubblico italiano come musicista maturo, perfettamente consapevole dei propri mezzi espressivi e in grado di guidare un ensemble ben equilibrato e affiatato grazie al fatto che i quattro si sono conosciuti al Berklee. Di qui una perfetta spaziatura tra gli strumentisti e il giusto tempo dato ad ognuno per esprimere le proprie potenzialità. Così ad esempio in “One Moment To Monet” è il piano di Salisbury a mettersi in particolare evidenza mentre in “Hal Believe It” è l’intera sezione ritmica ad evidenziare la sua bravura nel sostenere magnificamente il solismo del leader. Il quale dà un’impronta all’intero album già nelle primissime note del brano d’apertura quando su un tappeto disegnato dal basso introduce e sviluppa il tema, portandolo dolcemente a conclusione Comunque ad avviso di chi scrive il brano meglio riuscito è “Eres luz”, una suggestiva melodia disegnata anche dal contrabbasso di Cucchiara e che vede l’intero quartetto esprimersi al meglio.
Album d’esordio per questo alto-sassofonista originario di Frosinone ma di stanza a Brooklyn, NY, ben coadiuvato dal pianista originario dell’Oregon Justin Salisbury, dal bassista Giuseppe Cucchiara e dal batterista sudcoreano Jongkuk Kim. In programma tredici composizioni tutte scritte dal sassofonista che si è fatto le ossa suonando al Wally’s Jazz Cafe, il leggendario jazz club di Boston; in questa città Germani si è trasferito nel 2013 avendo ottenuto una borsa di studio per frequentare il Berklee College of Music. Mentre era lì, è stato ammesso al prestigioso Berklee Global Jazz Institute di Danilo Perez, dove ha studiato sotto la guida di Terri Lyne Carrington, Joe Lovano e del suo mentore, George Garzone. Avendo alle spalle tanti anni di studio e con maestri talmente prestigiosi, Germani si presenta al pubblico italiano come musicista maturo, perfettamente consapevole dei propri mezzi espressivi e in grado di guidare un ensemble ben equilibrato e affiatato grazie al fatto che i quattro si sono conosciuti al Berklee. Di qui una perfetta spaziatura tra gli strumentisti e il giusto tempo dato ad ognuno per esprimere le proprie potenzialità. Così ad esempio in “One Moment To Monet” è il piano di Salisbury a mettersi in particolare evidenza mentre in “Hal Believe It” è l’intera sezione ritmica ad evidenziare la sua bravura nel sostenere magnificamente il solismo del leader. Il quale dà un’impronta all’intero album già nelle primissime note del brano d’apertura quando su un tappeto disegnato dal basso introduce e sviluppa il tema, portandolo dolcemente a conclusione Comunque ad avviso di chi scrive il brano meglio riuscito è “Eres luz”, una suggestiva melodia disegnata anche dal contrabbasso di Cucchiara e che vede l’intero quartetto esprimersi al meglio.
Andrea Goretti – A Light in The Darkness – Dodicilune 503
 Undici composizioni originali che il pianista-compositore Andrea Goretti affronta in solitudine. Di qui una duplice fatica: da compositore e da esecutore. E la valutazione non può che essere positiva. Le composizioni appaiono ben strutturate, caratterizzate da introspezione e sincera meditazione, mentre le esecuzioni risultano perfettamente aderenti alle idee dell’artista. Quindi nessuno sfoggio virtuosistico ma un uso intelligente delle dinamiche, una accurata ricerca armonica nell’ambito di un pianismo tecnicamente ineccepibile. Il tutto supportato da una profonda conoscenza della letteratura sia classica sia jazzistica, con specifico riferimento alle tendenze più attuali. Non a caso in repertorio figura anche un brano, “T.T.T. X – Twelve Tone Tune X” costruito con una linea melodica di dodici suoni, ad omaggiare il celebre “Twelve Tone Tune” di Bill Evans. Altra dote di Andrea Goretti la capacità di saper bilanciare scrittura e improvvisazione, pratica quest’ultima, che pur evidenziandosi in tutto l’album si palesa particolarmente in “Neptune’s Blues” e “I giganti”. L’album si chiude con tre pezzi registrati dal vivo durante un concerto a Roma nel novembre del 2018: “Impro I”, “Lamento”, ispirato al blues e “Il Grinch 2”, dedicato, non senza un tocco d’ironia, al periodo natalizio, in particolare a quel personaggio – Grinch per l’appunto – inventato nel 1957 dal Dr. Seuss, che odia il Natale, non ne sopporta l’atmosfera allegra, i canti, i regali e le luci. L’album è impreziosito da una poesia di Umberto Petrin, “Question”, ispirata dalla musica di Goretti.
Undici composizioni originali che il pianista-compositore Andrea Goretti affronta in solitudine. Di qui una duplice fatica: da compositore e da esecutore. E la valutazione non può che essere positiva. Le composizioni appaiono ben strutturate, caratterizzate da introspezione e sincera meditazione, mentre le esecuzioni risultano perfettamente aderenti alle idee dell’artista. Quindi nessuno sfoggio virtuosistico ma un uso intelligente delle dinamiche, una accurata ricerca armonica nell’ambito di un pianismo tecnicamente ineccepibile. Il tutto supportato da una profonda conoscenza della letteratura sia classica sia jazzistica, con specifico riferimento alle tendenze più attuali. Non a caso in repertorio figura anche un brano, “T.T.T. X – Twelve Tone Tune X” costruito con una linea melodica di dodici suoni, ad omaggiare il celebre “Twelve Tone Tune” di Bill Evans. Altra dote di Andrea Goretti la capacità di saper bilanciare scrittura e improvvisazione, pratica quest’ultima, che pur evidenziandosi in tutto l’album si palesa particolarmente in “Neptune’s Blues” e “I giganti”. L’album si chiude con tre pezzi registrati dal vivo durante un concerto a Roma nel novembre del 2018: “Impro I”, “Lamento”, ispirato al blues e “Il Grinch 2”, dedicato, non senza un tocco d’ironia, al periodo natalizio, in particolare a quel personaggio – Grinch per l’appunto – inventato nel 1957 dal Dr. Seuss, che odia il Natale, non ne sopporta l’atmosfera allegra, i canti, i regali e le luci. L’album è impreziosito da una poesia di Umberto Petrin, “Question”, ispirata dalla musica di Goretti.
Pietro Lazazzara – “My Art of Gypsy Jazz” – Stradivarius
 Chiarezza esemplare nel titolo dell’album: siano nel campo di un certo ben preciso tipo di jazz che il chitarrista e compositore Pietro Lazazzara frequenta con disinvoltura. Ma sarebbe un errore confinare l’album nell’ambito del “Gipsy Jazz”: in effetti, restando questo la fonte principale da cui trae ispirazione, il percorso di Pietro è più complesso e completo. Eccolo quindi studente di chitarra classico, appassionato conoscitore del flamenco, laureato in musica jazz e infaticabile appassionato ricercatore nell’ambito di uno sconfinato universo musicale. Di qui una musica in cui tutti questi input sono ben amalgamati e condotti ad unità grazie ad una buona verve compositiva e ad una eccellente tecnica esecutiva che si palesa soprattutto nei due brani per chitarra-solo “Passion d’Amour” ed “Echi d’Infanzia”. Nell’album Lazazzara è, in effetti, coadiuvato da Antonio Solazzo al basso e in un brano, “Relax”, da Emanuele Maggiore al flicorno. In cartellone quattordici pezzi scritti dallo stesso chitarrista con l’eccezione di “Douce Ambiance” di Django Reinhardt, “Joseph Joseph” di Kahn, Chaplin, Nellie e “Bistrot Fada” di Stephane Wrembel. Alla fine di un duplice attento ascolto dell’album, si può ben dire che la figura di Lazazzara quale compositore ed esecutore si colloca su livelli più che buoni. Le composizioni appaiono tutte ben scritte, equilibrate, caratterizzate da una sapiente ricerca armonica e si fanno ammirare anche per il notevole bilanciamento tra parti scritte ed improvvisate. L’esecuzione, poi, è raffinata, elegante ad evidenziare un chitarrista sensibile, ispirato, dalla tecnica ineccepibile per quanto misurata e lontana dalla volontà di stupire l’ascoltatore cosicché ogni nota ha il suo preciso perché.
Chiarezza esemplare nel titolo dell’album: siano nel campo di un certo ben preciso tipo di jazz che il chitarrista e compositore Pietro Lazazzara frequenta con disinvoltura. Ma sarebbe un errore confinare l’album nell’ambito del “Gipsy Jazz”: in effetti, restando questo la fonte principale da cui trae ispirazione, il percorso di Pietro è più complesso e completo. Eccolo quindi studente di chitarra classico, appassionato conoscitore del flamenco, laureato in musica jazz e infaticabile appassionato ricercatore nell’ambito di uno sconfinato universo musicale. Di qui una musica in cui tutti questi input sono ben amalgamati e condotti ad unità grazie ad una buona verve compositiva e ad una eccellente tecnica esecutiva che si palesa soprattutto nei due brani per chitarra-solo “Passion d’Amour” ed “Echi d’Infanzia”. Nell’album Lazazzara è, in effetti, coadiuvato da Antonio Solazzo al basso e in un brano, “Relax”, da Emanuele Maggiore al flicorno. In cartellone quattordici pezzi scritti dallo stesso chitarrista con l’eccezione di “Douce Ambiance” di Django Reinhardt, “Joseph Joseph” di Kahn, Chaplin, Nellie e “Bistrot Fada” di Stephane Wrembel. Alla fine di un duplice attento ascolto dell’album, si può ben dire che la figura di Lazazzara quale compositore ed esecutore si colloca su livelli più che buoni. Le composizioni appaiono tutte ben scritte, equilibrate, caratterizzate da una sapiente ricerca armonica e si fanno ammirare anche per il notevole bilanciamento tra parti scritte ed improvvisate. L’esecuzione, poi, è raffinata, elegante ad evidenziare un chitarrista sensibile, ispirato, dalla tecnica ineccepibile per quanto misurata e lontana dalla volontà di stupire l’ascoltatore cosicché ogni nota ha il suo preciso perché.
Peggy Lee – The Hits of – All Anglow Again!” – Essential Jazz11443
 Peggy Lee (Jamestown, 26 maggio 1920 – Bel Air, 21 gennaio 2002) è stata artista di squisita sensibilità che ha incantato le platee di tutto il mondo. Dotata di una voce non potentissima ma di grande fascino, suggestiva, capace di portare l’ascoltatore in una dimensione “altra”, Peggy ottenne grande popolarità durante l’era dello swing quando lavorò e incise con grandi orchestre dirette, tra gli altri, da Benny Goodman, Nelson Riddle, Billy May. Questo album contiene l’edizione integrale dell’lp “All Aglow Again”; si tratta di una compilation realizzata nel 1960 con in repertorio dodici brani tratti dalle varie registrazioni effettuate sino a quel momento ivi comprese alcune hit come la celebre “Fever” canzone di Eddie Cooley e Otis Blackwell (usando lo pseudonimo di John Davenport) del 1956; incisa per la prima volta da Little Willie John nello stesso anno, diventò di grande successo grazie alla cover di Peggy Lee del 1958 che raggiunse la quinta posizione nel Regno Unito e l’ottava negli Stati Uniti ed in Olanda, vincendo il Grammy Hall of Fame Award 1998. In aggiunta al già citato “All Anglow Again!” il cd in oggetto presenta altri 17 brani scelti tra i maggiori hit della cantante come “Black Coffee”, “Sugar”, “Ain’t We Got Fun” e “La La Lu”. In buona sostanza per chi come il sottoscritto conosce già da qualche decennio l’arte di Peggy Lee nessuna sorpresa ma il piacere di ascoltare alcune delle sue più convincenti interpretazioni; per i più giovani un’occasione da cogliere per fare la conoscenza di una delle migliori cantanti jazz.
Peggy Lee (Jamestown, 26 maggio 1920 – Bel Air, 21 gennaio 2002) è stata artista di squisita sensibilità che ha incantato le platee di tutto il mondo. Dotata di una voce non potentissima ma di grande fascino, suggestiva, capace di portare l’ascoltatore in una dimensione “altra”, Peggy ottenne grande popolarità durante l’era dello swing quando lavorò e incise con grandi orchestre dirette, tra gli altri, da Benny Goodman, Nelson Riddle, Billy May. Questo album contiene l’edizione integrale dell’lp “All Aglow Again”; si tratta di una compilation realizzata nel 1960 con in repertorio dodici brani tratti dalle varie registrazioni effettuate sino a quel momento ivi comprese alcune hit come la celebre “Fever” canzone di Eddie Cooley e Otis Blackwell (usando lo pseudonimo di John Davenport) del 1956; incisa per la prima volta da Little Willie John nello stesso anno, diventò di grande successo grazie alla cover di Peggy Lee del 1958 che raggiunse la quinta posizione nel Regno Unito e l’ottava negli Stati Uniti ed in Olanda, vincendo il Grammy Hall of Fame Award 1998. In aggiunta al già citato “All Anglow Again!” il cd in oggetto presenta altri 17 brani scelti tra i maggiori hit della cantante come “Black Coffee”, “Sugar”, “Ain’t We Got Fun” e “La La Lu”. In buona sostanza per chi come il sottoscritto conosce già da qualche decennio l’arte di Peggy Lee nessuna sorpresa ma il piacere di ascoltare alcune delle sue più convincenti interpretazioni; per i più giovani un’occasione da cogliere per fare la conoscenza di una delle migliori cantanti jazz.
Joe Lovano – “Garden of Expression” – ECM 2685
 Conosco personalmente Lovano dall’oramai lontano 1982 e l’ho sempre considerato uno straordinario musicista oltre che una bella persona, cosa che mai guasta. Quest’ultimo album ci restituisce un Lovano in forma smagliante, alla testa di quel Trio Tapestry con cui lo avevamo apprezzato nell’omonimo album del 2019, quindi ancora con Marilyn Crispell al piano e Carmen Castaldi alla batteria. Registrato nel novembre del 2019, l’album è dedicato a quanti sono rimasti vittime del Covid 19. Di qui otto brani tutti scritti dallo stesso Lovano che conducono l’ascoltatore in atmosfere rarefatte disegnate dal leader ma ben supportate da pianoforte e batteria che non fanno assolutamente rimpiangere la mancanza del contrabbasso. Si ascolti quindi con quale e quanta delicatezza il pianismo di Marilyn avvolge il sax del leader, quasi a tessere un intricata trama su cui quasi si adagia la voce di Lovano, mentre la batteria di Carmen segue con grande intelligenza e intuito gli intenti del leader. Una musica, quindi, che si sostanzia nell’empatia che i tre evidenziano sin dalle primissime note a conferma di un “idem sentire” tutt’altro che banale. Esemplare al riguardo il suadente “Night Creatures” in cui la Crispell sembra quasi volersi espandere nel comune territorio pronta, però, a cedere il passo all’entrata del sassofono, il tutto porto con estrema delicatezza. Appare quasi come uno standard il successivo “West of the Moon” mentre nella title- track il trio abbandona le melodie disegnate in precedenza per avventurarsi su terreni diversi, quasi vicini ad un certo free, ma che comunque mette in luce un abilissimo e lucido Castaldi il quale non si lascia sfuggire l’occasione per evidenziare il suo, d’altronde ben noto, talento. L’album si chiude con un lungo (oltre 10 minuti) “Zen Like” scandito da campane tibetane che si stacca nettamente da tutto ciò che si è ascoltato sinora.
Conosco personalmente Lovano dall’oramai lontano 1982 e l’ho sempre considerato uno straordinario musicista oltre che una bella persona, cosa che mai guasta. Quest’ultimo album ci restituisce un Lovano in forma smagliante, alla testa di quel Trio Tapestry con cui lo avevamo apprezzato nell’omonimo album del 2019, quindi ancora con Marilyn Crispell al piano e Carmen Castaldi alla batteria. Registrato nel novembre del 2019, l’album è dedicato a quanti sono rimasti vittime del Covid 19. Di qui otto brani tutti scritti dallo stesso Lovano che conducono l’ascoltatore in atmosfere rarefatte disegnate dal leader ma ben supportate da pianoforte e batteria che non fanno assolutamente rimpiangere la mancanza del contrabbasso. Si ascolti quindi con quale e quanta delicatezza il pianismo di Marilyn avvolge il sax del leader, quasi a tessere un intricata trama su cui quasi si adagia la voce di Lovano, mentre la batteria di Carmen segue con grande intelligenza e intuito gli intenti del leader. Una musica, quindi, che si sostanzia nell’empatia che i tre evidenziano sin dalle primissime note a conferma di un “idem sentire” tutt’altro che banale. Esemplare al riguardo il suadente “Night Creatures” in cui la Crispell sembra quasi volersi espandere nel comune territorio pronta, però, a cedere il passo all’entrata del sassofono, il tutto porto con estrema delicatezza. Appare quasi come uno standard il successivo “West of the Moon” mentre nella title- track il trio abbandona le melodie disegnate in precedenza per avventurarsi su terreni diversi, quasi vicini ad un certo free, ma che comunque mette in luce un abilissimo e lucido Castaldi il quale non si lascia sfuggire l’occasione per evidenziare il suo, d’altronde ben noto, talento. L’album si chiude con un lungo (oltre 10 minuti) “Zen Like” scandito da campane tibetane che si stacca nettamente da tutto ciò che si è ascoltato sinora.
Shai Maestro – “Human” ECM 2688
 Coinvolgente la musica di questo quartetto la cui leadership si potrebbe tranquillamente spartire tra il pianista Shai Maestro e il trombettista statunitense Philip Dizack, coadiuvati da una puntuale sezione ritmica composta dal batterista israeliano Ofri Nehemya e dal contrabbassista peruviano Jorge Roeder. Certo la maestria del pianista israeliano non la scopriamo certo adesso dato che Shai è già al suo sesto disco da titolare, il secondo con l’etichetta ECM, e può vantare anche quattro album di spessore incisi con l’Avishai Cohen Trio. Ma in questo album c’è forse qualcosa di più. Innanzitutto una piena maturità compositiva declinata attraverso un repertorio di undici composizioni tutte sue ad eccezione di “In a Sentimental Mood”. In secondo luogo la piena conferma di uno stile pianistico che nulla aggiunge a ciò che è strettamente necessario ad esprimere la propria individualità, il proprio essere più profondo (si ascolti al riguardo soprattutto “Compassion” e “Hank and Charlie” il commovente omaggio porto a Hank Jones e Charlie Haden, con il contrabbasso di Jorge Roeder in bella evidenza). In terzo luogo la capacità di eseguire al meglio, in modo originale, composizioni non proprie come la su citata pagina ellingtoniana, pezzo tanto affascinante quanto difficile da riprodurre visto l’inevitabile confronto con l’originale. Infine la straordinaria facilità con cui riesce a rapportarsi con i compagni di viaggio; semplicemente perfetta l’intesa con il trombettista assai evidente soprattutto in “Human” e in “They Went to War” mentre la sezione ritmica è sempre lì, presente e discreta, a puntualizzare le linee disegnate da pianoforte e tromba.
Coinvolgente la musica di questo quartetto la cui leadership si potrebbe tranquillamente spartire tra il pianista Shai Maestro e il trombettista statunitense Philip Dizack, coadiuvati da una puntuale sezione ritmica composta dal batterista israeliano Ofri Nehemya e dal contrabbassista peruviano Jorge Roeder. Certo la maestria del pianista israeliano non la scopriamo certo adesso dato che Shai è già al suo sesto disco da titolare, il secondo con l’etichetta ECM, e può vantare anche quattro album di spessore incisi con l’Avishai Cohen Trio. Ma in questo album c’è forse qualcosa di più. Innanzitutto una piena maturità compositiva declinata attraverso un repertorio di undici composizioni tutte sue ad eccezione di “In a Sentimental Mood”. In secondo luogo la piena conferma di uno stile pianistico che nulla aggiunge a ciò che è strettamente necessario ad esprimere la propria individualità, il proprio essere più profondo (si ascolti al riguardo soprattutto “Compassion” e “Hank and Charlie” il commovente omaggio porto a Hank Jones e Charlie Haden, con il contrabbasso di Jorge Roeder in bella evidenza). In terzo luogo la capacità di eseguire al meglio, in modo originale, composizioni non proprie come la su citata pagina ellingtoniana, pezzo tanto affascinante quanto difficile da riprodurre visto l’inevitabile confronto con l’originale. Infine la straordinaria facilità con cui riesce a rapportarsi con i compagni di viaggio; semplicemente perfetta l’intesa con il trombettista assai evidente soprattutto in “Human” e in “They Went to War” mentre la sezione ritmica è sempre lì, presente e discreta, a puntualizzare le linee disegnate da pianoforte e tromba.
Angelo Mastronardi – “Rough Line” – GleamRecords7003
 Con questo terzo album da leader, il pianista si ripresenta con la formula preferita del trio assieme al batterista palermitano Melo Miceli e al contrabbassista americano Rogers Anning. In programma 6 composizioni originali scritte dal leader e due standard, “All Things You Are” (J.Kern / O. Hammerstein II) e “Oleo” (S. Rollins). Il terreno è quello di un jazz caratterizzato da una forte carica ritmica e da spiccate individualità che emergono nel corso delle varie esecuzioni; il tutto impreziosito da una accurata ricerca sul suono che si evidenzia ancora più chiaramente quando Mastronardi si produce non solo al pianoforte ma anche al Fender Rhodes. Come si accennava notevole l’apporto solistico di tutti i membri del trio: così ecco il basso di Rogers Anning particolarmente in evidenza in “Everything I Need” mentre la batteria di Melo Miceli si fa apprezzare in “Away From The Scene”. E il leader? A parte la sapienza con cui guida il trio, si ritaglia spazi per convincenti assolo: in particolare nei due brani eseguiti in solitudine, “All The Things You Are” e “7 H-Our”, Mastronardi evidenzia una assoluta padronanza della tastiera che sa utilizzare in maniera completa evidenziando tra l’altro una ottima diteggiatura e una eccellente indipendenza tra le due mani. In particolare il brano di Kern e Hammerstein è porto in maniera originale con l’intento da un canto di preservare la bellezza del tema dall’altro di osare qualcosa di nuovo, alla costante ricerca di quell’equilibrio fra tradizione e sperimentazione che caratterizza tutto l’album ; in “7H-Our” Mastronardi, avendo a che fare con una propria composizione, si muove con sicurezza nel dichiarato intento di sperimentare le possibilità timbriche del Fender.
Con questo terzo album da leader, il pianista si ripresenta con la formula preferita del trio assieme al batterista palermitano Melo Miceli e al contrabbassista americano Rogers Anning. In programma 6 composizioni originali scritte dal leader e due standard, “All Things You Are” (J.Kern / O. Hammerstein II) e “Oleo” (S. Rollins). Il terreno è quello di un jazz caratterizzato da una forte carica ritmica e da spiccate individualità che emergono nel corso delle varie esecuzioni; il tutto impreziosito da una accurata ricerca sul suono che si evidenzia ancora più chiaramente quando Mastronardi si produce non solo al pianoforte ma anche al Fender Rhodes. Come si accennava notevole l’apporto solistico di tutti i membri del trio: così ecco il basso di Rogers Anning particolarmente in evidenza in “Everything I Need” mentre la batteria di Melo Miceli si fa apprezzare in “Away From The Scene”. E il leader? A parte la sapienza con cui guida il trio, si ritaglia spazi per convincenti assolo: in particolare nei due brani eseguiti in solitudine, “All The Things You Are” e “7 H-Our”, Mastronardi evidenzia una assoluta padronanza della tastiera che sa utilizzare in maniera completa evidenziando tra l’altro una ottima diteggiatura e una eccellente indipendenza tra le due mani. In particolare il brano di Kern e Hammerstein è porto in maniera originale con l’intento da un canto di preservare la bellezza del tema dall’altro di osare qualcosa di nuovo, alla costante ricerca di quell’equilibrio fra tradizione e sperimentazione che caratterizza tutto l’album ; in “7H-Our” Mastronardi, avendo a che fare con una propria composizione, si muove con sicurezza nel dichiarato intento di sperimentare le possibilità timbriche del Fender.
Lucio Miele – “Kalpa” – Creative Sources Record
 Album assolutamente atipico in cui Lucio Miele, percussionista di tradizione classica, dedito alla ricerca e alla sperimentazione, si racconta attraverso sei sue composizioni, affiancato da Simona Fredella alla voce recitata in due brani e da Anacleto Vitolo al mastering. Chi conosce il musicista salernitano troverà in questo album una perfetta continuità con le sue realizzazioni in cui ha sempre cercato di condensare la molteplicità delle sue esperienze. Viceversa per chi questo album rappresenta il primo approccio con la musica di Miele, sicuramente ne resterà sorpreso, nel bene o nel male non spetta certo allo scrivente deciderlo. In ogni caso è opportuno sottolineare che Miele è artista sincero, intellettualmente onesto, che ha sempre seguito la sua strada per quanto ostica fosse la stessa. Certo, fare musica basandosi solo su percussioni ed elettronica non è impresa facile, anche quando si è perfettamente padroni degli strumenti utilizzati (si ascolti ad esempio il convincente uso dell’elettronica in “Mbombo”). Mancano i riferimenti usuali, la linea melodica, l’andamento ritmico è assolutamente frastagliato e imprevedibile, ma quando si approccia una realizzazione di questo tipo i vecchi parametri vanno messi da parte e occorre lasciarsi andare al flusso sonoro. Aprire la mente il cuore, l’anima e lasciare che la musica ci attraversi fin nel profondo alla ricerca di emozioni sopite che forse solo in questo modo saremo in grado di apprezzare. Insomma un album, come si accennava, di non facile ascolto ma che vale la pena fruire ma, ripetiamo, con disponibilità e attenzione…altrimenti è meglio lasciar perdere.
Album assolutamente atipico in cui Lucio Miele, percussionista di tradizione classica, dedito alla ricerca e alla sperimentazione, si racconta attraverso sei sue composizioni, affiancato da Simona Fredella alla voce recitata in due brani e da Anacleto Vitolo al mastering. Chi conosce il musicista salernitano troverà in questo album una perfetta continuità con le sue realizzazioni in cui ha sempre cercato di condensare la molteplicità delle sue esperienze. Viceversa per chi questo album rappresenta il primo approccio con la musica di Miele, sicuramente ne resterà sorpreso, nel bene o nel male non spetta certo allo scrivente deciderlo. In ogni caso è opportuno sottolineare che Miele è artista sincero, intellettualmente onesto, che ha sempre seguito la sua strada per quanto ostica fosse la stessa. Certo, fare musica basandosi solo su percussioni ed elettronica non è impresa facile, anche quando si è perfettamente padroni degli strumenti utilizzati (si ascolti ad esempio il convincente uso dell’elettronica in “Mbombo”). Mancano i riferimenti usuali, la linea melodica, l’andamento ritmico è assolutamente frastagliato e imprevedibile, ma quando si approccia una realizzazione di questo tipo i vecchi parametri vanno messi da parte e occorre lasciarsi andare al flusso sonoro. Aprire la mente il cuore, l’anima e lasciare che la musica ci attraversi fin nel profondo alla ricerca di emozioni sopite che forse solo in questo modo saremo in grado di apprezzare. Insomma un album, come si accennava, di non facile ascolto ma che vale la pena fruire ma, ripetiamo, con disponibilità e attenzione…altrimenti è meglio lasciar perdere.
Roberto Ottaviano – “Resonance & Rapsodies” – Dodicilune
 Doppio album del sassofonista (soprano) e compositore pugliese Roberto Ottaviano, affiancato in “Resonance” dal quartetto Eternal Love composto da Marco Colonna (clarinetti), Giorgio Pacorig (piano, rodhes), Giovanni Maier (contrabbasso) e Zeno De Rossi (batteria), ampliato dalla presenza di Alexander Hawkins (piano), Danilo Gallo (contrabbasso e basso acustico) e Hamid Drake (batteria), mentre nel secondo CD, “Rapsodies” solo dal quartetto Eternal Love. Una realizzazione, quindi, particolarmente impegnativa che non a caso ha vinto l’annuale referendum come miglior disco italiano del 2020. Ora, a prescindere dal valore che valutazioni del genere possono avere o non avere, resta il fatto che a mio avviso raramente una produzione discografica è stata così meritevole di tali considerazioni. In effetti Roberto Ottaviano è artista di grandissimo livello, tra i migliori che l’attuale scena jazzistica, non solo italiana, possa annoverare. La sua mente compositiva è sempre lucida, attuale, capace di cogliere i fermenti più significativi che attraversano l’universo musicale senza distinzione di genere mentre le modalità esecutive evidenziano un bagaglio tecnico molto profondo, talmente ben assorbito da non necessitare di alcuna palese esposizione e che, di conseguenza, si sostanzia in uno stile asciutto, senza fronzoli, che nulla lascia all’esibizionismo. L’intento che sta alla base dell’opera è, come afferma lo stesso Ottaviano, “una sorta di omaggio alla ricerca di quella sofferta poetica che fa parte della condizione umana”. Per dare forza e concretezza a questi concetti, Roberto fa ricorso ad una musica declinata attraverso ventitré brani in larga misura da lui stesso scritti in cui non mancano i riferimenti alla musica classica contemporanea. Ma è la pratica collettiva il dato fondamentale di questo doppio CD, una pratica che consente una sorta di doppione del sax di Ottaviano con i clarinetti di Marco Colonna, che risultano essenziali per allargare a dismisura il concetto di suono. Se volessimo sintetizzare in poche parole il significato più profondo di questo “Resonance & Rapsodies” si potrebbe forse dire che nel momento in cui rievoca le esperienze del passato Ottaviano non rinuncia a guardare oltre, non rinuncia ad una ricerca che costituisce una delle cifre fondamentali del suo essere artista.
Doppio album del sassofonista (soprano) e compositore pugliese Roberto Ottaviano, affiancato in “Resonance” dal quartetto Eternal Love composto da Marco Colonna (clarinetti), Giorgio Pacorig (piano, rodhes), Giovanni Maier (contrabbasso) e Zeno De Rossi (batteria), ampliato dalla presenza di Alexander Hawkins (piano), Danilo Gallo (contrabbasso e basso acustico) e Hamid Drake (batteria), mentre nel secondo CD, “Rapsodies” solo dal quartetto Eternal Love. Una realizzazione, quindi, particolarmente impegnativa che non a caso ha vinto l’annuale referendum come miglior disco italiano del 2020. Ora, a prescindere dal valore che valutazioni del genere possono avere o non avere, resta il fatto che a mio avviso raramente una produzione discografica è stata così meritevole di tali considerazioni. In effetti Roberto Ottaviano è artista di grandissimo livello, tra i migliori che l’attuale scena jazzistica, non solo italiana, possa annoverare. La sua mente compositiva è sempre lucida, attuale, capace di cogliere i fermenti più significativi che attraversano l’universo musicale senza distinzione di genere mentre le modalità esecutive evidenziano un bagaglio tecnico molto profondo, talmente ben assorbito da non necessitare di alcuna palese esposizione e che, di conseguenza, si sostanzia in uno stile asciutto, senza fronzoli, che nulla lascia all’esibizionismo. L’intento che sta alla base dell’opera è, come afferma lo stesso Ottaviano, “una sorta di omaggio alla ricerca di quella sofferta poetica che fa parte della condizione umana”. Per dare forza e concretezza a questi concetti, Roberto fa ricorso ad una musica declinata attraverso ventitré brani in larga misura da lui stesso scritti in cui non mancano i riferimenti alla musica classica contemporanea. Ma è la pratica collettiva il dato fondamentale di questo doppio CD, una pratica che consente una sorta di doppione del sax di Ottaviano con i clarinetti di Marco Colonna, che risultano essenziali per allargare a dismisura il concetto di suono. Se volessimo sintetizzare in poche parole il significato più profondo di questo “Resonance & Rapsodies” si potrebbe forse dire che nel momento in cui rievoca le esperienze del passato Ottaviano non rinuncia a guardare oltre, non rinuncia ad una ricerca che costituisce una delle cifre fondamentali del suo essere artista.
Dino Piana – “Al gir dal bughi” – PMR, Jando Music
 90 anni e non sentirli…o meglio che bel sentire ci procura questo nuovo album del trombonista Dino Piana. Conosco oramai da molti anni la premiata ditta composta da Dino e Franco Piana e ne ho sempre ricavato una bella impressione e non solo dal punto di vista squisitamente musicale, visata la gentilezza, la signorilità con cui i due amano rapportarsi con noi critici e giornalisti. Ma è il versante artistico su cui tocca concentrarsi in questa sede e allora dico, immediatamente, che l’album si colloca su quegli alti livelli cui Dino e Franco Piana ci hanno abituati oramai da decenni. Con in più un elemento di notevole importanza: il CD è stato fortemente voluto da Enrico Rava (storico amico di Dino Piana) e da Franco Piana per festeggiare i 90 anni (a luglio 91) del trombonista piemontese. Di qui la strutturazione di un organico d’eccellenza in cui accanto ai senatori Rava al flicorno e Dino Piana al trombone figurano Franco Piana al flicorno, Julian Oliver Mazzariello al piano, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Roberto Gatto alla batteria. Di qui la scelta di un repertorio oggi non di moda: nove standard celeberrimi – “Bernie’s Tune”, “Dear Old Stockholm”, “Everythings Happens To Me”, “I’ll Close My Eyes”, “Line For Lions”, “Rhythm A Ning”, “Polka Dotz and Moonbeams”, “When Light Are Low”, “When Will The Blues Leave” – che tutti, più o meno, si richiamano a quell’hard bop da cui in buona sostanza è poi derivato tutto il jazz moderno. Il gruppo si esprime con bella compattezza impreziosito dal fitto dialogo tra i fiati e dagli assolo di Dino che non si risparmia anzi fa sentire ben nitida la voce del suo strumento in ogni brano. Gli standard fluiscono genuinamente ‘freschi’ come se il tempo non fosse trascorso e l’ascolto è sempre gradevole anche se occorre attenzione per catturare le mille sottigliezze dell’esecuzione. Una precisazione: lo strano titolo deriva dal fatto che durante il primissimo incontro tra Rava e Piana, quest’ultimo associò al blues in fa il giro armonico del boogie-woogie per l’appunto “Al gir dal bughi”.
90 anni e non sentirli…o meglio che bel sentire ci procura questo nuovo album del trombonista Dino Piana. Conosco oramai da molti anni la premiata ditta composta da Dino e Franco Piana e ne ho sempre ricavato una bella impressione e non solo dal punto di vista squisitamente musicale, visata la gentilezza, la signorilità con cui i due amano rapportarsi con noi critici e giornalisti. Ma è il versante artistico su cui tocca concentrarsi in questa sede e allora dico, immediatamente, che l’album si colloca su quegli alti livelli cui Dino e Franco Piana ci hanno abituati oramai da decenni. Con in più un elemento di notevole importanza: il CD è stato fortemente voluto da Enrico Rava (storico amico di Dino Piana) e da Franco Piana per festeggiare i 90 anni (a luglio 91) del trombonista piemontese. Di qui la strutturazione di un organico d’eccellenza in cui accanto ai senatori Rava al flicorno e Dino Piana al trombone figurano Franco Piana al flicorno, Julian Oliver Mazzariello al piano, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Roberto Gatto alla batteria. Di qui la scelta di un repertorio oggi non di moda: nove standard celeberrimi – “Bernie’s Tune”, “Dear Old Stockholm”, “Everythings Happens To Me”, “I’ll Close My Eyes”, “Line For Lions”, “Rhythm A Ning”, “Polka Dotz and Moonbeams”, “When Light Are Low”, “When Will The Blues Leave” – che tutti, più o meno, si richiamano a quell’hard bop da cui in buona sostanza è poi derivato tutto il jazz moderno. Il gruppo si esprime con bella compattezza impreziosito dal fitto dialogo tra i fiati e dagli assolo di Dino che non si risparmia anzi fa sentire ben nitida la voce del suo strumento in ogni brano. Gli standard fluiscono genuinamente ‘freschi’ come se il tempo non fosse trascorso e l’ascolto è sempre gradevole anche se occorre attenzione per catturare le mille sottigliezze dell’esecuzione. Una precisazione: lo strano titolo deriva dal fatto che durante il primissimo incontro tra Rava e Piana, quest’ultimo associò al blues in fa il giro armonico del boogie-woogie per l’appunto “Al gir dal bughi”.
Marcello Rosa – “The World On A Slide” – Alfa Music 236
 Straordinario viaggio nel mondo del trombone. A fungere da gran cerimoniere è Marcello Rosa, uno dei personaggi più rilevanti dell’universo jazzistico nazionale. Conosco Marcello personalmente oramai da tanti anni e so perfettamente quanto ami la sua musica e quanta passione metta in ogni cosa che fa. Ovviamente a quest’aurea regola non sfugge “The World On A Slide” una raccolta di ben sedici brani –molti originali, altri scelti tra le più belle melodie del repertorio jazzistico del XX secolo – ma tutti suonati e arrangiati da Rosa nel corso della sua vita. Ebbene per questa sua ultima fatica discografica, Marcello ha voluto coronare un bel sogno: incidere un disco di soli e tanti tromboni. Ha così chiamato accanto a sé alcuni specialisti non solo del jazz ma anche della musica colta. Ed eccoli tutti i nomi dei temerari che hanno partecipato all’impresa: dalla musica colta Andrea Conti I trombone dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Luigino Leonardi trombonista presso la Banda musicale dell’Aeronautica Militare, Gianfranco Marchesi trombone basso dell’Orchestra sinfonica nazionale della RAI e il Quartetto italiano di tromboni, formato da Devid Ceste secondo trombone dell’Orchestra sinfonica nazionale della RAI, Matteo De Luca I trombone dell’orchestra della Suisse Romande di Ginevra, Diego Di Mario I trombone presso l’Orchestra sinfonica nazionale della RAI e Vincent Lepape I trombone dell’Orchestra del Teatro Regio di Torino. Dal mondo del jazz sono arrivati i già ‘collaudati’ Andrea Andreoli, Mario Corvini, Massimo Morganti e Roberto Rossi; accanto a loro i giovanissimi e brillanti Stefano Coccia, Elisabetta Mattei, Federico Proietti e il G.E.F.F. Trombone Quartet, composto da Giovanni Dominicis, Francesco Piersanti, Eugenio Renzetti e Gabriele Sapora. In taluni pezzi c’è pura una sezione ritmica composta da Paolo Tombolesi al pianoforte, Luca Berardi e Roy Panebianco alla chitarra, Marco Siniscalco al contrabbasso e basso elettrico, Cristiano Micalizzi alla batteria e Filippo La Porta alle percussioni. Il risultato è semplicemente entusiasmante: come si diceva una volta ‘dove peschi peschi bene’ ed in effetti tutte le esecuzioni contengono una carica tale da mai lasciarti indifferente. Qualche titolo? “Autumn Leaves” con Massimo Morganti in veste di solista, la suadente “Southern Ballad” che ad onta delle difficoltà di realizzazione narrate da Rosa è venuta molto bene con Roberto Rossi solista, il sempre toccante “What Are You Doing the Rest of Your Life” affidato al Quartetto Italiano di Tromboni con Gianfranco Marchesi. Da segnalare infine che come bonus track figurano “Miss Magnolia Lee” del giugno 1974 con Enrico Pieranunzi piano, Alessio Urso basso e Gegè Munari batteria e “Il ladro di noccioline” del 1980 con Daniele Cestana piano, Nanni Civitenga chitarra e chitarra basso e Enzo Restuccia batteria.
Straordinario viaggio nel mondo del trombone. A fungere da gran cerimoniere è Marcello Rosa, uno dei personaggi più rilevanti dell’universo jazzistico nazionale. Conosco Marcello personalmente oramai da tanti anni e so perfettamente quanto ami la sua musica e quanta passione metta in ogni cosa che fa. Ovviamente a quest’aurea regola non sfugge “The World On A Slide” una raccolta di ben sedici brani –molti originali, altri scelti tra le più belle melodie del repertorio jazzistico del XX secolo – ma tutti suonati e arrangiati da Rosa nel corso della sua vita. Ebbene per questa sua ultima fatica discografica, Marcello ha voluto coronare un bel sogno: incidere un disco di soli e tanti tromboni. Ha così chiamato accanto a sé alcuni specialisti non solo del jazz ma anche della musica colta. Ed eccoli tutti i nomi dei temerari che hanno partecipato all’impresa: dalla musica colta Andrea Conti I trombone dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Luigino Leonardi trombonista presso la Banda musicale dell’Aeronautica Militare, Gianfranco Marchesi trombone basso dell’Orchestra sinfonica nazionale della RAI e il Quartetto italiano di tromboni, formato da Devid Ceste secondo trombone dell’Orchestra sinfonica nazionale della RAI, Matteo De Luca I trombone dell’orchestra della Suisse Romande di Ginevra, Diego Di Mario I trombone presso l’Orchestra sinfonica nazionale della RAI e Vincent Lepape I trombone dell’Orchestra del Teatro Regio di Torino. Dal mondo del jazz sono arrivati i già ‘collaudati’ Andrea Andreoli, Mario Corvini, Massimo Morganti e Roberto Rossi; accanto a loro i giovanissimi e brillanti Stefano Coccia, Elisabetta Mattei, Federico Proietti e il G.E.F.F. Trombone Quartet, composto da Giovanni Dominicis, Francesco Piersanti, Eugenio Renzetti e Gabriele Sapora. In taluni pezzi c’è pura una sezione ritmica composta da Paolo Tombolesi al pianoforte, Luca Berardi e Roy Panebianco alla chitarra, Marco Siniscalco al contrabbasso e basso elettrico, Cristiano Micalizzi alla batteria e Filippo La Porta alle percussioni. Il risultato è semplicemente entusiasmante: come si diceva una volta ‘dove peschi peschi bene’ ed in effetti tutte le esecuzioni contengono una carica tale da mai lasciarti indifferente. Qualche titolo? “Autumn Leaves” con Massimo Morganti in veste di solista, la suadente “Southern Ballad” che ad onta delle difficoltà di realizzazione narrate da Rosa è venuta molto bene con Roberto Rossi solista, il sempre toccante “What Are You Doing the Rest of Your Life” affidato al Quartetto Italiano di Tromboni con Gianfranco Marchesi. Da segnalare infine che come bonus track figurano “Miss Magnolia Lee” del giugno 1974 con Enrico Pieranunzi piano, Alessio Urso basso e Gegè Munari batteria e “Il ladro di noccioline” del 1980 con Daniele Cestana piano, Nanni Civitenga chitarra e chitarra basso e Enzo Restuccia batteria.
Bob Salmieri – “…and Mama Was a Belly Dancer” – Cultural Bridge
 Il sassofonista tenore romano Bob Salmieri si è già fatto conoscere da quando, nel 2016, costituì l’Erodoto Project, i cui album sono stati recensiti su questi stessi spazi. E’ di pochi mesi fa la costituzione del ‘Bob Salmieri Bastarduna Quintet’ con Giancarlo Romani alla tromba, Vincenzo Lucarelli organo e piano, Maurizio Perrone contrabbasso e Massimiliano de Lucia alla batteria, ospite in tre brani il vibrafonista e pianista polacco Mateusz Nawrot. In piena pandemia il gruppo incide il disco “…and Mama was a belly dancer” per Cultural Bridge, declinato attraverso otto composizioni tutte del leader che anche come strumentista non si risparmia di certo per tutta la durata dell’album. Due le necessarie premesse: nell’intento di Salmieri si tratta di un concept album in quanto rivede e rivive i sogni di un uomo-bambino che costruisce i suoni, i sapori, i colori di un tempo lontano e di un mondo sognato. In secondo luogo il termine Bastarduna con cui si è voluto caratterizzare il gruppo indica una varietà pregiata di fichi d’India a voler indicare la strada ‘mediterranea’ che il gruppo intende perseguire. Ora se, more solito, almeno per me è assai difficile stabilire se la musica coincide con l’impianto concettuale che dovrebbe sostenerla, non c‘è invece dubbio alcuno sul fatto che il jazz proposto si inserisca nel solco di un’ispirazione di impronta chiaramente mediterranea, particolarmente evidente in “Madame oculus” e “Men With The Painted Faces” impreziosito da un bell’assolo di Lucarelli all’organo. Dal punto di vista della linea melodica, particolarmente apprezzabile “The Flying Devils”. Comunque è tutto l’album che si snoda attraverso un filo rosso che vede in primo piano il fitto colloquio tra i due fiati ben sostenuti dalla sezione ritmica con l’ospite polacco in grado di ben inserirsi nel discorso collettivo con assoli di pregevole fattura (lo si ascolti in “The Balinese Dancer (Reprise)”.
Il sassofonista tenore romano Bob Salmieri si è già fatto conoscere da quando, nel 2016, costituì l’Erodoto Project, i cui album sono stati recensiti su questi stessi spazi. E’ di pochi mesi fa la costituzione del ‘Bob Salmieri Bastarduna Quintet’ con Giancarlo Romani alla tromba, Vincenzo Lucarelli organo e piano, Maurizio Perrone contrabbasso e Massimiliano de Lucia alla batteria, ospite in tre brani il vibrafonista e pianista polacco Mateusz Nawrot. In piena pandemia il gruppo incide il disco “…and Mama was a belly dancer” per Cultural Bridge, declinato attraverso otto composizioni tutte del leader che anche come strumentista non si risparmia di certo per tutta la durata dell’album. Due le necessarie premesse: nell’intento di Salmieri si tratta di un concept album in quanto rivede e rivive i sogni di un uomo-bambino che costruisce i suoni, i sapori, i colori di un tempo lontano e di un mondo sognato. In secondo luogo il termine Bastarduna con cui si è voluto caratterizzare il gruppo indica una varietà pregiata di fichi d’India a voler indicare la strada ‘mediterranea’ che il gruppo intende perseguire. Ora se, more solito, almeno per me è assai difficile stabilire se la musica coincide con l’impianto concettuale che dovrebbe sostenerla, non c‘è invece dubbio alcuno sul fatto che il jazz proposto si inserisca nel solco di un’ispirazione di impronta chiaramente mediterranea, particolarmente evidente in “Madame oculus” e “Men With The Painted Faces” impreziosito da un bell’assolo di Lucarelli all’organo. Dal punto di vista della linea melodica, particolarmente apprezzabile “The Flying Devils”. Comunque è tutto l’album che si snoda attraverso un filo rosso che vede in primo piano il fitto colloquio tra i due fiati ben sostenuti dalla sezione ritmica con l’ospite polacco in grado di ben inserirsi nel discorso collettivo con assoli di pregevole fattura (lo si ascolti in “The Balinese Dancer (Reprise)”.
Roberto Spadoni – “Mah” – Sword Records
 Anche Roberto Spadoni fa parte delle mie oramai lunghe amicizie musicali ed è proprio partendo da questa base che mi sento di affermare la valenza dello stesso quale musicista assai ben preparato e che, tutto sommato, non ha ancora ottenuto i riconoscimenti che merita. Adesso, dopo lunghi anni in cui ha suonato la sua fida chitarra, diretto organici di varie dimensioni, composto, insegnato, si cimenta con qualcosa di nuovo: produrre, promuovere e diffondere la sua musica seguendola in tutta la sua lunga filiera, dalla composizione alla registrazione, dal progetto grafico alla stampa e alla diffusione. Di qui la creazione di una label che – con una venatura di ironia – sottolinea Spadoni ha chiamato ‘Sword Records’. “Mah” è per l’appunto la prima realizzazione targata ‘Sword Records’ per cui il leader-chitarrista si esibisce con Fabio Petretti (sax tenore & soprano), Paolo Ghetti (contrabbasso) e Massimo Manzi (batteria). In programma nove composizioni originali tutte scritte dal leader a conferma di quanto su accennato a proposito della poliedricità di Roberto. L’album è sicuramente apprezzabile sia per l’originalità della scrittura così ben equilibrata sia per la bravura dei singoli notevoli nella parti d’insieme così come nei vari assolo. Ecco quindi il contrabbasso di Paolo Ghetti farsi apprezzare in “Remore morali” un brano non nuovo ma sempre affascinante. In “Girotondo” è la batteria di Massimo Manzi in primo piano, impegnata in un fitto dialogo con i compagni di viaggio mentre in “Borgo antico” si apprezza Fabio Petretti impegnato a disegnare una fluida linea melodica. Dal canto suo il leader non fa mancare il suo apporto solistico in ognuno dei brani apparendo, almeno a chi scrive, particolarmente convincente in “Buonanotte”. Ottima anche la chiusura con “Ce la posso fare” un pezzo che, evidenzia ancora Spadoni, egli ha diretto molte volte e che comunque rappresenta una sorta di mantra, un augurio, “una carica di energia positiva”, impreziosito nell’occasione dagli assolo di Petretti e di Spadoni.
Anche Roberto Spadoni fa parte delle mie oramai lunghe amicizie musicali ed è proprio partendo da questa base che mi sento di affermare la valenza dello stesso quale musicista assai ben preparato e che, tutto sommato, non ha ancora ottenuto i riconoscimenti che merita. Adesso, dopo lunghi anni in cui ha suonato la sua fida chitarra, diretto organici di varie dimensioni, composto, insegnato, si cimenta con qualcosa di nuovo: produrre, promuovere e diffondere la sua musica seguendola in tutta la sua lunga filiera, dalla composizione alla registrazione, dal progetto grafico alla stampa e alla diffusione. Di qui la creazione di una label che – con una venatura di ironia – sottolinea Spadoni ha chiamato ‘Sword Records’. “Mah” è per l’appunto la prima realizzazione targata ‘Sword Records’ per cui il leader-chitarrista si esibisce con Fabio Petretti (sax tenore & soprano), Paolo Ghetti (contrabbasso) e Massimo Manzi (batteria). In programma nove composizioni originali tutte scritte dal leader a conferma di quanto su accennato a proposito della poliedricità di Roberto. L’album è sicuramente apprezzabile sia per l’originalità della scrittura così ben equilibrata sia per la bravura dei singoli notevoli nella parti d’insieme così come nei vari assolo. Ecco quindi il contrabbasso di Paolo Ghetti farsi apprezzare in “Remore morali” un brano non nuovo ma sempre affascinante. In “Girotondo” è la batteria di Massimo Manzi in primo piano, impegnata in un fitto dialogo con i compagni di viaggio mentre in “Borgo antico” si apprezza Fabio Petretti impegnato a disegnare una fluida linea melodica. Dal canto suo il leader non fa mancare il suo apporto solistico in ognuno dei brani apparendo, almeno a chi scrive, particolarmente convincente in “Buonanotte”. Ottima anche la chiusura con “Ce la posso fare” un pezzo che, evidenzia ancora Spadoni, egli ha diretto molte volte e che comunque rappresenta una sorta di mantra, un augurio, “una carica di energia positiva”, impreziosito nell’occasione dagli assolo di Petretti e di Spadoni.
Barney Wilen & Alain Jean-Marie – “Montreal Duets” – Elemental 2 CD
 Vi piace la “buona” musica senza distinzione di stili, di epoca, di messaggi più o meno espliciti…insomma senza se e senza ma? Se la risposta è affermativa allora dovete ascoltare questo doppio album. Siamo nella Chiesa di Gesù, a Montreal (Canada) il 4 luglio del 1993 in occasione dell’annuale Festival del jazz. In programma per un doppio concerto pianificato alle 20 e alle 22,30 un duo d’eccezione composto da Barney Wilen al sax tenore e dal pianista martinicano Alain Jean-Marie. Già a quell’epoca i due avevano lungamente suonato assieme sin dagli anni ’80 potendo vantare una propria ben solida reputazione. In particolare Barney era considerato uno dei più prestigiosi sassofonisti francesi avendo, tra l’altro, collaborato con Miles Davis per la colonna sonora del film “Ascenseur pour l’Échafaud” nel 1957 mentre Alain a conferma di una carriera prestigiosa aveva ricevuto il “Prix Django Reinhardt” e nel 2000 il “Django d’Or”. Ora se è vero che nel mondo della musica e del jazz in particolare non sempre uno più uno fa due, questa volta si potrebbe ben dire che invece fa tre. Ascoltarli nelle loro evoluzioni è davvero un piacere tale e tanta è la fluidità del loro linguaggio. I due si intendono a meraviglia, si inseguono, si interrompono, si passano la palla senza soluzione di continuità nel rispetto di soluzioni ritmiche che guardano da vicino alla grande tradizione del bop. Non a caso Alain Jean-Marie agli inizi della carriera era stato avvicinato stilisticamente a Bud Powell. Nell’ampio programma enucleare qualche brano è davvero difficile anche se una menzione particolare la merita la splendida ballad di Gordon Jenkins, “Good Bye”, pezzo con cui Barney Wylen chiuse la sua performance a Caen il 14 marzo 1996 in quello che sarebbe stato il suo ultimo concerto. Ascoltando “Good Bye” non ci si può non lasciar prendere da una ondata di malinconia nel ricordo di un grande artista che anche nell’esecuzione presente in questo album evidenzia una classe e una musicalità senza pari. E vorrei chiudere citando le parole di Jean-Paul Sartre riportate da Pascal Anquetil nel booklet del disco: “il y a un gros homme qui s’époumone à suivre son trombone dans ses évolutions, il y a un pianiste sans merci, un contrebassiste qui gratte ses cordes sans écouter les autres. Ils s’adressent à la meilleure part de vous-même, à la plus sèche, à la plus libre, à celle qui ne veut ni mélancolie ni ritournelle, mais l’éclat étourdissant d’un instant. Ils vous réclament, ils ne vous bercent pas”.
Vi piace la “buona” musica senza distinzione di stili, di epoca, di messaggi più o meno espliciti…insomma senza se e senza ma? Se la risposta è affermativa allora dovete ascoltare questo doppio album. Siamo nella Chiesa di Gesù, a Montreal (Canada) il 4 luglio del 1993 in occasione dell’annuale Festival del jazz. In programma per un doppio concerto pianificato alle 20 e alle 22,30 un duo d’eccezione composto da Barney Wilen al sax tenore e dal pianista martinicano Alain Jean-Marie. Già a quell’epoca i due avevano lungamente suonato assieme sin dagli anni ’80 potendo vantare una propria ben solida reputazione. In particolare Barney era considerato uno dei più prestigiosi sassofonisti francesi avendo, tra l’altro, collaborato con Miles Davis per la colonna sonora del film “Ascenseur pour l’Échafaud” nel 1957 mentre Alain a conferma di una carriera prestigiosa aveva ricevuto il “Prix Django Reinhardt” e nel 2000 il “Django d’Or”. Ora se è vero che nel mondo della musica e del jazz in particolare non sempre uno più uno fa due, questa volta si potrebbe ben dire che invece fa tre. Ascoltarli nelle loro evoluzioni è davvero un piacere tale e tanta è la fluidità del loro linguaggio. I due si intendono a meraviglia, si inseguono, si interrompono, si passano la palla senza soluzione di continuità nel rispetto di soluzioni ritmiche che guardano da vicino alla grande tradizione del bop. Non a caso Alain Jean-Marie agli inizi della carriera era stato avvicinato stilisticamente a Bud Powell. Nell’ampio programma enucleare qualche brano è davvero difficile anche se una menzione particolare la merita la splendida ballad di Gordon Jenkins, “Good Bye”, pezzo con cui Barney Wylen chiuse la sua performance a Caen il 14 marzo 1996 in quello che sarebbe stato il suo ultimo concerto. Ascoltando “Good Bye” non ci si può non lasciar prendere da una ondata di malinconia nel ricordo di un grande artista che anche nell’esecuzione presente in questo album evidenzia una classe e una musicalità senza pari. E vorrei chiudere citando le parole di Jean-Paul Sartre riportate da Pascal Anquetil nel booklet del disco: “il y a un gros homme qui s’époumone à suivre son trombone dans ses évolutions, il y a un pianiste sans merci, un contrebassiste qui gratte ses cordes sans écouter les autres. Ils s’adressent à la meilleure part de vous-même, à la plus sèche, à la plus libre, à celle qui ne veut ni mélancolie ni ritournelle, mais l’éclat étourdissant d’un instant. Ils vous réclament, ils ne vous bercent pas”.
*****
Ferenc Snétberger, Keller Quartett – Hallgató – ECM New Series 2653
 Com’è nostra consuetudine, consentiteci una tantum qualche digressione al di fuori degli ambiti prettamente jazzistici. Questa volta lo facciamo per segnalarvi questo album targato ECM New Series, dedicato al dolore vissuto da molti nel corso dei secoli senza motivo alcuno, che vede come protagonisti il chitarrista ungherese Ferenc Snetberger, il terzo pubblicato da ECM, e il Keller Quartet, anch’esso costituito da musicisti ungheresi. L’album, registrato in concerto nella Grand Hall della Liszt Academy di Budapest nel dicembre 2018, presenta un programma interamente dedicato alla musica classica. L’apertura e la chiusura sono dedicati a brani dello stesso Snétberger, inframmezzati da composizioni di Dimitri Shostakovich (il Quartetto per archi N. 8 in Do minore dedicato alle vittime della guerra e del fascismo), John Dowland ( “I Saw My Lady Weep” per chitarra e quartetto d’archi, e “Flow, My Tears” per chitarra e violoncello), Samuel Barber (lo struggente “Adagio for strings” interpretato dal solo “Keller Quartet”. Dal canto suo Ferenc Snetberger presenta alcune sue composizioni che non sfigurano al cospetto di contati autori. Così il “Concerto In Memory of My People,” in tre movimenti, composto da Snétberger nel 1994 per chitarra e orchestra, e qui riproposto in un arrangiamento per chitarra e quintetto d’archi, coglie perfettamente nel segno riuscendo a trasmettere l’ispirazione dell’autore che ricorda e dedica questa musica alla memoria dei suoi antenati gitani Roma e Sinti (cui il chitarrista appartiene) perseguitati e uccisi nei secoli. L’album si chiude con due composizioni del chitarrista, “Your Smile” per chitarra solo, unico brano in cui ci si distacca dalla sensazione di tristezza e dolore che domina tutto il CD e “Rhapsody No.1, for Guitar and Orchestra” qui però nella versione per chitarra e quintetto d’archi.
Com’è nostra consuetudine, consentiteci una tantum qualche digressione al di fuori degli ambiti prettamente jazzistici. Questa volta lo facciamo per segnalarvi questo album targato ECM New Series, dedicato al dolore vissuto da molti nel corso dei secoli senza motivo alcuno, che vede come protagonisti il chitarrista ungherese Ferenc Snetberger, il terzo pubblicato da ECM, e il Keller Quartet, anch’esso costituito da musicisti ungheresi. L’album, registrato in concerto nella Grand Hall della Liszt Academy di Budapest nel dicembre 2018, presenta un programma interamente dedicato alla musica classica. L’apertura e la chiusura sono dedicati a brani dello stesso Snétberger, inframmezzati da composizioni di Dimitri Shostakovich (il Quartetto per archi N. 8 in Do minore dedicato alle vittime della guerra e del fascismo), John Dowland ( “I Saw My Lady Weep” per chitarra e quartetto d’archi, e “Flow, My Tears” per chitarra e violoncello), Samuel Barber (lo struggente “Adagio for strings” interpretato dal solo “Keller Quartet”. Dal canto suo Ferenc Snetberger presenta alcune sue composizioni che non sfigurano al cospetto di contati autori. Così il “Concerto In Memory of My People,” in tre movimenti, composto da Snétberger nel 1994 per chitarra e orchestra, e qui riproposto in un arrangiamento per chitarra e quintetto d’archi, coglie perfettamente nel segno riuscendo a trasmettere l’ispirazione dell’autore che ricorda e dedica questa musica alla memoria dei suoi antenati gitani Roma e Sinti (cui il chitarrista appartiene) perseguitati e uccisi nei secoli. L’album si chiude con due composizioni del chitarrista, “Your Smile” per chitarra solo, unico brano in cui ci si distacca dalla sensazione di tristezza e dolore che domina tutto il CD e “Rhapsody No.1, for Guitar and Orchestra” qui però nella versione per chitarra e quintetto d’archi.
Che altro aggiungere se non che alla bellezza dei brani si aggiunge la valenza di Ferenc Snétberger che si conferma esecutore e compositore di sicuro livello.



















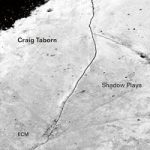













































 Una prima notazione tutt’altro che secondaria: “questo lavoro – afferma lo stesso Balducci – vede la luce ad otto anni dal mio precedente disco, “Blue from Heaven”, e a tre anni da “Evansiana”, pubblicato nel 2017. Lo dedico a John Taylor, che in questi due dischi è presente: punto di riferimento sia per me che per tanti altri musicisti europei, John mi ha onorato della sua presenza nel mio quartetto fino alla sua scomparsa, nel 2014”. Ebbene, nell’intento di omaggiare cotanto artista, il bassista/compositore pugliese Pierluigi Balducci, ben coadiuvato da Robert Bonisolo (sax tenore), Fabrizio Savino (chitarra) e Dario Congedo (batteria) ha realizzato questo eccellente album con sette brani originali tutti composti dal leader. Inquadrato l’album nelle sue linee generali, occorre aggiungere che il titolo rispecchia appieno la musica che si ascolta. Un equilibrio tra forma e contenuto, un bilanciamento apprezzabile tra parti scritte e improvvisate, un giusto alternarsi di atmosfere tra energico groove e avvolgente melodia, il tutto condito da una ricerca sul sound che ha dato frutti copiosi. In particolare si fa apprezzare il dialogo a più voci che vede impegnati alle volte Balducci e sezione ritmica, altre volte Balducci e Bonisolo; ciò senza trascurare il peso degli assolo che si ascoltano nei vari brani: particolarmente apprezzabile, ad esempio, il chitarrista nella title-track con il suo incedere elegantemente descrittivo mentre il sax di Bonisolo s’impone alla generale attenzione già a partire dalle primissime note del brano d’apertura “Blackarera” caratterizzato da un coinvolgente andamento ritmico.
Una prima notazione tutt’altro che secondaria: “questo lavoro – afferma lo stesso Balducci – vede la luce ad otto anni dal mio precedente disco, “Blue from Heaven”, e a tre anni da “Evansiana”, pubblicato nel 2017. Lo dedico a John Taylor, che in questi due dischi è presente: punto di riferimento sia per me che per tanti altri musicisti europei, John mi ha onorato della sua presenza nel mio quartetto fino alla sua scomparsa, nel 2014”. Ebbene, nell’intento di omaggiare cotanto artista, il bassista/compositore pugliese Pierluigi Balducci, ben coadiuvato da Robert Bonisolo (sax tenore), Fabrizio Savino (chitarra) e Dario Congedo (batteria) ha realizzato questo eccellente album con sette brani originali tutti composti dal leader. Inquadrato l’album nelle sue linee generali, occorre aggiungere che il titolo rispecchia appieno la musica che si ascolta. Un equilibrio tra forma e contenuto, un bilanciamento apprezzabile tra parti scritte e improvvisate, un giusto alternarsi di atmosfere tra energico groove e avvolgente melodia, il tutto condito da una ricerca sul sound che ha dato frutti copiosi. In particolare si fa apprezzare il dialogo a più voci che vede impegnati alle volte Balducci e sezione ritmica, altre volte Balducci e Bonisolo; ciò senza trascurare il peso degli assolo che si ascoltano nei vari brani: particolarmente apprezzabile, ad esempio, il chitarrista nella title-track con il suo incedere elegantemente descrittivo mentre il sax di Bonisolo s’impone alla generale attenzione già a partire dalle primissime note del brano d’apertura “Blackarera” caratterizzato da un coinvolgente andamento ritmico. Siamo nei primissimi anni ’60, per la precisione nel 1962, quando viene registrato un lp dal sassofonista Stan Getz con il chitarrista Charlie Byrd: è l’inizio del fenomeno ‘jazz samba’ (più tardi inteso come ‘bossa nova’) che tanto successo ebbe nel mondo del jazz. Tra i sacerdoti di questa nuova musica figura certamente il chitarrista e vocalist Luiz Bonfà (Rio de Janeiro, 17 ottobre 1922 – Rio de Janeiro, 12 gennaio 2001) che nello stesso 1962 fu tra i protagonisti dello storico spettacolo di bossa nova che si tenne alla Carnegie Hall. A testimonianza delle sue frequentazioni con il mondo del jazz restano le incisioni con Stan Getz, Quincy Jones, Frank Sinatra, Eumir Deodato. Moltissime le composizioni di Bonfà – oltre un centinaio – molte celebri, tra cui ricordiamo innanzitutto “Manhã de Carnaval” e “Samba de Orfeu” entrambi tratti dalla colonna sonora del film “Orfeo Negro”. In questo album si ascoltano due lp risalenti agli anni ’60. Nel primo, registrato a New York nel 1962, troviamo Bonfà a capo di un sestetto e una sezione d’archi arrangiata da Lalo Schifrin; il secondo – “The Gentle Rain” – è la colonna sonora dell’omonimo film in cui il chitarrista suona con un’orchestra arrangiata e diretta dall’amico Eumir Deodato, realizzata a Rio De Janiero nel 1966. Naturalmente in repertorio figurano altre perle targate Bonfà come il già citato “Manhã de Carnaval” e ancora “Samba de Duas Notas”, “Silencio do amor”, “Perdido de amor” registrato a Rio de Janeiro nel 1959 e porto come “bonus track”. Fornire un quadro esauriente dell’arte di Bonfà è opera davvero ardua dato l’enorme numero di registrazioni effettuate dall’artista tuttavia dall’ascolto di questo album si può ricavare un ritratto soddisfacente di quel che Bonfà ha rappresentato nel mondo della musica.
Siamo nei primissimi anni ’60, per la precisione nel 1962, quando viene registrato un lp dal sassofonista Stan Getz con il chitarrista Charlie Byrd: è l’inizio del fenomeno ‘jazz samba’ (più tardi inteso come ‘bossa nova’) che tanto successo ebbe nel mondo del jazz. Tra i sacerdoti di questa nuova musica figura certamente il chitarrista e vocalist Luiz Bonfà (Rio de Janeiro, 17 ottobre 1922 – Rio de Janeiro, 12 gennaio 2001) che nello stesso 1962 fu tra i protagonisti dello storico spettacolo di bossa nova che si tenne alla Carnegie Hall. A testimonianza delle sue frequentazioni con il mondo del jazz restano le incisioni con Stan Getz, Quincy Jones, Frank Sinatra, Eumir Deodato. Moltissime le composizioni di Bonfà – oltre un centinaio – molte celebri, tra cui ricordiamo innanzitutto “Manhã de Carnaval” e “Samba de Orfeu” entrambi tratti dalla colonna sonora del film “Orfeo Negro”. In questo album si ascoltano due lp risalenti agli anni ’60. Nel primo, registrato a New York nel 1962, troviamo Bonfà a capo di un sestetto e una sezione d’archi arrangiata da Lalo Schifrin; il secondo – “The Gentle Rain” – è la colonna sonora dell’omonimo film in cui il chitarrista suona con un’orchestra arrangiata e diretta dall’amico Eumir Deodato, realizzata a Rio De Janiero nel 1966. Naturalmente in repertorio figurano altre perle targate Bonfà come il già citato “Manhã de Carnaval” e ancora “Samba de Duas Notas”, “Silencio do amor”, “Perdido de amor” registrato a Rio de Janeiro nel 1959 e porto come “bonus track”. Fornire un quadro esauriente dell’arte di Bonfà è opera davvero ardua dato l’enorme numero di registrazioni effettuate dall’artista tuttavia dall’ascolto di questo album si può ricavare un ritratto soddisfacente di quel che Bonfà ha rappresentato nel mondo della musica. E’ un trio di caratura internazionale quello che il chitarrista danese Jakob Bro, al suo quinto disco da leader per la ECM, presenta in questa occasione: al suo fianco sono, infatti, il trombettista norvegese Arve Henriksen e il batterista spagnolo Jorge Rossy. Ad onta del fatto che i tre mai avevano inciso prima, la formazione si dimostra assolutamente compatta, ben guidata dal leader e perfettamente in grado di svolgere la musica che Bro aveva immaginato. Nove brani tutti composti dal chitarrista caratterizzati da un’atmosfera profonda, intimista, fortemente evocativa, ricca di echi, di riverberi, con chitarra e tromba che dialogano continuamente e la batteria di Rossy a punteggiare e sostenere il tutto, pur concedendo davvero poco all’impianto ritmico. Nell’ambito del repertorio figurano tre espliciti omaggi, in cui, però, Bro continua ad evidenziare la sua poetica mantenendosi ad una certa distanza dagli artisti evocati. Non a caso l’album si apre con “Reconstructing a Dream” in ricordo di quel periodo (2007) in cui collaborava con la Paul Motian’s Electric Bebop Band. “To Stanko” è un tributo al trombettista polacco Tomasz Stanko con il quale Bro aveva collaborato per ben cinque anni incidendo, tra l’altro, nel 2009 l’album ECM “Dark Eyes” unitamente a Alexi Tuomarila piano, Anders Christensen chitarra basso e Olavi Louhivuori batteria; la linea melodica è dolcemente suggestiva ben lontana, quindi, dal clima arroventato proprio dell’artista polacco. L’altro jazzista omaggiato è Lee Konitz per il quale Bro ha scritto ed eseguito “Music For Black Pigeons”; nei confronti del sassofonista Bro dichiara una sorta di sincera devozione sorta negli anni in cui hanno suonato assieme durante le tournée effettuate in Islanda, Groenlandia, Norvegia, Danimarca. Il brano più interessante? Difficile da enucleare anche se mi ha particolarmente colpito “Housework” sia per il sound affatto particolare della tromba, sia perché è piuttosto complicato enucleare le parti improvvisate dall’intelligente scrittura.
E’ un trio di caratura internazionale quello che il chitarrista danese Jakob Bro, al suo quinto disco da leader per la ECM, presenta in questa occasione: al suo fianco sono, infatti, il trombettista norvegese Arve Henriksen e il batterista spagnolo Jorge Rossy. Ad onta del fatto che i tre mai avevano inciso prima, la formazione si dimostra assolutamente compatta, ben guidata dal leader e perfettamente in grado di svolgere la musica che Bro aveva immaginato. Nove brani tutti composti dal chitarrista caratterizzati da un’atmosfera profonda, intimista, fortemente evocativa, ricca di echi, di riverberi, con chitarra e tromba che dialogano continuamente e la batteria di Rossy a punteggiare e sostenere il tutto, pur concedendo davvero poco all’impianto ritmico. Nell’ambito del repertorio figurano tre espliciti omaggi, in cui, però, Bro continua ad evidenziare la sua poetica mantenendosi ad una certa distanza dagli artisti evocati. Non a caso l’album si apre con “Reconstructing a Dream” in ricordo di quel periodo (2007) in cui collaborava con la Paul Motian’s Electric Bebop Band. “To Stanko” è un tributo al trombettista polacco Tomasz Stanko con il quale Bro aveva collaborato per ben cinque anni incidendo, tra l’altro, nel 2009 l’album ECM “Dark Eyes” unitamente a Alexi Tuomarila piano, Anders Christensen chitarra basso e Olavi Louhivuori batteria; la linea melodica è dolcemente suggestiva ben lontana, quindi, dal clima arroventato proprio dell’artista polacco. L’altro jazzista omaggiato è Lee Konitz per il quale Bro ha scritto ed eseguito “Music For Black Pigeons”; nei confronti del sassofonista Bro dichiara una sorta di sincera devozione sorta negli anni in cui hanno suonato assieme durante le tournée effettuate in Islanda, Groenlandia, Norvegia, Danimarca. Il brano più interessante? Difficile da enucleare anche se mi ha particolarmente colpito “Housework” sia per il sound affatto particolare della tromba, sia perché è piuttosto complicato enucleare le parti improvvisate dall’intelligente scrittura. Album da non perdere per gli appassionati di un certo tipo di jazz, molto vicino al blues. In effetti vi sono contenuti tutti i singoli che James Booker realizzò come leader all’inizio della sua carriera, tra il 1954 e il 1962, quando incideva per diverse etichette tra cui Imperial, Chess, Ace e Peacock. Il cd contiene inoltre brani di altri artisti in cui James Booker appare come sideman. E’ il caso, ad esempio, di “You’re On My Mind” e “The Nex Time” in cui suona accanto a Junior Parker (voce) e Arnett Cobb (sax tenore), e delle due tracce conclusive in cui collabora con il bluesman Earl King. Ma chi era James Booker domanda che probabilmente si staranno facendo i nostri più giovani lettori. Ebbene James Booker, (New Orleans, 17 dicembre 1939 – 8 novembre 1983), conosciuto come il Principe del piano di New Orleans, è stato uno dei musicisti più amati di Crescent City. Era un pianista eccellente, organista di livello (lo si ascolti ad esempio in “Cross My Heart”), vocalist e compositore che si era creato uno stile del tutto personale fondendo R&B, gospel, blues, boogie-woogie, jazz tradizionale e moderno attraverso un suono originale. Ma le sue conoscenze musicali andavano ben al di là rivolgendosi anche alla musica classica europea, così rivisitò in chiave blues il “Valzer del minuto” di Chopin e inserì una composizione dello stesso autore polacco in un brano boogie-woogie. Data l’importanza della sua musica nell’ambito della scena jazz-blues di New Orleans, la sua produzione fa parte dal 2008 degli archivi della Biblioteca del Congresso.
Album da non perdere per gli appassionati di un certo tipo di jazz, molto vicino al blues. In effetti vi sono contenuti tutti i singoli che James Booker realizzò come leader all’inizio della sua carriera, tra il 1954 e il 1962, quando incideva per diverse etichette tra cui Imperial, Chess, Ace e Peacock. Il cd contiene inoltre brani di altri artisti in cui James Booker appare come sideman. E’ il caso, ad esempio, di “You’re On My Mind” e “The Nex Time” in cui suona accanto a Junior Parker (voce) e Arnett Cobb (sax tenore), e delle due tracce conclusive in cui collabora con il bluesman Earl King. Ma chi era James Booker domanda che probabilmente si staranno facendo i nostri più giovani lettori. Ebbene James Booker, (New Orleans, 17 dicembre 1939 – 8 novembre 1983), conosciuto come il Principe del piano di New Orleans, è stato uno dei musicisti più amati di Crescent City. Era un pianista eccellente, organista di livello (lo si ascolti ad esempio in “Cross My Heart”), vocalist e compositore che si era creato uno stile del tutto personale fondendo R&B, gospel, blues, boogie-woogie, jazz tradizionale e moderno attraverso un suono originale. Ma le sue conoscenze musicali andavano ben al di là rivolgendosi anche alla musica classica europea, così rivisitò in chiave blues il “Valzer del minuto” di Chopin e inserì una composizione dello stesso autore polacco in un brano boogie-woogie. Data l’importanza della sua musica nell’ambito della scena jazz-blues di New Orleans, la sua produzione fa parte dal 2008 degli archivi della Biblioteca del Congresso. Questo è un album chiaramente divisivo: in effetti se amate il soul jazz e più in generale la soul music allora l’ascolto sarà più che gradevole; esattamente il contrario se vi sentite lontani da questo particolare genere. Il protagonista è un vocalist di assoluto rilievo, Sam Cooke, che può essere considerato uno dei padri fondatori della soul music essendo stato tra i primi a coniugare le tematiche gospel con input provenienti dalla vita reale. Nato a Clarksdale il 22 gennaio 1931 e scomparso a Los Angeles l’11 dicembre 1964, Sam sulla spinta del padre – il Reverendo Charles Cook della Chiesa Battista – si era già affermato da giovanissimo come leader del famoso gruppo gospel “teenage” “The Highway QC” che abbandonerà all’età di 19 anni per dedicarsi ad una musica “profana”. Nel corso della sua non lunga carriera, Sam collezionò una serie incredibile di successi, grazie ad un incredibile senso del ritmo e a straordinarie capacità vocali che gli consentivano di passare con disinvoltura da Gershwin (lo si ascolti in “Summertime” a classici del pop quale “Youn Send Me”, anch’esso presente in questa raccolta. E il pregio principale di questo CD consiste proprio nel fatto che nell’ambito delle 30 tracce, registrate tra il 1956 e il 1962, possiamo ascoltare tutti i più grandi successi del vocalist, da “Wonderful World” che apre la compilation a “Bring It On Home to Me”, da “Chain Gang” a “Twistin’ the Night Away” da “A Change Is Gonna Come” fino al conclusivo “Having a Party” per circa 78 minuti di musica. In queste numerose performances Sam Cooke è accompagnato anche da alcuni eccellenti jazzisti quali il pianista Hank Jones, Mike Pacheco (conga), Red Callender (basso).
Questo è un album chiaramente divisivo: in effetti se amate il soul jazz e più in generale la soul music allora l’ascolto sarà più che gradevole; esattamente il contrario se vi sentite lontani da questo particolare genere. Il protagonista è un vocalist di assoluto rilievo, Sam Cooke, che può essere considerato uno dei padri fondatori della soul music essendo stato tra i primi a coniugare le tematiche gospel con input provenienti dalla vita reale. Nato a Clarksdale il 22 gennaio 1931 e scomparso a Los Angeles l’11 dicembre 1964, Sam sulla spinta del padre – il Reverendo Charles Cook della Chiesa Battista – si era già affermato da giovanissimo come leader del famoso gruppo gospel “teenage” “The Highway QC” che abbandonerà all’età di 19 anni per dedicarsi ad una musica “profana”. Nel corso della sua non lunga carriera, Sam collezionò una serie incredibile di successi, grazie ad un incredibile senso del ritmo e a straordinarie capacità vocali che gli consentivano di passare con disinvoltura da Gershwin (lo si ascolti in “Summertime” a classici del pop quale “Youn Send Me”, anch’esso presente in questa raccolta. E il pregio principale di questo CD consiste proprio nel fatto che nell’ambito delle 30 tracce, registrate tra il 1956 e il 1962, possiamo ascoltare tutti i più grandi successi del vocalist, da “Wonderful World” che apre la compilation a “Bring It On Home to Me”, da “Chain Gang” a “Twistin’ the Night Away” da “A Change Is Gonna Come” fino al conclusivo “Having a Party” per circa 78 minuti di musica. In queste numerose performances Sam Cooke è accompagnato anche da alcuni eccellenti jazzisti quali il pianista Hank Jones, Mike Pacheco (conga), Red Callender (basso). E’ di poche settimane fa la dipartita di Chick Corea un artista che ha segnato la storia del jazz negli ultimi cinquant’anni. Ecco, quindi, questo pregevole doppio album della Concord che lumeggia uno dei tanti lati della complessa personalità artistica di Corea: quella del piano solo. Piano solo declinato attraverso una varietà di situazioni che testimonia, meglio di mille parole, da un lato l’incredibile conoscenza del repertorio pianistico, dall’altro la capacità di ben interpretarlo. Eccolo quindi alle prese con Mozart, con Gershwin, con Scarlatti, con Bill Evans, con Scriabin, con Antonio Carlos Jobim, con Monk, per chiudere con una serie di brani tratti da quell’inesauribile scrigno costituito dalle sue composizioni. In particolare il primo CD è dedicato a prezzi celebri che tutti conoscono mentre nel secondo è possibile ascoltare tutti brani di Corea eccezion fatta per “Pastime Paradise” di Stevie Wonder. I brani sono tratti da una serie di concerti svolti in vari Paesi europei e statunitensi e ovunque, dinnanzi ad un pubblico che lo acclama, Chick non si risparmia e affronta con disinvoltura i non facili confronti con gli autori su citati. Ma non basta ché Corea si lascia andare anche ad improvvisazioni che testimoniano la valenza di un artista che mai ha fatto ricorso al banale, al facile ascolto, ai cliché spesso di moda. Insomma ancora una volta Corea si concede senza limiti al suo pubblico, senza particolari modalità, fedele al suo motto più volte espresso secondo cui “a me piace – afferma il pianista – che il pubblico ai miei concerti si senta come se stessimo nel mio salotto a discutere del più e del meno”.
E’ di poche settimane fa la dipartita di Chick Corea un artista che ha segnato la storia del jazz negli ultimi cinquant’anni. Ecco, quindi, questo pregevole doppio album della Concord che lumeggia uno dei tanti lati della complessa personalità artistica di Corea: quella del piano solo. Piano solo declinato attraverso una varietà di situazioni che testimonia, meglio di mille parole, da un lato l’incredibile conoscenza del repertorio pianistico, dall’altro la capacità di ben interpretarlo. Eccolo quindi alle prese con Mozart, con Gershwin, con Scarlatti, con Bill Evans, con Scriabin, con Antonio Carlos Jobim, con Monk, per chiudere con una serie di brani tratti da quell’inesauribile scrigno costituito dalle sue composizioni. In particolare il primo CD è dedicato a prezzi celebri che tutti conoscono mentre nel secondo è possibile ascoltare tutti brani di Corea eccezion fatta per “Pastime Paradise” di Stevie Wonder. I brani sono tratti da una serie di concerti svolti in vari Paesi europei e statunitensi e ovunque, dinnanzi ad un pubblico che lo acclama, Chick non si risparmia e affronta con disinvoltura i non facili confronti con gli autori su citati. Ma non basta ché Corea si lascia andare anche ad improvvisazioni che testimoniano la valenza di un artista che mai ha fatto ricorso al banale, al facile ascolto, ai cliché spesso di moda. Insomma ancora una volta Corea si concede senza limiti al suo pubblico, senza particolari modalità, fedele al suo motto più volte espresso secondo cui “a me piace – afferma il pianista – che il pubblico ai miei concerti si senta come se stessimo nel mio salotto a discutere del più e del meno”. Album d’esordio per questo alto-sassofonista originario di Frosinone ma di stanza a Brooklyn, NY, ben coadiuvato dal pianista originario dell’Oregon Justin Salisbury, dal bassista Giuseppe Cucchiara e dal batterista sudcoreano Jongkuk Kim. In programma tredici composizioni tutte scritte dal sassofonista che si è fatto le ossa suonando al Wally’s Jazz Cafe, il leggendario jazz club di Boston; in questa città Germani si è trasferito nel 2013 avendo ottenuto una borsa di studio per frequentare il Berklee College of Music. Mentre era lì, è stato ammesso al prestigioso Berklee Global Jazz Institute di Danilo Perez, dove ha studiato sotto la guida di Terri Lyne Carrington, Joe Lovano e del suo mentore, George Garzone. Avendo alle spalle tanti anni di studio e con maestri talmente prestigiosi, Germani si presenta al pubblico italiano come musicista maturo, perfettamente consapevole dei propri mezzi espressivi e in grado di guidare un ensemble ben equilibrato e affiatato grazie al fatto che i quattro si sono conosciuti al Berklee. Di qui una perfetta spaziatura tra gli strumentisti e il giusto tempo dato ad ognuno per esprimere le proprie potenzialità. Così ad esempio in “One Moment To Monet” è il piano di Salisbury a mettersi in particolare evidenza mentre in “Hal Believe It” è l’intera sezione ritmica ad evidenziare la sua bravura nel sostenere magnificamente il solismo del leader. Il quale dà un’impronta all’intero album già nelle primissime note del brano d’apertura quando su un tappeto disegnato dal basso introduce e sviluppa il tema, portandolo dolcemente a conclusione Comunque ad avviso di chi scrive il brano meglio riuscito è “Eres luz”, una suggestiva melodia disegnata anche dal contrabbasso di Cucchiara e che vede l’intero quartetto esprimersi al meglio.
Album d’esordio per questo alto-sassofonista originario di Frosinone ma di stanza a Brooklyn, NY, ben coadiuvato dal pianista originario dell’Oregon Justin Salisbury, dal bassista Giuseppe Cucchiara e dal batterista sudcoreano Jongkuk Kim. In programma tredici composizioni tutte scritte dal sassofonista che si è fatto le ossa suonando al Wally’s Jazz Cafe, il leggendario jazz club di Boston; in questa città Germani si è trasferito nel 2013 avendo ottenuto una borsa di studio per frequentare il Berklee College of Music. Mentre era lì, è stato ammesso al prestigioso Berklee Global Jazz Institute di Danilo Perez, dove ha studiato sotto la guida di Terri Lyne Carrington, Joe Lovano e del suo mentore, George Garzone. Avendo alle spalle tanti anni di studio e con maestri talmente prestigiosi, Germani si presenta al pubblico italiano come musicista maturo, perfettamente consapevole dei propri mezzi espressivi e in grado di guidare un ensemble ben equilibrato e affiatato grazie al fatto che i quattro si sono conosciuti al Berklee. Di qui una perfetta spaziatura tra gli strumentisti e il giusto tempo dato ad ognuno per esprimere le proprie potenzialità. Così ad esempio in “One Moment To Monet” è il piano di Salisbury a mettersi in particolare evidenza mentre in “Hal Believe It” è l’intera sezione ritmica ad evidenziare la sua bravura nel sostenere magnificamente il solismo del leader. Il quale dà un’impronta all’intero album già nelle primissime note del brano d’apertura quando su un tappeto disegnato dal basso introduce e sviluppa il tema, portandolo dolcemente a conclusione Comunque ad avviso di chi scrive il brano meglio riuscito è “Eres luz”, una suggestiva melodia disegnata anche dal contrabbasso di Cucchiara e che vede l’intero quartetto esprimersi al meglio. Undici composizioni originali che il pianista-compositore Andrea Goretti affronta in solitudine. Di qui una duplice fatica: da compositore e da esecutore. E la valutazione non può che essere positiva. Le composizioni appaiono ben strutturate, caratterizzate da introspezione e sincera meditazione, mentre le esecuzioni risultano perfettamente aderenti alle idee dell’artista. Quindi nessuno sfoggio virtuosistico ma un uso intelligente delle dinamiche, una accurata ricerca armonica nell’ambito di un pianismo tecnicamente ineccepibile. Il tutto supportato da una profonda conoscenza della letteratura sia classica sia jazzistica, con specifico riferimento alle tendenze più attuali. Non a caso in repertorio figura anche un brano, “T.T.T. X – Twelve Tone Tune X” costruito con una linea melodica di dodici suoni, ad omaggiare il celebre “Twelve Tone Tune” di Bill Evans. Altra dote di Andrea Goretti la capacità di saper bilanciare scrittura e improvvisazione, pratica quest’ultima, che pur evidenziandosi in tutto l’album si palesa particolarmente in “Neptune’s Blues” e “I giganti”. L’album si chiude con tre pezzi registrati dal vivo durante un concerto a Roma nel novembre del 2018: “Impro I”, “Lamento”, ispirato al blues e “Il Grinch 2”, dedicato, non senza un tocco d’ironia, al periodo natalizio, in particolare a quel personaggio – Grinch per l’appunto – inventato nel 1957 dal Dr. Seuss, che odia il Natale, non ne sopporta l’atmosfera allegra, i canti, i regali e le luci. L’album è impreziosito da una poesia di Umberto Petrin, “Question”, ispirata dalla musica di Goretti.
Undici composizioni originali che il pianista-compositore Andrea Goretti affronta in solitudine. Di qui una duplice fatica: da compositore e da esecutore. E la valutazione non può che essere positiva. Le composizioni appaiono ben strutturate, caratterizzate da introspezione e sincera meditazione, mentre le esecuzioni risultano perfettamente aderenti alle idee dell’artista. Quindi nessuno sfoggio virtuosistico ma un uso intelligente delle dinamiche, una accurata ricerca armonica nell’ambito di un pianismo tecnicamente ineccepibile. Il tutto supportato da una profonda conoscenza della letteratura sia classica sia jazzistica, con specifico riferimento alle tendenze più attuali. Non a caso in repertorio figura anche un brano, “T.T.T. X – Twelve Tone Tune X” costruito con una linea melodica di dodici suoni, ad omaggiare il celebre “Twelve Tone Tune” di Bill Evans. Altra dote di Andrea Goretti la capacità di saper bilanciare scrittura e improvvisazione, pratica quest’ultima, che pur evidenziandosi in tutto l’album si palesa particolarmente in “Neptune’s Blues” e “I giganti”. L’album si chiude con tre pezzi registrati dal vivo durante un concerto a Roma nel novembre del 2018: “Impro I”, “Lamento”, ispirato al blues e “Il Grinch 2”, dedicato, non senza un tocco d’ironia, al periodo natalizio, in particolare a quel personaggio – Grinch per l’appunto – inventato nel 1957 dal Dr. Seuss, che odia il Natale, non ne sopporta l’atmosfera allegra, i canti, i regali e le luci. L’album è impreziosito da una poesia di Umberto Petrin, “Question”, ispirata dalla musica di Goretti. Chiarezza esemplare nel titolo dell’album: siano nel campo di un certo ben preciso tipo di jazz che il chitarrista e compositore Pietro Lazazzara frequenta con disinvoltura. Ma sarebbe un errore confinare l’album nell’ambito del “Gipsy Jazz”: in effetti, restando questo la fonte principale da cui trae ispirazione, il percorso di Pietro è più complesso e completo. Eccolo quindi studente di chitarra classico, appassionato conoscitore del flamenco, laureato in musica jazz e infaticabile appassionato ricercatore nell’ambito di uno sconfinato universo musicale. Di qui una musica in cui tutti questi input sono ben amalgamati e condotti ad unità grazie ad una buona verve compositiva e ad una eccellente tecnica esecutiva che si palesa soprattutto nei due brani per chitarra-solo “Passion d’Amour” ed “Echi d’Infanzia”. Nell’album Lazazzara è, in effetti, coadiuvato da Antonio Solazzo al basso e in un brano, “Relax”, da Emanuele Maggiore al flicorno. In cartellone quattordici pezzi scritti dallo stesso chitarrista con l’eccezione di “Douce Ambiance” di Django Reinhardt, “Joseph Joseph” di Kahn, Chaplin, Nellie e “Bistrot Fada” di Stephane Wrembel. Alla fine di un duplice attento ascolto dell’album, si può ben dire che la figura di Lazazzara quale compositore ed esecutore si colloca su livelli più che buoni. Le composizioni appaiono tutte ben scritte, equilibrate, caratterizzate da una sapiente ricerca armonica e si fanno ammirare anche per il notevole bilanciamento tra parti scritte ed improvvisate. L’esecuzione, poi, è raffinata, elegante ad evidenziare un chitarrista sensibile, ispirato, dalla tecnica ineccepibile per quanto misurata e lontana dalla volontà di stupire l’ascoltatore cosicché ogni nota ha il suo preciso perché.
Chiarezza esemplare nel titolo dell’album: siano nel campo di un certo ben preciso tipo di jazz che il chitarrista e compositore Pietro Lazazzara frequenta con disinvoltura. Ma sarebbe un errore confinare l’album nell’ambito del “Gipsy Jazz”: in effetti, restando questo la fonte principale da cui trae ispirazione, il percorso di Pietro è più complesso e completo. Eccolo quindi studente di chitarra classico, appassionato conoscitore del flamenco, laureato in musica jazz e infaticabile appassionato ricercatore nell’ambito di uno sconfinato universo musicale. Di qui una musica in cui tutti questi input sono ben amalgamati e condotti ad unità grazie ad una buona verve compositiva e ad una eccellente tecnica esecutiva che si palesa soprattutto nei due brani per chitarra-solo “Passion d’Amour” ed “Echi d’Infanzia”. Nell’album Lazazzara è, in effetti, coadiuvato da Antonio Solazzo al basso e in un brano, “Relax”, da Emanuele Maggiore al flicorno. In cartellone quattordici pezzi scritti dallo stesso chitarrista con l’eccezione di “Douce Ambiance” di Django Reinhardt, “Joseph Joseph” di Kahn, Chaplin, Nellie e “Bistrot Fada” di Stephane Wrembel. Alla fine di un duplice attento ascolto dell’album, si può ben dire che la figura di Lazazzara quale compositore ed esecutore si colloca su livelli più che buoni. Le composizioni appaiono tutte ben scritte, equilibrate, caratterizzate da una sapiente ricerca armonica e si fanno ammirare anche per il notevole bilanciamento tra parti scritte ed improvvisate. L’esecuzione, poi, è raffinata, elegante ad evidenziare un chitarrista sensibile, ispirato, dalla tecnica ineccepibile per quanto misurata e lontana dalla volontà di stupire l’ascoltatore cosicché ogni nota ha il suo preciso perché. Peggy Lee (Jamestown, 26 maggio 1920 – Bel Air, 21 gennaio 2002) è stata artista di squisita sensibilità che ha incantato le platee di tutto il mondo. Dotata di una voce non potentissima ma di grande fascino, suggestiva, capace di portare l’ascoltatore in una dimensione “altra”, Peggy ottenne grande popolarità durante l’era dello swing quando lavorò e incise con grandi orchestre dirette, tra gli altri, da Benny Goodman, Nelson Riddle, Billy May. Questo album contiene l’edizione integrale dell’lp “All Aglow Again”; si tratta di una compilation realizzata nel 1960 con in repertorio dodici brani tratti dalle varie registrazioni effettuate sino a quel momento ivi comprese alcune hit come la celebre “Fever” canzone di Eddie Cooley e Otis Blackwell (usando lo pseudonimo di John Davenport) del 1956; incisa per la prima volta da Little Willie John nello stesso anno, diventò di grande successo grazie alla cover di Peggy Lee del 1958 che raggiunse la quinta posizione nel Regno Unito e l’ottava negli Stati Uniti ed in Olanda, vincendo il Grammy Hall of Fame Award 1998. In aggiunta al già citato “All Anglow Again!” il cd in oggetto presenta altri 17 brani scelti tra i maggiori hit della cantante come “Black Coffee”, “Sugar”, “Ain’t We Got Fun” e “La La Lu”. In buona sostanza per chi come il sottoscritto conosce già da qualche decennio l’arte di Peggy Lee nessuna sorpresa ma il piacere di ascoltare alcune delle sue più convincenti interpretazioni; per i più giovani un’occasione da cogliere per fare la conoscenza di una delle migliori cantanti jazz.
Peggy Lee (Jamestown, 26 maggio 1920 – Bel Air, 21 gennaio 2002) è stata artista di squisita sensibilità che ha incantato le platee di tutto il mondo. Dotata di una voce non potentissima ma di grande fascino, suggestiva, capace di portare l’ascoltatore in una dimensione “altra”, Peggy ottenne grande popolarità durante l’era dello swing quando lavorò e incise con grandi orchestre dirette, tra gli altri, da Benny Goodman, Nelson Riddle, Billy May. Questo album contiene l’edizione integrale dell’lp “All Aglow Again”; si tratta di una compilation realizzata nel 1960 con in repertorio dodici brani tratti dalle varie registrazioni effettuate sino a quel momento ivi comprese alcune hit come la celebre “Fever” canzone di Eddie Cooley e Otis Blackwell (usando lo pseudonimo di John Davenport) del 1956; incisa per la prima volta da Little Willie John nello stesso anno, diventò di grande successo grazie alla cover di Peggy Lee del 1958 che raggiunse la quinta posizione nel Regno Unito e l’ottava negli Stati Uniti ed in Olanda, vincendo il Grammy Hall of Fame Award 1998. In aggiunta al già citato “All Anglow Again!” il cd in oggetto presenta altri 17 brani scelti tra i maggiori hit della cantante come “Black Coffee”, “Sugar”, “Ain’t We Got Fun” e “La La Lu”. In buona sostanza per chi come il sottoscritto conosce già da qualche decennio l’arte di Peggy Lee nessuna sorpresa ma il piacere di ascoltare alcune delle sue più convincenti interpretazioni; per i più giovani un’occasione da cogliere per fare la conoscenza di una delle migliori cantanti jazz. Conosco personalmente Lovano dall’oramai lontano 1982 e l’ho sempre considerato uno straordinario musicista oltre che una bella persona, cosa che mai guasta. Quest’ultimo album ci restituisce un Lovano in forma smagliante, alla testa di quel Trio Tapestry con cui lo avevamo apprezzato nell’omonimo album del 2019, quindi ancora con Marilyn Crispell al piano e Carmen Castaldi alla batteria. Registrato nel novembre del 2019, l’album è dedicato a quanti sono rimasti vittime del Covid 19. Di qui otto brani tutti scritti dallo stesso Lovano che conducono l’ascoltatore in atmosfere rarefatte disegnate dal leader ma ben supportate da pianoforte e batteria che non fanno assolutamente rimpiangere la mancanza del contrabbasso. Si ascolti quindi con quale e quanta delicatezza il pianismo di Marilyn avvolge il sax del leader, quasi a tessere un intricata trama su cui quasi si adagia la voce di Lovano, mentre la batteria di Carmen segue con grande intelligenza e intuito gli intenti del leader. Una musica, quindi, che si sostanzia nell’empatia che i tre evidenziano sin dalle primissime note a conferma di un “idem sentire” tutt’altro che banale. Esemplare al riguardo il suadente “Night Creatures” in cui la Crispell sembra quasi volersi espandere nel comune territorio pronta, però, a cedere il passo all’entrata del sassofono, il tutto porto con estrema delicatezza. Appare quasi come uno standard il successivo “West of the Moon” mentre nella title- track il trio abbandona le melodie disegnate in precedenza per avventurarsi su terreni diversi, quasi vicini ad un certo free, ma che comunque mette in luce un abilissimo e lucido Castaldi il quale non si lascia sfuggire l’occasione per evidenziare il suo, d’altronde ben noto, talento. L’album si chiude con un lungo (oltre 10 minuti) “Zen Like” scandito da campane tibetane che si stacca nettamente da tutto ciò che si è ascoltato sinora.
Conosco personalmente Lovano dall’oramai lontano 1982 e l’ho sempre considerato uno straordinario musicista oltre che una bella persona, cosa che mai guasta. Quest’ultimo album ci restituisce un Lovano in forma smagliante, alla testa di quel Trio Tapestry con cui lo avevamo apprezzato nell’omonimo album del 2019, quindi ancora con Marilyn Crispell al piano e Carmen Castaldi alla batteria. Registrato nel novembre del 2019, l’album è dedicato a quanti sono rimasti vittime del Covid 19. Di qui otto brani tutti scritti dallo stesso Lovano che conducono l’ascoltatore in atmosfere rarefatte disegnate dal leader ma ben supportate da pianoforte e batteria che non fanno assolutamente rimpiangere la mancanza del contrabbasso. Si ascolti quindi con quale e quanta delicatezza il pianismo di Marilyn avvolge il sax del leader, quasi a tessere un intricata trama su cui quasi si adagia la voce di Lovano, mentre la batteria di Carmen segue con grande intelligenza e intuito gli intenti del leader. Una musica, quindi, che si sostanzia nell’empatia che i tre evidenziano sin dalle primissime note a conferma di un “idem sentire” tutt’altro che banale. Esemplare al riguardo il suadente “Night Creatures” in cui la Crispell sembra quasi volersi espandere nel comune territorio pronta, però, a cedere il passo all’entrata del sassofono, il tutto porto con estrema delicatezza. Appare quasi come uno standard il successivo “West of the Moon” mentre nella title- track il trio abbandona le melodie disegnate in precedenza per avventurarsi su terreni diversi, quasi vicini ad un certo free, ma che comunque mette in luce un abilissimo e lucido Castaldi il quale non si lascia sfuggire l’occasione per evidenziare il suo, d’altronde ben noto, talento. L’album si chiude con un lungo (oltre 10 minuti) “Zen Like” scandito da campane tibetane che si stacca nettamente da tutto ciò che si è ascoltato sinora. Coinvolgente la musica di questo quartetto la cui leadership si potrebbe tranquillamente spartire tra il pianista Shai Maestro e il trombettista statunitense Philip Dizack, coadiuvati da una puntuale sezione ritmica composta dal batterista israeliano Ofri Nehemya e dal contrabbassista peruviano Jorge Roeder. Certo la maestria del pianista israeliano non la scopriamo certo adesso dato che Shai è già al suo sesto disco da titolare, il secondo con l’etichetta ECM, e può vantare anche quattro album di spessore incisi con l’Avishai Cohen Trio. Ma in questo album c’è forse qualcosa di più. Innanzitutto una piena maturità compositiva declinata attraverso un repertorio di undici composizioni tutte sue ad eccezione di “In a Sentimental Mood”. In secondo luogo la piena conferma di uno stile pianistico che nulla aggiunge a ciò che è strettamente necessario ad esprimere la propria individualità, il proprio essere più profondo (si ascolti al riguardo soprattutto “Compassion” e “Hank and Charlie” il commovente omaggio porto a Hank Jones e Charlie Haden, con il contrabbasso di Jorge Roeder in bella evidenza). In terzo luogo la capacità di eseguire al meglio, in modo originale, composizioni non proprie come la su citata pagina ellingtoniana, pezzo tanto affascinante quanto difficile da riprodurre visto l’inevitabile confronto con l’originale. Infine la straordinaria facilità con cui riesce a rapportarsi con i compagni di viaggio; semplicemente perfetta l’intesa con il trombettista assai evidente soprattutto in “Human” e in “They Went to War” mentre la sezione ritmica è sempre lì, presente e discreta, a puntualizzare le linee disegnate da pianoforte e tromba.
Coinvolgente la musica di questo quartetto la cui leadership si potrebbe tranquillamente spartire tra il pianista Shai Maestro e il trombettista statunitense Philip Dizack, coadiuvati da una puntuale sezione ritmica composta dal batterista israeliano Ofri Nehemya e dal contrabbassista peruviano Jorge Roeder. Certo la maestria del pianista israeliano non la scopriamo certo adesso dato che Shai è già al suo sesto disco da titolare, il secondo con l’etichetta ECM, e può vantare anche quattro album di spessore incisi con l’Avishai Cohen Trio. Ma in questo album c’è forse qualcosa di più. Innanzitutto una piena maturità compositiva declinata attraverso un repertorio di undici composizioni tutte sue ad eccezione di “In a Sentimental Mood”. In secondo luogo la piena conferma di uno stile pianistico che nulla aggiunge a ciò che è strettamente necessario ad esprimere la propria individualità, il proprio essere più profondo (si ascolti al riguardo soprattutto “Compassion” e “Hank and Charlie” il commovente omaggio porto a Hank Jones e Charlie Haden, con il contrabbasso di Jorge Roeder in bella evidenza). In terzo luogo la capacità di eseguire al meglio, in modo originale, composizioni non proprie come la su citata pagina ellingtoniana, pezzo tanto affascinante quanto difficile da riprodurre visto l’inevitabile confronto con l’originale. Infine la straordinaria facilità con cui riesce a rapportarsi con i compagni di viaggio; semplicemente perfetta l’intesa con il trombettista assai evidente soprattutto in “Human” e in “They Went to War” mentre la sezione ritmica è sempre lì, presente e discreta, a puntualizzare le linee disegnate da pianoforte e tromba. Con questo terzo album da leader, il pianista si ripresenta con la formula preferita del trio assieme al batterista palermitano Melo Miceli e al contrabbassista americano Rogers Anning. In programma 6 composizioni originali scritte dal leader e due standard, “All Things You Are” (J.Kern / O. Hammerstein II) e “Oleo” (S. Rollins). Il terreno è quello di un jazz caratterizzato da una forte carica ritmica e da spiccate individualità che emergono nel corso delle varie esecuzioni; il tutto impreziosito da una accurata ricerca sul suono che si evidenzia ancora più chiaramente quando Mastronardi si produce non solo al pianoforte ma anche al Fender Rhodes. Come si accennava notevole l’apporto solistico di tutti i membri del trio: così ecco il basso di Rogers Anning particolarmente in evidenza in “Everything I Need” mentre la batteria di Melo Miceli si fa apprezzare in “Away From The Scene”. E il leader? A parte la sapienza con cui guida il trio, si ritaglia spazi per convincenti assolo: in particolare nei due brani eseguiti in solitudine, “All The Things You Are” e “7 H-Our”, Mastronardi evidenzia una assoluta padronanza della tastiera che sa utilizzare in maniera completa evidenziando tra l’altro una ottima diteggiatura e una eccellente indipendenza tra le due mani. In particolare il brano di Kern e Hammerstein è porto in maniera originale con l’intento da un canto di preservare la bellezza del tema dall’altro di osare qualcosa di nuovo, alla costante ricerca di quell’equilibrio fra tradizione e sperimentazione che caratterizza tutto l’album ; in “7H-Our” Mastronardi, avendo a che fare con una propria composizione, si muove con sicurezza nel dichiarato intento di sperimentare le possibilità timbriche del Fender.
Con questo terzo album da leader, il pianista si ripresenta con la formula preferita del trio assieme al batterista palermitano Melo Miceli e al contrabbassista americano Rogers Anning. In programma 6 composizioni originali scritte dal leader e due standard, “All Things You Are” (J.Kern / O. Hammerstein II) e “Oleo” (S. Rollins). Il terreno è quello di un jazz caratterizzato da una forte carica ritmica e da spiccate individualità che emergono nel corso delle varie esecuzioni; il tutto impreziosito da una accurata ricerca sul suono che si evidenzia ancora più chiaramente quando Mastronardi si produce non solo al pianoforte ma anche al Fender Rhodes. Come si accennava notevole l’apporto solistico di tutti i membri del trio: così ecco il basso di Rogers Anning particolarmente in evidenza in “Everything I Need” mentre la batteria di Melo Miceli si fa apprezzare in “Away From The Scene”. E il leader? A parte la sapienza con cui guida il trio, si ritaglia spazi per convincenti assolo: in particolare nei due brani eseguiti in solitudine, “All The Things You Are” e “7 H-Our”, Mastronardi evidenzia una assoluta padronanza della tastiera che sa utilizzare in maniera completa evidenziando tra l’altro una ottima diteggiatura e una eccellente indipendenza tra le due mani. In particolare il brano di Kern e Hammerstein è porto in maniera originale con l’intento da un canto di preservare la bellezza del tema dall’altro di osare qualcosa di nuovo, alla costante ricerca di quell’equilibrio fra tradizione e sperimentazione che caratterizza tutto l’album ; in “7H-Our” Mastronardi, avendo a che fare con una propria composizione, si muove con sicurezza nel dichiarato intento di sperimentare le possibilità timbriche del Fender. Album assolutamente atipico in cui Lucio Miele, percussionista di tradizione classica, dedito alla ricerca e alla sperimentazione, si racconta attraverso sei sue composizioni, affiancato da Simona Fredella alla voce recitata in due brani e da Anacleto Vitolo al mastering. Chi conosce il musicista salernitano troverà in questo album una perfetta continuità con le sue realizzazioni in cui ha sempre cercato di condensare la molteplicità delle sue esperienze. Viceversa per chi questo album rappresenta il primo approccio con la musica di Miele, sicuramente ne resterà sorpreso, nel bene o nel male non spetta certo allo scrivente deciderlo. In ogni caso è opportuno sottolineare che Miele è artista sincero, intellettualmente onesto, che ha sempre seguito la sua strada per quanto ostica fosse la stessa. Certo, fare musica basandosi solo su percussioni ed elettronica non è impresa facile, anche quando si è perfettamente padroni degli strumenti utilizzati (si ascolti ad esempio il convincente uso dell’elettronica in “Mbombo”). Mancano i riferimenti usuali, la linea melodica, l’andamento ritmico è assolutamente frastagliato e imprevedibile, ma quando si approccia una realizzazione di questo tipo i vecchi parametri vanno messi da parte e occorre lasciarsi andare al flusso sonoro. Aprire la mente il cuore, l’anima e lasciare che la musica ci attraversi fin nel profondo alla ricerca di emozioni sopite che forse solo in questo modo saremo in grado di apprezzare. Insomma un album, come si accennava, di non facile ascolto ma che vale la pena fruire ma, ripetiamo, con disponibilità e attenzione…altrimenti è meglio lasciar perdere.
Album assolutamente atipico in cui Lucio Miele, percussionista di tradizione classica, dedito alla ricerca e alla sperimentazione, si racconta attraverso sei sue composizioni, affiancato da Simona Fredella alla voce recitata in due brani e da Anacleto Vitolo al mastering. Chi conosce il musicista salernitano troverà in questo album una perfetta continuità con le sue realizzazioni in cui ha sempre cercato di condensare la molteplicità delle sue esperienze. Viceversa per chi questo album rappresenta il primo approccio con la musica di Miele, sicuramente ne resterà sorpreso, nel bene o nel male non spetta certo allo scrivente deciderlo. In ogni caso è opportuno sottolineare che Miele è artista sincero, intellettualmente onesto, che ha sempre seguito la sua strada per quanto ostica fosse la stessa. Certo, fare musica basandosi solo su percussioni ed elettronica non è impresa facile, anche quando si è perfettamente padroni degli strumenti utilizzati (si ascolti ad esempio il convincente uso dell’elettronica in “Mbombo”). Mancano i riferimenti usuali, la linea melodica, l’andamento ritmico è assolutamente frastagliato e imprevedibile, ma quando si approccia una realizzazione di questo tipo i vecchi parametri vanno messi da parte e occorre lasciarsi andare al flusso sonoro. Aprire la mente il cuore, l’anima e lasciare che la musica ci attraversi fin nel profondo alla ricerca di emozioni sopite che forse solo in questo modo saremo in grado di apprezzare. Insomma un album, come si accennava, di non facile ascolto ma che vale la pena fruire ma, ripetiamo, con disponibilità e attenzione…altrimenti è meglio lasciar perdere. Doppio album del sassofonista (soprano) e compositore pugliese Roberto Ottaviano, affiancato in “Resonance” dal quartetto Eternal Love composto da Marco Colonna (clarinetti), Giorgio Pacorig (piano, rodhes), Giovanni Maier (contrabbasso) e Zeno De Rossi (batteria), ampliato dalla presenza di Alexander Hawkins (piano), Danilo Gallo (contrabbasso e basso acustico) e Hamid Drake (batteria), mentre nel secondo CD, “Rapsodies” solo dal quartetto Eternal Love. Una realizzazione, quindi, particolarmente impegnativa che non a caso ha vinto l’annuale referendum come miglior disco italiano del 2020. Ora, a prescindere dal valore che valutazioni del genere possono avere o non avere, resta il fatto che a mio avviso raramente una produzione discografica è stata così meritevole di tali considerazioni. In effetti Roberto Ottaviano è artista di grandissimo livello, tra i migliori che l’attuale scena jazzistica, non solo italiana, possa annoverare. La sua mente compositiva è sempre lucida, attuale, capace di cogliere i fermenti più significativi che attraversano l’universo musicale senza distinzione di genere mentre le modalità esecutive evidenziano un bagaglio tecnico molto profondo, talmente ben assorbito da non necessitare di alcuna palese esposizione e che, di conseguenza, si sostanzia in uno stile asciutto, senza fronzoli, che nulla lascia all’esibizionismo. L’intento che sta alla base dell’opera è, come afferma lo stesso Ottaviano, “una sorta di omaggio alla ricerca di quella sofferta poetica che fa parte della condizione umana”. Per dare forza e concretezza a questi concetti, Roberto fa ricorso ad una musica declinata attraverso ventitré brani in larga misura da lui stesso scritti in cui non mancano i riferimenti alla musica classica contemporanea. Ma è la pratica collettiva il dato fondamentale di questo doppio CD, una pratica che consente una sorta di doppione del sax di Ottaviano con i clarinetti di Marco Colonna, che risultano essenziali per allargare a dismisura il concetto di suono. Se volessimo sintetizzare in poche parole il significato più profondo di questo “Resonance & Rapsodies” si potrebbe forse dire che nel momento in cui rievoca le esperienze del passato Ottaviano non rinuncia a guardare oltre, non rinuncia ad una ricerca che costituisce una delle cifre fondamentali del suo essere artista.
Doppio album del sassofonista (soprano) e compositore pugliese Roberto Ottaviano, affiancato in “Resonance” dal quartetto Eternal Love composto da Marco Colonna (clarinetti), Giorgio Pacorig (piano, rodhes), Giovanni Maier (contrabbasso) e Zeno De Rossi (batteria), ampliato dalla presenza di Alexander Hawkins (piano), Danilo Gallo (contrabbasso e basso acustico) e Hamid Drake (batteria), mentre nel secondo CD, “Rapsodies” solo dal quartetto Eternal Love. Una realizzazione, quindi, particolarmente impegnativa che non a caso ha vinto l’annuale referendum come miglior disco italiano del 2020. Ora, a prescindere dal valore che valutazioni del genere possono avere o non avere, resta il fatto che a mio avviso raramente una produzione discografica è stata così meritevole di tali considerazioni. In effetti Roberto Ottaviano è artista di grandissimo livello, tra i migliori che l’attuale scena jazzistica, non solo italiana, possa annoverare. La sua mente compositiva è sempre lucida, attuale, capace di cogliere i fermenti più significativi che attraversano l’universo musicale senza distinzione di genere mentre le modalità esecutive evidenziano un bagaglio tecnico molto profondo, talmente ben assorbito da non necessitare di alcuna palese esposizione e che, di conseguenza, si sostanzia in uno stile asciutto, senza fronzoli, che nulla lascia all’esibizionismo. L’intento che sta alla base dell’opera è, come afferma lo stesso Ottaviano, “una sorta di omaggio alla ricerca di quella sofferta poetica che fa parte della condizione umana”. Per dare forza e concretezza a questi concetti, Roberto fa ricorso ad una musica declinata attraverso ventitré brani in larga misura da lui stesso scritti in cui non mancano i riferimenti alla musica classica contemporanea. Ma è la pratica collettiva il dato fondamentale di questo doppio CD, una pratica che consente una sorta di doppione del sax di Ottaviano con i clarinetti di Marco Colonna, che risultano essenziali per allargare a dismisura il concetto di suono. Se volessimo sintetizzare in poche parole il significato più profondo di questo “Resonance & Rapsodies” si potrebbe forse dire che nel momento in cui rievoca le esperienze del passato Ottaviano non rinuncia a guardare oltre, non rinuncia ad una ricerca che costituisce una delle cifre fondamentali del suo essere artista. 90 anni e non sentirli…o meglio che bel sentire ci procura questo nuovo album del trombonista Dino Piana. Conosco oramai da molti anni la premiata ditta composta da Dino e Franco Piana e ne ho sempre ricavato una bella impressione e non solo dal punto di vista squisitamente musicale, visata la gentilezza, la signorilità con cui i due amano rapportarsi con noi critici e giornalisti. Ma è il versante artistico su cui tocca concentrarsi in questa sede e allora dico, immediatamente, che l’album si colloca su quegli alti livelli cui Dino e Franco Piana ci hanno abituati oramai da decenni. Con in più un elemento di notevole importanza: il CD è stato fortemente voluto da Enrico Rava (storico amico di Dino Piana) e da Franco Piana per festeggiare i 90 anni (a luglio 91) del trombonista piemontese. Di qui la strutturazione di un organico d’eccellenza in cui accanto ai senatori Rava al flicorno e Dino Piana al trombone figurano Franco Piana al flicorno, Julian Oliver Mazzariello al piano, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Roberto Gatto alla batteria. Di qui la scelta di un repertorio oggi non di moda: nove standard celeberrimi – “Bernie’s Tune”, “Dear Old Stockholm”, “Everythings Happens To Me”, “I’ll Close My Eyes”, “Line For Lions”, “Rhythm A Ning”, “Polka Dotz and Moonbeams”, “When Light Are Low”, “When Will The Blues Leave” – che tutti, più o meno, si richiamano a quell’hard bop da cui in buona sostanza è poi derivato tutto il jazz moderno. Il gruppo si esprime con bella compattezza impreziosito dal fitto dialogo tra i fiati e dagli assolo di Dino che non si risparmia anzi fa sentire ben nitida la voce del suo strumento in ogni brano. Gli standard fluiscono genuinamente ‘freschi’ come se il tempo non fosse trascorso e l’ascolto è sempre gradevole anche se occorre attenzione per catturare le mille sottigliezze dell’esecuzione. Una precisazione: lo strano titolo deriva dal fatto che durante il primissimo incontro tra Rava e Piana, quest’ultimo associò al blues in fa il giro armonico del boogie-woogie per l’appunto “Al gir dal bughi”.
90 anni e non sentirli…o meglio che bel sentire ci procura questo nuovo album del trombonista Dino Piana. Conosco oramai da molti anni la premiata ditta composta da Dino e Franco Piana e ne ho sempre ricavato una bella impressione e non solo dal punto di vista squisitamente musicale, visata la gentilezza, la signorilità con cui i due amano rapportarsi con noi critici e giornalisti. Ma è il versante artistico su cui tocca concentrarsi in questa sede e allora dico, immediatamente, che l’album si colloca su quegli alti livelli cui Dino e Franco Piana ci hanno abituati oramai da decenni. Con in più un elemento di notevole importanza: il CD è stato fortemente voluto da Enrico Rava (storico amico di Dino Piana) e da Franco Piana per festeggiare i 90 anni (a luglio 91) del trombonista piemontese. Di qui la strutturazione di un organico d’eccellenza in cui accanto ai senatori Rava al flicorno e Dino Piana al trombone figurano Franco Piana al flicorno, Julian Oliver Mazzariello al piano, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Roberto Gatto alla batteria. Di qui la scelta di un repertorio oggi non di moda: nove standard celeberrimi – “Bernie’s Tune”, “Dear Old Stockholm”, “Everythings Happens To Me”, “I’ll Close My Eyes”, “Line For Lions”, “Rhythm A Ning”, “Polka Dotz and Moonbeams”, “When Light Are Low”, “When Will The Blues Leave” – che tutti, più o meno, si richiamano a quell’hard bop da cui in buona sostanza è poi derivato tutto il jazz moderno. Il gruppo si esprime con bella compattezza impreziosito dal fitto dialogo tra i fiati e dagli assolo di Dino che non si risparmia anzi fa sentire ben nitida la voce del suo strumento in ogni brano. Gli standard fluiscono genuinamente ‘freschi’ come se il tempo non fosse trascorso e l’ascolto è sempre gradevole anche se occorre attenzione per catturare le mille sottigliezze dell’esecuzione. Una precisazione: lo strano titolo deriva dal fatto che durante il primissimo incontro tra Rava e Piana, quest’ultimo associò al blues in fa il giro armonico del boogie-woogie per l’appunto “Al gir dal bughi”. Straordinario viaggio nel mondo del trombone. A fungere da gran cerimoniere è Marcello Rosa, uno dei personaggi più rilevanti dell’universo jazzistico nazionale. Conosco Marcello personalmente oramai da tanti anni e so perfettamente quanto ami la sua musica e quanta passione metta in ogni cosa che fa. Ovviamente a quest’aurea regola non sfugge “The World On A Slide” una raccolta di ben sedici brani –molti originali, altri scelti tra le più belle melodie del repertorio jazzistico del XX secolo – ma tutti suonati e arrangiati da Rosa nel corso della sua vita. Ebbene per questa sua ultima fatica discografica, Marcello ha voluto coronare un bel sogno: incidere un disco di soli e tanti tromboni. Ha così chiamato accanto a sé alcuni specialisti non solo del jazz ma anche della musica colta. Ed eccoli tutti i nomi dei temerari che hanno partecipato all’impresa: dalla musica colta Andrea Conti I trombone dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Luigino Leonardi trombonista presso la Banda musicale dell’Aeronautica Militare, Gianfranco Marchesi trombone basso dell’Orchestra sinfonica nazionale della RAI e il Quartetto italiano di tromboni, formato da Devid Ceste secondo trombone dell’Orchestra sinfonica nazionale della RAI, Matteo De Luca I trombone dell’orchestra della Suisse Romande di Ginevra, Diego Di Mario I trombone presso l’Orchestra sinfonica nazionale della RAI e Vincent Lepape I trombone dell’Orchestra del Teatro Regio di Torino. Dal mondo del jazz sono arrivati i già ‘collaudati’ Andrea Andreoli, Mario Corvini, Massimo Morganti e Roberto Rossi; accanto a loro i giovanissimi e brillanti Stefano Coccia, Elisabetta Mattei, Federico Proietti e il G.E.F.F. Trombone Quartet, composto da Giovanni Dominicis, Francesco Piersanti, Eugenio Renzetti e Gabriele Sapora. In taluni pezzi c’è pura una sezione ritmica composta da Paolo Tombolesi al pianoforte, Luca Berardi e Roy Panebianco alla chitarra, Marco Siniscalco al contrabbasso e basso elettrico, Cristiano Micalizzi alla batteria e Filippo La Porta alle percussioni. Il risultato è semplicemente entusiasmante: come si diceva una volta ‘dove peschi peschi bene’ ed in effetti tutte le esecuzioni contengono una carica tale da mai lasciarti indifferente. Qualche titolo? “Autumn Leaves” con Massimo Morganti in veste di solista, la suadente “Southern Ballad” che ad onta delle difficoltà di realizzazione narrate da Rosa è venuta molto bene con Roberto Rossi solista, il sempre toccante “What Are You Doing the Rest of Your Life” affidato al Quartetto Italiano di Tromboni con Gianfranco Marchesi. Da segnalare infine che come bonus track figurano “Miss Magnolia Lee” del giugno 1974 con Enrico Pieranunzi piano, Alessio Urso basso e Gegè Munari batteria e “Il ladro di noccioline” del 1980 con Daniele Cestana piano, Nanni Civitenga chitarra e chitarra basso e Enzo Restuccia batteria.
Straordinario viaggio nel mondo del trombone. A fungere da gran cerimoniere è Marcello Rosa, uno dei personaggi più rilevanti dell’universo jazzistico nazionale. Conosco Marcello personalmente oramai da tanti anni e so perfettamente quanto ami la sua musica e quanta passione metta in ogni cosa che fa. Ovviamente a quest’aurea regola non sfugge “The World On A Slide” una raccolta di ben sedici brani –molti originali, altri scelti tra le più belle melodie del repertorio jazzistico del XX secolo – ma tutti suonati e arrangiati da Rosa nel corso della sua vita. Ebbene per questa sua ultima fatica discografica, Marcello ha voluto coronare un bel sogno: incidere un disco di soli e tanti tromboni. Ha così chiamato accanto a sé alcuni specialisti non solo del jazz ma anche della musica colta. Ed eccoli tutti i nomi dei temerari che hanno partecipato all’impresa: dalla musica colta Andrea Conti I trombone dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Luigino Leonardi trombonista presso la Banda musicale dell’Aeronautica Militare, Gianfranco Marchesi trombone basso dell’Orchestra sinfonica nazionale della RAI e il Quartetto italiano di tromboni, formato da Devid Ceste secondo trombone dell’Orchestra sinfonica nazionale della RAI, Matteo De Luca I trombone dell’orchestra della Suisse Romande di Ginevra, Diego Di Mario I trombone presso l’Orchestra sinfonica nazionale della RAI e Vincent Lepape I trombone dell’Orchestra del Teatro Regio di Torino. Dal mondo del jazz sono arrivati i già ‘collaudati’ Andrea Andreoli, Mario Corvini, Massimo Morganti e Roberto Rossi; accanto a loro i giovanissimi e brillanti Stefano Coccia, Elisabetta Mattei, Federico Proietti e il G.E.F.F. Trombone Quartet, composto da Giovanni Dominicis, Francesco Piersanti, Eugenio Renzetti e Gabriele Sapora. In taluni pezzi c’è pura una sezione ritmica composta da Paolo Tombolesi al pianoforte, Luca Berardi e Roy Panebianco alla chitarra, Marco Siniscalco al contrabbasso e basso elettrico, Cristiano Micalizzi alla batteria e Filippo La Porta alle percussioni. Il risultato è semplicemente entusiasmante: come si diceva una volta ‘dove peschi peschi bene’ ed in effetti tutte le esecuzioni contengono una carica tale da mai lasciarti indifferente. Qualche titolo? “Autumn Leaves” con Massimo Morganti in veste di solista, la suadente “Southern Ballad” che ad onta delle difficoltà di realizzazione narrate da Rosa è venuta molto bene con Roberto Rossi solista, il sempre toccante “What Are You Doing the Rest of Your Life” affidato al Quartetto Italiano di Tromboni con Gianfranco Marchesi. Da segnalare infine che come bonus track figurano “Miss Magnolia Lee” del giugno 1974 con Enrico Pieranunzi piano, Alessio Urso basso e Gegè Munari batteria e “Il ladro di noccioline” del 1980 con Daniele Cestana piano, Nanni Civitenga chitarra e chitarra basso e Enzo Restuccia batteria. Il sassofonista tenore romano Bob Salmieri si è già fatto conoscere da quando, nel 2016, costituì l’Erodoto Project, i cui album sono stati recensiti su questi stessi spazi. E’ di pochi mesi fa la costituzione del ‘Bob Salmieri Bastarduna Quintet’ con Giancarlo Romani alla tromba, Vincenzo Lucarelli organo e piano, Maurizio Perrone contrabbasso e Massimiliano de Lucia alla batteria, ospite in tre brani il vibrafonista e pianista polacco Mateusz Nawrot. In piena pandemia il gruppo incide il disco “…and Mama was a belly dancer” per Cultural Bridge, declinato attraverso otto composizioni tutte del leader che anche come strumentista non si risparmia di certo per tutta la durata dell’album. Due le necessarie premesse: nell’intento di Salmieri si tratta di un concept album in quanto rivede e rivive i sogni di un uomo-bambino che costruisce i suoni, i sapori, i colori di un tempo lontano e di un mondo sognato. In secondo luogo il termine Bastarduna con cui si è voluto caratterizzare il gruppo indica una varietà pregiata di fichi d’India a voler indicare la strada ‘mediterranea’ che il gruppo intende perseguire. Ora se, more solito, almeno per me è assai difficile stabilire se la musica coincide con l’impianto concettuale che dovrebbe sostenerla, non c‘è invece dubbio alcuno sul fatto che il jazz proposto si inserisca nel solco di un’ispirazione di impronta chiaramente mediterranea, particolarmente evidente in “Madame oculus” e “Men With The Painted Faces” impreziosito da un bell’assolo di Lucarelli all’organo. Dal punto di vista della linea melodica, particolarmente apprezzabile “The Flying Devils”. Comunque è tutto l’album che si snoda attraverso un filo rosso che vede in primo piano il fitto colloquio tra i due fiati ben sostenuti dalla sezione ritmica con l’ospite polacco in grado di ben inserirsi nel discorso collettivo con assoli di pregevole fattura (lo si ascolti in “The Balinese Dancer (Reprise)”.
Il sassofonista tenore romano Bob Salmieri si è già fatto conoscere da quando, nel 2016, costituì l’Erodoto Project, i cui album sono stati recensiti su questi stessi spazi. E’ di pochi mesi fa la costituzione del ‘Bob Salmieri Bastarduna Quintet’ con Giancarlo Romani alla tromba, Vincenzo Lucarelli organo e piano, Maurizio Perrone contrabbasso e Massimiliano de Lucia alla batteria, ospite in tre brani il vibrafonista e pianista polacco Mateusz Nawrot. In piena pandemia il gruppo incide il disco “…and Mama was a belly dancer” per Cultural Bridge, declinato attraverso otto composizioni tutte del leader che anche come strumentista non si risparmia di certo per tutta la durata dell’album. Due le necessarie premesse: nell’intento di Salmieri si tratta di un concept album in quanto rivede e rivive i sogni di un uomo-bambino che costruisce i suoni, i sapori, i colori di un tempo lontano e di un mondo sognato. In secondo luogo il termine Bastarduna con cui si è voluto caratterizzare il gruppo indica una varietà pregiata di fichi d’India a voler indicare la strada ‘mediterranea’ che il gruppo intende perseguire. Ora se, more solito, almeno per me è assai difficile stabilire se la musica coincide con l’impianto concettuale che dovrebbe sostenerla, non c‘è invece dubbio alcuno sul fatto che il jazz proposto si inserisca nel solco di un’ispirazione di impronta chiaramente mediterranea, particolarmente evidente in “Madame oculus” e “Men With The Painted Faces” impreziosito da un bell’assolo di Lucarelli all’organo. Dal punto di vista della linea melodica, particolarmente apprezzabile “The Flying Devils”. Comunque è tutto l’album che si snoda attraverso un filo rosso che vede in primo piano il fitto colloquio tra i due fiati ben sostenuti dalla sezione ritmica con l’ospite polacco in grado di ben inserirsi nel discorso collettivo con assoli di pregevole fattura (lo si ascolti in “The Balinese Dancer (Reprise)”. Anche Roberto Spadoni fa parte delle mie oramai lunghe amicizie musicali ed è proprio partendo da questa base che mi sento di affermare la valenza dello stesso quale musicista assai ben preparato e che, tutto sommato, non ha ancora ottenuto i riconoscimenti che merita. Adesso, dopo lunghi anni in cui ha suonato la sua fida chitarra, diretto organici di varie dimensioni, composto, insegnato, si cimenta con qualcosa di nuovo: produrre, promuovere e diffondere la sua musica seguendola in tutta la sua lunga filiera, dalla composizione alla registrazione, dal progetto grafico alla stampa e alla diffusione. Di qui la creazione di una label che – con una venatura di ironia – sottolinea Spadoni ha chiamato ‘Sword Records’. “Mah” è per l’appunto la prima realizzazione targata ‘Sword Records’ per cui il leader-chitarrista si esibisce con Fabio Petretti (sax tenore & soprano), Paolo Ghetti (contrabbasso) e Massimo Manzi (batteria). In programma nove composizioni originali tutte scritte dal leader a conferma di quanto su accennato a proposito della poliedricità di Roberto. L’album è sicuramente apprezzabile sia per l’originalità della scrittura così ben equilibrata sia per la bravura dei singoli notevoli nella parti d’insieme così come nei vari assolo. Ecco quindi il contrabbasso di Paolo Ghetti farsi apprezzare in “Remore morali” un brano non nuovo ma sempre affascinante. In “Girotondo” è la batteria di Massimo Manzi in primo piano, impegnata in un fitto dialogo con i compagni di viaggio mentre in “Borgo antico” si apprezza Fabio Petretti impegnato a disegnare una fluida linea melodica. Dal canto suo il leader non fa mancare il suo apporto solistico in ognuno dei brani apparendo, almeno a chi scrive, particolarmente convincente in “Buonanotte”. Ottima anche la chiusura con “Ce la posso fare” un pezzo che, evidenzia ancora Spadoni, egli ha diretto molte volte e che comunque rappresenta una sorta di mantra, un augurio, “una carica di energia positiva”, impreziosito nell’occasione dagli assolo di Petretti e di Spadoni.
Anche Roberto Spadoni fa parte delle mie oramai lunghe amicizie musicali ed è proprio partendo da questa base che mi sento di affermare la valenza dello stesso quale musicista assai ben preparato e che, tutto sommato, non ha ancora ottenuto i riconoscimenti che merita. Adesso, dopo lunghi anni in cui ha suonato la sua fida chitarra, diretto organici di varie dimensioni, composto, insegnato, si cimenta con qualcosa di nuovo: produrre, promuovere e diffondere la sua musica seguendola in tutta la sua lunga filiera, dalla composizione alla registrazione, dal progetto grafico alla stampa e alla diffusione. Di qui la creazione di una label che – con una venatura di ironia – sottolinea Spadoni ha chiamato ‘Sword Records’. “Mah” è per l’appunto la prima realizzazione targata ‘Sword Records’ per cui il leader-chitarrista si esibisce con Fabio Petretti (sax tenore & soprano), Paolo Ghetti (contrabbasso) e Massimo Manzi (batteria). In programma nove composizioni originali tutte scritte dal leader a conferma di quanto su accennato a proposito della poliedricità di Roberto. L’album è sicuramente apprezzabile sia per l’originalità della scrittura così ben equilibrata sia per la bravura dei singoli notevoli nella parti d’insieme così come nei vari assolo. Ecco quindi il contrabbasso di Paolo Ghetti farsi apprezzare in “Remore morali” un brano non nuovo ma sempre affascinante. In “Girotondo” è la batteria di Massimo Manzi in primo piano, impegnata in un fitto dialogo con i compagni di viaggio mentre in “Borgo antico” si apprezza Fabio Petretti impegnato a disegnare una fluida linea melodica. Dal canto suo il leader non fa mancare il suo apporto solistico in ognuno dei brani apparendo, almeno a chi scrive, particolarmente convincente in “Buonanotte”. Ottima anche la chiusura con “Ce la posso fare” un pezzo che, evidenzia ancora Spadoni, egli ha diretto molte volte e che comunque rappresenta una sorta di mantra, un augurio, “una carica di energia positiva”, impreziosito nell’occasione dagli assolo di Petretti e di Spadoni. Vi piace la “buona” musica senza distinzione di stili, di epoca, di messaggi più o meno espliciti…insomma senza se e senza ma? Se la risposta è affermativa allora dovete ascoltare questo doppio album. Siamo nella Chiesa di Gesù, a Montreal (Canada) il 4 luglio del 1993 in occasione dell’annuale Festival del jazz. In programma per un doppio concerto pianificato alle 20 e alle 22,30 un duo d’eccezione composto da Barney Wilen al sax tenore e dal pianista martinicano Alain Jean-Marie. Già a quell’epoca i due avevano lungamente suonato assieme sin dagli anni ’80 potendo vantare una propria ben solida reputazione. In particolare Barney era considerato uno dei più prestigiosi sassofonisti francesi avendo, tra l’altro, collaborato con Miles Davis per la colonna sonora del film “Ascenseur pour l’Échafaud” nel 1957 mentre Alain a conferma di una carriera prestigiosa aveva ricevuto il “Prix Django Reinhardt” e nel 2000 il “Django d’Or”. Ora se è vero che nel mondo della musica e del jazz in particolare non sempre uno più uno fa due, questa volta si potrebbe ben dire che invece fa tre. Ascoltarli nelle loro evoluzioni è davvero un piacere tale e tanta è la fluidità del loro linguaggio. I due si intendono a meraviglia, si inseguono, si interrompono, si passano la palla senza soluzione di continuità nel rispetto di soluzioni ritmiche che guardano da vicino alla grande tradizione del bop. Non a caso Alain Jean-Marie agli inizi della carriera era stato avvicinato stilisticamente a Bud Powell. Nell’ampio programma enucleare qualche brano è davvero difficile anche se una menzione particolare la merita la splendida ballad di Gordon Jenkins, “Good Bye”, pezzo con cui Barney Wylen chiuse la sua performance a Caen il 14 marzo 1996 in quello che sarebbe stato il suo ultimo concerto. Ascoltando “Good Bye” non ci si può non lasciar prendere da una ondata di malinconia nel ricordo di un grande artista che anche nell’esecuzione presente in questo album evidenzia una classe e una musicalità senza pari. E vorrei chiudere citando le parole di Jean-Paul Sartre riportate da Pascal Anquetil nel booklet del disco: “il y a un gros homme qui s’époumone à suivre son trombone dans ses évolutions, il y a un pianiste sans merci, un contrebassiste qui gratte ses cordes sans écouter les autres. Ils s’adressent à la meilleure part de vous-même, à la plus sèche, à la plus libre, à celle qui ne veut ni mélancolie ni ritournelle, mais l’éclat étourdissant d’un instant. Ils vous réclament, ils ne vous bercent pas”.
Vi piace la “buona” musica senza distinzione di stili, di epoca, di messaggi più o meno espliciti…insomma senza se e senza ma? Se la risposta è affermativa allora dovete ascoltare questo doppio album. Siamo nella Chiesa di Gesù, a Montreal (Canada) il 4 luglio del 1993 in occasione dell’annuale Festival del jazz. In programma per un doppio concerto pianificato alle 20 e alle 22,30 un duo d’eccezione composto da Barney Wilen al sax tenore e dal pianista martinicano Alain Jean-Marie. Già a quell’epoca i due avevano lungamente suonato assieme sin dagli anni ’80 potendo vantare una propria ben solida reputazione. In particolare Barney era considerato uno dei più prestigiosi sassofonisti francesi avendo, tra l’altro, collaborato con Miles Davis per la colonna sonora del film “Ascenseur pour l’Échafaud” nel 1957 mentre Alain a conferma di una carriera prestigiosa aveva ricevuto il “Prix Django Reinhardt” e nel 2000 il “Django d’Or”. Ora se è vero che nel mondo della musica e del jazz in particolare non sempre uno più uno fa due, questa volta si potrebbe ben dire che invece fa tre. Ascoltarli nelle loro evoluzioni è davvero un piacere tale e tanta è la fluidità del loro linguaggio. I due si intendono a meraviglia, si inseguono, si interrompono, si passano la palla senza soluzione di continuità nel rispetto di soluzioni ritmiche che guardano da vicino alla grande tradizione del bop. Non a caso Alain Jean-Marie agli inizi della carriera era stato avvicinato stilisticamente a Bud Powell. Nell’ampio programma enucleare qualche brano è davvero difficile anche se una menzione particolare la merita la splendida ballad di Gordon Jenkins, “Good Bye”, pezzo con cui Barney Wylen chiuse la sua performance a Caen il 14 marzo 1996 in quello che sarebbe stato il suo ultimo concerto. Ascoltando “Good Bye” non ci si può non lasciar prendere da una ondata di malinconia nel ricordo di un grande artista che anche nell’esecuzione presente in questo album evidenzia una classe e una musicalità senza pari. E vorrei chiudere citando le parole di Jean-Paul Sartre riportate da Pascal Anquetil nel booklet del disco: “il y a un gros homme qui s’époumone à suivre son trombone dans ses évolutions, il y a un pianiste sans merci, un contrebassiste qui gratte ses cordes sans écouter les autres. Ils s’adressent à la meilleure part de vous-même, à la plus sèche, à la plus libre, à celle qui ne veut ni mélancolie ni ritournelle, mais l’éclat étourdissant d’un instant. Ils vous réclament, ils ne vous bercent pas”. Com’è nostra consuetudine, consentiteci una tantum qualche digressione al di fuori degli ambiti prettamente jazzistici. Questa volta lo facciamo per segnalarvi questo album targato ECM New Series, dedicato al dolore vissuto da molti nel corso dei secoli senza motivo alcuno, che vede come protagonisti il chitarrista ungherese Ferenc Snetberger, il terzo pubblicato da ECM, e il Keller Quartet, anch’esso costituito da musicisti ungheresi. L’album, registrato in concerto nella Grand Hall della Liszt Academy di Budapest nel dicembre 2018, presenta un programma interamente dedicato alla musica classica. L’apertura e la chiusura sono dedicati a brani dello stesso Snétberger, inframmezzati da composizioni di Dimitri Shostakovich (il Quartetto per archi N. 8 in Do minore dedicato alle vittime della guerra e del fascismo), John Dowland ( “I Saw My Lady Weep” per chitarra e quartetto d’archi, e “Flow, My Tears” per chitarra e violoncello), Samuel Barber (lo struggente “Adagio for strings” interpretato dal solo “Keller Quartet”. Dal canto suo Ferenc Snetberger presenta alcune sue composizioni che non sfigurano al cospetto di contati autori. Così il “Concerto In Memory of My People,” in tre movimenti, composto da Snétberger nel 1994 per chitarra e orchestra, e qui riproposto in un arrangiamento per chitarra e quintetto d’archi, coglie perfettamente nel segno riuscendo a trasmettere l’ispirazione dell’autore che ricorda e dedica questa musica alla memoria dei suoi antenati gitani Roma e Sinti (cui il chitarrista appartiene) perseguitati e uccisi nei secoli. L’album si chiude con due composizioni del chitarrista, “Your Smile” per chitarra solo, unico brano in cui ci si distacca dalla sensazione di tristezza e dolore che domina tutto il CD e “Rhapsody No.1, for Guitar and Orchestra” qui però nella versione per chitarra e quintetto d’archi.
Com’è nostra consuetudine, consentiteci una tantum qualche digressione al di fuori degli ambiti prettamente jazzistici. Questa volta lo facciamo per segnalarvi questo album targato ECM New Series, dedicato al dolore vissuto da molti nel corso dei secoli senza motivo alcuno, che vede come protagonisti il chitarrista ungherese Ferenc Snetberger, il terzo pubblicato da ECM, e il Keller Quartet, anch’esso costituito da musicisti ungheresi. L’album, registrato in concerto nella Grand Hall della Liszt Academy di Budapest nel dicembre 2018, presenta un programma interamente dedicato alla musica classica. L’apertura e la chiusura sono dedicati a brani dello stesso Snétberger, inframmezzati da composizioni di Dimitri Shostakovich (il Quartetto per archi N. 8 in Do minore dedicato alle vittime della guerra e del fascismo), John Dowland ( “I Saw My Lady Weep” per chitarra e quartetto d’archi, e “Flow, My Tears” per chitarra e violoncello), Samuel Barber (lo struggente “Adagio for strings” interpretato dal solo “Keller Quartet”. Dal canto suo Ferenc Snetberger presenta alcune sue composizioni che non sfigurano al cospetto di contati autori. Così il “Concerto In Memory of My People,” in tre movimenti, composto da Snétberger nel 1994 per chitarra e orchestra, e qui riproposto in un arrangiamento per chitarra e quintetto d’archi, coglie perfettamente nel segno riuscendo a trasmettere l’ispirazione dell’autore che ricorda e dedica questa musica alla memoria dei suoi antenati gitani Roma e Sinti (cui il chitarrista appartiene) perseguitati e uccisi nei secoli. L’album si chiude con due composizioni del chitarrista, “Your Smile” per chitarra solo, unico brano in cui ci si distacca dalla sensazione di tristezza e dolore che domina tutto il CD e “Rhapsody No.1, for Guitar and Orchestra” qui però nella versione per chitarra e quintetto d’archi.



