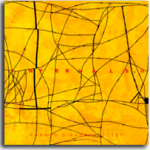da Alessandro Fadalti | 13/Ott/2022 | Guide all'ascolto, News, Primo piano
Per cosa ci piacerebbe essere ricordati dopo la nostra morte? Solo a sentire questa domanda si materializzano ambienti rumorosi di bocche che in un flusso infinito recitano un monologo adornato di fantasticherie intime ed infinite, oppure risme di fogli bianchi che vengono incisi da penne fino a finire l’inchiostro, sfogliandoli freneticamente fino a creare una sorta di testamento immaginario da dedicare al mondo; o magari nessuna risposta, una pausa a cui non seguirà alcuna nota: il vuoto. Pensare all’oltre mondo è umanamente comune, l’abbiamo fatto tutti e immaginare quale memoria lasceremo di noi è un tema caldo. Una volta che si spengono le luci del nostro palco gli spettatori si alzano, cominciano a mettersi in fila i tuoi dolci affetti, conoscenti, colleghi, amici e parenti che non vedono l’ora di scrivere un epitaffio d’amore da dedicarti. L’unico dispiacere è che qualunque discorso propinato finisce in una damigiana da cui tracannano i provetti poeti fino ad affogare. Tutti alzano il gomito in questo rituale di auto terapia per affrontare la morte, mentre tu, che dovresti essere il diretto destinatario di ogni poesia recitata al brindisi, non potrai mai ascoltare quello che gli altri hanno da raccontare di te stesso. Quindi ha davvero senso spedire una lettera a un morto? No, meglio scrivere per quelli che restano, perché creare memoria è più importante che rispondere agli ipotetici capricci di un defunto, difatti lui non può nemmeno ribattere e dir la sua a meno che i medium non diventino avvocati e notai degli spiriti dell’aldilà.
Questo preambolo ci pone nell’ottica di ricercare quale sia l’approccio migliore per raccontare post mortem una vita musicale così intensa di significati ed eterogenea come quella di Pharoah Sanders. Un musicista del suo calibro è un poliedro complesso, in ogni angolo si rispecchia una storia che differisce per prospettiva ma si interseca per eventi. Immaginando di voler camminare sopra questa gigantesca forma geometrica ci si renderebbe presto conto che per coglierne il centro, quindi il nucleo e la sua anima, non si può solo camminare a zonzo senza farsi domande, serve un aiuto. Un album potrebbe essere la grande guida che ci serve per non perderci.
La guida che voglio proporre è un  Lost Record del Live in Paris del 1975, pubblicato e restaurato dall’etichetta discografica Transversales Disques. Sébastien Rosat, co-fondatore dell’etichetta, mi ha spiegato in un breve scambio di mail che l’album è stato come ritrovare un tesoro; già dal primo ascolto si capiva quanto fosse una performance straordinaria. La Transversales Disques ha compiuto in primis un lavoro di restauro sul materiale ritrovato nel 2017 nel caveau di Radio France e a impreziosire l’esperienza c’è la minuzia per la ricerca di fotografie scattate per quella performance. Proprio quando le ricerche stavano per arrivare a un punto morto ci ha pensato la fortuna a fargli ritrovare una foto del concerto in “Jazz Hot” Magazine per mano della fotocamera di Christian Rose che ha fornito un rullino pieno di splendide istantanee dell’evento, arricchendo un’edizione discografica rara e unica; sicuramente realizzata con quel tipo di passione che solo gli amanti del jazz riescono a mettere in ciò che fanno nella vita. Questa storia ci catapulta in una prospettiva romantica nei confronti dell’album, ma diventa un antipasto ricco di proteine per affrontare il viaggio che propongo, ma soprattutto è funzionale a un piccolo gioco di prestigio: usare l’album del concerto come incipit, cercando di rovesciare la classica prospettiva della biografia al servizio della musica, seguendo piuttosto il flusso sonoro del live e quello degli eventi in ordine cronologico. Questo processo permette di trasformare quel poliedro di cui parlavo, attraverso la scomposizione e ricomposizione in una nuova forma, quella plasmata dalle note del sassofono di Sanders il 17 novembre del 1975 al Grand Auditorium nello studio 105 della Maison de la Radio.
Lost Record del Live in Paris del 1975, pubblicato e restaurato dall’etichetta discografica Transversales Disques. Sébastien Rosat, co-fondatore dell’etichetta, mi ha spiegato in un breve scambio di mail che l’album è stato come ritrovare un tesoro; già dal primo ascolto si capiva quanto fosse una performance straordinaria. La Transversales Disques ha compiuto in primis un lavoro di restauro sul materiale ritrovato nel 2017 nel caveau di Radio France e a impreziosire l’esperienza c’è la minuzia per la ricerca di fotografie scattate per quella performance. Proprio quando le ricerche stavano per arrivare a un punto morto ci ha pensato la fortuna a fargli ritrovare una foto del concerto in “Jazz Hot” Magazine per mano della fotocamera di Christian Rose che ha fornito un rullino pieno di splendide istantanee dell’evento, arricchendo un’edizione discografica rara e unica; sicuramente realizzata con quel tipo di passione che solo gli amanti del jazz riescono a mettere in ciò che fanno nella vita. Questa storia ci catapulta in una prospettiva romantica nei confronti dell’album, ma diventa un antipasto ricco di proteine per affrontare il viaggio che propongo, ma soprattutto è funzionale a un piccolo gioco di prestigio: usare l’album del concerto come incipit, cercando di rovesciare la classica prospettiva della biografia al servizio della musica, seguendo piuttosto il flusso sonoro del live e quello degli eventi in ordine cronologico. Questo processo permette di trasformare quel poliedro di cui parlavo, attraverso la scomposizione e ricomposizione in una nuova forma, quella plasmata dalle note del sassofono di Sanders il 17 novembre del 1975 al Grand Auditorium nello studio 105 della Maison de la Radio.
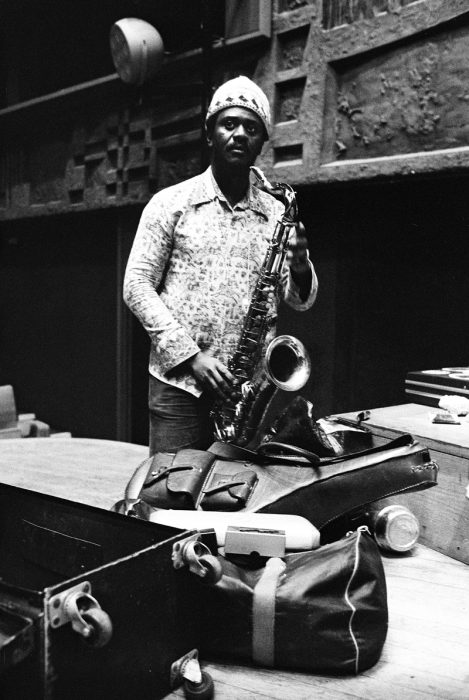 Love is Here part I/part II
Love is Here part I/part II
Il seguente brano potrebbe essere tanto un inedito quanto un arrangiamento improvvisato estremamente articolato di Love is Here To Stay, fatto sta che troverà pubblicazione per la prima volta in un album del 1978 Love Will Find a Way, accompagnato dalla splendida voce della cantante Phyllis Hyman. Il fatto che sia stato eseguito nel 1975 a Parigi, per venir poi pubblicato solo tre anni dopo, lo rende un esempio calzante del processo creativo del faraone. Sanders non è il tipico musicista con la matita pronta in mano a calcare il pentagramma, il punto di partenza è sempre quello dell’improvvisazione da cui si generano idee e motivi, dispiegandosi in una cosiddetta forma estesa (approccio tipico nell’estetica free), ma in questo caso è più corretto chiamarla Suite, come lui la concepiva: improvvisazioni molto lunghe ma divise in due parti. Andando oltre il contesto, quello che sentiamo di primo impatto è un forte senso energico da parte di tutto il gruppo a partire dal pianismo percussivo di Danny Mixon, alla batteria serrata di Greg Bandy in cui si inserisce l’ostinato basso di Calvin Hill, talmente intenso che sembra di poter sentire le dita della pelle levigarsi su quelle corde e infine il sassofono tenore di Sanders, che comincia con un lirismo e una dolcezza ingannevole nell’eseguire il tema. Un inganno perché nei primi minuti qualcuno potrebbe soltanto dire che è molto bravo, ha una tecnica solida ma non fuori dal comune al suo strumento; tuttavia, man mano che passano le battute ci si accorge presto di cos’abbia di così particolare da catturare ogni orecchio. La sensazione è che l’ancia venga strozzata e la campana d’ottone vibri ad altissima magnitudo, con un fluire rapidissimo di raggruppamenti di note in scala che assomigliano quasi a un glissando, altre volte si sofferma su ritmi irregolari arrivando fino a dei sovracuti urlanti, lo screaming come lo definivano alcuni, che però in Sanders si fonde a uno stile che è in parte erede del sassofonismo di Coltrane. A partire dall’album Soultrane (1958), il critico Ira Gelter in un articolo su Down Beat dello stesso anno, chiama Sheets of Sound questo approccio al sassofono. Viene da stupirsi pensando a come Sanders sia un musicista in grado di essere così aggressivo e dolce allo stesso tempo mentre suona, ma in questa duplicità passano in mezzo molti stati d’animo, ci si rende conto abbastanza in fretta di quanto la sua palette espressiva sia più complessa e variegata rispetto a quella manciata di note del tema all’inizio del brano. L’effetto è seducente, ci sentiamo lentamente magnetizzati, solo dopo solo, brano dopo brano mentre veniamo accompagnati dalla direzione di queste energie in gioco. La forza è talmente trascinante anche nel solo di pianoforte per fare un esempio, in cui ascoltiamo giochi di simili intenzioni gestuale tra registri e intensità esecutiva; percepiamo quindi una coesione tipica di quei musicisti che riescono a entrare nella misteriosa dimensione dell’Interplay.

Udin&Jazz 2008 – ph Luca A.d’Agostino
Farrell Tune
Se quella sera tra il pubblico ci fosse stato un ascoltatore casuale di jazz, trascinato di peso in quell’auditorium da un amico a sentire per la prima volta un concerto di Sanders, potrebbe essersi chinato di lato durante i primi applausi per sussurrare con stupore ed entusiasmo al suo vicino di posto: “Che figata oh! Ma scusa, chi è questo Sanders?”. Farrell “Pharoah” Sanders rientra tra quei jazzisti che in quegli anni hanno vissuto storie di vita simili tra esordi e scelte intraprese, curiosamente tutti sono arrivati ad incontrarsi e a collaborare nell’ambito della cosiddetta new thing: sono nati e cresciuti in ambienti di ghetto delle grandi città o negli stati periferici dell’America, hanno scoperto l’amore per il jazz o attraverso la musica della messa afroamericana o con la band delle High School, infine hanno creato una propria formazione o hanno tentato di piazzarsi a fianco di qualche nome grosso. La città natale di Sanders è Little Rock in Arkansas, uno stato dove i locali per suonare sono divisi come in una scacchiera, quelli per i bianchi e quelli per i neri, in questi ultimi era il rhythm and blues con i suoi ritmi molto ballabili e le note piacenti a far da padrone, un genere che ha fatto da palestra negli anni giovanili di molti jazzisti dell’epoca. Questa condivisione di destini simili è forse uno dei motivi per cui tutti questi musicisti free riuscivano a entrare così fortemente in connessione gli uni con gli altri; mi riferisco a persone del calibro di Archie Shepp, Albert Ayler, Ornette Coleman, Billy Higgins, Don Cherry e Cecil Taylor… Però, volendo scavare più a fondo su chi sia Farrell Sanders dovremmo allontanarci un minimo da meri dati storiografici e rivolgerci al diretto interessato. In merito è interessante quello che emerge in una delle interviste più semplici e umane che lui abbia mai fatto, quella realizzata da Nathaniel Friedman per il New Yorker nel gennaio 2020. Le risposte di Sanders non sono prolisse, arrivano dritte al punto. Quello che emerge è una persona perfezionista nel suo esperire la musica. Nel suo periodo di grande attività con la Impulse! capitava di rifare dei take, nonostante nelle registrazioni di musica a improvvisazione libera è piuttosto raro, in quanto la direzione sonora che si stava creando non gli piaceva tanto. Scherzo beffardo però vuole che poi, andando a riascoltare quei take appena interrotti, si divorava le mani quando si accorgeva -troppo tardi – di quanto fosse bello ciò che stava succedendo. Anche ad album completato la storia non cambiava, riascoltava le sue stesse opere già pubblicate e trovava continuamente passaggi e note al loro interno dove poter redarguirsi esclamando “potevo farlo meglio”. Con Impulse! Gli capitava di dover registrare anche due o tre album all’anno, però questo non frenava il suo perfezionismo, perché esso si lega anche alla ricerca di novità: si nota infatti come in ogni album di quel periodo c’è un perenne tentativo di rinnovarsi. Non passava molto tempo prima che considerasse invecchiata un’idea musicale, a tal punto che quando alla veneranda età di 79 anni parla della ricerca di un suono che lo renda soddisfatto, ammette di non averlo ancora trovato. Arriva a confessare come in realtà non sia mai esistito un singolo album dove fosse pienamente compiaciuto del suono ottenuto. In un altro aneddoto racconta un dettaglio che ci fa capire quanto fosse esasperato questo atteggiamento nei confronti della ricerca del suono: consumava scatole e scatole di ance, le provava tutte scegliendole e buttando via quelle che non suonavano giuste. Questa ricerca ossessiva del nuovo spiega come mai la sua discografia sia stilisticamente variegata, non sopporta l’idea di doversi ripetere quando suona, non vuole mantenere quell’approccio burocratico nei confronti della musica tipico di certi suoi colleghi… Il paradosso, però, è che quando ascolta la musica di questi ultimi ne rimane affascinato dalla bellezza e si chiede cosa stiano usando per suonare così bene. Ulteriore dettaglio che ci fa capire al meglio chi è e la sua musica è certamente la sua attrazione per i paesaggi sonori, sin da piccolo gli piaceva sentire il rumore delle cose e cita alcuni esempi come il cigolio delle macchine vecchie per strada, il rumore delle onde, i treni che sfrecciano sulla ferrovia, gli aeroplani che decollano. Questo atteggiamento lo ha portato sempre a cercare di trasformare i suoni brutti, che lo ammaliavano, in belli in qualche modo. Il tassello mancante a questa sintesi della sua umanità sta in un’altra intervista; quella del 1995 per la rete televisiva BBC, dove ci fa capire come lui suonerebbe qualsiasi cosa cercando di trasformarla in qualcosa di bello, spiegando come lui sia una persona che non ha scopi al di fuori di voler semplicemente esprimersi. Questo brano lo rappresenta al meglio, pensandoci, un semplice tema porta in stile Rhythm and Blues dove la sua ripetitività diventa invisibile in quanto non più un centro d’attrazione musicale grazie ai musicisti che improvvisano con grande libertà e tutto suona così fresco e nuovo ad ogni passaggio; un trucco apparentemente semplice, ma in realtà molto difficile da padroneggiare.
The Creator Has a Masterplan / I Want To Talk About You 
The Creator Has a Masterplan è quasi certamente il brano più iconico di Pharoah, in questo live possiamo sentirlo in una versione ridotta con un taglio dell’introduzione e della prima sezione dal carattere lento e contemplativo. Comincia direttamente dalla seconda sezione, la più rapida, mantenendo quello scambio tra momenti frenetici e feroci con lo stile aggressivo di Sanders. A questo segue uno dei più classici degli standard jazz come I Want To Talk About You di Billy Eckstine. Sembra strano che questi due brani possano essere messi vicini, ma restituiscono un’immagine della sua visione musicale ed estetica di vita, ci permettono di capire quanto due persone con cui ha collaborato negli anni ’60 lo abbiano segnato e influenzato nel mestiere del musicante: Sun Ra e John Coltrane. Sanders nel 1962 arriva a New York, una metà che ha lo stesso sapore italiano del classico “vai a Milano, lì c’è tutto”. Sempre nell’intervista per il New Yorker spiega come sia arrivato nella grande mela facendo l’autostop, con un portafoglio vuoto di verdoni ma pieno di verde… speranza, cimentandosi in una vita da senzatetto pur di respirare l’ossigeno dei quartieri dove si suonava il jazz più sperimentale e spinto. Inizialmente cerca di arraffare i soldi per poter mangiare in ogni modo, addirittura donando il sangue per appena diciassette dollari, ma il flusso degli eventi lo trasporta nel luogo giusto al momento giusto. Uno dei lavori più stabili che ha avuto era il cuoco e una sera al Greenwich Village viene notato da Sun Ra che lo vorrà nella sua Arkestra, questa fu l’occasione per compiere il primo balzo da sogno americano del jazzista. Suonare nel 1964 con l’Arkestra, sicuramente una formazione così folle e rivoluzionaria come il suo capo, non poteva che ispirarlo nelle sue avventure seguenti. Ci sarebbe un sacco da scrivere su come Sun Ra abbia praticamente gettato le basi per l’estetica cosmica e meditativa del jazz che verrà di lì in poi, ma tralasciando discorsi su possessioni aliene rivelatrici di verità sull’esistenza dei terrestri e del cosmo, basti sapere un dettaglio utile a questa narrazione, Sun Ra era affascinato sin da piccolo alla cultura egizia, da quando in televisione aveva assistito al ritrovamento della tomba di Tutankhamon. Proprio attraverso la cultura egizia una buona fetta degli afroamericani di quell’epoca cominciano il cosiddetto esodo di ritorno verso la Madre Africa e l’Islam. Questo ci porta a capire come mai Sun Ra rinominerà Faraone il suo amico e collega Farrell Sanders, è quindi impossibile slegare questa esperienza quando pensiamo all’immagine di Pharoah con il suo vestiario che ci fa intendere come quell’eredità dell’Arkestra sia diventata parte di lui. Il Creatore ha un piano superiore, riprendendo il concetto islamico di unicità del Tawhid e questa idea spiega come il flusso abbia guidato Pharoah fino a quel punto. Questo piano superiore però non è di certo ancora arrivato alla sua realizzazione, perché l’anno dopo la storia di Sanders si incrocia con quella di Coltrane nell’album Ascension. I due già avevano stretto amicizia quando si erano incontrati in California nel 1959. Nel ’58 Sanders si iscrive all’Oakland Junior College in California per studiare arte e musica, portando avanti la sua passione per la pittura, tuttavia non smette di suonare. Porta a termine un affarone, baratta il suo clarinetto con un sassofono d’argento che a sua volta scambierà con un vecchio modello di tenore come ha sempre voluto. In quella California, dove per suonare nessuno fa questioni sul colore della pelle, incontra John Coltrane. Il loro rapporto viene spesso condito da grandi discorsi mistici, ma sia Coltrane sia Sanders ne parlano con la semplicità di due migliori amici che raccontano l’uno dell’altro. Erano entrambi molto silenziosi, non avevano molto da dirsi, ma quando erano vicini si capivano con qualche sguardo o frase breve. Un episodio che spiega al meglio la profondità del loro rapporto sta di nuovo in quel perfezionismo a volte assillante di Sanders, chiedeva spesso durante le sessioni se il suo suono andasse bene, se le sue note erano giuste o cozzassero, ma Coltrane non rispondeva quasi mai. A furia di insistere però un giorno Coltrane esordì con un semplice “Sì va bene così, tu continua a soffiare”. Poche parole, a dimostrazione di quanto John conoscesse bene l’indole di Sanders. Nelle note di copertina dell’album Live At Village Vanguard Again, leggiamo invece un discorso più lungo – ripreso da Nat Hentoff – di Trane che recita: «Pharoah è un uomo di grandi risorse spirituali. È sempre alla ricerca della verità. Cerca di permettere al suo spirito di guidare le sue azioni. È un uomo che ha, oltre al resto, energia, onestà mentale e che va dritto all’essenza delle cose. Mi piace moltissimo la forza con cui suona. Inoltre, è uno degli innovatori e io mi considero fortunato per il fatto che si sia dimostrato disposto ad aiutarmi, a far parte del nostro gruppo». Hanno due personalità simili nella vita, ma si colmano nelle loro differenze, questo punto sfugge spesso quando si parla erroneamente di come e cosa Sanders abbia ereditato del sassofonismo di Coltrane. La verità è che le loro sonorità sono complementari ed è per questo che assieme suonavano così bene, si inseriscono in un rapporto dialettico, infatti, Sanders è tra i pochi musicisti che sono rimasti fissi nel quintetto di Trane fino alla morte nel ‘67. Tutto questo discorso ci fa capire come in fondo non c’è nulla di così mistico nel rapporto tra loro due, è vero che erano delle persone profondamente spirituali ma ciò non vuol dire che fossero dei santoni invasati di parole ispiratrici e religiose come spesso li si dipinge. Da un lato Coltrane arrivava a chiudersi in camera e disegnare linee nel circolo delle quinte o creare scale usando sequenze numeriche matematiche, mentre Sanders aveva un poderoso istinto a guidarlo quando imboccava l’ancia, tuttavia, dopo ore e ore a fare improvvisazioni libere, come racconta lo stesso Sanders, i due si concedevano di divertirsi suonando qualche standard e alcune ballad. In tal senso, a mio parere, un pezzo come I Want to Talk About You, ci rivela molto sull’influenza di Coltrane su Sanders, più di quanto non lo facciano album come Tauhid, Karma, Summun Bukmun Umyun, Jewels of Thought o andando più in là negli anni, Elevation.
Love is Everywhere

Pharoah Sanders – Udin&Jazz 2008 – ph Luca A. d’Agostino
L’ultimo brano riporta alla memoria una frase che disse un altro dei suoi amici con cui collaborò per anni, il pianista Lonnie Liston Smith, che in un’intervista con Chris Parkin racconta cosa significasse suonare con Sanders: «Sembrava che cantasse più note contemporaneamente e proprio in quel periodo stavo cercando di tirar fuori nuove potenzialità dal mio pianoforte a coda, suonando con l’avambraccio per ottenere un suono più potente. Ho chiesto a Pharoah: “Come fai ad avere questo suono?” Lui mi ha risposto; “Ma anche tu suoni come se avessi più di dieci dita!”. A lui piaceva spingersi sempre oltre il limite». Questo discorso di spingersi oltre il limite mi ha sempre ispirato e fa riflettere su quello che è il discorso che voglio portare in chiusura di quest’album. È innegabile e stupefacente come in dieci anni e una dozzina di album Pharoah Sanders sia diventato un musicista completo già a metà degli anni ’70. Quel bisogno di ricercare la verità e rinnovarsi non gli permettono di frenarsi, non è sufficiente ciò che ha già fatto e la sua spinta creatrice lo porta in più direzioni negli anni a venire. Per un periodo, sul finire degli anni ’70, torna indietro nella musica, abbandonando l’estetica spirituale, riabbracciando musiche più vicine alla tradizione blues come l’Hard Bop o riesplorando il Modal stile West Coast. Arriva nel 1994 a viaggiare in Marocco dove conoscerà la musica Gnawa e registrerà The Trance of Seven Colors con Mahmoud Guinia. Sanders cambia spesso etichetta nel corso della sua carriera, incidendo per dieci etichette diverse, suonando con ogni musicista di ogni estrazione in virtù di quel processo di trasformazione di cui abbiamo parlato. Non si può non restare affascinati da una spinta propulsiva alla creazione come la sua, talmente potente che nel 2021 ritorna in studio dopo lungo tempo registrando Promises, un album con il producer britannico Floating Points e la London Shymphony Orchestra. Il suo sassofono ha ormai raggiunto gli ottant’anni suonati, ascoltandolo riconosciamo subito il suo stile; eppure, ci appare un’altra volta come qualcosa di nuovo mentre veniamo trasportati nel suo mondo con quei nove movimenti attorno allo stesso motivo, racchiudendo forse il migliore album del jazz del ventunesimo secolo. Mi piace pensare che alla fine della sua vita sia riuscito a trovare almeno in quell’album quella sonorità perfetta, senza macchie, quella che con certezza può affermare che gli piace, senza rimuginarci sopra, quella che, in sintesi, ha sempre voluto trovare, ma quanta ironia se pensiamo come un anno prima in quella intervista con Friedman dice di non aver ancora trovato! Questo “ancora” è carico di significato ora che ci ripenso. Il suo voler superare certi limiti e andare oltre è d’obbligo per compiere un viaggio musicale come il suo, si potrebbe pensare che questi continui cambiamenti, che di lustro in lustro ha fatto, derivino da una forza di spirito, ma questa voglia di superare i limiti da sola non basta a spiegare la sua anima. Orientarci alla ricerca di essa facendo una lista di questi cambiamenti nella sua vita ci porta verso l’infinito, fino a diventare un oceano dove, da qualunque parte indichi la bussola, navigheremmo senza ritrovare più la terra ferma. Bisogna prendere fiato, fare il punto e trarre una conclusione prima di disorientarsi. Love is Everywhere mi ha permesso proprio di fare questo: gettare l’ancora in una destinazione precisa. Questo pezzo ha all’interno un chant (caratteristica che manterrà in molti suoi brani, specie dalla collaborazione con il cantante Leon Thomas in poi) e invita il pubblico a recitare con lui questo canto, come in una messa. Questo rituale ci permette di trascendere dal sentiero che abbiamo percorso ascoltando l’album. Vediamo finalmente il poliedro nella sua nuova forma e abbiamo scavato abbastanza da trovarne il nucleo? Forse sì! L’anima che guida questa voglia di sfondare muri e superarsi sta in un dettaglio solo apparentemente trascurabile, rileggendo la sua discografia e soffermandoci sui titoli di alcuni brani possiamo notarlo abbastanza in fretta. Love is Here, Love is Everywhere, o brani con titoli omonimi all’album come Love in Us All (1974), Love will find a way (1977), Welcome to Love (1991), Crescent with Love (1994)… in cui l’amore viene suonato come qualcosa di energico e movimentato dandoci una visione allegra e positiva del sentimento o, al massimo, dove manca l’elemento del ritmo incalzante c’è quello contemplativo; in netto contrasto con il dolore e il lamento perpetuo che troviamo nel resto del mondo jazz, catapultandoci in una dimensione più drammatica, melensa, nostalgica, enigmatica e ignota: What is this thing called love, You don’t know what love is, In a Sentimental Mood, There will never be another you e tanti altri. La domanda iniziale dell’articolo trova risposta, ecco che il nucleo si disvela davanti ai nostri occhi: ciò che Sanders ci ha lasciato è amore, che si esprime da noi stessi verso tutte le cose che ci circondano e da esse fa ritorno a noi. Oserei dire che avendo superato certi limiti sia addirittura un amore ancora più supremo di quello che Coltrane cantava nel 1960 in A Love Supreme. Quanto meno, questa è la forma dello spirito che ho visto io esplorando il mondo di Farrell Pharoah Sanders.
Alessandro Fadalti
da Gerlando Gatto | 02/Ago/2022 | Eventi, News, Primo piano
Dopo un periodo di relativa stasi per motivi facilmente individuabili, Roma è tornata ad essere attrattiva per gli passionati di jazz. Così da un canto l’Auditorium (con pochi ma eccellenti appuntamenti) dall’altro la Casa del Jazz con la sua consueta rassegna estiva, stanno fornendo ai cultori del jazz parecchi appuntamenti degni di rilievo, su alcuni dei quali mi soffermerò qui di seguito.
Il 10 luglio, alla Cavea dell’Auditorium, appuntamento con Gregory Porter. Sono oramai parecchi anni che conosco ad apprezzo questo vocalist e ancora una volta la sua performance ha corrisposto in pieno alle mie aspettative. La sua musicalità, il feeling che riesce a trasmettere agli ascoltatori, il suo senso del ritmo, il modo in cui riesce ad interpretare qualsiasi testo sono davvero straordinari. E non è certo un caso che la sua carriera artistica sia costellata da grandi successi e riconoscimenti tra cui due Grammy Awards per Miglior Album Vocale.

Per celebrare un decennio di successi, Gregory Porter ha pubblicato “Still Rising”, un doppio album contenente 34 tracce tra brani inediti, covers, duetti e una selezione speciale delle sue canzoni più amate. Ed è proprio sul repertorio di quest’ultimo doppio album che si è incentrata la performance romana. Ben coadiuvato da Hip Crawford al piano, Tivon Pennicott al sax tenore, Emanuel Harrold alla batteria, Jahmal Nichols al basso elettrico e Ondrej Pivec all’organo (gli stessi che l’hanno accompagnato nella già citata ultima fatica discografica) Porter ha dato ancora una volta un saggio di bravura proponendo una musica in cui era facile scorgere echi di soul, di gospel, di blues, financo di pop, mescolati in un unicum tanto originale quanto suggestivo. Ed è stato a tratti entusiasmante sentirlo duettare con alcuni dei suoi compagni di viaggio in un concerto tutto sommato breve ma di grande intensità.
Ascoltando Porter viene naturale un parallelo con i nostri giovani rampanti: beh, penso che ai vari San Giovanni, Albe, LDA, Ultimo e via discorrendo non farebbe male ascoltare qualche disco di chi sa cantare veramente bene. Ma questo è un tema che mi sollecita oramai da tempo e su cui prima o poi vorrò intervenire.
 Il 13, sempre alla Cavea, appuntamento con una vera e propria leggenda del jazz: Herbie Hancock. Spesso si adopera la parola “leggenda” in modo esagerato ma nel caso in questione non v’è dubbio alcuno che il termine sia più che appropriato. Non è questa la sede adatta per sintetizzare un curriculum assolutamente straordinario; basti solo dire che l’artista di Chicago, oggi ottantunenne, ha attraversato, sempre da protagonista, generi e mode come performer, compositore, arrangiatore, produttore, scopritore di talenti, inventore di nuove tendenze, senza mai perdere una coerenza di fondo. A Roma si è presentato alla testa di una band eccezionale completata da Terence Blanchard alla tromba, Lionel Loueke (chitarra), James Genus (basso) e Justin Tyson (batteria). Ascoltare un concerto di Hancock è come rivivere, in sintesi, buona parte della storia del jazz dal momento che questo artista ha sviluppato un’estetica giocata sempre su una sorta di doppio binario: da un canto virtuoso pianista del jazz acustico, dall’altro estimatore se non fondatore del funky elettronico. E questi due aspetti della sua personalità sono apparsi evidenti anche nel concerto romano; così in una prima parte abbiamo ascoltato alcuni classici del jazz come il sempre verde “Footprints” di Wayne Shorter, un altro giovanotto di 89 anni, omaggiato da Hancock che si alternava al piano e alle tastiere non disdegnando un ricorso mai esagerato al vocoder (ma che comunque se non ci fosse stato nulla avrebbe tolto alla validità del concerto). Nella seconda parte Hancock si richiamava al suo coté più funky e chiudeva il concerto con “Chameleon” brano tratto dal celebre album “Head Hunters” del 1973, scatenando l’entusiasmo del pubblico che si è accalcato a ballare sotto il palco.
Il 13, sempre alla Cavea, appuntamento con una vera e propria leggenda del jazz: Herbie Hancock. Spesso si adopera la parola “leggenda” in modo esagerato ma nel caso in questione non v’è dubbio alcuno che il termine sia più che appropriato. Non è questa la sede adatta per sintetizzare un curriculum assolutamente straordinario; basti solo dire che l’artista di Chicago, oggi ottantunenne, ha attraversato, sempre da protagonista, generi e mode come performer, compositore, arrangiatore, produttore, scopritore di talenti, inventore di nuove tendenze, senza mai perdere una coerenza di fondo. A Roma si è presentato alla testa di una band eccezionale completata da Terence Blanchard alla tromba, Lionel Loueke (chitarra), James Genus (basso) e Justin Tyson (batteria). Ascoltare un concerto di Hancock è come rivivere, in sintesi, buona parte della storia del jazz dal momento che questo artista ha sviluppato un’estetica giocata sempre su una sorta di doppio binario: da un canto virtuoso pianista del jazz acustico, dall’altro estimatore se non fondatore del funky elettronico. E questi due aspetti della sua personalità sono apparsi evidenti anche nel concerto romano; così in una prima parte abbiamo ascoltato alcuni classici del jazz come il sempre verde “Footprints” di Wayne Shorter, un altro giovanotto di 89 anni, omaggiato da Hancock che si alternava al piano e alle tastiere non disdegnando un ricorso mai esagerato al vocoder (ma che comunque se non ci fosse stato nulla avrebbe tolto alla validità del concerto). Nella seconda parte Hancock si richiamava al suo coté più funky e chiudeva il concerto con “Chameleon” brano tratto dal celebre album “Head Hunters” del 1973, scatenando l’entusiasmo del pubblico che si è accalcato a ballare sotto il palco.
E veniamo adesso ai concerti alla Casa del Jazz.
 Il 12 luglio una vecchia e cara conoscenza del pubblico romano: John Scofield. Il chitarrista può a ben ragione essere considerato una delle massime espressioni della chitarra jazz degli ultimi decenni. Musicista eclettico, voglioso sempre di sperimentare strade nuove, questa volta si è presentato con un progetto del tutto nuovo, “Yankee Go Home”, con cui torna alle radici del rock americano, riscoprendo classici fra il folk e il rock’n’roll. Accanto a lui Jon Cowherd (pianoforte e tastiere), Vicente Archer (contrabbasso)e Josh Dion (batteria). E’ lo stesso Scofield a illustrare il senso di questo nuovo progetto, non senza elogiare i suoi compagni di viaggio: “L’idea –afferma Scofield – è di coprire successi americani/rock e canzoni folk jazz, più alcuni dei miei brani originali scritti in quel modo. Mi sto riconnettendo con molte delle mie radici Rock ‘n Roll da adolescente, naturalmente colorate dai miei 50 anni di pratica Jazz…. Questi ragazzi sono straordinariamente versatili, altrettanto bravi quando si tratta di suonare in modo interattivo e creativo. Stiamo esplorando rock, funk, country, jazz e musica libera e ci divertiamo moltissimo. Sono entusiasta di questa collaborazione”. Risultato raggiunto? Assolutamente sì; il repertorio, comprendente brani tra gli altri di Bob Dylan, Neil Young, Grateful Dead, B.B. King, Buddy Holly, viene declinato attraverso quella maestria strumentale che ben conosciamo oramai da tanti anni. Scofield è sempre lì a tessere le fila del discorso, con un solismo preciso, elegante, raffinato mai soverchiante cosicché tutti i suoi compagni di viaggio hanno la possibilità di mettersi in luce. I vari pezzi vengono riletti alla luce di quelle esperienze cui lo stesso Scofield faceva riferimento ridando loro una sorta di nuova linfa e il pubblico dimostra di apprezzare con lunghi appalusi a scena aperta. Immancabile il bis: un coinvolgente blues che evidenzia come Scofield rimanga solidamente ancorato anche alle radici della musica afro-americana.
Il 12 luglio una vecchia e cara conoscenza del pubblico romano: John Scofield. Il chitarrista può a ben ragione essere considerato una delle massime espressioni della chitarra jazz degli ultimi decenni. Musicista eclettico, voglioso sempre di sperimentare strade nuove, questa volta si è presentato con un progetto del tutto nuovo, “Yankee Go Home”, con cui torna alle radici del rock americano, riscoprendo classici fra il folk e il rock’n’roll. Accanto a lui Jon Cowherd (pianoforte e tastiere), Vicente Archer (contrabbasso)e Josh Dion (batteria). E’ lo stesso Scofield a illustrare il senso di questo nuovo progetto, non senza elogiare i suoi compagni di viaggio: “L’idea –afferma Scofield – è di coprire successi americani/rock e canzoni folk jazz, più alcuni dei miei brani originali scritti in quel modo. Mi sto riconnettendo con molte delle mie radici Rock ‘n Roll da adolescente, naturalmente colorate dai miei 50 anni di pratica Jazz…. Questi ragazzi sono straordinariamente versatili, altrettanto bravi quando si tratta di suonare in modo interattivo e creativo. Stiamo esplorando rock, funk, country, jazz e musica libera e ci divertiamo moltissimo. Sono entusiasta di questa collaborazione”. Risultato raggiunto? Assolutamente sì; il repertorio, comprendente brani tra gli altri di Bob Dylan, Neil Young, Grateful Dead, B.B. King, Buddy Holly, viene declinato attraverso quella maestria strumentale che ben conosciamo oramai da tanti anni. Scofield è sempre lì a tessere le fila del discorso, con un solismo preciso, elegante, raffinato mai soverchiante cosicché tutti i suoi compagni di viaggio hanno la possibilità di mettersi in luce. I vari pezzi vengono riletti alla luce di quelle esperienze cui lo stesso Scofield faceva riferimento ridando loro una sorta di nuova linfa e il pubblico dimostra di apprezzare con lunghi appalusi a scena aperta. Immancabile il bis: un coinvolgente blues che evidenzia come Scofield rimanga solidamente ancorato anche alle radici della musica afro-americana.
Il 21 uno dei concerti inseriti nell’ambito della rassegna, tutta dedicata alle nuove tendenze e, dunque, alle più interessanti proposte di jazz contemporaneo. Un mondo affascinante, in cui si incontrano jazz, soul, funk, hip-hop, elettronica e spoken word.
In particolare giovedì 21 di scena il batterista Makaya McCraven produttore e batterista emergente, definito da Down Beat come uno dei più influenti musicisti del prossimo decennio.
In effetti Makaya McCraven, figlio di Stephen McCraven, batterista di Archie Shepp tra gli altri, è tutto questo e molto di più: americano di Parigi classe ‘83, iniziato alla musica jazz dal padre, cresciuto tra gli altri con la formazione derivante dal già citato Shepp, inizia a collaborare con artisti del calibro di Kris Delmhorst e gli Apollo Sunshine, prima di stabilire un suo complesso con il bassista Junius Paul, il chitarrista Matt Gold e il trombettista già attivo autonomamente Marquis Hill, formazione con cui si è presentato alla Casa del Jazz, per un concerto che ha soddisfatto appieno le più rosee aspettative.
 La band inizia a suonare senza presentare alcunché; McCraven è uomo di poche parole, e non si concede quasi mai pause, tranne una ogni tre pezzi circa per presentare e ringraziare la sua band e per annunciare – qualche volta – il nome del prossimo pezzo. Per il resto è stata una serata di pura musica ed energia: non solo di McCraven, il cui vigore era pari alla sua abilità – mai sentito un batterista che suonasse per circa un’ora e mezza, senza mai smettere di percuotere pelli e piatti con tanta ininterrotta energia – ma anche di tutti gli altri musicisti, che durante il concerto si cimentavano con diversi tipi di percussioni. Altra nota di merito va alla varietà di brani suonati: si passa da pezzi ormai diventati standard del jazz, come “Autumn in New York”, Frank’s Tune” di Frank Strzier o “A Slice of the Top” a pezzi originali di McCraven, come “In These Times”, “The Bounce!” e un inedito tratto dal suo prossimo album in uscita a settembre.
La band inizia a suonare senza presentare alcunché; McCraven è uomo di poche parole, e non si concede quasi mai pause, tranne una ogni tre pezzi circa per presentare e ringraziare la sua band e per annunciare – qualche volta – il nome del prossimo pezzo. Per il resto è stata una serata di pura musica ed energia: non solo di McCraven, il cui vigore era pari alla sua abilità – mai sentito un batterista che suonasse per circa un’ora e mezza, senza mai smettere di percuotere pelli e piatti con tanta ininterrotta energia – ma anche di tutti gli altri musicisti, che durante il concerto si cimentavano con diversi tipi di percussioni. Altra nota di merito va alla varietà di brani suonati: si passa da pezzi ormai diventati standard del jazz, come “Autumn in New York”, Frank’s Tune” di Frank Strzier o “A Slice of the Top” a pezzi originali di McCraven, come “In These Times”, “The Bounce!” e un inedito tratto dal suo prossimo album in uscita a settembre.
Riguardo alla performance dell’”archeologo del beat”, (come si definisce lo stesso batterista), essa nel suo complesso si basava su due punti di forza: la leadership di McCraven, che con grande forza e precisione trascinava sia i suoi musicisti sia il pubblico durante le esibizioni, nonché l’approccio inedito da DJ dello stesso McCraven specie nelle sue composizioni: infatti in gran parte dei brani veniva ripetuto un leitmotif al basso, che diventava il vero centro motore della situazione, attorno a cui venivano aggiunte gradualmente la batteria, la chitarra, la tromba e varie percussioni; in seguito si passava ad una graduale elaborazione dei motiv aggiunti alla linea di basso che, rimanendo sempre costante, forniva all’ascoltatore un filo rosso che legava le varie elaborazioni e improvvisazioni e un senso di familiarità all’interno della composizione. Quest’operazione coniuga a mio parere il processo creativo di numerose canzoni house, dance ed EDM con l’improvvisazione tipica del jazz: inoltre l’enfasi posta sulle percussioni nel concerto è caratteristica anche dei beat dei brani hip hop, dove il ritmo della base è cruciale per orientare il rapper durante il brano in questione.
 Il 23 la Casa de Jazz proponeva un quesito intrigante: può la sofisticata poetica di un Pieranunzi coniugarsi con l’incredibile carica energetica di Antonello Salis? In altri termini possono coesistere due musicisti stilisticamente quasi all’opposto, uniti solo dalla grande passione e dedizione alla musica? Ciò perché il concerto in programma prevedeva per l’appunto un duo di piano composto da questi due artisti che mai avevano avuto modo di incontrarsi sul palco. Grande attesa, quindi, e non a caso grande affluenza di pubblico…ripagato da un concerto sicuramente interessante. Seduti l’uno di fronte all’altro i due hanno suonato per circa un’ora e mezza sciorinando un’intesa che non era facile prevedere. Spesso si partiva da un tema che veniva sviluppato, esaminato, sviscerato fin nelle sue più intime pieghe e quindi riproposto in una veste totalmente diversa che traeva nelle capacità improvvisative dei due nuova linfa vitale. E questa volta non si può dire che l’uno si sia piegato alle esigenze dell’altro in quanto ambedue hanno sviluppato appieno le proprie tematiche che finivano con l’incontrarsi su un terreno ben frequentato sia da Enrico sia da Antonello: l’improvvisazione pura o forse meglio la capacità di creare musica strada facendo. In effetti, oltre che partire da un dato tema, i due si sono spesso avventurati anche sul foglio bianco, vale a dire cominciando a suonare senza conoscere il punto di approdo, con una maestria che solo pochi posseggono.
Il 23 la Casa de Jazz proponeva un quesito intrigante: può la sofisticata poetica di un Pieranunzi coniugarsi con l’incredibile carica energetica di Antonello Salis? In altri termini possono coesistere due musicisti stilisticamente quasi all’opposto, uniti solo dalla grande passione e dedizione alla musica? Ciò perché il concerto in programma prevedeva per l’appunto un duo di piano composto da questi due artisti che mai avevano avuto modo di incontrarsi sul palco. Grande attesa, quindi, e non a caso grande affluenza di pubblico…ripagato da un concerto sicuramente interessante. Seduti l’uno di fronte all’altro i due hanno suonato per circa un’ora e mezza sciorinando un’intesa che non era facile prevedere. Spesso si partiva da un tema che veniva sviluppato, esaminato, sviscerato fin nelle sue più intime pieghe e quindi riproposto in una veste totalmente diversa che traeva nelle capacità improvvisative dei due nuova linfa vitale. E questa volta non si può dire che l’uno si sia piegato alle esigenze dell’altro in quanto ambedue hanno sviluppato appieno le proprie tematiche che finivano con l’incontrarsi su un terreno ben frequentato sia da Enrico sia da Antonello: l’improvvisazione pura o forse meglio la capacità di creare musica strada facendo. In effetti, oltre che partire da un dato tema, i due si sono spesso avventurati anche sul foglio bianco, vale a dire cominciando a suonare senza conoscere il punto di approdo, con una maestria che solo pochi posseggono.
Ed è stato lo stesso Pieranunzi a svelare come la musica eseguita sia stata tutta improvvisata. Tra i brani eseguiti, da ricordare una sempre suggestiva “Moon River” di Henry Mancini, una “Well, you needn’t” di Thelonious Monk che nulla ha perso dell’originario fascino, una memorabile versione di “Naima” di John Coltrane, nonché un sentito omaggio ad Ennio Morricone con “Il clan dei siciliani”.
E a conferma della splendida atmosfera che si respirava sul palco, Pieranunzi è apparso particolarmente in forma anche quando ha intrattenuto il pubblico con sagaci commenti sulla “strumentazione” di Antonello (tra cui una latta di tonno Callipo) e con un sentito ricordo della sua esperienza a fianco di Morricone.
Ed eccoci alla serata di lunedì 25. Mi reco alla Casa del Jazz al solito orario e noto immediatamente una sorta di novità: una fila interminabile di auto parcheggiate sul marciapiedi a indicare una straordinaria affluenza di pubblico. Cosa che verifico subito: i giardini della Casa del Jazz sono letteralmente invasi da una massa di giovani festanti in attesa dell’evento: il concerto di “Sons of Kemet”.
La band inglese è giunta a Roma preceduta da una formidabile campagna di stampa che la indicava come una delle massime espressioni del cosiddetto nu jazz; a richiamare il pubblico anche la considerazione che si trattava dell’ultima tournée del gruppo che nei prossimi mesi dovrebbe sciogliersi. Insomma tutto pronto per un grande successo di pubblico… che puntualmente è arrivato.
 Guidati dal funambolico sassofonista Shabaka Hutchings, il quartetto (completato dal basso tuba di Theon Cross e ben due batterie nelle mani di Eddie Hick e della giovanissima e bravissima Jas Keyser in sostituzione di Tom Skinner in tour con Thom Yorke) ha sciorinato una musica di grande intensità, basata sul fitto tappeto ritmico intessuto dalle due batterie su cui svolgevano i loro interventi i due fiati. In particolare il sax del leader, spesso effettato con delay o reverberi, non disegnava lunghe linee melodiche ma intonava frasi ritmiche e frammenti melodici ripetuti più volte mentre il basso tuba contribuiva in maniera determinante a completare il tessuto ritmico delle due batterie. Il tutto ‘condito’ da un volume molto, molto elevato a creare una musica che raggiungesse l’obiettivo di portare al massimo l’eccitazione dell’uditorio e di coinvolgerlo in una sorta di rito collettivo in cui i richiami all’Africa erano ben evidenti. Si tenga presente che il concerto si è sviluppato su una linea di continuità ininterrotta tranne due momenti in cui Shabaka Hutchings ha imbracciato un flauto di legno per intonare una splendida melodia di origine africana e il tubista si è espresso in solitudine. Obiettivo raggiunto? Quanto al coinvolgimento direi proprio di sì… anche se non al cento per cento. Nel senso che, ad esempio, il vostro cronista non si è sentito coinvolto dalla musica dei Sons of Kemet. Ed il perché non è difficile da spiegare: avendo avuto la fortuna di ascoltare anche dal vivo alcuni dei più grandi musicisti – per intenderci quelli che hanno scritto davvero la storia del jazz – non è facile lasciarsi impressionare da qualcuno che pur suonando bene non raggiunge quei vertici cui prima si faceva riferimento. Quanto ai messaggi che questa musica così aggressiva intende veicolare, ci viene in soccorso lo stesso Shabaka Hutchings affermando che “Black to the Future (ultimo album del gruppo) è un poema sonoro di invocazione del potere, del ricordo e della guarigione. Raffigura un movimento, quello della ridefinizione e riaffermazione di cosa significa lottare per il black power”. Ma anche sotto questo aspetto non riusciamo a vedere una grande novità dal momento che il jazz come musica di protesta non è certo cosa di oggi.
Guidati dal funambolico sassofonista Shabaka Hutchings, il quartetto (completato dal basso tuba di Theon Cross e ben due batterie nelle mani di Eddie Hick e della giovanissima e bravissima Jas Keyser in sostituzione di Tom Skinner in tour con Thom Yorke) ha sciorinato una musica di grande intensità, basata sul fitto tappeto ritmico intessuto dalle due batterie su cui svolgevano i loro interventi i due fiati. In particolare il sax del leader, spesso effettato con delay o reverberi, non disegnava lunghe linee melodiche ma intonava frasi ritmiche e frammenti melodici ripetuti più volte mentre il basso tuba contribuiva in maniera determinante a completare il tessuto ritmico delle due batterie. Il tutto ‘condito’ da un volume molto, molto elevato a creare una musica che raggiungesse l’obiettivo di portare al massimo l’eccitazione dell’uditorio e di coinvolgerlo in una sorta di rito collettivo in cui i richiami all’Africa erano ben evidenti. Si tenga presente che il concerto si è sviluppato su una linea di continuità ininterrotta tranne due momenti in cui Shabaka Hutchings ha imbracciato un flauto di legno per intonare una splendida melodia di origine africana e il tubista si è espresso in solitudine. Obiettivo raggiunto? Quanto al coinvolgimento direi proprio di sì… anche se non al cento per cento. Nel senso che, ad esempio, il vostro cronista non si è sentito coinvolto dalla musica dei Sons of Kemet. Ed il perché non è difficile da spiegare: avendo avuto la fortuna di ascoltare anche dal vivo alcuni dei più grandi musicisti – per intenderci quelli che hanno scritto davvero la storia del jazz – non è facile lasciarsi impressionare da qualcuno che pur suonando bene non raggiunge quei vertici cui prima si faceva riferimento. Quanto ai messaggi che questa musica così aggressiva intende veicolare, ci viene in soccorso lo stesso Shabaka Hutchings affermando che “Black to the Future (ultimo album del gruppo) è un poema sonoro di invocazione del potere, del ricordo e della guarigione. Raffigura un movimento, quello della ridefinizione e riaffermazione di cosa significa lottare per il black power”. Ma anche sotto questo aspetto non riusciamo a vedere una grande novità dal momento che il jazz come musica di protesta non è certo cosa di oggi.
Quindi ben vengano gruppi del genere ma se mi si dice che questa è la nuova strada che il jazz si avvia a percorrere devo confessare che il jazz dei prossimi anni non mi avrà tra i suoi massimi sostenitori. Ovviamente la cosa poco importerà ai più ma a mio avviso il ruolo di un cronista-critico non è quello di affermare sempre che tutto va bene, ma anche di esprimere qualche perplessità, sempre motivandole, è ovvio.
 Smaltita la sbornia dell’“Afrofuturism” (così viene definita la musica di Sons of Kemet da chi se ne intende), ecco il 27 sempre alla Casa del Jazz, la giovane e brava sassofonista Nubya Garcia, reduce dallo straordinario successo ottenuto dal suo primo album “Source” su etichetta Concord. Bel concerto questo con una musica sì proiettata verso il futuro ma sempre memore di ciò che il jazz ha rappresentato fino ad oggi. Anche la Garcia viene fuori dalla tumultuosa scena londinese di questi ultimi anni affermandosi passo dopo passo come una delle strumentiste più preparate e fantasiose del pur vasto panorama. In effetti Nubya frequenta il sax da tanti anni riuscendo così a raggiungere una tecnica tutt’altro che banale, una tecnica comunque sempre messa al servizio dell’espressività e di una concezione musicale fortemente inclusiva dal momento che nelle sue performances sono ben riscontrabili echi di jazz spirituale, dub, reggae, ritmi latini e suoni africani. Così il concerto si è sviluppato lungo modalità contrassegnate da notevoli assolo non solo della leader ma anche del pianista-tastierista Alastair MacSween mentre la sezione ritmica (Daniel Casimir contrabbasso e Sam Jones batteria) forniva un supporto sempre preciso, puntuale, propositivo. E a proposito di ritmo, da sottolineare la sensualità dei ritmi colombiani rinverdita dalla Nubya nella riproposizione di uno dei brani più riusciti dell’intera serata, “La Cumbia Me Está Llamando”, scritta con il trio colombiano al femminile “La Perla”.
Smaltita la sbornia dell’“Afrofuturism” (così viene definita la musica di Sons of Kemet da chi se ne intende), ecco il 27 sempre alla Casa del Jazz, la giovane e brava sassofonista Nubya Garcia, reduce dallo straordinario successo ottenuto dal suo primo album “Source” su etichetta Concord. Bel concerto questo con una musica sì proiettata verso il futuro ma sempre memore di ciò che il jazz ha rappresentato fino ad oggi. Anche la Garcia viene fuori dalla tumultuosa scena londinese di questi ultimi anni affermandosi passo dopo passo come una delle strumentiste più preparate e fantasiose del pur vasto panorama. In effetti Nubya frequenta il sax da tanti anni riuscendo così a raggiungere una tecnica tutt’altro che banale, una tecnica comunque sempre messa al servizio dell’espressività e di una concezione musicale fortemente inclusiva dal momento che nelle sue performances sono ben riscontrabili echi di jazz spirituale, dub, reggae, ritmi latini e suoni africani. Così il concerto si è sviluppato lungo modalità contrassegnate da notevoli assolo non solo della leader ma anche del pianista-tastierista Alastair MacSween mentre la sezione ritmica (Daniel Casimir contrabbasso e Sam Jones batteria) forniva un supporto sempre preciso, puntuale, propositivo. E a proposito di ritmo, da sottolineare la sensualità dei ritmi colombiani rinverdita dalla Nubya nella riproposizione di uno dei brani più riusciti dell’intera serata, “La Cumbia Me Está Llamando”, scritta con il trio colombiano al femminile “La Perla”.
Gerlando & Beny Gatto
da Gerlando Gatto | 22/Ott/2019 | I nostri CD, Primo piano, Recensioni

Leo Records
(di Luigi Onori)

L’etichetta inglese Leo Records ha da poco festeggiato il suo quarantesimo anno di esistenza: il 6 giugno 2019 al londinese Cafe OTO si sono esibiti alcuni artisti che hanno, nel tempo, collaborato con Leo Feigin: Carolyn Hume, Paul May, Phil Minton, Roger Turner, Charlie Beresford, Peter Marsh. Sono una piccola rappresentanza di quanto la Leo Records ha documentato nel tempo; saltatore in alto russo – ai tempi dell’Unione Sovietica – Leo Feigin chiese ed ottenne asilo politico in Inghilterra negli anni ’70 ed iniziò a lavorare per la BBC. Nel 1979 non trovò alcun produttore per la musica che, clandestinamente, riceveva dall’Urss e decise di fondare una propria etichetta, con lo slogan “music for inquiring mind and the passionate heart”. Da allora Feigin non ha mai smesso di dare spazio ad artisti d’avanguardia americani, europei, giapponesi…in un catalogo vastissimo; fondamentale – negli anni ’80 e ’90 – fu l’opera di diffusione da parte della Leo Records dell’avantgarde jazz sovietico, che accompagnò la fine del regime e fornì un “luogo”, non solo sonoro, per molti oppositori. Un’idea della vastità, a volte entropica e dispersiva, di orizzonti dell’etichetta inglese ce la offre una delle ultime uscite del 2019, forte di cinque album.
Perelman-Maneri-Wooley, “Strings 3”
 Il sassofonista tenore Ivo Perelman è uno degli artisti-pilastro nella produzione della Leo Records, almeno nell’ultimo decennio. A questo straordinario e prolifico improvvisatore di origine brasiliana, Feigin ha concesso di documentare gli incontri con tanti artisti, da cui sono scaturite alcune consolidate collaborazioni. Quella con il solista di viola Mat Maneri (altro “campione” dell’etichetta) è particolarmente solida, anche perché Perelman era da giovanissimo un virtuoso del violoncello, nella natìa San Paolo, ed ha molto registrato con strumenti ad arco. Ecco il senso della serie “Strings”, il cui terzo episodio vede anche il coinvolgimento del promettente trombettista Nate Wooley. I cinquantatre minuti di musica sono articolati in undici tracce semplicemente numerate, frutto della totale improvvisazione-esplorazione di registri sonori, intrecci polifonici, campi sonori nel senso più vasto e “contemporaneo” del termine.
Il sassofonista tenore Ivo Perelman è uno degli artisti-pilastro nella produzione della Leo Records, almeno nell’ultimo decennio. A questo straordinario e prolifico improvvisatore di origine brasiliana, Feigin ha concesso di documentare gli incontri con tanti artisti, da cui sono scaturite alcune consolidate collaborazioni. Quella con il solista di viola Mat Maneri (altro “campione” dell’etichetta) è particolarmente solida, anche perché Perelman era da giovanissimo un virtuoso del violoncello, nella natìa San Paolo, ed ha molto registrato con strumenti ad arco. Ecco il senso della serie “Strings”, il cui terzo episodio vede anche il coinvolgimento del promettente trombettista Nate Wooley. I cinquantatre minuti di musica sono articolati in undici tracce semplicemente numerate, frutto della totale improvvisazione-esplorazione di registri sonori, intrecci polifonici, campi sonori nel senso più vasto e “contemporaneo” del termine.
Perelman-Maneri-Wooley-Shipp, “String 4”
 La registrazione è posteriore di alcuni mesi, rispetto alla precedente, sempre ai Parkwest Studios di New York. Il trio si amplia a quartetto con l’importante presenza del pianista Matthew Shipp, uno dei ricercatori sonori più interessanti degli ultimi decenni, da qualche tempo un po’ in ombra. I suoi interventi accordali e solistici rendono meno aereo l’intreccio tenore/viola/tromba e Shipp porta, nella libera improvvisazione, un apprezzabile senso della forma e della misura; quasi cinquantacinque i minuti di musica, anche in questo caso suddivisi in nove parti numerate. Perelman è coproduttore della serie “strings” e suo è il “cover artwork” su opere di Tom Beckam. La libertà di esplorazione delle relazioni tra ance e “corde” si coniuga, così, con un attento controllo del prodotto discografico.
La registrazione è posteriore di alcuni mesi, rispetto alla precedente, sempre ai Parkwest Studios di New York. Il trio si amplia a quartetto con l’importante presenza del pianista Matthew Shipp, uno dei ricercatori sonori più interessanti degli ultimi decenni, da qualche tempo un po’ in ombra. I suoi interventi accordali e solistici rendono meno aereo l’intreccio tenore/viola/tromba e Shipp porta, nella libera improvvisazione, un apprezzabile senso della forma e della misura; quasi cinquantacinque i minuti di musica, anche in questo caso suddivisi in nove parti numerate. Perelman è coproduttore della serie “strings” e suo è il “cover artwork” su opere di Tom Beckam. La libertà di esplorazione delle relazioni tra ance e “corde” si coniuga, così, con un attento controllo del prodotto discografico.
Christof Mahnig & Die Abmahnung, “Red Carpet”
 Trombettista, leader e compositore di tutti i nove brani, Mahnig si muove su coordinate quasi antitetiche a quelle di Ivo Perelman. La storia-tradizione del jazz è per lui motivo di studio e creazione, recuperando elementi di carattere formale e linguistico senza, però, un processo mimetico né derivativo. La parte centrale del Cd è costituita dalla suite “Three Pictures” (circa quindici minuti) ed il trombettista dialoga in tutte le tracce con il chitarrista Laurent Metéau, il contrabbassista Rafael Jerje ed batterista Manuel Künzi. Il risultato è un album che unisce godibilità e innovazione, sfruttando il ristretto organico in modo magistrale. Il cd è stato prodotto con il supporto economico di istituzioni culturali svizzere (Lucerna).
Trombettista, leader e compositore di tutti i nove brani, Mahnig si muove su coordinate quasi antitetiche a quelle di Ivo Perelman. La storia-tradizione del jazz è per lui motivo di studio e creazione, recuperando elementi di carattere formale e linguistico senza, però, un processo mimetico né derivativo. La parte centrale del Cd è costituita dalla suite “Three Pictures” (circa quindici minuti) ed il trombettista dialoga in tutte le tracce con il chitarrista Laurent Metéau, il contrabbassista Rafael Jerje ed batterista Manuel Künzi. Il risultato è un album che unisce godibilità e innovazione, sfruttando il ristretto organico in modo magistrale. Il cd è stato prodotto con il supporto economico di istituzioni culturali svizzere (Lucerna).
Blazing Flame Quintet/6, “Wrecked Chateau”
 La parola, la poesia (tutti i testi nel booklet) sono al centro di questo lavoro discografico che si potrebbe definire polistilistico: l’ascolto dell’iniziale “Back Into The High Tide We Go” è piuttosto esemplificativa. Tutti le liriche sono del “vocalist” (la sua è una “song poetry”, in realtà) Steve Day, supportato talvolta da Julian Dale che è anche contrabbassista e violoncellista. Il gruppo prevede inoltre Peter Evans (violino elettrico a cinque corde), David Mowat (tromba), Mark Langford (sax tenore, clarinetto basso), Marco Anderson (batteria, percussioni). Non mancano sfumature e accentazioni rock, atmosfere teatrali e riferimenti jazzistici anche nei versi (“Flaming Gershwin”). Musica aperta, porosa, mutevole, visionaria, libertaria, di artisti non più giovani ma ancora “utopistici”.
La parola, la poesia (tutti i testi nel booklet) sono al centro di questo lavoro discografico che si potrebbe definire polistilistico: l’ascolto dell’iniziale “Back Into The High Tide We Go” è piuttosto esemplificativa. Tutti le liriche sono del “vocalist” (la sua è una “song poetry”, in realtà) Steve Day, supportato talvolta da Julian Dale che è anche contrabbassista e violoncellista. Il gruppo prevede inoltre Peter Evans (violino elettrico a cinque corde), David Mowat (tromba), Mark Langford (sax tenore, clarinetto basso), Marco Anderson (batteria, percussioni). Non mancano sfumature e accentazioni rock, atmosfere teatrali e riferimenti jazzistici anche nei versi (“Flaming Gershwin”). Musica aperta, porosa, mutevole, visionaria, libertaria, di artisti non più giovani ma ancora “utopistici”.
Oogui, “Travoltazuki”
 Feigin riesce a spiazzarti, sempre. Il produttore definisce il gruppo un “disto-disco-trio” ed il lavoro discografico “un laboratorio di sorprese musicali che mettono insieme jazz, disco, progressive rock e improvvisazione”. Il tramite con l’etichetta d’avanguardia inglese è stato il chitarrista svizzero Vinz Vonlanthen (ha inciso più volte per la Leo, nell’ambito della musica improvvisata): ha creato un trio con il pianista/tastierista Florence Melnotte ed il batterista/percussionista Sylvian Fourier (all’occorrenza tutti usano la voce) per rileggere il sound della disco anni ’80 in una chiave assolutamente personale (“Shitimogo”; nell’interno del cd c’è anche un John Travolta “mascherato”). Operazione riuscita? In ogni caso bisogna dar atto a Leo Feigin di una grande apertura, il che non è poco per i suoi ottantuno anni (è nato nel 1938 in quella che si chiamava Leningrado).
Feigin riesce a spiazzarti, sempre. Il produttore definisce il gruppo un “disto-disco-trio” ed il lavoro discografico “un laboratorio di sorprese musicali che mettono insieme jazz, disco, progressive rock e improvvisazione”. Il tramite con l’etichetta d’avanguardia inglese è stato il chitarrista svizzero Vinz Vonlanthen (ha inciso più volte per la Leo, nell’ambito della musica improvvisata): ha creato un trio con il pianista/tastierista Florence Melnotte ed il batterista/percussionista Sylvian Fourier (all’occorrenza tutti usano la voce) per rileggere il sound della disco anni ’80 in una chiave assolutamente personale (“Shitimogo”; nell’interno del cd c’è anche un John Travolta “mascherato”). Operazione riuscita? In ogni caso bisogna dar atto a Leo Feigin di una grande apertura, il che non è poco per i suoi ottantuno anni (è nato nel 1938 in quella che si chiamava Leningrado).
***
Parco della Musica Records

La Parco della Musica Records è l’etichetta discografica della Fondazione Musica per Roma che dal 2004 pubblica i migliori progetti registrati all’Auditorium Parco della Musica di Roma o proposti da artisti profondamente legati ad esso. Le linee editoriali seguono la stessa ricerca e selezione che caratterizza la programmazione musicale dell’Auditorium. La Parco della Musica Records è riuscita a raggiungere in pochi anni una posizione di prestigio nel mondo discografico guadagnando consensi sempre più positivi da parte della critica nazionale e internazionale e ottenendo numerosi premi e riconoscimenti.
Franco D’Andrea – “Intervals I”, “Intervals II”, “A Light Day”
 Franco D’Andrea è artista di caratura mondiale cosicché ogni suo album viene giustamente considerato un evento. Figuratevi quando di album, a distanza pochi mesi, ne escono addirittura tre. Attivo sin dai primi anni Sessanta, il pianista di Merano, come si diceva in apertura, è oggi considerato una punta di diamante del jazz globalmente inteso grazie alla sua classe, alla sua originalità e soprattutto alla sua ansia di ricerca che non conosce pause ad onta dei 78 anni suonati. D’altro canto chi lo conosce personalmente sa benissimo quanto Franco sia ancora fresco nel suo entusiasmo, gentile, disponibile, capace, suonando, di entusiasmarsi, di emozionarsi come un ragazzino alle prime armi. I primi due CD, significativamente intitolati «Intervals», evidenziano appieno quell’ansia di ricerca del pianista che si esercita sull’intervallo, ossia sulla distanza che separa due suoni, intervallo che può essere melodico o armonico. In questa puntigliosa e trascinante disamina D’Andrea è accompagnato da un ottetto di cui fa parte il suo sestetto ormai storico (Andrea Ayassot ai sassofoni, Daniele D’Agaro al clarinetto, Mauro Ottolini al trombone, Aldo Mella al contrabbasso e Zeno De Rossi alla batteria), ai quali si aggiungono la chitarra elettrica di Enrico Terragnoli e l’elettronica di Luca Roccatagliati, in arte DJ
Franco D’Andrea è artista di caratura mondiale cosicché ogni suo album viene giustamente considerato un evento. Figuratevi quando di album, a distanza pochi mesi, ne escono addirittura tre. Attivo sin dai primi anni Sessanta, il pianista di Merano, come si diceva in apertura, è oggi considerato una punta di diamante del jazz globalmente inteso grazie alla sua classe, alla sua originalità e soprattutto alla sua ansia di ricerca che non conosce pause ad onta dei 78 anni suonati. D’altro canto chi lo conosce personalmente sa benissimo quanto Franco sia ancora fresco nel suo entusiasmo, gentile, disponibile, capace, suonando, di entusiasmarsi, di emozionarsi come un ragazzino alle prime armi. I primi due CD, significativamente intitolati «Intervals», evidenziano appieno quell’ansia di ricerca del pianista che si esercita sull’intervallo, ossia sulla distanza che separa due suoni, intervallo che può essere melodico o armonico. In questa puntigliosa e trascinante disamina D’Andrea è accompagnato da un ottetto di cui fa parte il suo sestetto ormai storico (Andrea Ayassot ai sassofoni, Daniele D’Agaro al clarinetto, Mauro Ottolini al trombone, Aldo Mella al contrabbasso e Zeno De Rossi alla batteria), ai quali si aggiungono la chitarra elettrica di Enrico Terragnoli e l’elettronica di Luca Roccatagliati, in arte DJ 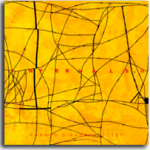 Rocca, elementi che risulteranno determinanti per arricchire la tavolozza timbrica del gruppo. “Intervals I” contiene la registrazione integrale del concerto tenuto il 21 marzo 2017 all’Auditorium Parco della Musica di Roma, mentre “Intervals II” contiene brani registrati durante le prove per il concerto del 21…Descrivere la musica contenuta nei due album è impresa praticamente impossibile (e forse anche inutile) data la varietà di situazioni e combinazioni che l’artista propone. Comunque una qualche differenziazione – non facile da cogliere – tra i due CD esiste nel senso che il primo volume è più strutturato, in cui è abbastanza facile scorgere i diversi input che hanno contribuito a rendere così particolare e articolato il linguaggio di D’Andrea (si ascolti, al riguardo ‘Intervals 3 / Old Jazz’ e ‘Traditions N.2’). Meno omogeneo il secondo volume, ancora più aperto in quanto, come spiega lo stesso D’Andrea, contiene situazioni estreme sperimentate durante le prove ma poi non confluite nel concerto. Altro aspetto importante che viene in primo piano e che accomuna ambedue i CD è la ricchezza della tavolozza timbrica, arricchita da una sorta di “sezione elettronica”, che contribuisce notevolmente a creare un nuovo suono di gruppo.
Rocca, elementi che risulteranno determinanti per arricchire la tavolozza timbrica del gruppo. “Intervals I” contiene la registrazione integrale del concerto tenuto il 21 marzo 2017 all’Auditorium Parco della Musica di Roma, mentre “Intervals II” contiene brani registrati durante le prove per il concerto del 21…Descrivere la musica contenuta nei due album è impresa praticamente impossibile (e forse anche inutile) data la varietà di situazioni e combinazioni che l’artista propone. Comunque una qualche differenziazione – non facile da cogliere – tra i due CD esiste nel senso che il primo volume è più strutturato, in cui è abbastanza facile scorgere i diversi input che hanno contribuito a rendere così particolare e articolato il linguaggio di D’Andrea (si ascolti, al riguardo ‘Intervals 3 / Old Jazz’ e ‘Traditions N.2’). Meno omogeneo il secondo volume, ancora più aperto in quanto, come spiega lo stesso D’Andrea, contiene situazioni estreme sperimentate durante le prove ma poi non confluite nel concerto. Altro aspetto importante che viene in primo piano e che accomuna ambedue i CD è la ricchezza della tavolozza timbrica, arricchita da una sorta di “sezione elettronica”, che contribuisce notevolmente a creare un nuovo suono di gruppo.
 A differenza degli altri due album, “A Light Day” è un doppio CD in cui ancora una volta Franco D’Andreea affronta la dimensione, per lui assai congeniale, del piano-solo. In programma parecchie composizioni dello stesso D’Andrea, affiancate a riletture di alcuni storici brani Dixieland. Il risultato è ancora una volta entusiasmante. Come su accennato il piano solo è per D’Andrea un contesto che lo ha già visto indiscusso protagonista. Questa ulteriore produzione discografica ci restituisce un artista semplicemente sontuoso dal punto di vista sia esecutivo sia compositivo. Chi conosce il musicista di Merano sa bene quanto lo stesso sia legato al jazz del passato pur rinnovandolo e rivisitandolo alla luce della sua sensibilità di musicista moderno. Di qui un jazz originale, in cui la ricerca sul materiale si combina perfettamente con quella sul suono e sulla combinazione di elementi derivati sia dal primo jazz sia dal free; e non crediamo di esagerare affermando che D’Andrea è uno dei pochissimi artisti al mondo capace di operare una tale sintesi giungendo a risultati sempre – e sottolineamo sempre – di assoluta originalità e di grande valore artistico.
A differenza degli altri due album, “A Light Day” è un doppio CD in cui ancora una volta Franco D’Andreea affronta la dimensione, per lui assai congeniale, del piano-solo. In programma parecchie composizioni dello stesso D’Andrea, affiancate a riletture di alcuni storici brani Dixieland. Il risultato è ancora una volta entusiasmante. Come su accennato il piano solo è per D’Andrea un contesto che lo ha già visto indiscusso protagonista. Questa ulteriore produzione discografica ci restituisce un artista semplicemente sontuoso dal punto di vista sia esecutivo sia compositivo. Chi conosce il musicista di Merano sa bene quanto lo stesso sia legato al jazz del passato pur rinnovandolo e rivisitandolo alla luce della sua sensibilità di musicista moderno. Di qui un jazz originale, in cui la ricerca sul materiale si combina perfettamente con quella sul suono e sulla combinazione di elementi derivati sia dal primo jazz sia dal free; e non crediamo di esagerare affermando che D’Andrea è uno dei pochissimi artisti al mondo capace di operare una tale sintesi giungendo a risultati sempre – e sottolineamo sempre – di assoluta originalità e di grande valore artistico.
Riccardo Del Fra – “Moving People”
 “Per me, comporre vuol dire trasmettere un significato”; cosí il contrabbassista Riccardo Del Fra inizia la breve presentazione del compact “Moving People”. Trattasi di una suite che il medesimo compositore non esita a definire basata sui canoni di “motion and emotion”, movimento ed emozioni che ne determinano lo sviluppo, l’andamento, le sequenze armoniche. C’è una sottotraccia, nel lavoro commissionatogli dalla Fondazione Genshagen di Berlino, un mandato ispirato all’amicizia fra i popoli: il genere umano in marcia, il suo moto perpetuo, visto nell’attuale momento storico in cui incalza il problema dell’immigrazione con i conseguenti nodi politici da sciogliere. Del Fra assembla per l’occasione una formazione cosmopolita, in rappresentanza di cinque Paesi: ” mette insieme e dirige diversi background stilistici creando un risultato sorprendente” annota Ted Panken mentre Jen Paul Ricard, sempre all’interno della cover, ne sottolinea la bellezza del mondo melodico. Caratteristica del resto tipica anche del precedente disco “My Chet My Song”, inciso per la stessa label, in cui la componente “motoemotiva” era già presente nelle prestazioni di questo contrabbassista lirico, abituato a lavorare in profondità sulle corde per estrarne l’anima, alimentare la fantasia, impregnare in concreto l’interpretazione. La scelta dei partners pare misurata per realizzare al meglio le dieci composizioni dell’album sulla base di quanto programmato, lasciando ampio spazio ora all’improvvisazione (‘Ressac’, ‘Street Scenes’), ora all’immaginazione (‘The Sea Behind’, ‘Around The Fire’), ora alla percezione effimera (‘Ephemeral Refractions’) ora alla spinta ritmica (‘Children Walking Through A Minefield’), al dialogo fra strumenti (‘Wind On An Open Book II’), infine ad ampie aperture (‘Cieli sereni’); in un progetto che i (sette) jazzisti, artisti in cammino e musicisti “d’incontro” per definizione, applicano doviziosamente. Sono il trombettista polacco Tomasz Dabrowski, il sassofonista tedesco Jan Prax, i francesi Rémi Fox al baritono e soprano e Cart-Henry Morisset al pianoforte, e gli americani Jason Brown alla batteria e l’ospite Kurt Rosenwinkel alla chitarra. Il tema principale, “Moving People”, è di quelli che ritornano in mente per merito di una melodia delicata ed iterata che penetra, lasciando una sensazione indefinita di viaggio, intrisa di pathos intenso ed intime suggestioni. (Amedeo Furfaro)
“Per me, comporre vuol dire trasmettere un significato”; cosí il contrabbassista Riccardo Del Fra inizia la breve presentazione del compact “Moving People”. Trattasi di una suite che il medesimo compositore non esita a definire basata sui canoni di “motion and emotion”, movimento ed emozioni che ne determinano lo sviluppo, l’andamento, le sequenze armoniche. C’è una sottotraccia, nel lavoro commissionatogli dalla Fondazione Genshagen di Berlino, un mandato ispirato all’amicizia fra i popoli: il genere umano in marcia, il suo moto perpetuo, visto nell’attuale momento storico in cui incalza il problema dell’immigrazione con i conseguenti nodi politici da sciogliere. Del Fra assembla per l’occasione una formazione cosmopolita, in rappresentanza di cinque Paesi: ” mette insieme e dirige diversi background stilistici creando un risultato sorprendente” annota Ted Panken mentre Jen Paul Ricard, sempre all’interno della cover, ne sottolinea la bellezza del mondo melodico. Caratteristica del resto tipica anche del precedente disco “My Chet My Song”, inciso per la stessa label, in cui la componente “motoemotiva” era già presente nelle prestazioni di questo contrabbassista lirico, abituato a lavorare in profondità sulle corde per estrarne l’anima, alimentare la fantasia, impregnare in concreto l’interpretazione. La scelta dei partners pare misurata per realizzare al meglio le dieci composizioni dell’album sulla base di quanto programmato, lasciando ampio spazio ora all’improvvisazione (‘Ressac’, ‘Street Scenes’), ora all’immaginazione (‘The Sea Behind’, ‘Around The Fire’), ora alla percezione effimera (‘Ephemeral Refractions’) ora alla spinta ritmica (‘Children Walking Through A Minefield’), al dialogo fra strumenti (‘Wind On An Open Book II’), infine ad ampie aperture (‘Cieli sereni’); in un progetto che i (sette) jazzisti, artisti in cammino e musicisti “d’incontro” per definizione, applicano doviziosamente. Sono il trombettista polacco Tomasz Dabrowski, il sassofonista tedesco Jan Prax, i francesi Rémi Fox al baritono e soprano e Cart-Henry Morisset al pianoforte, e gli americani Jason Brown alla batteria e l’ospite Kurt Rosenwinkel alla chitarra. Il tema principale, “Moving People”, è di quelli che ritornano in mente per merito di una melodia delicata ed iterata che penetra, lasciando una sensazione indefinita di viaggio, intrisa di pathos intenso ed intime suggestioni. (Amedeo Furfaro)
Martux_m – “Apollo 11 Reloaded”
 La musica elettronica non ci entusiasma: di qui lo scetticismo con cui ci siamo posti ad ascoltare questo album. Per fortuna le cose sono andate meglio del previsto. Intendiamoci: non è che ci abbia entusiasmato, ma siamo riusciti ad ascoltarlo sino alla fine senza problema alcuno, anzi apprezzando particolarmente i due brani in cui figura Francesco Bearzatti. Ciò perché Martux_m è artista maturo, consapevole delle proprie possibilità, che usa l’elettronica come linguaggio, come mezzo di comunicazione al di là di qualsivoglia intento edonistico. Come si può facilmente evincere dal titolo, il progetto nasce in occasione delle celebrazioni dei 50 anni dello sbarco del primo uomo sulla luna. Assecondando la sua straordinaria fantasia, Martux_m ha inteso, attraverso la sua musica, descrivere le varie fasi della missione Apollo 11, dalla partenza con il primo brano “Lift Off”, al rientro sulla terra con l’ultimo brano “Return”. In mezzo, tra l’altro, due brani particolarmente legati a quello specifico periodo storico: “Us and them” dei Pink Floyd tratto dall’indimenticabile “The dark side of the moon” e “Space Oddity” di David Bowie. In apertura accennavamo alla maturità artistica di Martux_m e a conferma di ciò da segnalare la validità dei collaboratori che il musicista ha scelto per questa nuova impresa discografica: sul piano dell’organico ecco inseriti Giulio Maresca all’elettronica in tutti i brani e il sax di Francesco Bearzatti in “Us And Them” e “Space Oddity”. Ma non basta ché ritroviamo Danilo Rea in veste di compositore dell’ultimo brano “Return”, e arrangiatore (nei due brani in cui si ascolta Bearzatti), il compositore cinematografico Pasquale Catalano (autore di “Sightseeing on the Moon”). Il risultato è, come si accennava, più che soddisfacente, in grado, cioè, di farsi ascoltare da un pubblico che va al di là dei soli appassionati di elettronica.
La musica elettronica non ci entusiasma: di qui lo scetticismo con cui ci siamo posti ad ascoltare questo album. Per fortuna le cose sono andate meglio del previsto. Intendiamoci: non è che ci abbia entusiasmato, ma siamo riusciti ad ascoltarlo sino alla fine senza problema alcuno, anzi apprezzando particolarmente i due brani in cui figura Francesco Bearzatti. Ciò perché Martux_m è artista maturo, consapevole delle proprie possibilità, che usa l’elettronica come linguaggio, come mezzo di comunicazione al di là di qualsivoglia intento edonistico. Come si può facilmente evincere dal titolo, il progetto nasce in occasione delle celebrazioni dei 50 anni dello sbarco del primo uomo sulla luna. Assecondando la sua straordinaria fantasia, Martux_m ha inteso, attraverso la sua musica, descrivere le varie fasi della missione Apollo 11, dalla partenza con il primo brano “Lift Off”, al rientro sulla terra con l’ultimo brano “Return”. In mezzo, tra l’altro, due brani particolarmente legati a quello specifico periodo storico: “Us and them” dei Pink Floyd tratto dall’indimenticabile “The dark side of the moon” e “Space Oddity” di David Bowie. In apertura accennavamo alla maturità artistica di Martux_m e a conferma di ciò da segnalare la validità dei collaboratori che il musicista ha scelto per questa nuova impresa discografica: sul piano dell’organico ecco inseriti Giulio Maresca all’elettronica in tutti i brani e il sax di Francesco Bearzatti in “Us And Them” e “Space Oddity”. Ma non basta ché ritroviamo Danilo Rea in veste di compositore dell’ultimo brano “Return”, e arrangiatore (nei due brani in cui si ascolta Bearzatti), il compositore cinematografico Pasquale Catalano (autore di “Sightseeing on the Moon”). Il risultato è, come si accennava, più che soddisfacente, in grado, cioè, di farsi ascoltare da un pubblico che va al di là dei soli appassionati di elettronica.
Fabrizio Sferra, Costanza Alegiani – “Grace in Town”
 Conosciamo Fabrizio da qualche decennio, da quando cominciò ad interessarsi di jazz suonando nel ‘West Trio’ assieme al fratello Aldo, eccellente chitarrista. E siamo stati tra i primissimi giornalisti a notarlo e farlo conoscere al popolo del jazz. Di qui il nostro stupore quando ci siamo trovati fra le mani questo album in cui Fabrizio ha abbandonato bacchette e spazzole per reinventarsi compositore e interprete canoro di dieci nuove composizioni da lui stesso scritte con i testi della compagna di viaggio Costanza Alegiani (cui si è aggiunta nel brano di chiusura Sarah Victoria Barberis). Ma perché questo cambio di rotta così radicale? L’album, spiega Sferra in una recente intervista “nasce dalla voglia di riprendere una pratica abituale della fanciullezza e dell’adolescenza (prima cioè di cominciare a dedicarmi, all’età di diciotto anni, allo studio della batteria e all’avventura del jazz, sviluppata poi in questi ultimi quarant’anni), quella cioè del cantare e scrivere canzoni. Quindi è nato, a livello musicale, come un gioco: il ritrovarsi intimo con una vecchia, semplice passione: mettere insieme il canto di una linea melodica con degli accordi, e lasciarsi trasportare nello sviluppo di una forma”. Risultato: un album delicato, a tratti coinvolgente, in cui l’anima jazzistica di Fabrizio Sferra si fonde con la voce di Costanza Alegiani a disegnare un’oretta di buona musica impreziosita da un organico orchestrale di tutto rispetto con Alessandro Gwis al piano e tastiere, Francesco Diodati alla chitarra elettrica, Francesco Ponticelli al basso e Federico Scettri alla batteria in sei dei dieci brani in programma (negli altri alla batteria torna Sferra). Ben calibrato è anche il ricorso all’elettronica che conferisce al progetto un sound assolutamente attuale attraversando territori i più svariati: dal rock al blues, dal moderno allo sperimentalismo, il tutto mantenendosi ad una certa distanza da quel linguaggio jazzistico da cui Sferra proviene.
Conosciamo Fabrizio da qualche decennio, da quando cominciò ad interessarsi di jazz suonando nel ‘West Trio’ assieme al fratello Aldo, eccellente chitarrista. E siamo stati tra i primissimi giornalisti a notarlo e farlo conoscere al popolo del jazz. Di qui il nostro stupore quando ci siamo trovati fra le mani questo album in cui Fabrizio ha abbandonato bacchette e spazzole per reinventarsi compositore e interprete canoro di dieci nuove composizioni da lui stesso scritte con i testi della compagna di viaggio Costanza Alegiani (cui si è aggiunta nel brano di chiusura Sarah Victoria Barberis). Ma perché questo cambio di rotta così radicale? L’album, spiega Sferra in una recente intervista “nasce dalla voglia di riprendere una pratica abituale della fanciullezza e dell’adolescenza (prima cioè di cominciare a dedicarmi, all’età di diciotto anni, allo studio della batteria e all’avventura del jazz, sviluppata poi in questi ultimi quarant’anni), quella cioè del cantare e scrivere canzoni. Quindi è nato, a livello musicale, come un gioco: il ritrovarsi intimo con una vecchia, semplice passione: mettere insieme il canto di una linea melodica con degli accordi, e lasciarsi trasportare nello sviluppo di una forma”. Risultato: un album delicato, a tratti coinvolgente, in cui l’anima jazzistica di Fabrizio Sferra si fonde con la voce di Costanza Alegiani a disegnare un’oretta di buona musica impreziosita da un organico orchestrale di tutto rispetto con Alessandro Gwis al piano e tastiere, Francesco Diodati alla chitarra elettrica, Francesco Ponticelli al basso e Federico Scettri alla batteria in sei dei dieci brani in programma (negli altri alla batteria torna Sferra). Ben calibrato è anche il ricorso all’elettronica che conferisce al progetto un sound assolutamente attuale attraversando territori i più svariati: dal rock al blues, dal moderno allo sperimentalismo, il tutto mantenendosi ad una certa distanza da quel linguaggio jazzistico da cui Sferra proviene.
***
Poll Winners Records

E’ un’etichetta specializzata nelle riedizione in CD di molti titoli che possiamo considerare dei veri e propri classici della storia del jazz, titoli che si sono meritati le ‘cinque stelle’ nelle recensioni di “Down Beat”. Caratteristica di queste riedizioni l’aggiunta, oltre all’album originale, di contenuti extra.
Duke Ellington – “Ellington Uptown • The Liberian Suite • Masterpieces By Ellington”
 Ancora un doppio cd di grande valore storico; vi ritroviamo tutte le registrazioni effettuate durante le sessioni da cui sono stati tratti gli album di Duke Ellington: “Ellington Uptown” (Columbia ML4639 / CL830), “The Liberian Suite” (Columbia CL848) e “Masterpieces by Ellington” (Columbia ML4418). In particolare “Ellington Uptown” era stato originariamente pubblicato in due diverse versioni, la prima contenente anche “The Harlem Suite” e la seconda con al posto della “Harlem Suite” la “Controversial Suite”. “The Liberian Suite” è stata prima pubblicata come un LP 10 pollici e poi come LP 12 pollici con l’aggiunta di “The Harlem Suite”. Tutte queste registrazioni sono riunite qui con l’aggiunta di un brano (“Come on Home”) che completa le sessioni di “Ellington Uptown”, e quattro rare versioni alternative de “The Liberian Suite” registrate nel corso della stessa sessione. Come ulteriore bonus una versione del brano “The Tattooed Bride” registrato dal vivo alla Carnegie Hall il 13 novembre del 1948. Chi conosce la musica del “Duca” sa che ci troviamo dinnanzi ad una delle migliori formazioni assemblate da Ellington, con tutti i migliori solisti in primo piano, da Cat Anderson a Clak Terry, da Juan Tizol a Britt Woodman, da Russell Procope a Johnny Hodges … tanto per citarne alcuni. La musica è semplicemente straordinaria: non a caso su questi pezzi di Ellington sono stati versati fiumi di inchiostro. Si pensi solo a “The Harlem Suite” ovvero “A Tone Parallel To Harlem” una composizione di 14 minuti in cui Ellington supera i confini del jazz propriamente inteso per assurgere a livelli di assoluta grandezza, al di là di qualsivoglia genere.
Ancora un doppio cd di grande valore storico; vi ritroviamo tutte le registrazioni effettuate durante le sessioni da cui sono stati tratti gli album di Duke Ellington: “Ellington Uptown” (Columbia ML4639 / CL830), “The Liberian Suite” (Columbia CL848) e “Masterpieces by Ellington” (Columbia ML4418). In particolare “Ellington Uptown” era stato originariamente pubblicato in due diverse versioni, la prima contenente anche “The Harlem Suite” e la seconda con al posto della “Harlem Suite” la “Controversial Suite”. “The Liberian Suite” è stata prima pubblicata come un LP 10 pollici e poi come LP 12 pollici con l’aggiunta di “The Harlem Suite”. Tutte queste registrazioni sono riunite qui con l’aggiunta di un brano (“Come on Home”) che completa le sessioni di “Ellington Uptown”, e quattro rare versioni alternative de “The Liberian Suite” registrate nel corso della stessa sessione. Come ulteriore bonus una versione del brano “The Tattooed Bride” registrato dal vivo alla Carnegie Hall il 13 novembre del 1948. Chi conosce la musica del “Duca” sa che ci troviamo dinnanzi ad una delle migliori formazioni assemblate da Ellington, con tutti i migliori solisti in primo piano, da Cat Anderson a Clak Terry, da Juan Tizol a Britt Woodman, da Russell Procope a Johnny Hodges … tanto per citarne alcuni. La musica è semplicemente straordinaria: non a caso su questi pezzi di Ellington sono stati versati fiumi di inchiostro. Si pensi solo a “The Harlem Suite” ovvero “A Tone Parallel To Harlem” una composizione di 14 minuti in cui Ellington supera i confini del jazz propriamente inteso per assurgere a livelli di assoluta grandezza, al di là di qualsivoglia genere.
Dizzy Gillespie, Charlie Parker – “Diz ‘n’ Bird. The Beginning”
 L’album “Diz ‘n’ Bird – The Beginning” (Roost-SK-106) venne pubblicato nel 1959, cinque anni dopo la morte di Charlie Parker, e conteneva rare registrazioni degli albori del bebop. L’album riuniva alcune registrazioni provenienti da un concerto in quintetto del 1947 di Parker e Gillespie alla Carnegie Hall (con John Lewis al piano, Al McKibbon al basso e Joe Harris alla batteria), e da un concerto del quintetto di Gillespie del 1953 alla Salle Pleyel di Parigi (con Bill Graham sax baritono, Wade Legge piano, Lou Hackney basso, Al Jones batteria, Joe Carroll e Sarah Vaughan voce) accoppiandole con registrazioni di Bird per la Dial del 1947 (con Miles Davis, J.J. Johnson trombone, Duke Jordan piano, Tommy Potter basso e Max Roach batteria). Questa nuova edizione in doppio cd include il concerto completo alla Carnegie Hall del 1947, più l’intero concerto alla Salle Pleyel, insieme alle tracce di Dial incluse nell’LP originale; come bonus sono state aggiunte delle registrazioni radiofoniche effettuate al club Birdland nel 1951 dai due in sestetto con Bud Powell piano, Tommy Potter basso, Roy Haynes batteria e Symphony Sid Torin alla conduzione radiofonica). Basterebbero queste semplici elencazioni per capire che si tratta di un album che tutti gli appassionati di jazz dovrebbero possedere. In effetti, oltre al valore storico, si tratta di registrazioni che illustrano tutta la carica dirompente di questi straordinari musicisti che a metà degli anni ’40 irruppero in un panorama jazzistico fino ad allora dominato dalle orchestre swing. Ed è davvero opportuno, consigliabile un ascolto attento soprattutto da parte dei più giovani che si avvicinano al jazz saltando a piè pari i primi 50 anni di questa straordinaria musica.
L’album “Diz ‘n’ Bird – The Beginning” (Roost-SK-106) venne pubblicato nel 1959, cinque anni dopo la morte di Charlie Parker, e conteneva rare registrazioni degli albori del bebop. L’album riuniva alcune registrazioni provenienti da un concerto in quintetto del 1947 di Parker e Gillespie alla Carnegie Hall (con John Lewis al piano, Al McKibbon al basso e Joe Harris alla batteria), e da un concerto del quintetto di Gillespie del 1953 alla Salle Pleyel di Parigi (con Bill Graham sax baritono, Wade Legge piano, Lou Hackney basso, Al Jones batteria, Joe Carroll e Sarah Vaughan voce) accoppiandole con registrazioni di Bird per la Dial del 1947 (con Miles Davis, J.J. Johnson trombone, Duke Jordan piano, Tommy Potter basso e Max Roach batteria). Questa nuova edizione in doppio cd include il concerto completo alla Carnegie Hall del 1947, più l’intero concerto alla Salle Pleyel, insieme alle tracce di Dial incluse nell’LP originale; come bonus sono state aggiunte delle registrazioni radiofoniche effettuate al club Birdland nel 1951 dai due in sestetto con Bud Powell piano, Tommy Potter basso, Roy Haynes batteria e Symphony Sid Torin alla conduzione radiofonica). Basterebbero queste semplici elencazioni per capire che si tratta di un album che tutti gli appassionati di jazz dovrebbero possedere. In effetti, oltre al valore storico, si tratta di registrazioni che illustrano tutta la carica dirompente di questi straordinari musicisti che a metà degli anni ’40 irruppero in un panorama jazzistico fino ad allora dominato dalle orchestre swing. Ed è davvero opportuno, consigliabile un ascolto attento soprattutto da parte dei più giovani che si avvicinano al jazz saltando a piè pari i primi 50 anni di questa straordinaria musica.
Django Reinhardt – “Djangology”
 Django Reinhardt fu non solo uno dei più grandi jazzisti del secolo scorso, ma per lunga pezza l’unico musicista europeo in grado di competere ad armi pari con i colleghi d’oltre oceano. Il suo stile chitarristico, in effetti, era influenzato molto più dalle correnti europee che non dagli input che avevano formato e fatto crescere il jazz statunitense. Ricordiamo, al riguardo, il celeberrimo quintetto dell’Hot Club di Francia costituito nel 1934 da Django con il violinista Stephane Grappelli, anch’egli europeo. Tutto ciò risalta evidente anche da questo album che contiene innanzitutto il completo lp “Djangology” registrato nel 1949 da Reinhardt e Grappelli a Roma con una sezione ritmica locale con Gianni Safred al piano, Carlo Pecori al contrabbasso e Aurelio De Carolis alla batteria. L’album venne pubblicato dalla RCA Victor nel 1961, quindi dieci anni dopo la scomparsa del chitarrista. Adesso questo CD riporta in luce il “vecchio” lp con l’aggiunta, come bonus, di dodici tracce tratte dalle stesse sessioni del 1949. Quanto alla qualità della musica c’è veramente poco da aggiungere. Anche se accompagnati da una sezione ritmica con cui non avevano molta dimestichezza, chitarrista e violinista esplicano appieno la loro arte con una intensità e una passione che ancora oggi colpiscono a 70 anni dalla loro registrazione. Ritroviamo, così alcuni capolavori assoluti quali “Minor Swing” che non a caso apre il CD, “The Man I Love” che altrettanto non casualmente lo chiude, e poi in mezzo “Lover Man”, “Swing 42”, “Daphné”…Insomma un album che sicuramente non stupirà chi già conosce questo straordinario artista ma che aprirà orizzonti fin ora sconosciuti a quei tanti giovani che mai hanno ascoltato qualcosa di Django Reinhardt.
Django Reinhardt fu non solo uno dei più grandi jazzisti del secolo scorso, ma per lunga pezza l’unico musicista europeo in grado di competere ad armi pari con i colleghi d’oltre oceano. Il suo stile chitarristico, in effetti, era influenzato molto più dalle correnti europee che non dagli input che avevano formato e fatto crescere il jazz statunitense. Ricordiamo, al riguardo, il celeberrimo quintetto dell’Hot Club di Francia costituito nel 1934 da Django con il violinista Stephane Grappelli, anch’egli europeo. Tutto ciò risalta evidente anche da questo album che contiene innanzitutto il completo lp “Djangology” registrato nel 1949 da Reinhardt e Grappelli a Roma con una sezione ritmica locale con Gianni Safred al piano, Carlo Pecori al contrabbasso e Aurelio De Carolis alla batteria. L’album venne pubblicato dalla RCA Victor nel 1961, quindi dieci anni dopo la scomparsa del chitarrista. Adesso questo CD riporta in luce il “vecchio” lp con l’aggiunta, come bonus, di dodici tracce tratte dalle stesse sessioni del 1949. Quanto alla qualità della musica c’è veramente poco da aggiungere. Anche se accompagnati da una sezione ritmica con cui non avevano molta dimestichezza, chitarrista e violinista esplicano appieno la loro arte con una intensità e una passione che ancora oggi colpiscono a 70 anni dalla loro registrazione. Ritroviamo, così alcuni capolavori assoluti quali “Minor Swing” che non a caso apre il CD, “The Man I Love” che altrettanto non casualmente lo chiude, e poi in mezzo “Lover Man”, “Swing 42”, “Daphné”…Insomma un album che sicuramente non stupirà chi già conosce questo straordinario artista ma che aprirà orizzonti fin ora sconosciuti a quei tanti giovani che mai hanno ascoltato qualcosa di Django Reinhardt.
da Gerlando Gatto | 23/Dic/2018 | I nostri CD, Primo piano, Recensioni

John Abercrombie – “Open Land” Meeting J. Abercrombie – DVD ECM 675
 Prodotto e filmato dal regista Arno Oehri (artista multimediale e filmmaker del Liechtenstein) e dal produttore Oliver Primus (musicista e articolista svizzero) questo documentario, al di là delle intenzioni degli autori, si è purtroppo trasformato in un omaggio alla memoria dal momento che l’artista è scomparso nell’agosto 2017, pochi mesi prima che l’opera fosse ufficialmente presentata. Ovviamente ciò nulla toglie alla valenza della produzione che, anzi, ci offre l’occasione per ricordare e riflettere sulla figura di un musicista straordinario non sempre valorizzato in base ai suoi meriti. La tecnica scelta dagli autori per raccontare il chitarrista è quella che personalmente prediligo, vale a dire far parlare direttamente il personaggio. Così i due sono andati ad intervistare Abercrombie nella sua casa e si son fatti raccontare le vicende principali della sua vita e della sua arte. Così ci restituiscono oltre che l’artista anche e forse soprattutto l’uomo Abercrombie, con le sue aspirazioni, i suoi desideri, il suo amore per la moglie Lisa…e perché no le sue paure come quando il 7 dicembre del 2003 si incendiò la sua casa con la conseguente perdita di quasi tutto ciò che possedeva. Il risultato è un ritratto vivido, a tratti toccante, di un artista che ha saputo coniugare la musica con la vita di tutti i giorni. Dal punto di vista musicale, il brano forse più interessante è “Another Ralph’s” registrato al Tangente Club di Eschen (Liechtenstein) nel 2014 dal trio comprendente, oltre ad Abercrombie, Adam Nussbaum alla batteria e
Prodotto e filmato dal regista Arno Oehri (artista multimediale e filmmaker del Liechtenstein) e dal produttore Oliver Primus (musicista e articolista svizzero) questo documentario, al di là delle intenzioni degli autori, si è purtroppo trasformato in un omaggio alla memoria dal momento che l’artista è scomparso nell’agosto 2017, pochi mesi prima che l’opera fosse ufficialmente presentata. Ovviamente ciò nulla toglie alla valenza della produzione che, anzi, ci offre l’occasione per ricordare e riflettere sulla figura di un musicista straordinario non sempre valorizzato in base ai suoi meriti. La tecnica scelta dagli autori per raccontare il chitarrista è quella che personalmente prediligo, vale a dire far parlare direttamente il personaggio. Così i due sono andati ad intervistare Abercrombie nella sua casa e si son fatti raccontare le vicende principali della sua vita e della sua arte. Così ci restituiscono oltre che l’artista anche e forse soprattutto l’uomo Abercrombie, con le sue aspirazioni, i suoi desideri, il suo amore per la moglie Lisa…e perché no le sue paure come quando il 7 dicembre del 2003 si incendiò la sua casa con la conseguente perdita di quasi tutto ciò che possedeva. Il risultato è un ritratto vivido, a tratti toccante, di un artista che ha saputo coniugare la musica con la vita di tutti i giorni. Dal punto di vista musicale, il brano forse più interessante è “Another Ralph’s” registrato al Tangente Club di Eschen (Liechtenstein) nel 2014 dal trio comprendente, oltre ad Abercrombie, Adam Nussbaum alla batteria e
Gary Versace all’organo Hammond (i due sono anche intervistati in merito al loro rapporto umano e professionale con Abercrombie). Tra gli altri momenti degni di nota da ricordare l’esibizione a New York in quartetto con Rob Sheps al sax, Eliot Zigmund alla batteria e David Kingsnorth al basso.
Arild Andersen – “In-House Science” – ECM 2594
 Ho avuto la fortuna di conoscere personalmente Arild Andersen a Stavanger, in Norvegia, nell’oramai lontano 1983 quando già era considerato un astro nascente della nuova scena scandinava. Sono passati tanti anni e Arild ha confermato appieno tutte le premesse di quei tempi essendo considerato, oggi, uno dei migliori e più innovativi bassisti dell’intero panorama jazzistico. E questo CD ne è l’ennesima riprova… se pur ce ne fosse stato bisogno. Registrato il 29 settembre del 2016 in un luogo storico quale il museo Villa Rothstein a Bad Ischl in Austria, Andersen capeggia un formidabile trio completato da Tommy Smith al sax tenore e dal “nostro” paolo Vinaccia alla batteria. Quindi un trio che fa a meno di uno strumento armonico senza che ciò abbia la minima influenza sulla qualità della musica. I tre si muovono all’insegna di una empatia totale, con Arild che detta i tempi, Smith che sfoggia un fraseggio elastico, vivace, sempre in linea con le atmosfere volute dal leader (autore, tra l’altro, di tutti e sei i brani in programma) e Vinaccia che si esprime con la solita maestria producendo un volume sonoro denso e trascinante. Di qui una musica che si dipana per tutta la durata dell’album con grande scioltezza passando da atmosfere romantiche, sognanti, a climi più torridi ai confini dell’avanguardia, sempre impreziosita dalla massima attenzione alla più piccola sfumatura. E per avere un’idea di quanto si sta dicendo, basta ascoltare attentamente, in rapida successione “North Of The Northwind” dai toni soffusi e il sax di Smith a ricordare a tratti l’espressività propria di Gato Barbieri, e “In-House” in cui i tre scatenano una vera e propria tempesta sonora con un Andersen che sfoggia una padronanza dello strumento davvero non comune e un Vinaccia che ancora una volta evidenzia il perché sia considerato dai musicisti nordici un sodale imprescindibile.
Ho avuto la fortuna di conoscere personalmente Arild Andersen a Stavanger, in Norvegia, nell’oramai lontano 1983 quando già era considerato un astro nascente della nuova scena scandinava. Sono passati tanti anni e Arild ha confermato appieno tutte le premesse di quei tempi essendo considerato, oggi, uno dei migliori e più innovativi bassisti dell’intero panorama jazzistico. E questo CD ne è l’ennesima riprova… se pur ce ne fosse stato bisogno. Registrato il 29 settembre del 2016 in un luogo storico quale il museo Villa Rothstein a Bad Ischl in Austria, Andersen capeggia un formidabile trio completato da Tommy Smith al sax tenore e dal “nostro” paolo Vinaccia alla batteria. Quindi un trio che fa a meno di uno strumento armonico senza che ciò abbia la minima influenza sulla qualità della musica. I tre si muovono all’insegna di una empatia totale, con Arild che detta i tempi, Smith che sfoggia un fraseggio elastico, vivace, sempre in linea con le atmosfere volute dal leader (autore, tra l’altro, di tutti e sei i brani in programma) e Vinaccia che si esprime con la solita maestria producendo un volume sonoro denso e trascinante. Di qui una musica che si dipana per tutta la durata dell’album con grande scioltezza passando da atmosfere romantiche, sognanti, a climi più torridi ai confini dell’avanguardia, sempre impreziosita dalla massima attenzione alla più piccola sfumatura. E per avere un’idea di quanto si sta dicendo, basta ascoltare attentamente, in rapida successione “North Of The Northwind” dai toni soffusi e il sax di Smith a ricordare a tratti l’espressività propria di Gato Barbieri, e “In-House” in cui i tre scatenano una vera e propria tempesta sonora con un Andersen che sfoggia una padronanza dello strumento davvero non comune e un Vinaccia che ancora una volta evidenzia il perché sia considerato dai musicisti nordici un sodale imprescindibile.
Maxime Bender – “Universal Sky” – Cam Jazz 7924-2
 Per avere una chiara idea di ciò che Maxime propone basta rifarsi alla definizione da lui stesso coniata circa il jazz che ama: “con meno swing e più pop”. Quindi un linguaggio che intende allontanarsi dal jazz canonico per affrontare nuovi lidi. In ciò il multistrumentista lussemburghese (sax tenore, sax soprano, flauto, pianoforte) è coadiuvato nell’occasione da Manu Codjia alla chitarra, Jean-Yves Jung all’organo Hammond B3 e Jérôme Klein alla batteria. Etichette a parte, il risultato è ancora una volta positivo. In repertorio dieci brani di cui otto scritti dallo stesso Bender e gli altri due rispettivamente dal compositore americano Justin Vernon e dal batterista del gruppo Jérôme Klein, quindi una prova di piena maturità per Bender anche come compositore. Ed in effetti i brani sono tutti ben strutturati, altrettanto ben arrangiati, sostenuti da un gruppo quanto mai coeso che riesce ad eseguire in grande scioltezza sia le parti obbligate sia quelle improvvisate tanto che risulta oggettivamente difficile distinguerle. Ogni singola nota è come distillata sapientemente, avendo riguardo a dove andrà a collocarsi, Di qui anche una ricchezza timbrica, dinamica e di atmosfere che prende l’ascoltatore dalla prima all’ultima nota dell’album. Ecco quindi il clima sognante, onirico di “Dust Of Light” (con il chitarrista Manu Codjia in bella evidenza) cui si contrappone la forza ritmica di “Missing Piece”, ecco “Fly” con l’Hammond in grande evidenza mentre in “Infinity” è il sax di Bender a disegnare la sinuosa linea melodica… e via di questo passo in un continuo alternarsi di ruoli che evidenzia quella compattezza cui prima si faceva riferimento.
Per avere una chiara idea di ciò che Maxime propone basta rifarsi alla definizione da lui stesso coniata circa il jazz che ama: “con meno swing e più pop”. Quindi un linguaggio che intende allontanarsi dal jazz canonico per affrontare nuovi lidi. In ciò il multistrumentista lussemburghese (sax tenore, sax soprano, flauto, pianoforte) è coadiuvato nell’occasione da Manu Codjia alla chitarra, Jean-Yves Jung all’organo Hammond B3 e Jérôme Klein alla batteria. Etichette a parte, il risultato è ancora una volta positivo. In repertorio dieci brani di cui otto scritti dallo stesso Bender e gli altri due rispettivamente dal compositore americano Justin Vernon e dal batterista del gruppo Jérôme Klein, quindi una prova di piena maturità per Bender anche come compositore. Ed in effetti i brani sono tutti ben strutturati, altrettanto ben arrangiati, sostenuti da un gruppo quanto mai coeso che riesce ad eseguire in grande scioltezza sia le parti obbligate sia quelle improvvisate tanto che risulta oggettivamente difficile distinguerle. Ogni singola nota è come distillata sapientemente, avendo riguardo a dove andrà a collocarsi, Di qui anche una ricchezza timbrica, dinamica e di atmosfere che prende l’ascoltatore dalla prima all’ultima nota dell’album. Ecco quindi il clima sognante, onirico di “Dust Of Light” (con il chitarrista Manu Codjia in bella evidenza) cui si contrappone la forza ritmica di “Missing Piece”, ecco “Fly” con l’Hammond in grande evidenza mentre in “Infinity” è il sax di Bender a disegnare la sinuosa linea melodica… e via di questo passo in un continuo alternarsi di ruoli che evidenzia quella compattezza cui prima si faceva riferimento.
Ketil Bjørnstad & Anneli Drecker – “A Suite Of Poems” – ECM 2440
 La genesi di questo toccante album è illustrata chiaramente dallo stesso Bjørnstad nelle note che accompagnano il CD laddove ci racconta che, durante le sue più che frequenti nottate passate in albergo, riceveva poesie inviategli dall’amico Lars Saabye Christensen dalle varie località che il poeta e scrittore norvegese era solito visitare. Dopo averle custodite per anni, il pianista ha pensato di rivestirle di musica, di affidarne l’interpretazione alla voce di Anneli Drecker eccellente vocalist norvegese, originaria della città di Tromsø, sulla scena oramai da più di vent’anni e già collaboratrice di artisti quali Jah Wobble e Hector Zazou. I titoli dei pezzi sono di per sé esplicativi: ecco quindi l’apertura affidata a “Mayflower, New York”, seguita da “Duxton, Melbourne” e giù fino al conclusivo “Schloss Elmau”. Da quanto sin qui detto risulta abbastanza chiaramente il tipo di musica che si ascolta nell’album tenendo ben presente che Ketil Bjørnstad è pianista capace di interpretare con eguale bravura e partecipazione musica classica, jazz e folk. Bjørnstad cerca quindi, il più delle volte riuscendoci perfettamente, di ricreare con la sua musica le atmosfere suggeritegli dall’amico Christensen e legate alle località visitate. Ecco l’intimismo di “L’Hotel” e di “Lutetia” legati ad una romantica e nostalgica Parigi, ecco il sapore blues di “Astor Crowne, New Orleans”, ecco l’atmosfera vagamente orientaleggiante di “Mayday Inn, Hong Kong”. Insomma un ‘altra prova di grande maestria da parte di Ketil Bjørnstad che ha operato anche una scelta felicissima nel chiamare accanto a sé una interprete come Anneli Drecker capace di dare un peso specifico ad ogni singola sillaba, ad ogni parola, rendendo così giustizia a dei testi di per sé quanto mai significativi.
La genesi di questo toccante album è illustrata chiaramente dallo stesso Bjørnstad nelle note che accompagnano il CD laddove ci racconta che, durante le sue più che frequenti nottate passate in albergo, riceveva poesie inviategli dall’amico Lars Saabye Christensen dalle varie località che il poeta e scrittore norvegese era solito visitare. Dopo averle custodite per anni, il pianista ha pensato di rivestirle di musica, di affidarne l’interpretazione alla voce di Anneli Drecker eccellente vocalist norvegese, originaria della città di Tromsø, sulla scena oramai da più di vent’anni e già collaboratrice di artisti quali Jah Wobble e Hector Zazou. I titoli dei pezzi sono di per sé esplicativi: ecco quindi l’apertura affidata a “Mayflower, New York”, seguita da “Duxton, Melbourne” e giù fino al conclusivo “Schloss Elmau”. Da quanto sin qui detto risulta abbastanza chiaramente il tipo di musica che si ascolta nell’album tenendo ben presente che Ketil Bjørnstad è pianista capace di interpretare con eguale bravura e partecipazione musica classica, jazz e folk. Bjørnstad cerca quindi, il più delle volte riuscendoci perfettamente, di ricreare con la sua musica le atmosfere suggeritegli dall’amico Christensen e legate alle località visitate. Ecco l’intimismo di “L’Hotel” e di “Lutetia” legati ad una romantica e nostalgica Parigi, ecco il sapore blues di “Astor Crowne, New Orleans”, ecco l’atmosfera vagamente orientaleggiante di “Mayday Inn, Hong Kong”. Insomma un ‘altra prova di grande maestria da parte di Ketil Bjørnstad che ha operato anche una scelta felicissima nel chiamare accanto a sé una interprete come Anneli Drecker capace di dare un peso specifico ad ogni singola sillaba, ad ogni parola, rendendo così giustizia a dei testi di per sé quanto mai significativi.
Art Blakey – “Moanin” – Green Corner – 100901 2 CD
 In altra occasione ho illustrato il perché molte case discografiche, in un certo periodo del passato, abbiano preferito immettere sul mercato copie in versione sia stereo sia mono. Ecco, questi due album appartengono per l’appunto a questa serie di registrazioni effettuate ad Hackensack il 30 ottobre del 1958. More solito, in questi casi il doppio album conserva intatto il suo valore sia storico sia musicale. Dal primo punto di vista è la prima volta che la versione mono viene prodotta su CD. Quanto alla valenza della musica non credo ci sia chi dubita della stessa. Si tratta, in effetti, della terza edizione dei Jazz Messengers comprendente artisti quali Lee Morgan alla tromba, Benny Golson nella duplice veste di tenorista e compositore (molti dei brani sono suoi), Bobby Timmons al piano e Jymie Merritt al contrabbasso. Come bonus le sole due alternate tracks tratte dalla seduta del 30 ottobre 1958 e non comprese nell’originario LP, e altri quattro brani registrati dalla stessa formazione durante un concerto all’Olympia di Parigi nel novembre, dicembre dello stesso 1958. Esaurite queste delucidazioni, resta ben poco da dire se non che si tratta di registrazioni davvero imperdibili; basti citare l’entusiasmante “Moanin” di Bobby Timmons e la trascinante “Blues March” di Benny Golson così aderente allo spirito delle marching band di New Orleans. Insomma una ghiotta occasione per chi ancora non avesse queste registrazioni nella propria discoteca.
In altra occasione ho illustrato il perché molte case discografiche, in un certo periodo del passato, abbiano preferito immettere sul mercato copie in versione sia stereo sia mono. Ecco, questi due album appartengono per l’appunto a questa serie di registrazioni effettuate ad Hackensack il 30 ottobre del 1958. More solito, in questi casi il doppio album conserva intatto il suo valore sia storico sia musicale. Dal primo punto di vista è la prima volta che la versione mono viene prodotta su CD. Quanto alla valenza della musica non credo ci sia chi dubita della stessa. Si tratta, in effetti, della terza edizione dei Jazz Messengers comprendente artisti quali Lee Morgan alla tromba, Benny Golson nella duplice veste di tenorista e compositore (molti dei brani sono suoi), Bobby Timmons al piano e Jymie Merritt al contrabbasso. Come bonus le sole due alternate tracks tratte dalla seduta del 30 ottobre 1958 e non comprese nell’originario LP, e altri quattro brani registrati dalla stessa formazione durante un concerto all’Olympia di Parigi nel novembre, dicembre dello stesso 1958. Esaurite queste delucidazioni, resta ben poco da dire se non che si tratta di registrazioni davvero imperdibili; basti citare l’entusiasmante “Moanin” di Bobby Timmons e la trascinante “Blues March” di Benny Golson così aderente allo spirito delle marching band di New Orleans. Insomma una ghiotta occasione per chi ancora non avesse queste registrazioni nella propria discoteca.
Rainer Böhm – “Hydor” Piano Works XII
 La ACT può vantare una lunga e ricca tradizione in fatto di pianisti dal momento che per l’etichetta hanno inciso personaggi internazionali del calibro di Joachim Kuhn, Esbjorn Svensson e Michael Wollny… tanto per citare qualche nome. Coerentemente con tale impostazione, il produttore Siggi Loch ha creato una collana di album dedicati al piano solo, “Piano Works”, giunta al suo tredicesimo volume. Il nuovo protagonista è Rainer Böhm. Nato a Ravensburg nel sud della Germania nel 1977, Böhm è considerato dai critici tedeschi uno dei migliori pianisti jazz del suo Paese, ma non ha ancora raggiunto una notorietà a livello internazionale. Ecco, quindi, una buona occasione per farne conoscenza. Il suo è, in effetti, un pianismo maturo, consapevole, un linguaggio che coniuga brillantemente una eccellente tecnica pianistica con notevoli capacità espressive. Frutto, tutto ciò, non solo di una squisita sensibilità ma anche di un approfondito studio della letteratura pianistica globalmente intesa. In effetti Böhm si è fatto conoscere in patria soprattutto per gli adattamenti in termini jazzistici dei grandi classici quali Verdi, Wagner, Beethoven e Bach. In questo album Böhm si fa notare anche come eccellente compositore (tutti i tredici brani del disco sono a sua firma), e proprio attraverso questi pezzi l’artista evidenzia la sua capacità di assorbire molto di ciò che i grandi pianisti del passato ci hanno lasciato. Così nel suo stile è possibile rintracciare echi della tradizione classica così come del jazz soprattutto di quello nord-europeo senza che tutto ciò si ripercuota minimamente sull’originalità della proposta.
La ACT può vantare una lunga e ricca tradizione in fatto di pianisti dal momento che per l’etichetta hanno inciso personaggi internazionali del calibro di Joachim Kuhn, Esbjorn Svensson e Michael Wollny… tanto per citare qualche nome. Coerentemente con tale impostazione, il produttore Siggi Loch ha creato una collana di album dedicati al piano solo, “Piano Works”, giunta al suo tredicesimo volume. Il nuovo protagonista è Rainer Böhm. Nato a Ravensburg nel sud della Germania nel 1977, Böhm è considerato dai critici tedeschi uno dei migliori pianisti jazz del suo Paese, ma non ha ancora raggiunto una notorietà a livello internazionale. Ecco, quindi, una buona occasione per farne conoscenza. Il suo è, in effetti, un pianismo maturo, consapevole, un linguaggio che coniuga brillantemente una eccellente tecnica pianistica con notevoli capacità espressive. Frutto, tutto ciò, non solo di una squisita sensibilità ma anche di un approfondito studio della letteratura pianistica globalmente intesa. In effetti Böhm si è fatto conoscere in patria soprattutto per gli adattamenti in termini jazzistici dei grandi classici quali Verdi, Wagner, Beethoven e Bach. In questo album Böhm si fa notare anche come eccellente compositore (tutti i tredici brani del disco sono a sua firma), e proprio attraverso questi pezzi l’artista evidenzia la sua capacità di assorbire molto di ciò che i grandi pianisti del passato ci hanno lasciato. Così nel suo stile è possibile rintracciare echi della tradizione classica così come del jazz soprattutto di quello nord-europeo senza che tutto ciò si ripercuota minimamente sull’originalità della proposta.
Jakob Bro – “Bay Of Rainbows” – ECM 2618
 L’album è il frutto delle registrazioni effettuate nel luglio del 2017 al club Jazz Standard di New York; protagonista il trio del chitarrista danese Jakob Bro (1978), con il bassista Thomas Morgan e il batterista Joey Baron. L’album assume una doppia importanza nella vita di Bro in quanto da un lato è il coronamento di un sogno più volte espresso dall’artista (registrare un album live a New York), dall’altro è il primo disco live da lui registrato per la ECM. Bro non si lascia sfuggire l’occasione e dà vita ad un album eccellente confermando, anche come autore (tutte e sei le tracce dell’album sono sue composizioni), quanto già di buono si era ascoltato nelle sue precedenti produzioni: una musica nitida, costruita quasi per sottrazione, con la chitarra del leader a imbastire eteree trame sonore ben sostenute da una sezione ritmica esemplare per leggerezza e pertinenza. Così la musica si sviluppa come su un tappeto di nuvole, sorvolando diversi territori senza atterrare completamente. L’andamento generale è quindi piuttosto rarefatto anche se in alcuni brani assume una più concreta matericità: si ascolti, ad esempio, l’unico inedito “Dug” dove l’accompagnamento sostenuto della sezione ritmica si coniuga con una fraseggio chitarristico sicuramente non etereo come nei precedenti brani, ai limiti del free, oseremmo dire. Sottolineavamo come “Dug” fosse l’unico inedito in quanto gli altri brani erano già stati incisi da Bro nei suoi precedenti album. Tornando a “Bay Of Rainbows” il brano che più ci ha colpiti è stato “Evening Song” (già presente in “Balladeering”, Loveland Records, inciso nel 2008 ma pubblicato l’anno successivo in cui Bro capeggiava una all stars comprendente l’altro chitarrista Bill Frisell, Lee Konitz sax alto, Ben Street basso e Paul Motian batteria). L’album si chiude con una differente versione del brano d’apertura, “Mild”.
L’album è il frutto delle registrazioni effettuate nel luglio del 2017 al club Jazz Standard di New York; protagonista il trio del chitarrista danese Jakob Bro (1978), con il bassista Thomas Morgan e il batterista Joey Baron. L’album assume una doppia importanza nella vita di Bro in quanto da un lato è il coronamento di un sogno più volte espresso dall’artista (registrare un album live a New York), dall’altro è il primo disco live da lui registrato per la ECM. Bro non si lascia sfuggire l’occasione e dà vita ad un album eccellente confermando, anche come autore (tutte e sei le tracce dell’album sono sue composizioni), quanto già di buono si era ascoltato nelle sue precedenti produzioni: una musica nitida, costruita quasi per sottrazione, con la chitarra del leader a imbastire eteree trame sonore ben sostenute da una sezione ritmica esemplare per leggerezza e pertinenza. Così la musica si sviluppa come su un tappeto di nuvole, sorvolando diversi territori senza atterrare completamente. L’andamento generale è quindi piuttosto rarefatto anche se in alcuni brani assume una più concreta matericità: si ascolti, ad esempio, l’unico inedito “Dug” dove l’accompagnamento sostenuto della sezione ritmica si coniuga con una fraseggio chitarristico sicuramente non etereo come nei precedenti brani, ai limiti del free, oseremmo dire. Sottolineavamo come “Dug” fosse l’unico inedito in quanto gli altri brani erano già stati incisi da Bro nei suoi precedenti album. Tornando a “Bay Of Rainbows” il brano che più ci ha colpiti è stato “Evening Song” (già presente in “Balladeering”, Loveland Records, inciso nel 2008 ma pubblicato l’anno successivo in cui Bro capeggiava una all stars comprendente l’altro chitarrista Bill Frisell, Lee Konitz sax alto, Ben Street basso e Paul Motian batteria). L’album si chiude con una differente versione del brano d’apertura, “Mild”.
Miles Davis – “Jazz Track” – Poll Winners 27385
 Prima di illustrare brevemente il contenuto di questo album, credo sia importante sottolineare il perché vi sto proponendo molti album della serie “Poll Winners”. In effetti l’etichetta “Poll Winners” dedica il proprio catalogo alle ristampe di quei titoli recensiti dalla rivista ‘Down Beat’ con il massimo dei voti (cinque stelle). Tale premiazione è talmente significativa e importante che molti di questi album diventano spesso dei veri classici. Le nuove edizioni presentano la versione integrale degli album originali a cinque stelle***** con l’aggiunta di brani di altri titoli dello stesso autore all’apice del proprio successo artistico. La raccolta comprende, quindi, vere e proprie pietre miliari della storia del jazz prodotte dai più grandi musicisti del genere, tra cui va senza dubbio annoverato questo “Jazz Track” che nelle sue componenti essenziali ha costituito una parte essenziale nella storia di Miles Davis e quindi del jazz nella sua interezza. Il CD è idealmente suddiviso in tre parti: i primi dieci brani contengono la colonna sonora del film francese “Ascensore per il patibolo” registrata nel dicembre 1957 a Parigi da Miles Davis con il batterista statunitense Kenny Clarke e altri due musicisti locali capitanati dal pianista René Urtreger (Barney Wilen sax tenore e Pierre Michelot basso). I successivi quattro brani sono tratti dalle sedute di registrazione del 26 maggio del 1958 quando Miles Davis rinnovò il suo sestetto con Bill Evans al posto di Red Garland e la riammissione nel gruppo del contralto di Julian Cannonball Adderley che veniva così ad affiancare il sax tenore di John Coltrane; la sezione ritmica era completata dal batterista Jimmy Cobb al posto di Philly Joe Jones e da Paul Chambers al basso. Gli ultimi 3 sono bonus e provengono dalla seduta del 16 marzo 1956, protagonista un quintetto con Davis, Sonny Rollins sassofono tenore, Tommy Flanagan pianoforte, Paul Chambers contrabbasso, Art Taylor – batteria
Prima di illustrare brevemente il contenuto di questo album, credo sia importante sottolineare il perché vi sto proponendo molti album della serie “Poll Winners”. In effetti l’etichetta “Poll Winners” dedica il proprio catalogo alle ristampe di quei titoli recensiti dalla rivista ‘Down Beat’ con il massimo dei voti (cinque stelle). Tale premiazione è talmente significativa e importante che molti di questi album diventano spesso dei veri classici. Le nuove edizioni presentano la versione integrale degli album originali a cinque stelle***** con l’aggiunta di brani di altri titoli dello stesso autore all’apice del proprio successo artistico. La raccolta comprende, quindi, vere e proprie pietre miliari della storia del jazz prodotte dai più grandi musicisti del genere, tra cui va senza dubbio annoverato questo “Jazz Track” che nelle sue componenti essenziali ha costituito una parte essenziale nella storia di Miles Davis e quindi del jazz nella sua interezza. Il CD è idealmente suddiviso in tre parti: i primi dieci brani contengono la colonna sonora del film francese “Ascensore per il patibolo” registrata nel dicembre 1957 a Parigi da Miles Davis con il batterista statunitense Kenny Clarke e altri due musicisti locali capitanati dal pianista René Urtreger (Barney Wilen sax tenore e Pierre Michelot basso). I successivi quattro brani sono tratti dalle sedute di registrazione del 26 maggio del 1958 quando Miles Davis rinnovò il suo sestetto con Bill Evans al posto di Red Garland e la riammissione nel gruppo del contralto di Julian Cannonball Adderley che veniva così ad affiancare il sax tenore di John Coltrane; la sezione ritmica era completata dal batterista Jimmy Cobb al posto di Philly Joe Jones e da Paul Chambers al basso. Gli ultimi 3 sono bonus e provengono dalla seduta del 16 marzo 1956, protagonista un quintetto con Davis, Sonny Rollins sassofono tenore, Tommy Flanagan pianoforte, Paul Chambers contrabbasso, Art Taylor – batteria
Mathias Eick – “Ravensburg” – ECM 2584
 Tutto all’insegna della ricerca melodica questo album del trombettista norvegese Mathias Eick che dopo aver collaborato con alcune delle formazioni norvegesi più interessanti e innovative (Motif, JagaJazzist, Motorpsycho and Lars Horntvedt) è approdato in casa ECM dando vita a questo suo quarto album da leader (dopo “The Door”, “Skala” e “Midwest”). La più importante novità di questo CD è data dalla presenza del violinista, anch’egli norvegese, Håkon Aase, messosi già in luce collaborando con la formazione di Thomas Strønen. In effetti tromba e violino dialogano magnificamente conferendo al gruppo un sound del tutto particolare e ben sostenuto dal resto del gruppo formato da Andreas Ulvo piano, Audun Erlien basso elettrico e due batteristi, Torstein Lofthus e Helge Andreas Norbakken (quest’ultimo anche alle percussioni) che interagiscono con sapiente equilibrio. Ma il protagonista resta senza alcun dubbio Mathias: il suo linguaggio appare allo stesso tempo antico (molti e ben individuabili i richiami al jazz propriamente detto) e attuale (nel suo stile evidenti le influenze da un canto della musica classica contemporanea, dall’altro della new age intesa soprattutto come un genere in cui si mescolano echi provenienti da culture diverse come quelle indiane, ebree e magrebine)… cui si aggiungono echi della cultura scandinava presenti nella maggior parte dei musicisti nordici. Insomma un universo di riferimento assai vasto e variegato che Eick padroneggia assai bene anche dal punto di vista compositivo dal momento che tutti e otto i brani in programma sono dovuti alla sua penna. Brani che, ferma quella ricerca melodica cui prima si faceva riferimento, alternano atmosfere intimiste, oniriche a climi più materici, terrene.
Tutto all’insegna della ricerca melodica questo album del trombettista norvegese Mathias Eick che dopo aver collaborato con alcune delle formazioni norvegesi più interessanti e innovative (Motif, JagaJazzist, Motorpsycho and Lars Horntvedt) è approdato in casa ECM dando vita a questo suo quarto album da leader (dopo “The Door”, “Skala” e “Midwest”). La più importante novità di questo CD è data dalla presenza del violinista, anch’egli norvegese, Håkon Aase, messosi già in luce collaborando con la formazione di Thomas Strønen. In effetti tromba e violino dialogano magnificamente conferendo al gruppo un sound del tutto particolare e ben sostenuto dal resto del gruppo formato da Andreas Ulvo piano, Audun Erlien basso elettrico e due batteristi, Torstein Lofthus e Helge Andreas Norbakken (quest’ultimo anche alle percussioni) che interagiscono con sapiente equilibrio. Ma il protagonista resta senza alcun dubbio Mathias: il suo linguaggio appare allo stesso tempo antico (molti e ben individuabili i richiami al jazz propriamente detto) e attuale (nel suo stile evidenti le influenze da un canto della musica classica contemporanea, dall’altro della new age intesa soprattutto come un genere in cui si mescolano echi provenienti da culture diverse come quelle indiane, ebree e magrebine)… cui si aggiungono echi della cultura scandinava presenti nella maggior parte dei musicisti nordici. Insomma un universo di riferimento assai vasto e variegato che Eick padroneggia assai bene anche dal punto di vista compositivo dal momento che tutti e otto i brani in programma sono dovuti alla sua penna. Brani che, ferma quella ricerca melodica cui prima si faceva riferimento, alternano atmosfere intimiste, oniriche a climi più materici, terrene.
Sheila Jordan – “Lucky to be me” – abeat 185
 Sheila Jordan è una di quelle rare artiste di cui parlano tutti bene: pubblico, critica, colleghi. E questo album non fa certo eccezione alla regola. La vocalist americana, che raggiunse una fama internazionale aggiungendo le parole alla musica di Charlie Parker, è amata ed apprezzata anche in Italia dove ha registrato live questo album l’11 novembre del 2016 a Castellanza (MI) accompagnata da Attilio Zanchi al contrabbasso, Roberto Cipelli al piano e Tommaso Bradascio alla batteria. Da quanto sin qui detto si deduce facilmente che si tratta di un ottimo album che mette in luce da un canto le indiscusse qualità vocali di Sheila, dall’altro la capacità dei musicisti italiani di stare a fianco, validamente, anche delle più importanti stelle del firmamento jazzistico internazionale. E la valenza di Zanchi e compagni è testimoniata dalla stessa Jordan la quale, riferendosi al titolo dell’album, afferma di aver “chiamato questo disco ‘Lucky to be me’ non solo perché è uno dei brani, ma perché mi sento veramente fortunata nella vita ad avere amici e musicisti così meravigliosi, che si divertono a fare musica con me, ad organizzare tour e registrazioni. Sono come una famiglia e mi sento fortunata ad averli con me in questa vita”. Ed è bello avvertire come un’artista che nella sua vita ha conosciuto tantissimi successi, sia ancora sorretta da un tale entusiasmo ed una così grande voglia di cantare, di appassionare il pubblico. E la cosa risulta ancora più straordinaria ove si tenga conto che la Jordan, nata nel 1928, a Detroit, Michigan, frequenta le scene da molti anni avendo debuttato da bambina: poco più che adolescente lavorava già nei club di Detroit. Da allora non si più fermata inanellando una serie di performances – sia live sia su disco – davvero straordinarie. E per quei quattro o cinque che ancora non la conoscessero, ecco questo album è un’ottima occasione per avere un piccolo saggio di chi è Sheila Jordan.
Sheila Jordan è una di quelle rare artiste di cui parlano tutti bene: pubblico, critica, colleghi. E questo album non fa certo eccezione alla regola. La vocalist americana, che raggiunse una fama internazionale aggiungendo le parole alla musica di Charlie Parker, è amata ed apprezzata anche in Italia dove ha registrato live questo album l’11 novembre del 2016 a Castellanza (MI) accompagnata da Attilio Zanchi al contrabbasso, Roberto Cipelli al piano e Tommaso Bradascio alla batteria. Da quanto sin qui detto si deduce facilmente che si tratta di un ottimo album che mette in luce da un canto le indiscusse qualità vocali di Sheila, dall’altro la capacità dei musicisti italiani di stare a fianco, validamente, anche delle più importanti stelle del firmamento jazzistico internazionale. E la valenza di Zanchi e compagni è testimoniata dalla stessa Jordan la quale, riferendosi al titolo dell’album, afferma di aver “chiamato questo disco ‘Lucky to be me’ non solo perché è uno dei brani, ma perché mi sento veramente fortunata nella vita ad avere amici e musicisti così meravigliosi, che si divertono a fare musica con me, ad organizzare tour e registrazioni. Sono come una famiglia e mi sento fortunata ad averli con me in questa vita”. Ed è bello avvertire come un’artista che nella sua vita ha conosciuto tantissimi successi, sia ancora sorretta da un tale entusiasmo ed una così grande voglia di cantare, di appassionare il pubblico. E la cosa risulta ancora più straordinaria ove si tenga conto che la Jordan, nata nel 1928, a Detroit, Michigan, frequenta le scene da molti anni avendo debuttato da bambina: poco più che adolescente lavorava già nei club di Detroit. Da allora non si più fermata inanellando una serie di performances – sia live sia su disco – davvero straordinarie. E per quei quattro o cinque che ancora non la conoscessero, ecco questo album è un’ottima occasione per avere un piccolo saggio di chi è Sheila Jordan.
Janne Mark – “Pilgrim” – ACT 9735-2
 Questo “Pilgrim” ci presenta la vocalist danese Janne Mark in una sorta di nazionale danese completata dal pianista Henrik Gunde Pedersen, dal bassista Esben Eyermann, dal batterista Jesper Uno Kofoe, dal chitarrista ‘lap steel’ Gustaf Ljunggren cui si affianca, per esplicita volontà della vocalist, il trombettista norvegese Arve Henriksen.
Questo “Pilgrim” ci presenta la vocalist danese Janne Mark in una sorta di nazionale danese completata dal pianista Henrik Gunde Pedersen, dal bassista Esben Eyermann, dal batterista Jesper Uno Kofoe, dal chitarrista ‘lap steel’ Gustaf Ljunggren cui si affianca, per esplicita volontà della vocalist, il trombettista norvegese Arve Henriksen.
L’album ha una sua specificità che lo pone al di fuori di qualsivoglia schema con cui al difuori della Scandinavia siamo abituati ad ascoltare la musica jazz. Ciò perché Janne Mark scrive, oggi, inni, cosa assolutamente inconsueta…da noi ma del tutto normale al Nord ove questo genere ha una grande importanza costituendo la fonte di molte canzoni. In particolare in Danimarca la tradizione dell’inno è sostanzialmente agraria in quanto la maggior parte della popolazione viveva in campagna e quindi gli inni venivano da quella realtà. Oggi le cose sono ovviamente cambiate e la Mark scrive musica in cui alla tradizione agraria aggiunge l’input derivante dalla realtà urbana; per completare il tutto la vocalist rivolge lo sguardo anche al jazz (proprio per questo ha chiamato Arve Henriksen) giungendo ad un unicum davvero irripetibile. Ed è la stessa Mark ad illustrare il senso della sua poetica affermando che “la musica di Pilgrim è scritta per quanti non hanno alcuna familiarità con la chiesa ma anche per quanti, viceversa, conoscono assai bene la religione”. Ed in effetti ascoltando le dieci tracce dell’album, a farla da padrona è una musica riflessiva, che trasporta l’ascoltatore in una dimensione ‘altra’, lontana dalle problematiche dell’oggi, della vita di tutti i giorni, trasmettendo un senso di pace che difficilmente ritroviamo nelle espressioni artistiche attuali. Insomma un album che ci fa conoscere una musicista di grande spessore, affascinante, matura, dotata di una squisita sensibilità e di una grande capacità di scrittura e ci conferma Arve Henriksen come una delle personalità più spiccate dell’odierno panorama jazzistico del Nord Europa.
Thelonious Monk Quartet – “Monk’s Dream” – Green Corner 100899 2 CD
 Anche questo doppio album fa parte della serie “The Stereo & Mono Versions” cui si faceva cenno a proposito dell’album di Art Blakey. Questa volta il protagonista è Thelonious Monk alla testa del suo celeberrimo quartetto con Charlie Rouse al sax tenore, John Ore al basso e Frankie Dunlop alla batteria. In programma il primo LP che Monk, dopo la fine della sua collaborazione con la Riverside Records, incise per la Columbia. “Monk’s Dream”, prodotto da Teo Macero, registrato alla fine del 1962 e pubblicato nel 1963, divenne nel corso degli anni l’album più venduto di Monk e fu determinante nella scelta del Times Magazine di dedicargli una copertina nel 1964. Originariamente l’LP conteneva otto pezzi, di cui cinque originali di Monk, cui si aggiungono “Body and Soul” di Green- Heyman-Sour-Eyton, “Just a Gigolo” di Caesar-Brammer-Casucci e “Sweet and Lovely” di Arnheim-Tobias-Lemare; le esecuzioni sono affidate al quartetto eccezion fatta per “Just a Gigolò” e “Body and Soul” affidate al piano solo di Monk. In questa riedizione come bonus troviamo quattro ‘alternative trakes’ tratte dalle stesse sedute di registrazione dell’ottobre-novembre del 1962, le prime versioni in studio di Monk della maggior parte dei brani dell’album e una versione per pianoforte dal vivo del 1961 di “Body and Soul”. A Questo puto credo non ci sia molto altro da aggiungere: si tratta di grande musica, di alcune delle pietre miliari del jazz che ci raccontano del genio di un grandissimo pianista e compositore quale Thelonious Monk.
Anche questo doppio album fa parte della serie “The Stereo & Mono Versions” cui si faceva cenno a proposito dell’album di Art Blakey. Questa volta il protagonista è Thelonious Monk alla testa del suo celeberrimo quartetto con Charlie Rouse al sax tenore, John Ore al basso e Frankie Dunlop alla batteria. In programma il primo LP che Monk, dopo la fine della sua collaborazione con la Riverside Records, incise per la Columbia. “Monk’s Dream”, prodotto da Teo Macero, registrato alla fine del 1962 e pubblicato nel 1963, divenne nel corso degli anni l’album più venduto di Monk e fu determinante nella scelta del Times Magazine di dedicargli una copertina nel 1964. Originariamente l’LP conteneva otto pezzi, di cui cinque originali di Monk, cui si aggiungono “Body and Soul” di Green- Heyman-Sour-Eyton, “Just a Gigolo” di Caesar-Brammer-Casucci e “Sweet and Lovely” di Arnheim-Tobias-Lemare; le esecuzioni sono affidate al quartetto eccezion fatta per “Just a Gigolò” e “Body and Soul” affidate al piano solo di Monk. In questa riedizione come bonus troviamo quattro ‘alternative trakes’ tratte dalle stesse sedute di registrazione dell’ottobre-novembre del 1962, le prime versioni in studio di Monk della maggior parte dei brani dell’album e una versione per pianoforte dal vivo del 1961 di “Body and Soul”. A Questo puto credo non ci sia molto altro da aggiungere: si tratta di grande musica, di alcune delle pietre miliari del jazz che ci raccontano del genio di un grandissimo pianista e compositore quale Thelonious Monk.
Wolfgang Muthspiel – “Where The River Goes” – ECM 2610
 Questo album è la logica prosecuzione di “Rising Grace” pubblicato nel 2016; non a caso la formazione è quasi identica dal momento che accanto al chitarrista austriaco ritroviamo Brad Mehldau al pianoforte, Ambrose Akinmusire alla tromba e Larry Grenadier al contrabbasso mentre Eric Harland alla batteria sostituisce Brian Blade.
Questo album è la logica prosecuzione di “Rising Grace” pubblicato nel 2016; non a caso la formazione è quasi identica dal momento che accanto al chitarrista austriaco ritroviamo Brad Mehldau al pianoforte, Ambrose Akinmusire alla tromba e Larry Grenadier al contrabbasso mentre Eric Harland alla batteria sostituisce Brian Blade.
Ma, come si dice, cambiando l’ordine dei fattori il prodotto non cambia per cui la musica si mantiene su livelli di assoluta eccellenza grazie, soprattutto, alla valenza del gruppo in quanto tale. Non si tratta, cioè, di cinque grandi musicisti che messi assieme producono buona musica dato il loro peso specifico individuale, ma di cinque artisti che decidono di unirsi per dar vita a qualcosa di nuovo, qualcosa che abbia una propria identità senza per questo trascurare il talento di ognuno. Il tutto impreziosito dalle capacità compositive del leader chitarrista che firma tutte le composizioni in programma eccezion fatta per “Blueshead” di Mehldau e “Clearing” improvvisazione collettiva dell’intero gruppo. E l’improvvisazione non è certo elemento secondario in queste registrazioni caratterizzate da un eccellente equilibrio tra parti scritte e spazio lasciato all’estro dei singoli. Ecco ad esempio il contrabbasso di Grenadier impegnato in un trascinante assolo nel già citato “Blueshead” mentre Muthspiel evidenzia il proprio talento in tutti i brani con una menzione particolare per il pezzo di chiusura, “Panorama”. Ma è l’atmosfera generale del disco che incanta, un’atmosfera in cui la bellezza della linea melodica si impone su tutto grazie soprattutto a Brad Mehldau e Ambrose Akinmusire che riescono ad interpretare al meglio le intenzioni del leader-compositore.
Barre Phillips – “End To End” – ECM 2575
 Un album di solo contrabbasso non è certo di facile ascolto anche se ad eseguirlo è un fuoriclasse come Barre Phillips. In buona sostanza si tratta dell’ennesima prova senza rete di uno dei più grandi solisti di tutti i tempi, un artista che, ad onta dei suoi ottantatre anni, pur non avendo alcunché da dimostrare, si lancia in una impresa temeraria come questa. D’altro canto chi conosce Barre Phillips, chi ha imparato ad apprezzarlo negli anni anche attraverso le sue numerose collaborazioni con musicisti d’avanguardia quali Dave Holland, Paul Bley e Evan Parker, non si stupirà più di tanto nel constatare come Barre abbia deciso di imbarcarsi in questa ardua operazione. Risultato? Certo molto dipende da come si ascolta questo tipo di musica: per i tradizionalisti sarà d’obbligo storcere il naso, per chi preferisce stilemi più all’avanguardia si tratta di un’opera assolutamente straordinaria. Barre evidenzia ancora una volta non solo una tecnica sopraffina ma un rapporto quasi simbiotico con lo strumento che lo porta ad esprimersi compiutamente nei tredici brani in repertorio. Quindi la necessità da parte dell’ascoltare di immergersi totalmente nell’universo sonoro immaginato da Phillips per gustarne appieno ogni minimo risvolto e comprendere ciò che l’album rappresenta per il contrabbassista. Al riguardo è lo stesso artista, nelle note di copertina che accompagnano l’album, a chiarire come si tratti della “fine di un ciclo, non un riassunto, ma l’ultima pagina di un diario iniziato cinquant’anni fa”. L’album è diviso in tre parti: “Quest” (comprendente i primi cinque brani); “Inner Door” (con i successivi quattro) e “Outer Window” (gli ultimi quattro). Nonostante la presenza di un unico strumento, le atmosfere sono assai variegate passando da momenti lirici ad altri caratterizzati da una maggiore fisicità con in primo piano sempre tecnica ed espressività
Un album di solo contrabbasso non è certo di facile ascolto anche se ad eseguirlo è un fuoriclasse come Barre Phillips. In buona sostanza si tratta dell’ennesima prova senza rete di uno dei più grandi solisti di tutti i tempi, un artista che, ad onta dei suoi ottantatre anni, pur non avendo alcunché da dimostrare, si lancia in una impresa temeraria come questa. D’altro canto chi conosce Barre Phillips, chi ha imparato ad apprezzarlo negli anni anche attraverso le sue numerose collaborazioni con musicisti d’avanguardia quali Dave Holland, Paul Bley e Evan Parker, non si stupirà più di tanto nel constatare come Barre abbia deciso di imbarcarsi in questa ardua operazione. Risultato? Certo molto dipende da come si ascolta questo tipo di musica: per i tradizionalisti sarà d’obbligo storcere il naso, per chi preferisce stilemi più all’avanguardia si tratta di un’opera assolutamente straordinaria. Barre evidenzia ancora una volta non solo una tecnica sopraffina ma un rapporto quasi simbiotico con lo strumento che lo porta ad esprimersi compiutamente nei tredici brani in repertorio. Quindi la necessità da parte dell’ascoltare di immergersi totalmente nell’universo sonoro immaginato da Phillips per gustarne appieno ogni minimo risvolto e comprendere ciò che l’album rappresenta per il contrabbassista. Al riguardo è lo stesso artista, nelle note di copertina che accompagnano l’album, a chiarire come si tratti della “fine di un ciclo, non un riassunto, ma l’ultima pagina di un diario iniziato cinquant’anni fa”. L’album è diviso in tre parti: “Quest” (comprendente i primi cinque brani); “Inner Door” (con i successivi quattro) e “Outer Window” (gli ultimi quattro). Nonostante la presenza di un unico strumento, le atmosfere sono assai variegate passando da momenti lirici ad altri caratterizzati da una maggiore fisicità con in primo piano sempre tecnica ed espressività
Antonio Sanchez & Migration – “Lines in The Sand” – Cam Jazz 7940-2
 Come ho già avuto modo di esprimere in diverse occasioni, non credo molto nella musica “politica” vale a dire in quelle espressioni musicali che ancor prima del contenuto artistico pongono in evidenza quello politico. Ma, come ogni buona regola, anche questa soffre le sue brave eccezioni e “Lines in The Sand” è una di queste. In effetti l’album per specifica ammissione dello stesso batterista, si pone come uno specifico atto d’accusa contro la politica posta in essere da Donald Trump nei confronti degli emigranti che arrivano dal Messico, terra d’origine di Sanchez. Nel libretto che accompagna l’album, Sanchez dichiara di sentirsi un uomo fortunato perché la sorte, oltre a concedergli affetti familiari e un’istruzione gli ha consentito di vivere un quarto di secolo in un Paese che ha saputo accettare il suo talento. Purtroppo gli Stati Uniti di oggi non sono quelli del 1993 quando Antonio si stabilì a New York: alla Casa Bianca è la demagogia a dettar legge. Come accennavo credo fortemente all’onestà intellettuale di Sanchez in quanto dopo aver ottenuto quattro Grammy Awards, una nomina per un Golden Globe e aver collaborato con alcuni dei più grandi jazzisti di sempre (Chick Corea, Charlie Haden, Gary Burton, Toots Thielemans, Pat Metheny tra gli altri) non ha certo bisogno di ricorrere a certi mezzucci per affermare le proprie qualità. E d’altro canto la stessa musica da lui proposta in questo “Lines in The Sand” trasuda tristezza, protesta, ferma volontà di non accettare passivamente questo stato di cose. Dal punto di vista più strettamente musicale, quello proposto da Sanchez è un mix di jazz contemporaneo, rock, elettronica e altre influenze, il tutto declinato attraverso la bellezza delle linee melodiche e un perfetto equilibrio tra sonorità acustiche e suoni elettronici. In questo ambito particolarmente efficace risulta l’affiatamento del gruppo completato da John Escreet piano e tastiere, Matt Brewer al basso, Chase Baird al sax tenore, Thana Alexa alla voce sua compagna nella musica e nella vita, cui si aggiungono in due brani Nathan Shram alla viola e Elad Kabilio al cello.
Come ho già avuto modo di esprimere in diverse occasioni, non credo molto nella musica “politica” vale a dire in quelle espressioni musicali che ancor prima del contenuto artistico pongono in evidenza quello politico. Ma, come ogni buona regola, anche questa soffre le sue brave eccezioni e “Lines in The Sand” è una di queste. In effetti l’album per specifica ammissione dello stesso batterista, si pone come uno specifico atto d’accusa contro la politica posta in essere da Donald Trump nei confronti degli emigranti che arrivano dal Messico, terra d’origine di Sanchez. Nel libretto che accompagna l’album, Sanchez dichiara di sentirsi un uomo fortunato perché la sorte, oltre a concedergli affetti familiari e un’istruzione gli ha consentito di vivere un quarto di secolo in un Paese che ha saputo accettare il suo talento. Purtroppo gli Stati Uniti di oggi non sono quelli del 1993 quando Antonio si stabilì a New York: alla Casa Bianca è la demagogia a dettar legge. Come accennavo credo fortemente all’onestà intellettuale di Sanchez in quanto dopo aver ottenuto quattro Grammy Awards, una nomina per un Golden Globe e aver collaborato con alcuni dei più grandi jazzisti di sempre (Chick Corea, Charlie Haden, Gary Burton, Toots Thielemans, Pat Metheny tra gli altri) non ha certo bisogno di ricorrere a certi mezzucci per affermare le proprie qualità. E d’altro canto la stessa musica da lui proposta in questo “Lines in The Sand” trasuda tristezza, protesta, ferma volontà di non accettare passivamente questo stato di cose. Dal punto di vista più strettamente musicale, quello proposto da Sanchez è un mix di jazz contemporaneo, rock, elettronica e altre influenze, il tutto declinato attraverso la bellezza delle linee melodiche e un perfetto equilibrio tra sonorità acustiche e suoni elettronici. In questo ambito particolarmente efficace risulta l’affiatamento del gruppo completato da John Escreet piano e tastiere, Matt Brewer al basso, Chase Baird al sax tenore, Thana Alexa alla voce sua compagna nella musica e nella vita, cui si aggiungono in due brani Nathan Shram alla viola e Elad Kabilio al cello.
Ida Sand – “My Soul Kitchen” – ACT 97362
 E’ proprio vero che la musica non conosce confini e così eccoci in Svezia per apprezzare una vocalist svedese che canta con pertinenza soul e funky. Si tratta di Ida Sand accompagnata da “Stockholm Undeground” ovvero un quintetto all stars comprendente Jesper Nordenström organo Hammond, synt e tastiere, Henrik Janson chitarra elettrica, Lars DK Danielsson basso elettrico, Per Lindvall batteria e Magnus Lindgren sax tenore e baritono, flauti e clarinetto con in più alcuni ospiti illustri tra cui Nils Landgren trombone e vocale. In repertorio brani, tra gli altri, di Al Green, Stevie Wonder, Ray Charles e The Meters cui si aggiungono alcuni original della vocalist e reinterpretazioni, sempre in chiave soul, di composizioni firmate da John Fogerty e Mike Shapiro. Il risultato, come si accennava, è ottimo in quanto la Sand aderisce perfettamente ai canoni non solo estetici della soul-music. Le sue interpretazioni sono una palese dimostrazione di come ella ami questo genere musicale riuscendo a coglierne l’intima essenza. D’alto canto bisogna riconoscere che in Svezia il soul gode di molta popolarità e che altri artisti vi si sono dedicati con successo; come non ricordare, al riguardo, quel Nils Landgren che con la sua “Funk Unit”, per esplicita ammissione della stessa Sand, ha avuto una indiscussa influenza sul suo stile vocale. Comunque tornando alla Sand, questo suo quarto album si differenzia notevolmente dai precedenti in cui aveva esplorato le vie del jazz, del blues e del folk, coronando un vecchio sogno. In ciò perfettamente coadiuvata dai musicisti scelti per accompagnarla tra cui particolarmente rilevante il ruolo di Magnus Lindgren non solo come solista ma anche come arrangiatore delle parti riservate ai fiati.
E’ proprio vero che la musica non conosce confini e così eccoci in Svezia per apprezzare una vocalist svedese che canta con pertinenza soul e funky. Si tratta di Ida Sand accompagnata da “Stockholm Undeground” ovvero un quintetto all stars comprendente Jesper Nordenström organo Hammond, synt e tastiere, Henrik Janson chitarra elettrica, Lars DK Danielsson basso elettrico, Per Lindvall batteria e Magnus Lindgren sax tenore e baritono, flauti e clarinetto con in più alcuni ospiti illustri tra cui Nils Landgren trombone e vocale. In repertorio brani, tra gli altri, di Al Green, Stevie Wonder, Ray Charles e The Meters cui si aggiungono alcuni original della vocalist e reinterpretazioni, sempre in chiave soul, di composizioni firmate da John Fogerty e Mike Shapiro. Il risultato, come si accennava, è ottimo in quanto la Sand aderisce perfettamente ai canoni non solo estetici della soul-music. Le sue interpretazioni sono una palese dimostrazione di come ella ami questo genere musicale riuscendo a coglierne l’intima essenza. D’alto canto bisogna riconoscere che in Svezia il soul gode di molta popolarità e che altri artisti vi si sono dedicati con successo; come non ricordare, al riguardo, quel Nils Landgren che con la sua “Funk Unit”, per esplicita ammissione della stessa Sand, ha avuto una indiscussa influenza sul suo stile vocale. Comunque tornando alla Sand, questo suo quarto album si differenzia notevolmente dai precedenti in cui aveva esplorato le vie del jazz, del blues e del folk, coronando un vecchio sogno. In ciò perfettamente coadiuvata dai musicisti scelti per accompagnarla tra cui particolarmente rilevante il ruolo di Magnus Lindgren non solo come solista ma anche come arrangiatore delle parti riservate ai fiati.
Woody Shaw – “Tokyo ‘81” – Elemental 5990429
 E’ il 7 dicembre 1981 e il trombettista-flicornista Woody Shaw si esibisce a Tokyo con
E’ il 7 dicembre 1981 e il trombettista-flicornista Woody Shaw si esibisce a Tokyo con
Steve Turre trombone e percussioni, Mulgrew Miller piano, Stafford James basso e Tony Reedus batteria. La session viene registrata e adesso è a disposizione di tutti noi. A chi conosce minimamente la storia del jazz, non sfugge l’importanza di Woody Shaw artista che forse non ha ottenuto tutti i riconoscimenti che avrebbe meritato. Nonostante una vita piuttosto breve – scomparve all’età di 45 anni – Woody è considerato da buona parte della critica l’ultimo musicista che sia riuscito ad elaborare un nuovo linguaggio improvvisativo sulla tromba. E queste registrazioni ne sono l’ennesima conferma. Woody suona magnificamente, senza un attimo di stanca, dando nuova linfa a pezzi già ultra battuti. Si ascolti, ad esempio, con quanta maestria interpreti il celeberrimo “’Round Midnight” di Monk perfettamente coadiuvato dal suo quartetto che evidenzia un’intesa difficile da non aggettivare come ‘perfetta’. Turre e Miller seguono le improvvisazioni del leader con il pianista che esplora tutte le possibilità armoniche insite nel brano e Turre che sfoggia il suo solismo così fluido e spesso contrastante con le asperità del linguaggio di Shaw. L’album presenta sette tracce di cui l’ultima, “Sweet Love Of Mine” dello stesso Shaw, registrata live a L’Aia il 14 luglio del 1985 dalla Paris Reunion Band comprendente, oltre al leader, Jimmy Woode al basso, Billy Brooks alla batteria, Kenny Drew al piano, Johnny Griffin al sax tenore, Nathan Davis al sax tenore e soprano, Slide Hampton al trombone e Dizzy Reece alla tromba.
Omar Sosa, Yilian Cañizares – “Aguas” – Otà Records
 Il pianista cubano Omar Sosa si è fatto conoscere dal pubblico italiano grazie alle collaborazioni con Paolo Fresu. Abbiamo, quindi, imparato ad apprezzare un musicista colto, sensibile, che lavora quasi per sottrazione, un musicista che mai fa ricorso a virtuosismi puntando, piuttosto, a trasmettere stati d’animo, emozioni. Di qui un pianismo che accarezza le melodie con un andamento ritmico solo all’apparenza semplice ma in realtà mai banale e del tutto coerente con il contesto in cui si inserisce. E questo nuovo album non fa che confermare queste doti. Omar, nell’occasione, suona con la violinista e vocalist Yilian Cañizares, nata a L’Avana nel 1981, e il percussionista Inor Sotolongo, nato anch’egli a L’Avana nel 1971, ma oggi residente in Francia sin dal 2001. Omar e Yilian si sono conosciuti nel corso delle rispettive tournée nel vecchio continente e non c’è voluto molto per scoprire un idem sentire che li ha condotti alla realizzazione di questo album. In repertorio undici tracce scritte da Omar Sosa e Yilian Cañizares e riflette appieno le vedute musicali dei due artisti. Così se Omar Sosa non nasconde la nostalgia per la sua isola rivendicando l’importanza delle tradizioni musicali cubane da cui deriva la sua musica “contemplativa, piena di umiltà, dignità e pace”, la vocalist pone l’accento sulla necessità di “mettere da parte te stessa e il tuo ego” per far sì che la musica possa prendere vita. Così quanto si ascolta in “Aguas” è un mix perfettamente riuscito tra il jazz e la musica tradizionale cubana con qualche rimando anche alla musica classica. Sosa disegna un tappeto melodico- ritmico di rara e moderna lucentezza mentre la Cañizares dimostra di saper improvvisare sia con la voce sia con il violino. Prezioso anche il lavoro del percussionista Sotolongo mai invadente. Tra i vari brani particolarmente rilevanti “Milonga” impreziosito da un assolo di Sosa e ““La Respiracion”
Il pianista cubano Omar Sosa si è fatto conoscere dal pubblico italiano grazie alle collaborazioni con Paolo Fresu. Abbiamo, quindi, imparato ad apprezzare un musicista colto, sensibile, che lavora quasi per sottrazione, un musicista che mai fa ricorso a virtuosismi puntando, piuttosto, a trasmettere stati d’animo, emozioni. Di qui un pianismo che accarezza le melodie con un andamento ritmico solo all’apparenza semplice ma in realtà mai banale e del tutto coerente con il contesto in cui si inserisce. E questo nuovo album non fa che confermare queste doti. Omar, nell’occasione, suona con la violinista e vocalist Yilian Cañizares, nata a L’Avana nel 1981, e il percussionista Inor Sotolongo, nato anch’egli a L’Avana nel 1971, ma oggi residente in Francia sin dal 2001. Omar e Yilian si sono conosciuti nel corso delle rispettive tournée nel vecchio continente e non c’è voluto molto per scoprire un idem sentire che li ha condotti alla realizzazione di questo album. In repertorio undici tracce scritte da Omar Sosa e Yilian Cañizares e riflette appieno le vedute musicali dei due artisti. Così se Omar Sosa non nasconde la nostalgia per la sua isola rivendicando l’importanza delle tradizioni musicali cubane da cui deriva la sua musica “contemplativa, piena di umiltà, dignità e pace”, la vocalist pone l’accento sulla necessità di “mettere da parte te stessa e il tuo ego” per far sì che la musica possa prendere vita. Così quanto si ascolta in “Aguas” è un mix perfettamente riuscito tra il jazz e la musica tradizionale cubana con qualche rimando anche alla musica classica. Sosa disegna un tappeto melodico- ritmico di rara e moderna lucentezza mentre la Cañizares dimostra di saper improvvisare sia con la voce sia con il violino. Prezioso anche il lavoro del percussionista Sotolongo mai invadente. Tra i vari brani particolarmente rilevanti “Milonga” impreziosito da un assolo di Sosa e ““La Respiracion”
Steve Tibbetts – “Life Of” – ECM 2599
 Steve Tibbetts incise il suo primo album nel 1977; nel 1981 l’album d’esordio con la ECM; da allora il chitarrista è divenuto uno degli artisti più presenti nel catalogo della casa tedesca tanto da impersonare, si potrebbe dire, l’estetica voluta da Manfred Eicher. Un’estetica basata sulla raffinatezza, sulla purezza del suono, su una certa atmosfera ‘globalista’ con l’esplicito richiamo a popoli e strumenti esotici. E tutta la carriera di questo personaggio è stata caratterizzata da tali elementi, con la costante di una ricerca che mai si è soffermata sui traguardi raggiunti. Di qui un costante allargamento degli orizzonti musicali di Tibbetts che strada facendo ha trovato nel percussionista Mark Anderson un partner ideale cui, nell’occasione di quest’ultimo album (il nono per ECM), si aggiunge Michelle Kinney (cello, drone). Il risultato è ancora una volta eccellente. L’album si articola attraverso una serie di bozzetti che lasciano all’ascoltatore la possibilità di viaggiare con la fantasia e immaginare luoghi e situazioni. Così non mancano i riferimenti alla musica medioevale, al blues, ma anche a quei luoghi lontani del sud est asiatico, quali il Bali e soprattutto il Nepal dove ha lungamento soggiornato conoscendo il vocalist monaco buddista Chöying Dolma con il quale ha inciso due stupendi album intitolati “Chö” e “Selwa”. E ascoltando anche la musica di “Life Of” non si può non riconoscere come non solo i suoni, ma anche qualcosa di molto più profondo, insito nella spiritualità di quei luoghi, sia rimasta per sempre impressa nell’anima del chitarrista del Minnesota. Anche di qui la ricchezza espressiva della sua chitarra Martin a 12 corde mentre il piano assume spesso coloriture simili ad un gamelan; immancabili alcune campionature che richiamano gong balinesi. Come già accennato, fondamentale anche l’apporto del percussionista Mark Anderson che introduce elementi ritmici tutt’altro che consueti mentre la Kinney, per utilizzare le stesse parole di Tib betts “è capace di portare la struttura musicale del brano come su una nuvola”.
Steve Tibbetts incise il suo primo album nel 1977; nel 1981 l’album d’esordio con la ECM; da allora il chitarrista è divenuto uno degli artisti più presenti nel catalogo della casa tedesca tanto da impersonare, si potrebbe dire, l’estetica voluta da Manfred Eicher. Un’estetica basata sulla raffinatezza, sulla purezza del suono, su una certa atmosfera ‘globalista’ con l’esplicito richiamo a popoli e strumenti esotici. E tutta la carriera di questo personaggio è stata caratterizzata da tali elementi, con la costante di una ricerca che mai si è soffermata sui traguardi raggiunti. Di qui un costante allargamento degli orizzonti musicali di Tibbetts che strada facendo ha trovato nel percussionista Mark Anderson un partner ideale cui, nell’occasione di quest’ultimo album (il nono per ECM), si aggiunge Michelle Kinney (cello, drone). Il risultato è ancora una volta eccellente. L’album si articola attraverso una serie di bozzetti che lasciano all’ascoltatore la possibilità di viaggiare con la fantasia e immaginare luoghi e situazioni. Così non mancano i riferimenti alla musica medioevale, al blues, ma anche a quei luoghi lontani del sud est asiatico, quali il Bali e soprattutto il Nepal dove ha lungamento soggiornato conoscendo il vocalist monaco buddista Chöying Dolma con il quale ha inciso due stupendi album intitolati “Chö” e “Selwa”. E ascoltando anche la musica di “Life Of” non si può non riconoscere come non solo i suoni, ma anche qualcosa di molto più profondo, insito nella spiritualità di quei luoghi, sia rimasta per sempre impressa nell’anima del chitarrista del Minnesota. Anche di qui la ricchezza espressiva della sua chitarra Martin a 12 corde mentre il piano assume spesso coloriture simili ad un gamelan; immancabili alcune campionature che richiamano gong balinesi. Come già accennato, fondamentale anche l’apporto del percussionista Mark Anderson che introduce elementi ritmici tutt’altro che consueti mentre la Kinney, per utilizzare le stesse parole di Tib betts “è capace di portare la struttura musicale del brano come su una nuvola”.
Mark Turner, Ethan Iverson – “Temporary Kings” – ECM 2583
 Sicuramente uno dei dischi più interessanti che mi sia capitato di ascoltare negli ultimi mesi. Uno accanto all’altro un grandioso tenor-sassofonista quale Mark Turner che abbiamo imparato a conoscere sia per le numerose collaborazioni con gruppi di eccellenza quali il Billy Hart Quartet (in cui suonava anche Iverson), e il trio con il bassista Larry Grenadier e il batterista Jeff Ballard, sia per i progetti che lo hanno visto leader, ed un pianista quale Ethan Iverson che ha raggiunto eccezionali livelli di notorietà (assolutamente meritati) con i “Bad Plus” da cui si è staccato negli ultimi tempi. Questa formula del duo senza sezione ritmica è particolarmente rischiosa in quanto praticamente i due artisti sono costretti a muoversi senza rete, inerpicandosi per sentieri impervi da loro stessi immaginati e costruiti. Di qui una musica che definire cameristica non è certo una forzatura: le influenze del cool-jazz sono evidenti – e non solo per la riproposizione di un brano di Warne Marsh, “Dixie’s Dilemma” – così come evidenti appaiono i richiami alla musica colta del Novecento. Tutto ciò crea un’atmosfera generale del tutto atipica e intrigante, grazie anche ad una continua ricerca timbrica e ad un contrapporsi di linee tracciate dai due musicisti che mai scadono nel banale. In repertorio, oltre al già citato brano di Marsh, sei pezzi del sassofonista e due del pianista, tutti declinati attraverso una profonda intesa che trova, forse, nel pianismo di Iverson il suo maggior punto di riferimento. Gli interventi pianistici sono sempre perfetti quanto a tempismo e coerenza con il discorso che si vuol portare avanti, dando così a Turner l’opportunità di librarsi leggero, etereo con il suo bellissimo sound.
Sicuramente uno dei dischi più interessanti che mi sia capitato di ascoltare negli ultimi mesi. Uno accanto all’altro un grandioso tenor-sassofonista quale Mark Turner che abbiamo imparato a conoscere sia per le numerose collaborazioni con gruppi di eccellenza quali il Billy Hart Quartet (in cui suonava anche Iverson), e il trio con il bassista Larry Grenadier e il batterista Jeff Ballard, sia per i progetti che lo hanno visto leader, ed un pianista quale Ethan Iverson che ha raggiunto eccezionali livelli di notorietà (assolutamente meritati) con i “Bad Plus” da cui si è staccato negli ultimi tempi. Questa formula del duo senza sezione ritmica è particolarmente rischiosa in quanto praticamente i due artisti sono costretti a muoversi senza rete, inerpicandosi per sentieri impervi da loro stessi immaginati e costruiti. Di qui una musica che definire cameristica non è certo una forzatura: le influenze del cool-jazz sono evidenti – e non solo per la riproposizione di un brano di Warne Marsh, “Dixie’s Dilemma” – così come evidenti appaiono i richiami alla musica colta del Novecento. Tutto ciò crea un’atmosfera generale del tutto atipica e intrigante, grazie anche ad una continua ricerca timbrica e ad un contrapporsi di linee tracciate dai due musicisti che mai scadono nel banale. In repertorio, oltre al già citato brano di Marsh, sei pezzi del sassofonista e due del pianista, tutti declinati attraverso una profonda intesa che trova, forse, nel pianismo di Iverson il suo maggior punto di riferimento. Gli interventi pianistici sono sempre perfetti quanto a tempismo e coerenza con il discorso che si vuol portare avanti, dando così a Turner l’opportunità di librarsi leggero, etereo con il suo bellissimo sound.
da Gerlando Gatto | 15/Ott/2018 | I nostri CD, Primo piano, Recensioni

Oscar Brown Jr. – “Between Heaven And Hell” plus “Sin & Soul” – Soul Jam 600912
 Nel corso degli anni Oscar Brown Jr. è diventato famoso non solo e non tanto per le sue grandi capacità di vocalist quanto per l’aver assunto determinate posizioni politiche che sarebbero divenute patrimonio di tutta la musica nera al di là di ogni distinzione tra jazz, funk, rap, R&B. In effetti considerare Brown solo come jazzista è piuttosto riduttivo dal momento che lo stesso si è affermato anche come poeta e drammaturgo. Questo album ci restituisce, comunque, Oscar Brown Jr. nella sua veste di eccellente jazzista quale lo si ritrova in due LP, “Between Heaven And Hell” del 1962 e “Sin & Soul” del 1960 con l’aggiunta di tre bonus tracks sempre dei primissimi anni sessanta. Si tratta, in buona sostanza, dei primi due LP incisi da Oscar Brown e che anche per questo assumono una precisa rilevanza storica. In “Sin & Soul” Oscar Brown ha scritto parole e musica della maggior parte dei brani in repertorio; da segnalare come in tre pezzi la musica sia opera di altrettanti personaggi all’epoca emergenti ma che in breve sarebbero diventati celebri: “Work Song” di Nat Adderley, “Dat Dere” di Bobby Timmons e “Afro-Blue” di Mongo Santamaria. Ma è proprio nelle composizioni ascrivibili in toto al vocalist che troviamo i motivi di maggiore interesse con brani emblematici quali “Bid’em In” e “Humdrum Blues” che rappresentano in toto la poetica dell’artista così complessa e così calata nella realtà degli afro-americani.
Nel corso degli anni Oscar Brown Jr. è diventato famoso non solo e non tanto per le sue grandi capacità di vocalist quanto per l’aver assunto determinate posizioni politiche che sarebbero divenute patrimonio di tutta la musica nera al di là di ogni distinzione tra jazz, funk, rap, R&B. In effetti considerare Brown solo come jazzista è piuttosto riduttivo dal momento che lo stesso si è affermato anche come poeta e drammaturgo. Questo album ci restituisce, comunque, Oscar Brown Jr. nella sua veste di eccellente jazzista quale lo si ritrova in due LP, “Between Heaven And Hell” del 1962 e “Sin & Soul” del 1960 con l’aggiunta di tre bonus tracks sempre dei primissimi anni sessanta. Si tratta, in buona sostanza, dei primi due LP incisi da Oscar Brown e che anche per questo assumono una precisa rilevanza storica. In “Sin & Soul” Oscar Brown ha scritto parole e musica della maggior parte dei brani in repertorio; da segnalare come in tre pezzi la musica sia opera di altrettanti personaggi all’epoca emergenti ma che in breve sarebbero diventati celebri: “Work Song” di Nat Adderley, “Dat Dere” di Bobby Timmons e “Afro-Blue” di Mongo Santamaria. Ma è proprio nelle composizioni ascrivibili in toto al vocalist che troviamo i motivi di maggiore interesse con brani emblematici quali “Bid’em In” e “Humdrum Blues” che rappresentano in toto la poetica dell’artista così complessa e così calata nella realtà degli afro-americani.
Nell’altro LP – “Between Heaven And Hell” – possiamo ascoltare dodici brani di cui ben dieci scritti totalmente dal vocalist e due in cui Oscar Brown ha composto la musica su testi di poeti quali Gwendolyn Brooks e Paul L. Dunbar. Notevoli in questo caso non solo l’interpretazione del leader ma anche i preziosi arrangiamenti di Ralph Burns e, in due brani “Mr. Kicks” e “Hazel’s Hips”, di Quincy Jones. Altresì notevoli gli apporti dei solisti quali, ad esempio, il trombettista Joe Newman e il pianista Patti Bown.
Miles Davis – “In Person Friday and Saturday Nights at the Blackhawk” – Poll Winners 27373 2 CD
 E rimaniamo negli anni ’60 con queste straordinarie registrazioni di Miles Davis. Questo doppio cd ripropone, infatti, lo storico concerto registrato dal trombettista il 21 e 22 aprile del 1961 al Blackhawk di San Francisco, originariamente pubblicato come “Miles Davis in Person at the Blackhawk Vols. 1 & 2” (Columbia CS8469/CS 8470).
E rimaniamo negli anni ’60 con queste straordinarie registrazioni di Miles Davis. Questo doppio cd ripropone, infatti, lo storico concerto registrato dal trombettista il 21 e 22 aprile del 1961 al Blackhawk di San Francisco, originariamente pubblicato come “Miles Davis in Person at the Blackhawk Vols. 1 & 2” (Columbia CS8469/CS 8470).
Anche in questo caso sono molti i motivi di interesse. Innanzitutto, dal punto di vista storico, si tratta di una delle pochissime registrazioni di Miles Davis con Hank Mobley al sax tenore (le altre due registrazioni di questo quintetto furono “Someday My Prince Will Come” e “Miles Davis at Carnegie Hall”). In secondo luogo si tratta delle prime performances e relative registrazioni che Miles, alla testa di questo gruppo, abbia effettuato in un club. Inoltre è possibile ascoltare una delle migliori sezioni ritmiche che la storia del jazz possa vantare, vale a dire Wynton Kelly al piano, Paul Chambers al contrabbasso e Jimmy Cobb alla batteria che non a caso hanno suonato e registrato spesso come un trio a sé stante. Dal punto di vista squisitamente musicale non credo siano necessarie molte parole per illustrare la valenza di questa musica e ne era convinto lo tesso Miles che rispondendo ad alcune domande di Ralph J. Gleason, incaricato di scrivere le note di copertina, affermò che non c’era alcunché da scrivere sulla musica dal momento che la stessa parlava da sé. E parlava un linguaggio allo stesso tempo moderno ma legato alle tradizioni, con una front-line in cui Hank Mobley riusciva a dialogare con grande intensità con Miles in uno dei suoi giorni migliori. Il tutto supportato da una sezione ritmica, come si diceva, di assoluta eccellenza. Tutti i brani sono da godere nella loro interezza anche se personalmente ho apprezzato in modo particolare “Walkin’” e “Softly As In A Morning Sunrise”.
Bill Evans – “New Jazz Conceptions” – Poll Winner 27364
 Durante questa rassegna di ristampe mi leggerete usare spesso l’aggettivo ‘storico’ ma in taluni casi è davvero indispensabile. Ad esempio come meglio definire questo CD di Bill Evans dal momento che si tratta dell’album d’esordio dell’allora ventisettenne pianista come leader (prodotto da Orrin Keepnews per la Riverside Records RLP-12-223) riprodotto nella sua interezza e comprendente quindi un’alternate take di “No Cover, No Minimum” che chiude la session. Originariamente l’lp, registrato nel settembre del 1956, conteneva undici tracce di cui otto in trio con Teddy Kotick al basso e Paul Motian alla batteria, e tre in piano solo tra cui la prima registrazione del capolavoro di Evans, “Waltz for Debby”. Basterebbero queste poche note per far capire come si tratti di un album che ogni appassionato di jazz dovrebbe possedere e ascoltare con attenzione. Quell’attenzione che evidentemente non prestarono gli ascoltatori dell’epoca dato che il primo anno della sua uscita l’album vendette appena 800 copie. In effetti, anche se Evans stava ancora mettendo a punto il suo stile che avrebbe dato una svolta imprescindibile alla concezione del piano-trio, tuttavia non era certo difficile cogliere le potenzialità di questo straordinario artista. E le possibilità di comparazione erano lì, sotto gli occhi di tutti, dal momento che in questo specifico album Evans poneva il focus della sua ricerca ancora sul grande song book americano proponendo solo poche sue composizioni – “Five” , “Displacement”, oltre ai già citati “No Cover, No Minimum” e “Waltz for Debby”. Quasi inutile sottolineare come a distanza di oltre sessanta anni queste incisioni conservino intatta tutta la loro freschezza, originalità a conferma che la grande musica non conosce confini di spazio o di tempo. Magnifica, in particolare, l’interpretazione di “My Romance” di Rodgers-Hart. L’album è completato da altri sei brani provenienti da due session dello stesso periodo in cui Evans suona con Dick García chitarra, Jerry Bruno basso e Camille Morin batteria nei primi tre, e con Eddie Costa vibrafono, Joe Puma chitarra, Oscar Pettiford basso e Paul Motian batteria negli altri tre. Da leggere, infine, la recensione scritta per Down Beat da Nat Hentoff e fedelmente riportata nel libretto che accompagna l’album unitamente alle note originarie di Orrin Keepnews e ad un ulteriore contributo di Mel Parson redatte per la riedizione del disco.
Durante questa rassegna di ristampe mi leggerete usare spesso l’aggettivo ‘storico’ ma in taluni casi è davvero indispensabile. Ad esempio come meglio definire questo CD di Bill Evans dal momento che si tratta dell’album d’esordio dell’allora ventisettenne pianista come leader (prodotto da Orrin Keepnews per la Riverside Records RLP-12-223) riprodotto nella sua interezza e comprendente quindi un’alternate take di “No Cover, No Minimum” che chiude la session. Originariamente l’lp, registrato nel settembre del 1956, conteneva undici tracce di cui otto in trio con Teddy Kotick al basso e Paul Motian alla batteria, e tre in piano solo tra cui la prima registrazione del capolavoro di Evans, “Waltz for Debby”. Basterebbero queste poche note per far capire come si tratti di un album che ogni appassionato di jazz dovrebbe possedere e ascoltare con attenzione. Quell’attenzione che evidentemente non prestarono gli ascoltatori dell’epoca dato che il primo anno della sua uscita l’album vendette appena 800 copie. In effetti, anche se Evans stava ancora mettendo a punto il suo stile che avrebbe dato una svolta imprescindibile alla concezione del piano-trio, tuttavia non era certo difficile cogliere le potenzialità di questo straordinario artista. E le possibilità di comparazione erano lì, sotto gli occhi di tutti, dal momento che in questo specifico album Evans poneva il focus della sua ricerca ancora sul grande song book americano proponendo solo poche sue composizioni – “Five” , “Displacement”, oltre ai già citati “No Cover, No Minimum” e “Waltz for Debby”. Quasi inutile sottolineare come a distanza di oltre sessanta anni queste incisioni conservino intatta tutta la loro freschezza, originalità a conferma che la grande musica non conosce confini di spazio o di tempo. Magnifica, in particolare, l’interpretazione di “My Romance” di Rodgers-Hart. L’album è completato da altri sei brani provenienti da due session dello stesso periodo in cui Evans suona con Dick García chitarra, Jerry Bruno basso e Camille Morin batteria nei primi tre, e con Eddie Costa vibrafono, Joe Puma chitarra, Oscar Pettiford basso e Paul Motian batteria negli altri tre. Da leggere, infine, la recensione scritta per Down Beat da Nat Hentoff e fedelmente riportata nel libretto che accompagna l’album unitamente alle note originarie di Orrin Keepnews e ad un ulteriore contributo di Mel Parson redatte per la riedizione del disco.
Maynard Ferguson – “The Birdland Dream Band” – RCA Victor 88985407092
 Ancora una ristampa di grande importanza storica e artistica. Siamo a metà degli anni ’50, per la precisione nel 1956, e Maynard Ferguson ha l’opportunità di formare una orchestra stellare significativamente chiamata “Birdland Dream Band” con cui effettua numerose tournée e incide qualche album come quello presentato in questo CD, impreziosito dalla presenza di altri nove alternate tracks non comprese nell’originale LP. Le registrazioni, effettuate alla Webster Hall di New York nel settembre del 1956, evidenziano tutta la potenza interpretativa dell’orchestra. In effetti grazie agli arrangiamenti di personaggi quali Al Cohn, Bob Brookmeyer, Jimmy Giuffre, Ernie Wilkins, Bill Holman, Marty Paich, Willie Maiden, Johnny Mandel, Herb Geller, e a solisti del calibro del trombonista Jimmy Cleveland, dell’altista Herb Geller, del tenorista Al Cohn, del trombettista Nick Travis, del pianista Hank Jones la band raggiunge un successo strepitoso e costituisce di fatto la base di lancio per la prestigiosa carriera da band-leader che avrebbe contrassegnato la vita di Ferguson. Successo, intendiamoci, del tutto meritato come avrete modo di constatare ascoltando l’album. La musica è serrata, lo swing intenso, trascinante, il sound orchestrale compatto, gli interventi solistici perfetti con il leader sovente in primo piano; i brani si susseguono senza un attimo di tregua a declinare un repertorio di assoluto livello in cui figurano, in veste di autori, Al Cohn, Bill Holman, Bobby Brookmeyer, Jimmy Giuffre, Marty Paich, Manny Albam e John Mandel, come a dire una piccola enciclopedia del jazz.
Ancora una ristampa di grande importanza storica e artistica. Siamo a metà degli anni ’50, per la precisione nel 1956, e Maynard Ferguson ha l’opportunità di formare una orchestra stellare significativamente chiamata “Birdland Dream Band” con cui effettua numerose tournée e incide qualche album come quello presentato in questo CD, impreziosito dalla presenza di altri nove alternate tracks non comprese nell’originale LP. Le registrazioni, effettuate alla Webster Hall di New York nel settembre del 1956, evidenziano tutta la potenza interpretativa dell’orchestra. In effetti grazie agli arrangiamenti di personaggi quali Al Cohn, Bob Brookmeyer, Jimmy Giuffre, Ernie Wilkins, Bill Holman, Marty Paich, Willie Maiden, Johnny Mandel, Herb Geller, e a solisti del calibro del trombonista Jimmy Cleveland, dell’altista Herb Geller, del tenorista Al Cohn, del trombettista Nick Travis, del pianista Hank Jones la band raggiunge un successo strepitoso e costituisce di fatto la base di lancio per la prestigiosa carriera da band-leader che avrebbe contrassegnato la vita di Ferguson. Successo, intendiamoci, del tutto meritato come avrete modo di constatare ascoltando l’album. La musica è serrata, lo swing intenso, trascinante, il sound orchestrale compatto, gli interventi solistici perfetti con il leader sovente in primo piano; i brani si susseguono senza un attimo di tregua a declinare un repertorio di assoluto livello in cui figurano, in veste di autori, Al Cohn, Bill Holman, Bobby Brookmeyer, Jimmy Giuffre, Marty Paich, Manny Albam e John Mandel, come a dire una piccola enciclopedia del jazz.
Ella Fitzgerald – “Sings the Cole Porter Song Book” – Poll Winners 27363 – 2 CD
 Rimaniamo negli anni cinquanta; Lady Ella è in piena attività, oramai riconosciuta come una delle più importanti vocalist jazz; così si esibisce in tournée attraverso l’Europa e il Nord America, accompagnata dall’orchestra di Duke Ellington e instaura una proficua collaborazione con Louis Armstrong documentata da tre indimenticabili album: “Porgy and Bess”, dedicato all’omonima opera di George Gershwin, e due incisioni di standard jazz, “Ella and Louis” e “Ella and Louis Again”. In questo stesso periodo incide per l’etichetta discografica Verve Records una serie di Songbooks, prodotta da Norman Granz, contenenti le canzoni scritte dai più grandi compositori americani. Questo doppio CD, registrato nel 1956, ci presenta per l’appunto Ella Fitzgerald impegnata nella interpretazioni del song book di Cole Porter. Questa volta l’aggettivo “storico” è quanto mai opportuno: in effetti l’album già nel 2000 entra a far parte del Grammy Hall of Frame e nel 2003 è uno dei 50 dischi scelti dalla Libreria del Congresso per far parte del “National Recording Registry”. In effetti l’album è semplicemente straordinario: Ella è in gran forma, la sua voce è fresca, caratterizzata come al solito da un’ampia estensione e da una perfetta intonazione, sorprendente il suo scat che avrebbe poi costituito parte integrante della sua cifra stilistica, grande la capacità di improvvisazione jazzistica. Assolutamente pertinente l’accompagnamento fornito dalla big band di Buddy Bergman in cui spiccano solisti come i trombettisti Pete Candoli, Harry “Sweets” Edison, Maynard Ferguson, i sassofonisti Herb Geller, Bud Shank, Bob Cooper, il chitarrista Barney Kessel, il contrabbassista Joe Mondragon e il batterista Alvin Stoller. A ciò si aggiunga la bellezza dei temi firmati da Cole Porter: brani come “In The Still Of The Night”, “I Get A Kick Of You”, “Just One of Those Things”, “Begin the Beguine”…tanto per citare qualche titolo, vengono lumeggiati nelle pieghe più remote e riproposte in tutta la loro valenza. Il doppio album contiene come bonus track “Love For Sale” registrato il 29 aprile del 1957 con Don Abney piano, Herb Ellis chitarra, Ray Brown basso e Jo Jones batteria. Ad impreziosire il tutto un ampio libretto con interventi di Alan Guntry, Don Freeman, Norman Granz, Fred Lounsberry.
Rimaniamo negli anni cinquanta; Lady Ella è in piena attività, oramai riconosciuta come una delle più importanti vocalist jazz; così si esibisce in tournée attraverso l’Europa e il Nord America, accompagnata dall’orchestra di Duke Ellington e instaura una proficua collaborazione con Louis Armstrong documentata da tre indimenticabili album: “Porgy and Bess”, dedicato all’omonima opera di George Gershwin, e due incisioni di standard jazz, “Ella and Louis” e “Ella and Louis Again”. In questo stesso periodo incide per l’etichetta discografica Verve Records una serie di Songbooks, prodotta da Norman Granz, contenenti le canzoni scritte dai più grandi compositori americani. Questo doppio CD, registrato nel 1956, ci presenta per l’appunto Ella Fitzgerald impegnata nella interpretazioni del song book di Cole Porter. Questa volta l’aggettivo “storico” è quanto mai opportuno: in effetti l’album già nel 2000 entra a far parte del Grammy Hall of Frame e nel 2003 è uno dei 50 dischi scelti dalla Libreria del Congresso per far parte del “National Recording Registry”. In effetti l’album è semplicemente straordinario: Ella è in gran forma, la sua voce è fresca, caratterizzata come al solito da un’ampia estensione e da una perfetta intonazione, sorprendente il suo scat che avrebbe poi costituito parte integrante della sua cifra stilistica, grande la capacità di improvvisazione jazzistica. Assolutamente pertinente l’accompagnamento fornito dalla big band di Buddy Bergman in cui spiccano solisti come i trombettisti Pete Candoli, Harry “Sweets” Edison, Maynard Ferguson, i sassofonisti Herb Geller, Bud Shank, Bob Cooper, il chitarrista Barney Kessel, il contrabbassista Joe Mondragon e il batterista Alvin Stoller. A ciò si aggiunga la bellezza dei temi firmati da Cole Porter: brani come “In The Still Of The Night”, “I Get A Kick Of You”, “Just One of Those Things”, “Begin the Beguine”…tanto per citare qualche titolo, vengono lumeggiati nelle pieghe più remote e riproposte in tutta la loro valenza. Il doppio album contiene come bonus track “Love For Sale” registrato il 29 aprile del 1957 con Don Abney piano, Herb Ellis chitarra, Ray Brown basso e Jo Jones batteria. Ad impreziosire il tutto un ampio libretto con interventi di Alan Guntry, Don Freeman, Norman Granz, Fred Lounsberry.
Oliver Nelson – “The Blues and the Abstract Truth” – The Stereo & Mono Versions – Green Corner 100894 – 2 CD
 Oliver Nelson nasce a St.Louis, Missouri, nel 1932 e comincia a suonare il pianoforte all’età di sei anni per passare al sassofono ad undici. Nel 1947 le prime scritture professionali con diverse band nei dintorni di St.Louis, finché nel 1950 entra nella big band di Louis Jordan suonando il sassofono contralto ed occupandosi altresì degli arrangiamenti. Il grande successo arriva nel 1961 quando, dopo sei album come leader, incide per l’appunto “The Blues and the Abstract Truth” (che contiene tra gli altri il famoso “Stolen Moments”, poi diventato uno standard); accanto a lui una serie di musicisti eccezionali quali George Barrow al sax baritono, il trombettista Freddie Hubbard, il sassofonista e flautista Eric Dolphy (alla sua ultima collaborazione con Nelson dopo una serie di registrazioni per la Prestige), Bill Evans al piano (nel suo unico album con Nelson), Paul Chambers e Roy Haynes rispettivamente basso e batteria. L’album ci viene proposto nella duplice versione mono e stereo e la cosa non deve stupire più di tanto ove si consideri che nei primissimi anni sessanta le case discografiche erano solite pubblicare nella duplice versione dato che ancora la stereofonia non era molto diffusa. Dal punto di vista squisitamente musicale, l’album è una vera e propria perla nella discografia di quegli anni; dall’alto della sua perizia di arrangiatore e compositore, Nelson, pur non rispettando la canonica struttura delle 12 battute, si lancia in una profonda esplorazione del blues di cui ci propone una sua particolarissima e brillante visione, in ciò perfettamente assecondato da quei grandiosi musicisti cui prima si faceva riferimento. Il brano più noto e probabilmente il migliore è “Stolen Moments”; dopo una introduzione collettiva è Freddie Hubbard a prendere un convincente assolo, seguito dal flauto di Dolphy e dal sax tenore di Nelson. L’assolo di Bill Evans e la riproposizione corale del tema chiudono il brano. Un’ultima non secondaria notazione: il doppio CD contiene altri due album, “Trane Whistle” (1960), della big band del sassofonista Eddie “Lockjaw” Davis con arrangiamenti di Oliver Nelson e Ernie Wilkins, e “Straight Ahead” (1961) dello stesso Nelson.
Oliver Nelson nasce a St.Louis, Missouri, nel 1932 e comincia a suonare il pianoforte all’età di sei anni per passare al sassofono ad undici. Nel 1947 le prime scritture professionali con diverse band nei dintorni di St.Louis, finché nel 1950 entra nella big band di Louis Jordan suonando il sassofono contralto ed occupandosi altresì degli arrangiamenti. Il grande successo arriva nel 1961 quando, dopo sei album come leader, incide per l’appunto “The Blues and the Abstract Truth” (che contiene tra gli altri il famoso “Stolen Moments”, poi diventato uno standard); accanto a lui una serie di musicisti eccezionali quali George Barrow al sax baritono, il trombettista Freddie Hubbard, il sassofonista e flautista Eric Dolphy (alla sua ultima collaborazione con Nelson dopo una serie di registrazioni per la Prestige), Bill Evans al piano (nel suo unico album con Nelson), Paul Chambers e Roy Haynes rispettivamente basso e batteria. L’album ci viene proposto nella duplice versione mono e stereo e la cosa non deve stupire più di tanto ove si consideri che nei primissimi anni sessanta le case discografiche erano solite pubblicare nella duplice versione dato che ancora la stereofonia non era molto diffusa. Dal punto di vista squisitamente musicale, l’album è una vera e propria perla nella discografia di quegli anni; dall’alto della sua perizia di arrangiatore e compositore, Nelson, pur non rispettando la canonica struttura delle 12 battute, si lancia in una profonda esplorazione del blues di cui ci propone una sua particolarissima e brillante visione, in ciò perfettamente assecondato da quei grandiosi musicisti cui prima si faceva riferimento. Il brano più noto e probabilmente il migliore è “Stolen Moments”; dopo una introduzione collettiva è Freddie Hubbard a prendere un convincente assolo, seguito dal flauto di Dolphy e dal sax tenore di Nelson. L’assolo di Bill Evans e la riproposizione corale del tema chiudono il brano. Un’ultima non secondaria notazione: il doppio CD contiene altri due album, “Trane Whistle” (1960), della big band del sassofonista Eddie “Lockjaw” Davis con arrangiamenti di Oliver Nelson e Ernie Wilkins, e “Straight Ahead” (1961) dello stesso Nelson.
Art Pepper – “Smack Up” – Poll Winners 27360
 Anche questo album ha una sua precisa caratterizzazione storica: si tratta, infatti, della penultima registrazione effettuata dal sassofonista e clarinettista Art Pepper come leader prima che lo stesso fosse incarcerato a S. Quentino per motivi di droga e tornasse a registrare solo nel 1964. Purtroppo la frequentazione con le droghe fu una costante nella vita di Pepper condizionandolo in maniera decisiva e riducendo in maniera sostanziale le sue possibilità espressive. In altri termini Pepper avrebbe potuto dare molto di più se avesse avuto una vita regolata. Chiaramente influenzato da Charlie Parker all’inizio della carriera, Pepper riuscì a trovare una sua strada nel corso degli anni, specie nel periodo che va dal 1957 al 1960. Ed in effetti questo “Smack Up” venne registrato a Los Angeles nell’ottobre del 1960 in quintetto con il trombettista Jack Sheldon, il pianista Pete Jolly, il bassista Jimmy Bond e il batterista Frank Butler. Nelle note di copertina originarie, scritte da Leonard Feather e riportate nel libretto che accompagna il CD, si può leggere come le doti principali dell’altosassofonista vadano ricercate nella passionale eloquenza anche se chiaramente influenzata da Parker e nell’assoluta originalità del suo sound che lo rendono immediatamente riconoscibile. Molti anni sono trascorsi da quando Feather formulò tali valutazioni ma non si può non essere d’accordo con lui ascoltando questo splendido album in cui Pepper evidenzia appieno la sua complessa personalità, ben coadiuvato da eccellenti compagni d’avventura tra cui in primissimo piano il trombettista Jack Sheldon e il pianista Pete Jolly. Come bonus track l’album contiene l’unico brano della colonna sonora del film The Subterraneans in quintetto co-guidato da Pepper e Sheldon, ed una sessione completa del 1959 in nonetto, con Jack Sheldon e Chet Baker alla tromba, Art Pepper e Herb Geller al sax alto, Stu Williamson al trombone a valve, Harold Land al sax tenore, Paul Moer al pianoforte, Buddy Clark al basso e Mel Lewis alla batteria.
Anche questo album ha una sua precisa caratterizzazione storica: si tratta, infatti, della penultima registrazione effettuata dal sassofonista e clarinettista Art Pepper come leader prima che lo stesso fosse incarcerato a S. Quentino per motivi di droga e tornasse a registrare solo nel 1964. Purtroppo la frequentazione con le droghe fu una costante nella vita di Pepper condizionandolo in maniera decisiva e riducendo in maniera sostanziale le sue possibilità espressive. In altri termini Pepper avrebbe potuto dare molto di più se avesse avuto una vita regolata. Chiaramente influenzato da Charlie Parker all’inizio della carriera, Pepper riuscì a trovare una sua strada nel corso degli anni, specie nel periodo che va dal 1957 al 1960. Ed in effetti questo “Smack Up” venne registrato a Los Angeles nell’ottobre del 1960 in quintetto con il trombettista Jack Sheldon, il pianista Pete Jolly, il bassista Jimmy Bond e il batterista Frank Butler. Nelle note di copertina originarie, scritte da Leonard Feather e riportate nel libretto che accompagna il CD, si può leggere come le doti principali dell’altosassofonista vadano ricercate nella passionale eloquenza anche se chiaramente influenzata da Parker e nell’assoluta originalità del suo sound che lo rendono immediatamente riconoscibile. Molti anni sono trascorsi da quando Feather formulò tali valutazioni ma non si può non essere d’accordo con lui ascoltando questo splendido album in cui Pepper evidenzia appieno la sua complessa personalità, ben coadiuvato da eccellenti compagni d’avventura tra cui in primissimo piano il trombettista Jack Sheldon e il pianista Pete Jolly. Come bonus track l’album contiene l’unico brano della colonna sonora del film The Subterraneans in quintetto co-guidato da Pepper e Sheldon, ed una sessione completa del 1959 in nonetto, con Jack Sheldon e Chet Baker alla tromba, Art Pepper e Herb Geller al sax alto, Stu Williamson al trombone a valve, Harold Land al sax tenore, Paul Moer al pianoforte, Buddy Clark al basso e Mel Lewis alla batteria.
Sonny Stitt, Hank Jones – “Cherokee” – Phono 2 CD
 Ecco una ristampa imperdibile per chi ama Sonny Stitt e per chi, più in generale, ama la buona musica. Questo doppio cd riunisce, infatti, quattro sessioni complete nella loro interezza da cui sono scaturiti gli album “Sonny Stitt with The New Yorkers”, “Now!”, e “Salt and Pepper”, così come l’album “Stitt in Orbit” (comprendente altri due brani, non inclusi qui, poiché tratti da una sessione con una formazione diversa) registrati tra il 1957 e il 1963. In tutte queste registrazioni il sassofonista ha al suo fianco il pianista Hank Jones con il quale aveva già collaborato nel 1953 come membri del Buddy Rich Quartet, e, dopo le session qui presentate, non avrebbero registrato insieme fino al 1972 nell’album “Goin’ Down Slow” in quartetto con George Duvivier basso e Idris Muhammad batteria. In tutti i brani qui proposti Sonny Stitt e Hank Jones suonano in quartetto o con Wendell Marshall al basso e Shadow Wilson alla batteria o con Tommy Potter basso e Roy Haynes batteria o ancora con Al Lucas basso e Osie Johnson batteria. Nell’album “Salt and Pepper”, si aggiunge Paul Gonsalves, per la sua unica collaborazione registrata con Stitt mentre la sezione ritmica è affidata a Milt Hinton e Osie Johnson. Dal punto di vista musicale i brani che possiamo ascoltare in queste registrazioni sono un valido esempio del migliore jazz che si suonava in quel periodo. Stitt è in gran forma ed ha già intrapreso la strada che man mano lo porterà a distaccarsi dal suo modello d’ispirazione, Charlie Parker, come dimostrano, tra l’altro, le registrazioni effettuate nel ’60 con Miles Davis. Dal canto suo Hank Jones è nel pieno della maturità espressiva e proprio negli anni sessanta costituisce un suo quartetto, assieme al batterista Osie Johnson, al chitarrista Barry Galbraight e al bassista Milt Hinton che ottiene un clamoroso successo di pubblico e di critica. Come avrete modo di ascoltare il suo pianismo si integra perfettamente con le linee bop tracciate da Stitt per una musica che davvero non conosce l’usura del tempo.
Ecco una ristampa imperdibile per chi ama Sonny Stitt e per chi, più in generale, ama la buona musica. Questo doppio cd riunisce, infatti, quattro sessioni complete nella loro interezza da cui sono scaturiti gli album “Sonny Stitt with The New Yorkers”, “Now!”, e “Salt and Pepper”, così come l’album “Stitt in Orbit” (comprendente altri due brani, non inclusi qui, poiché tratti da una sessione con una formazione diversa) registrati tra il 1957 e il 1963. In tutte queste registrazioni il sassofonista ha al suo fianco il pianista Hank Jones con il quale aveva già collaborato nel 1953 come membri del Buddy Rich Quartet, e, dopo le session qui presentate, non avrebbero registrato insieme fino al 1972 nell’album “Goin’ Down Slow” in quartetto con George Duvivier basso e Idris Muhammad batteria. In tutti i brani qui proposti Sonny Stitt e Hank Jones suonano in quartetto o con Wendell Marshall al basso e Shadow Wilson alla batteria o con Tommy Potter basso e Roy Haynes batteria o ancora con Al Lucas basso e Osie Johnson batteria. Nell’album “Salt and Pepper”, si aggiunge Paul Gonsalves, per la sua unica collaborazione registrata con Stitt mentre la sezione ritmica è affidata a Milt Hinton e Osie Johnson. Dal punto di vista musicale i brani che possiamo ascoltare in queste registrazioni sono un valido esempio del migliore jazz che si suonava in quel periodo. Stitt è in gran forma ed ha già intrapreso la strada che man mano lo porterà a distaccarsi dal suo modello d’ispirazione, Charlie Parker, come dimostrano, tra l’altro, le registrazioni effettuate nel ’60 con Miles Davis. Dal canto suo Hank Jones è nel pieno della maturità espressiva e proprio negli anni sessanta costituisce un suo quartetto, assieme al batterista Osie Johnson, al chitarrista Barry Galbraight e al bassista Milt Hinton che ottiene un clamoroso successo di pubblico e di critica. Come avrete modo di ascoltare il suo pianismo si integra perfettamente con le linee bop tracciate da Stitt per una musica che davvero non conosce l’usura del tempo.
Kai Winding – “Solo + Kai Olé” – Phono 870284
 Quella di Kai Winding è stata una sorte piuttosto strana: nonostante nessuno metta in dubbio le sue qualità, tuttavia lo si ricorda soprattutto per le registrazioni effettuate durante gli anni ’50 con Jai Jai Johnson e viene assolutamente trascurata tutta la produzione successiva. Invece questo cd riunisce due album completi degli anni ‘60, che compaiono per la prima volta su CD: “Solo” (Verve V6-8525) e “Kai Olé” (Verve V6-8427). Il primo album, registrato tra gennaio e febbraio del 1963, vede il trombonista alla testa di un combo con Ross Tompkins al piano, Dick Garcia chitarra, Russell George basso, Gus Johnson o Tommy Check batteria. Nel secondo, registrato nel 1961, il trombonista di Aarhus, Danimarca, guida una grande orchestra di dodici elementi arrangiata e condotta da Al Cohn e dal collega trombonista Billy Byers. Nella band spiccano solisti come Phil Woods, Clark Terry, Joe Newman e lo stesso Byers. Dal punto di vista squisitamente musicale, “Solo” si caratterizza per il fatto che Winding, contrariamente a quanto era solito fare in quel periodo, abbandona la formazione con più tromboni e si presenta come unico fiato in quartetto o in quintetto. In tali contesti ha modo di esprimere appieno tutte le proprie potenzialità tanto che ancora oggi l’album viene considerato uno dei migliori registrati da Winding negli anni ’60. Anni in cui Kai incide soprattutto anche album jazz-pop per la Verve Records con il produttore Creed Taylor. Tornando a “Solo”, lo si ascolti particolarmente in “Days Of Wine And Roses”. Diverse le atmosfere ricercate in “Kai Olé” che può essere considerato un album di latin jazz; non a caso in repertorio figurano brani come “Manteca”, “Caribe” e “Besame Mucho”. Winding e compagni esplorano questo linguaggio e trovano piena libertà espressiva servendosi al meglio delle percussioni latine nella mani dell’eccellente Willie Rodriguez. Ma il protagonista è sempre lui, il trombonista danese, che mette in vetrina una sonorità ancora una volta splendida ed un fraseggio sempre fluido e preciso.
Quella di Kai Winding è stata una sorte piuttosto strana: nonostante nessuno metta in dubbio le sue qualità, tuttavia lo si ricorda soprattutto per le registrazioni effettuate durante gli anni ’50 con Jai Jai Johnson e viene assolutamente trascurata tutta la produzione successiva. Invece questo cd riunisce due album completi degli anni ‘60, che compaiono per la prima volta su CD: “Solo” (Verve V6-8525) e “Kai Olé” (Verve V6-8427). Il primo album, registrato tra gennaio e febbraio del 1963, vede il trombonista alla testa di un combo con Ross Tompkins al piano, Dick Garcia chitarra, Russell George basso, Gus Johnson o Tommy Check batteria. Nel secondo, registrato nel 1961, il trombonista di Aarhus, Danimarca, guida una grande orchestra di dodici elementi arrangiata e condotta da Al Cohn e dal collega trombonista Billy Byers. Nella band spiccano solisti come Phil Woods, Clark Terry, Joe Newman e lo stesso Byers. Dal punto di vista squisitamente musicale, “Solo” si caratterizza per il fatto che Winding, contrariamente a quanto era solito fare in quel periodo, abbandona la formazione con più tromboni e si presenta come unico fiato in quartetto o in quintetto. In tali contesti ha modo di esprimere appieno tutte le proprie potenzialità tanto che ancora oggi l’album viene considerato uno dei migliori registrati da Winding negli anni ’60. Anni in cui Kai incide soprattutto anche album jazz-pop per la Verve Records con il produttore Creed Taylor. Tornando a “Solo”, lo si ascolti particolarmente in “Days Of Wine And Roses”. Diverse le atmosfere ricercate in “Kai Olé” che può essere considerato un album di latin jazz; non a caso in repertorio figurano brani come “Manteca”, “Caribe” e “Besame Mucho”. Winding e compagni esplorano questo linguaggio e trovano piena libertà espressiva servendosi al meglio delle percussioni latine nella mani dell’eccellente Willie Rodriguez. Ma il protagonista è sempre lui, il trombonista danese, che mette in vetrina una sonorità ancora una volta splendida ed un fraseggio sempre fluido e preciso.
****
Ajugada Quartet – “Hand Luggage” – Filibusta 1813
 Quattro donne per questo Ajugada Quartet al suo debutto discografico: Antonella Vitale voce, Gaia Possenti pianoforte, Giulia Salsone chitarra e Danielle Di Maio sax alto e soprano, con l’aggiunta, in veste di special guest, di Juan Carlos Alberto Zamora armonica, Neney Santos percussioni e Stefano Isola synth. Costituitosi recentemente, il gruppo ha già potuto riscuotere l’interesse del pubblico nei concerti tenutisi alla Casa del Jazz di Roma, al Festival R-Esistenza Jazz presso l’Acrobax a Roma, al Festival del Jazz Teatro di Ostia Lido, Teatro Palladium di Roma Festival delle Compositrici e a “L’Aquila Jazz per le Terre del sisma edizione 2018”. Quindi, se, come si dice, il buongiorno si vede dal mattino non c’è dubbio che sentiremo ancora parlare di questa formazione. Senza alcuna pretesa di sperimentazione né di stupire l’ascoltatore, con molta umiltà e onestà intellettuale (merce oltremodo rara di questi tempi), le quattro artiste si muovono alla ricerca di belle melodie, senza per questo disdegnare la scrittura, con la presenza, quindi, in repertorio di ben sette original. In altre parole il gruppo prende per mano l’ascoltatore e lo conduce in un affascinante viaggio musicale attraverso stili e input differenti: così partendo da un brano di grande jazz come “Kind Folk” di Kenny Wheeler si arriva al Brasile di Egberto Gismonti e a Fito Paez, grande personaggio della scena artistica argentina. L’intesa è notevole: la voce si integra perfettamente in un contesto strumentale in cui piano e chitarra non fanno avvertire la mancanza di una sezione ritmica canonica (basso e batteria) mentre gli interventi degli ospiti appaiono quanto mai centrati e pertinenti. Si ascolti, al riguardo, Juan Carlos Albeto Zamora ne “Il regalo” e in “Livingstone”.
Quattro donne per questo Ajugada Quartet al suo debutto discografico: Antonella Vitale voce, Gaia Possenti pianoforte, Giulia Salsone chitarra e Danielle Di Maio sax alto e soprano, con l’aggiunta, in veste di special guest, di Juan Carlos Alberto Zamora armonica, Neney Santos percussioni e Stefano Isola synth. Costituitosi recentemente, il gruppo ha già potuto riscuotere l’interesse del pubblico nei concerti tenutisi alla Casa del Jazz di Roma, al Festival R-Esistenza Jazz presso l’Acrobax a Roma, al Festival del Jazz Teatro di Ostia Lido, Teatro Palladium di Roma Festival delle Compositrici e a “L’Aquila Jazz per le Terre del sisma edizione 2018”. Quindi, se, come si dice, il buongiorno si vede dal mattino non c’è dubbio che sentiremo ancora parlare di questa formazione. Senza alcuna pretesa di sperimentazione né di stupire l’ascoltatore, con molta umiltà e onestà intellettuale (merce oltremodo rara di questi tempi), le quattro artiste si muovono alla ricerca di belle melodie, senza per questo disdegnare la scrittura, con la presenza, quindi, in repertorio di ben sette original. In altre parole il gruppo prende per mano l’ascoltatore e lo conduce in un affascinante viaggio musicale attraverso stili e input differenti: così partendo da un brano di grande jazz come “Kind Folk” di Kenny Wheeler si arriva al Brasile di Egberto Gismonti e a Fito Paez, grande personaggio della scena artistica argentina. L’intesa è notevole: la voce si integra perfettamente in un contesto strumentale in cui piano e chitarra non fanno avvertire la mancanza di una sezione ritmica canonica (basso e batteria) mentre gli interventi degli ospiti appaiono quanto mai centrati e pertinenti. Si ascolti, al riguardo, Juan Carlos Albeto Zamora ne “Il regalo” e in “Livingstone”.
Enrica Bacchia – “E ritorno a casa” – Accordo BGZ/001
 Spesso, parlando del mio recente volume “L’altra metà del jazz”, ho detto che una delle interviste che mi aveva maggiormente colpito per la capacità dell’interlocutore di mettersi a nudo era stata quella con Enrica Bacchia. E la capacità di questa straordinaria artista di andare dritta al cuore si manifesta sì con le parole… ma ancor meglio con la musica. Non è certo un caso che la Bacchia sia considerata una delle massime espressioni del canto europeo e se ce ne fosse stato ulteriore bisogno questo album è lì a dimostrarlo. Perfettamente coadiuvata da Massimo Zemolin (chitarra 7 corde), e Stefano Graziani (chitarra) cui si aggiungono in alcuni brani Luigi Sella al sax soprano, Francesco Pollon al pianoforte, David Boato alla tromba e Stefano Panizzo come arrangiatore nel brano di chiusura, la Bacchia affronta un repertorio all’apparenza “leggero” ma proprio per questo difficile da tradurre in qualcosa di completamente diverso dalla pop-routine. Ma la vocalist ci riesce perfettamente aderendo al titolo dell’album. E di un ritorno a casa in effetti si tratta dal momento che dopo aver declinato repertori americani, sudamericani ed europei, questa volta si rivolge a melodie di stampo italico che tutti conosciamo perfettamente. Particolarmente toccante l’apertura affidata a “Se io fossi un angelo” di Lucio Dalla, cantautore in cima alle preferenze del vostro cronista; Enrica affronta il brano con sincera partecipazione e grande trasporto nel raccontare ciò che Dalla voleva dirci con i suoi testi tutt’altro che banali. E l’attenzione ai testi è una costante di tutto il CD sottolineata dal fatto che la vocalist è accompagnata, per quasi tutto l’album, solo dalle corde di chitarra all’interno di un’architettura sonora semplice ma efficace. L’album si chiude con un brano strumentale scritto da Stefano Graziani con il trombettista David Boato in bella evidenza.
Spesso, parlando del mio recente volume “L’altra metà del jazz”, ho detto che una delle interviste che mi aveva maggiormente colpito per la capacità dell’interlocutore di mettersi a nudo era stata quella con Enrica Bacchia. E la capacità di questa straordinaria artista di andare dritta al cuore si manifesta sì con le parole… ma ancor meglio con la musica. Non è certo un caso che la Bacchia sia considerata una delle massime espressioni del canto europeo e se ce ne fosse stato ulteriore bisogno questo album è lì a dimostrarlo. Perfettamente coadiuvata da Massimo Zemolin (chitarra 7 corde), e Stefano Graziani (chitarra) cui si aggiungono in alcuni brani Luigi Sella al sax soprano, Francesco Pollon al pianoforte, David Boato alla tromba e Stefano Panizzo come arrangiatore nel brano di chiusura, la Bacchia affronta un repertorio all’apparenza “leggero” ma proprio per questo difficile da tradurre in qualcosa di completamente diverso dalla pop-routine. Ma la vocalist ci riesce perfettamente aderendo al titolo dell’album. E di un ritorno a casa in effetti si tratta dal momento che dopo aver declinato repertori americani, sudamericani ed europei, questa volta si rivolge a melodie di stampo italico che tutti conosciamo perfettamente. Particolarmente toccante l’apertura affidata a “Se io fossi un angelo” di Lucio Dalla, cantautore in cima alle preferenze del vostro cronista; Enrica affronta il brano con sincera partecipazione e grande trasporto nel raccontare ciò che Dalla voleva dirci con i suoi testi tutt’altro che banali. E l’attenzione ai testi è una costante di tutto il CD sottolineata dal fatto che la vocalist è accompagnata, per quasi tutto l’album, solo dalle corde di chitarra all’interno di un’architettura sonora semplice ma efficace. L’album si chiude con un brano strumentale scritto da Stefano Graziani con il trombettista David Boato in bella evidenza.
Maurizio Brunod – “Nostalgia progressiva” – Caligola 2241
 Album di notevole interesse questo firmato da tre fra gli artisti più innovativi del panorama musicale italiano: il chitarrista Maurizio Brunod, il vocalist Boris Savoldelli e il trombettista Giorgio Li Calzi. Più volte ho espresso la mia avversione nei confronti di un uso eccessivo dell’elettronica nella musica; in questo caso, viceversa, siamo di fronte a tre artisti che sanno molto bene come padroneggiare le nuove tecnologie sì da offrire una musica allo stesso tempo moderna ma non slegata dal passato, una musica che suona estremamente attuale ma che allo stesso tempo guarda – con “nostalgia progressiva” – alla stagione d’oro del rock progressivo e della psichedelia. Insomma non un nostalgico ritorno al passato ma una rivisitazione originale di un patrimonio caro a noi tutti. Di qui un repertorio di dieci brani in cui ci sono i King Crimson, i Beatles, Elvis Costello, i Nucleus di Ian Carr… insomma alcuni di quei musicisti che hanno dato vita alla straordinaria stagione che ha caratterizzato l’Inghilterra di fine anni ’60… fino ai Kraftwerk banda tedesca pioniera della musica elettronica e alle italianissime Orme di cui viene riproposto “Gioco di bimba”. I tre si integrano alla perfezione e potendo contare su un tappeto ritmico-percussivo di grande efficacia, affrontano con estrema disinvoltura anche i passaggi più ardui, senza alcuna preoccupazione di andare oltre il limite, di assecondare un facile ascolto lasciandosi andare all’ispirazione del momento. Prova ne sia che l’album, nonostante la sua complessità, è stato realizzato in un solo giorno. Notevole l’equilibrio raggiunto tra le citazioni quasi filologiche di queste immortali melodie e la capacità di improvvisare che riguarda sia il singolo musicista sia il trio nella sua totalità.
Album di notevole interesse questo firmato da tre fra gli artisti più innovativi del panorama musicale italiano: il chitarrista Maurizio Brunod, il vocalist Boris Savoldelli e il trombettista Giorgio Li Calzi. Più volte ho espresso la mia avversione nei confronti di un uso eccessivo dell’elettronica nella musica; in questo caso, viceversa, siamo di fronte a tre artisti che sanno molto bene come padroneggiare le nuove tecnologie sì da offrire una musica allo stesso tempo moderna ma non slegata dal passato, una musica che suona estremamente attuale ma che allo stesso tempo guarda – con “nostalgia progressiva” – alla stagione d’oro del rock progressivo e della psichedelia. Insomma non un nostalgico ritorno al passato ma una rivisitazione originale di un patrimonio caro a noi tutti. Di qui un repertorio di dieci brani in cui ci sono i King Crimson, i Beatles, Elvis Costello, i Nucleus di Ian Carr… insomma alcuni di quei musicisti che hanno dato vita alla straordinaria stagione che ha caratterizzato l’Inghilterra di fine anni ’60… fino ai Kraftwerk banda tedesca pioniera della musica elettronica e alle italianissime Orme di cui viene riproposto “Gioco di bimba”. I tre si integrano alla perfezione e potendo contare su un tappeto ritmico-percussivo di grande efficacia, affrontano con estrema disinvoltura anche i passaggi più ardui, senza alcuna preoccupazione di andare oltre il limite, di assecondare un facile ascolto lasciandosi andare all’ispirazione del momento. Prova ne sia che l’album, nonostante la sua complessità, è stato realizzato in un solo giorno. Notevole l’equilibrio raggiunto tra le citazioni quasi filologiche di queste immortali melodie e la capacità di improvvisare che riguarda sia il singolo musicista sia il trio nella sua totalità.
Kulu Sé Mama – “Nécessaire de Voyage” – Dodicilune 380
 Album gradevole e interessante questo “Nécessaire de Voyage”, primo lavoro discografico del quintetto Kulu Sé Mama. Diretto da Gabriele Rampino (sax tenore e soprano, sound design) e completato da Maurizio Bizzochetti (chitarre), Maurizio Ripa (piano), Maurizio Manca (basso elettrico) e Daniele Bonazzi (batteria). In repertorio 7 brani originali (firmati da Rampino e Ripa) che non difettano certo quanto ad originalità e valenza di scrittura. Ma quel che forse maggiormente colpisce è l’empatia che evidenziano questi musicisti, la facilità con cui si cercano, si trovano e riescono a dialogare su un canovaccio spesso non banale. E la cosa non stupisce più di tanto ove si consideri che il gruppo nasce verso la fine degli anni ’80 ospitando diversi musicisti fino a giungere alla formazione attuale in cui ritroviamo due tra i cofondatori del gruppo vale a dire Gabriele Rampino e Maurizio Bizzochetti. Dal punto di vista musicale, il gruppo si muove lungo direttrici non particolarmente nuove in quanto il suo stile raccoglie input provenienti da diversi generi musicali che oggi vanno per la maggiore, ivi compresi, ovviamente, il jazz. Ma lo fa con originalità e con una certa raffinatezza timbrica. A ciò si aggiunga la buona scrittura e si avrà un quadro completo del perché l’album merita attenzione. Tra i brani vi consigliamo di ascoltare “To the Forgotten” e “Endless Mirror”, ambedue impreziositi dagli assolo di Gabriele Rampino sia al sax tenore sia al sax soprano, mentre nel brano di chiusura – “They Say It’s A Ballad” a mettersi in evidenza è la chitarra di Maurizio Bizzochetti.
Album gradevole e interessante questo “Nécessaire de Voyage”, primo lavoro discografico del quintetto Kulu Sé Mama. Diretto da Gabriele Rampino (sax tenore e soprano, sound design) e completato da Maurizio Bizzochetti (chitarre), Maurizio Ripa (piano), Maurizio Manca (basso elettrico) e Daniele Bonazzi (batteria). In repertorio 7 brani originali (firmati da Rampino e Ripa) che non difettano certo quanto ad originalità e valenza di scrittura. Ma quel che forse maggiormente colpisce è l’empatia che evidenziano questi musicisti, la facilità con cui si cercano, si trovano e riescono a dialogare su un canovaccio spesso non banale. E la cosa non stupisce più di tanto ove si consideri che il gruppo nasce verso la fine degli anni ’80 ospitando diversi musicisti fino a giungere alla formazione attuale in cui ritroviamo due tra i cofondatori del gruppo vale a dire Gabriele Rampino e Maurizio Bizzochetti. Dal punto di vista musicale, il gruppo si muove lungo direttrici non particolarmente nuove in quanto il suo stile raccoglie input provenienti da diversi generi musicali che oggi vanno per la maggiore, ivi compresi, ovviamente, il jazz. Ma lo fa con originalità e con una certa raffinatezza timbrica. A ciò si aggiunga la buona scrittura e si avrà un quadro completo del perché l’album merita attenzione. Tra i brani vi consigliamo di ascoltare “To the Forgotten” e “Endless Mirror”, ambedue impreziositi dagli assolo di Gabriele Rampino sia al sax tenore sia al sax soprano, mentre nel brano di chiusura – “They Say It’s A Ballad” a mettersi in evidenza è la chitarra di Maurizio Bizzochetti.
Late Sense Quartet – “Meetings” – Improvvisatore Involontario 054
 Altro disco d’esordio; a presentarsi al pubblico del jazz è il Late Sense Quartet ovvero Gaetano Santoro al sax, Edoardo Ponzi al vibrafono e marimba, Francesco Marchetti al basso e Mauro Cimarra alla batteria cui si aggiunge in veste di ospite speciale il trombonista Massimo Morganti e un non meglio identificato N2B all’elettronica, probabilmente responsabile della ghost track a chiusura dell’album. Il quartetto si muove lungo direttrici certo non nuove ma percorse con sicurezza cementata da una profonda intesa, dato che il gruppo nasce come trio nel 2015 cui l’anno successivo si aggiunge Gaetano Santoro. Di qui il titolo dell’album che vuole significare la profonda importanza degli incontri e proprio “Meetings fanno notare i musicisti – rappresenta l’incontro fra sensibilità e vite diverse alla ricerca di un minimo comun denominatore che sia il trampolino per creare una musica davvero condivisa”. Ed è proprio grazie a questa intesa che il gruppo riesce a ben districarsi tra atmosfere bop ed un linguaggio che vuole essere più libero, più moderno. Risultato raggiunto appieno soprattutto quando il quartetto diventa quintetto con l’aggiunta di Morganti che si fa ascoltare nella suggestiva “Ballad for my Valentine”, in “Come una rima semplice” (con in bella evidenza anche il vibrafono di Edoardo Ponzi) e nel più movimentato “Broken blue” pezzi firmati i primi due da Marchetti e Ponzi, e il terzo da Gaetano Santoro. Quest’ultimo evidenzia un bel timbro ed una facilità di fraseggio specie quando si trova a dialogare con l’altro fiato. Precisa, mai invadente ma sempre propositiva la sezione ritmica. Insomma un gruppo da cui aspettiamo belle sorprese.
Altro disco d’esordio; a presentarsi al pubblico del jazz è il Late Sense Quartet ovvero Gaetano Santoro al sax, Edoardo Ponzi al vibrafono e marimba, Francesco Marchetti al basso e Mauro Cimarra alla batteria cui si aggiunge in veste di ospite speciale il trombonista Massimo Morganti e un non meglio identificato N2B all’elettronica, probabilmente responsabile della ghost track a chiusura dell’album. Il quartetto si muove lungo direttrici certo non nuove ma percorse con sicurezza cementata da una profonda intesa, dato che il gruppo nasce come trio nel 2015 cui l’anno successivo si aggiunge Gaetano Santoro. Di qui il titolo dell’album che vuole significare la profonda importanza degli incontri e proprio “Meetings fanno notare i musicisti – rappresenta l’incontro fra sensibilità e vite diverse alla ricerca di un minimo comun denominatore che sia il trampolino per creare una musica davvero condivisa”. Ed è proprio grazie a questa intesa che il gruppo riesce a ben districarsi tra atmosfere bop ed un linguaggio che vuole essere più libero, più moderno. Risultato raggiunto appieno soprattutto quando il quartetto diventa quintetto con l’aggiunta di Morganti che si fa ascoltare nella suggestiva “Ballad for my Valentine”, in “Come una rima semplice” (con in bella evidenza anche il vibrafono di Edoardo Ponzi) e nel più movimentato “Broken blue” pezzi firmati i primi due da Marchetti e Ponzi, e il terzo da Gaetano Santoro. Quest’ultimo evidenzia un bel timbro ed una facilità di fraseggio specie quando si trova a dialogare con l’altro fiato. Precisa, mai invadente ma sempre propositiva la sezione ritmica. Insomma un gruppo da cui aspettiamo belle sorprese.
Ugo Moroni – “Pinturas” – Dodicilune 408
 Registrato nel giugno del 2017 l’album presenta il chitarrista e compositore campano di adozione bolognese alla testa di una formazione piuttosto ampia (quattordici elementi) ad interpretare cinque brani di cui tre originals cui si affiancano “A Foggy Day” di George Gershwin e “Demon’s Dance” di Jack McLean eseguita in ottetto. Come sottolinea lo stesso Moroni, i titoli dei brani sono ripresi dalle opere di Francisco Goya mentre la copertina è stata realizzata da Korvo appositamente per questo lavoro. Devo confessare che ho dovuto ascoltare diverse volte l’album in oggetto per realizzare un’opinione compiuta. In effetti ai primi ascolti l’album scorreva bene, con la band ottimamente rodata e alcuni brani particolarmente gradevoli… ma c’era qualcosa che non girava a dovere; successivamente ho realizzato che i pezzi in cui a mio avviso la band si esprimeva meglio erano i due standard ben arrangiati e altrettanto ben eseguiti. Ciò significava, quindi, che erano le altre tre composizioni a non convincere pienamente. In altri termini se Moroni evidenzia una certa maturità sia come strumentista sia come band-leader, probabilmente deve ancora approfondire l’elemento compositivo. Certo nessuno si aspetta che i nostri musicisti sfornino capolavori alla Porter o alla Nelson (per citare due autori di cui ci occupiamo in questa stessa rubrica) ma delle composizioni ben strutturate, equilibrate e in cui parti scritte e improvvisazione si integrino senza sforzo almeno apparente, questo sì. Ecco in alcuni passaggi dei pezzi di Moroni mi è parso di percepire qualche forzatura, qualche sbavatura che sono sicuro saranno superati nei prossimi lavori. Un’ultima considerazione: come ho detto centinaia di volte, queste mie notazioni non hanno la pretesa di essere verità assolute, costituendo un punto di vista assolutamente personale.
Registrato nel giugno del 2017 l’album presenta il chitarrista e compositore campano di adozione bolognese alla testa di una formazione piuttosto ampia (quattordici elementi) ad interpretare cinque brani di cui tre originals cui si affiancano “A Foggy Day” di George Gershwin e “Demon’s Dance” di Jack McLean eseguita in ottetto. Come sottolinea lo stesso Moroni, i titoli dei brani sono ripresi dalle opere di Francisco Goya mentre la copertina è stata realizzata da Korvo appositamente per questo lavoro. Devo confessare che ho dovuto ascoltare diverse volte l’album in oggetto per realizzare un’opinione compiuta. In effetti ai primi ascolti l’album scorreva bene, con la band ottimamente rodata e alcuni brani particolarmente gradevoli… ma c’era qualcosa che non girava a dovere; successivamente ho realizzato che i pezzi in cui a mio avviso la band si esprimeva meglio erano i due standard ben arrangiati e altrettanto ben eseguiti. Ciò significava, quindi, che erano le altre tre composizioni a non convincere pienamente. In altri termini se Moroni evidenzia una certa maturità sia come strumentista sia come band-leader, probabilmente deve ancora approfondire l’elemento compositivo. Certo nessuno si aspetta che i nostri musicisti sfornino capolavori alla Porter o alla Nelson (per citare due autori di cui ci occupiamo in questa stessa rubrica) ma delle composizioni ben strutturate, equilibrate e in cui parti scritte e improvvisazione si integrino senza sforzo almeno apparente, questo sì. Ecco in alcuni passaggi dei pezzi di Moroni mi è parso di percepire qualche forzatura, qualche sbavatura che sono sicuro saranno superati nei prossimi lavori. Un’ultima considerazione: come ho detto centinaia di volte, queste mie notazioni non hanno la pretesa di essere verità assolute, costituendo un punto di vista assolutamente personale.
NovoTono – “Overlays” – ParmaFrontiere 04
 Conoscevo già i NovoTono per l’album “Wanderung” registrato nel 2007 in quartetto dai fratelli Ferrari con Federico Cumar al trombone e Luca Serrapiglio al sax soprano.
Conoscevo già i NovoTono per l’album “Wanderung” registrato nel 2007 in quartetto dai fratelli Ferrari con Federico Cumar al trombone e Luca Serrapiglio al sax soprano.
Adesso ritroviamo il combo che si identifica, però, solo con il duo costituito dai fratelli Ferrari, Adalberto (clarinetto basso, clarinetto, sax soprano, clarinetto contralto) e Andrea (clarinetto basso). L’album, registrato nell’aprile di questo 2018, contiene dodici tracce di cui ben undici originali firmate ora da uno ora dall’altro fratello, e una breve medley costituita da “Odwalla” e “Lonely Woman” scritti rispettivamente da Roscoe Mitchell e Ornette Coleman. Praticamente nudi dinnanzi alla musica, senza il supporto di strumenti armonici e ritmici, i due fratelli se la cavano egregiamente grazie ad un’empatia che si avverte, prepotente, sin dalle primissime note. Senza alcuno sforzo apparente, clarinetto e sassofono si accarezzano, si scontrano, si inseguono in un perfetto equilibrio tra pagina scritta e improvvisazione; il dialogo è fitto, complesso, ma sempre coinvolgente e soprattutto mai banale; le personalità dei due musicisti sono diverse ma riescono ad integrarsi nel proporre una musica assolutamente personale. Un’ultima notazione tutt’altro che secondaria: splendida la copertina opera di Cristina Crippa, regista e fotografa, che ha immortalato i due artisti in un luogo magico quale la Città Fantasma di Consonno, il borgo che nel 1976 vide naufragare a causa di una frana il tentativo del conte Bagno di costruire in Brianza una Las Vegas nostrana.
Enzo Pietropaoli Wire Trio – “Woodstock Reloaded” – Jando Music Via Veneto 123
 E’ il 1969 e dal 15 al 18 agosto si svolge a Bethel, una piccola città rurale nello stato di New York, una manifestazione che sarebbe stata ricordata come la “tre giorni di pace e musica rock”: è il festival di Woodstock che richiama circa 400.000 giovani e a cui partecipano trentadue musicisti e gruppi, fra i più noti del tempo. Quanto sia stato importante questo evento lo dimostra il fatto che è rimasto indelebilmente scolpito nella mente e nel cuore di noi tutti che amiamo la musica. Ad ulteriore conferma ecco questo nuovo album del bassista Enzo Pietropaoli in trio con Enrico Zanisi al piano e tastiere e Alessandro Paternesi alla batteria. In programma otto brani tratti da Woodstock 1969 cui si aggiunge, in chiusura, un original dello Stesso Pietropaoli significativamente intitolato “Back Home”. Ecco quindi “Soul Sacrifice” di Carlo Santana, “With A Little Help From My Friends” magnificamente interpretato allora da Joe Cocker, “Seel Me Feel Me” che ci riporta ai Who… e via di questo passo in una sorta di immaginaria galleria in cui incontriamo Janis Joplin, Joan Baez, Creedence Clearwater Revival, Sly And The Family Stone, Jimi Hendrix… Ma, attenzione, non si tratta di una semplice ripresentazione di cover ché Pietropaoli è musicista troppo bravo ed esperto per cadere in simili banalità. Il progetto è completamente diverso e la stessa struttura dell’organico lo dimostra: Enzo vuole rileggere questi celebri brani alla stregua di un linguaggio più moderno che, nel rispetto assoluto delle valenze originarie, abbia comunque assorbito quanto in campo musicale è avvenuto nel corso di questi decenni. E il risultato è perfettamente raggiunto: i tre si muovono con grande disinvoltura ed empatia evidenziando come si possa fare grande jazz anche rifacendosi ad un repertorio che poco o nulla ha a che vedere con la musica afro-americana.
E’ il 1969 e dal 15 al 18 agosto si svolge a Bethel, una piccola città rurale nello stato di New York, una manifestazione che sarebbe stata ricordata come la “tre giorni di pace e musica rock”: è il festival di Woodstock che richiama circa 400.000 giovani e a cui partecipano trentadue musicisti e gruppi, fra i più noti del tempo. Quanto sia stato importante questo evento lo dimostra il fatto che è rimasto indelebilmente scolpito nella mente e nel cuore di noi tutti che amiamo la musica. Ad ulteriore conferma ecco questo nuovo album del bassista Enzo Pietropaoli in trio con Enrico Zanisi al piano e tastiere e Alessandro Paternesi alla batteria. In programma otto brani tratti da Woodstock 1969 cui si aggiunge, in chiusura, un original dello Stesso Pietropaoli significativamente intitolato “Back Home”. Ecco quindi “Soul Sacrifice” di Carlo Santana, “With A Little Help From My Friends” magnificamente interpretato allora da Joe Cocker, “Seel Me Feel Me” che ci riporta ai Who… e via di questo passo in una sorta di immaginaria galleria in cui incontriamo Janis Joplin, Joan Baez, Creedence Clearwater Revival, Sly And The Family Stone, Jimi Hendrix… Ma, attenzione, non si tratta di una semplice ripresentazione di cover ché Pietropaoli è musicista troppo bravo ed esperto per cadere in simili banalità. Il progetto è completamente diverso e la stessa struttura dell’organico lo dimostra: Enzo vuole rileggere questi celebri brani alla stregua di un linguaggio più moderno che, nel rispetto assoluto delle valenze originarie, abbia comunque assorbito quanto in campo musicale è avvenuto nel corso di questi decenni. E il risultato è perfettamente raggiunto: i tre si muovono con grande disinvoltura ed empatia evidenziando come si possa fare grande jazz anche rifacendosi ad un repertorio che poco o nulla ha a che vedere con la musica afro-americana.
Sonia Spinello – “Café Society” – abeat 182
 Una bella voce perfettamente intonata, giocata prevalentemente sul registro medio, eccellenti capacità interpretative, una spiccata personalità nel riproporre un repertorio assai impegnativo come quello scelto per questo album. La Spinello è andata, infatti, a ripescare alcune perle del songbook americano, brani incisi più e più volte da stelle di primaria grandezza con cui è difficile confrontarsi. Ma la vocalist non è certo tipo da impressionarsi come dimostra l’originale rilettura contenuta nel “Billie Holiday project” (abjz 545) e “Wonderland” (abjz 162), in cui va a rivisitare brani di Steve Wonder e Sting. E lo fa con tale originalità da meritare da parte di “critique award magazine” in Giappone il riconoscimento di miglior disco voce femminile dell’anno 2016. E forse ricorderete che anche il sottoscritto era rimasto particolarmente colpito dall’album tanto da aver votato la Spinello come miglior nuovo talento nell’annuale “Top Jazz” Ma torniamo a questo “Café Society” in cui Sonia è inserita in un quintetto completato da Fabio Buonarota alla tromba (con il quale aveva già collaborato in “Wonderland”), Lorenzo Cominoli alla chitarra, Attilio Zanchi al contrabbasso e Gianni Cazzola alla batteria, come a dire una delle migliori sezioni ritmiche che sia possibile ascoltare nel nostro Paese. Ben coadiuvata da cotanti compagni d’avventura, la Spinello sfodera una prestazione maiuscola; così proseguendo nella linea stilistica che la contraddistingue, la vocalist ancora una volta ha voluto rispettare le melodie originarie sì da farle vieppiù risaltare. E in questo senso particolarmente apprezzabile le interpretazioni di “Love for Sale” di Cole Porter e “Our Love Is Here to Stay” di George e Ira Gershwin impreziosito da una brillante intro di Attilio Zanchi.
Una bella voce perfettamente intonata, giocata prevalentemente sul registro medio, eccellenti capacità interpretative, una spiccata personalità nel riproporre un repertorio assai impegnativo come quello scelto per questo album. La Spinello è andata, infatti, a ripescare alcune perle del songbook americano, brani incisi più e più volte da stelle di primaria grandezza con cui è difficile confrontarsi. Ma la vocalist non è certo tipo da impressionarsi come dimostra l’originale rilettura contenuta nel “Billie Holiday project” (abjz 545) e “Wonderland” (abjz 162), in cui va a rivisitare brani di Steve Wonder e Sting. E lo fa con tale originalità da meritare da parte di “critique award magazine” in Giappone il riconoscimento di miglior disco voce femminile dell’anno 2016. E forse ricorderete che anche il sottoscritto era rimasto particolarmente colpito dall’album tanto da aver votato la Spinello come miglior nuovo talento nell’annuale “Top Jazz” Ma torniamo a questo “Café Society” in cui Sonia è inserita in un quintetto completato da Fabio Buonarota alla tromba (con il quale aveva già collaborato in “Wonderland”), Lorenzo Cominoli alla chitarra, Attilio Zanchi al contrabbasso e Gianni Cazzola alla batteria, come a dire una delle migliori sezioni ritmiche che sia possibile ascoltare nel nostro Paese. Ben coadiuvata da cotanti compagni d’avventura, la Spinello sfodera una prestazione maiuscola; così proseguendo nella linea stilistica che la contraddistingue, la vocalist ancora una volta ha voluto rispettare le melodie originarie sì da farle vieppiù risaltare. E in questo senso particolarmente apprezzabile le interpretazioni di “Love for Sale” di Cole Porter e “Our Love Is Here to Stay” di George e Ira Gershwin impreziosito da una brillante intro di Attilio Zanchi.
Gerlando Gatto
da Marco Giorgi per www.red-ki.com | 12/Lug/2018 | Appuntamenti, I nostri Eventi, Primo piano, Recensioni

Neanche l’atteso ottavo di finale tra Russia e Croazia ai campionati mondiali di calcio ha impedito ai fan degli Snarky Puppy di accorrere all’Auditorium Parco della Musica di Roma per assistere al concerto di una delle più interessanti formazioni apparse negli ultimi anni. Abbiamo scritto “una delle più interessanti formazioni apparse negli ultimi anni” e non “una delle più interessanti formazioni apparse nel mondo del jazz negli ultimi anni” per correttezza intellettuale.
In realtà gli Snarky Puppy sono una band del tutto atipica, per questo, quando si parla di loro, occorre scegliere bene i termini e accettare il fatto che con loro le categorie musicali generalmente utilizzate per definire la musica sono del tutto inutili.
Sotto certi versi gli Snarky Puppy ci hanno fatto venire in mente il pianeta Solaris descritto dallo scrittore polacco Stanislaw Lew e portato sugli schermi dal regista russo Andreij Tarkovskij (sul remake con George Clooney stendiamo un velo pietoso…). Come Solaris, gli Snarky Puppy sono una formazione in continua evoluzione, mai uguale a se stessa, estremamente cangiante nelle scelte musicali, ma capace di dare vita ai tuoi desideri più reconditi ed inespressi. Tanto per dare un’idea della difficoltà di catalogazione, nel 2014 il gruppo guidato dal bassista Michael League ha ottenuto con Something il Grammy Award come migliore performance rhythm’n’blues. Nel 2015 i lettori di Down Beat hanno eletto gli Snarky Puppy il Jazz Group of the Year mentre nel 2016 e 2017, rispettivamente, con Sylvia e Culcha Vulcha hanno ottenuto un Grammy come Best Contemporary Instrumental Album. Come se ciò non fosse sufficiente League ha trovato anche la maniera di produrre gli ultimi due album di David Crosby, Lighthouse e Sky Trail, regalando una seconda giovinezza al vecchio gigante della West Coast.
Non chiedeteci che genere suonano gli Snarky Puppy perché non sapremmo cosa rispondere. Li suonano tutti e tutti insieme, ma contemporaneamente non ne suonano nessuno. In questo operano una fusione tra generi, ma guai a definirli fusion. Immaginate la band come un enorme shaker musicale dove gli ingredienti sono miscelati in dosi diverse. Ad agitare il tutto è una possente sezione ritmica, con le batterie a dialogare sempre tra loro, il basso elettrico a tenere groove, spesso doppiati dalla mano sinistra di una tastiera. Al di sopra degli strati ritmici creati emergono improvvisamente assoli di chitarra elettrica, oppure è la sezione fiati che disegna linee soul, funk jazz, rock, giungendo anche a ricordare gli inni del Philadelphia sound.
Anche a livello di formazione il gruppo di Brooklyn (anche se formato a Dallas, Texas) non ha un assetto tipo. Sono infatti una trentina i musicisti che ne fanno parte, a rotazione. Come più volte ha affermato League, riferendosi agli Snarky Puppy, è più giusto pensare al concetto di una famiglia i cui componenti si frequentano, ma non necessariamente si vedono sempre tutti insieme. Per ogni strumento ci sono tre o quattro musicisti disponibili. I chitarristi sono tre, cinque i tastieristi, quattro i batteristi, sei i musicisti ai fiati. Anche la fase di composizione dei brani è molto originale. Chiunque può proporre una sua composizione che viene poi provata assieme. Nel corso di questa fase ogni musicista può portare cambiamenti o avanzare i suoi suggerimenti. Il brano viene eseguito sino a quando non viene trovata la giusta alchimia frutto del lavoro di squadra.
A Roma gli Snarky Puppy si sono presentati in nove, con una formazione composta da due batterie, un basso elettrico, una chitarra elettrica, due fiati, una tromba e un sax tenore (a volte tre quando un tastierista lasciava il suo strumento e si aggiungeva alla sezione), tre tastiere. Un groove di basso di League ha dato il via a un concerto, purtroppo non impeccabile dal punto di vista sonoro. Spesso si sono udite distorsioni sui fiati, che sono un elemento fondamentale nel suono della band e il volume, generalmente troppo elevato, ha penalizzato la musica invece che esaltarla. Di solito questi problemi si risolvono dopo un paio di brani, ma purtroppo stavolta i fonici non sono riusciti a rimediare. Il rimpianto di non aver potuto ascoltare la musica degli Snarky Puppy al 100% delle sue possibilità è stato ben presto superato dall’entusiasmante prestazione del gruppo. Già al secondo brano, un lento con una parte di fiati alla Sketches of Spain, incastonato su una ritmica funk, ha indotto il pubblico all’applauso ritmico e ad accompagnare, cantando, i temi della band. Non ci era mai accaduto ascoltare la platea intonare dei temi strumentali. Kite, tratto da We Like It Here, è stato accolto da un’ovazione e così tutti i successivi brani proposti dal gruppo. L’entusiasmo del pubblico, in genere molto giovane, è stato autentico e trascinante. Nel corso della serata che è stata essenzialmente improntata al funk (perdonerete la semplificazione giornalistica) abbiamo provato ad analizzare le componenti del gruppo, così come al ristorante si cerca di individuare la ricetta o l’ingrediente segreto di un piatto che ci sta piacendo particolarmente. La base, come detto prima, è la ritmica, con le due batterie a portare i primi mattoni nella costruzione dei brani e il basso elettrico a iniziare l’innalzamenti del muro della struttura portante. Le tre tastiere avevano (perdonate ancora la banalizzazione) compiti ben precisi. La prima era essenzialmente ritmica e spesso doppiava le linee di basso di League. La seconda aveva un suono molto tagliente, anni Settanta, alla Chick Corea del periodo Return to Forever, mentre la terza (probabilmente un Hammond C-3) aveva una funzione più soul e groovy. La chitarra elettrica era essenzialmente rock, mentre la sezione fiati (che meraviglia, l’avremmo voluta più ampia) agiva quasi come solista e aveva il compito di eseguire linee melodiche fossero esse improvvisazioni jazz o stacchi funk. Ogni volta che la sezione entrava in azione, le sue linee risultavano sorprendenti e capaci di trasformare il mood del brano, vuoi per la bellezza dei temi proposti vuoi per l’inatteso contrasto apportato rispetto alla generale dinamica del brano. In una intervista League ha spiegato di essere cresciuto ascoltando tantissimo pop, soul, rhythm’n’blues. La scuola jazz che ha frequentato gli ha insegnato le basi della teoria musicale, rendendolo capace di comporre musica con sensibilità pop, sebbene dotata di profondità. League non ha mai voluto essere il nuovo grande musicista jazz ma piuttosto essere un musicista che scrive musica unica, risultato della combinazione dei generi che ama. Da quanto abbiamo potuto ascoltare nel corso del concerto, League ha decisamente realizzato il suo obiettivo.
Marco Giorgi
www.red-ki.com
 Lost Record del Live in Paris del 1975, pubblicato e restaurato dall’etichetta discografica Transversales Disques. Sébastien Rosat, co-fondatore dell’etichetta, mi ha spiegato in un breve scambio di mail che l’album è stato come ritrovare un tesoro; già dal primo ascolto si capiva quanto fosse una performance straordinaria. La Transversales Disques ha compiuto in primis un lavoro di restauro sul materiale ritrovato nel 2017 nel caveau di Radio France e a impreziosire l’esperienza c’è la minuzia per la ricerca di fotografie scattate per quella performance. Proprio quando le ricerche stavano per arrivare a un punto morto ci ha pensato la fortuna a fargli ritrovare una foto del concerto in “Jazz Hot” Magazine per mano della fotocamera di Christian Rose che ha fornito un rullino pieno di splendide istantanee dell’evento, arricchendo un’edizione discografica rara e unica; sicuramente realizzata con quel tipo di passione che solo gli amanti del jazz riescono a mettere in ciò che fanno nella vita. Questa storia ci catapulta in una prospettiva romantica nei confronti dell’album, ma diventa un antipasto ricco di proteine per affrontare il viaggio che propongo, ma soprattutto è funzionale a un piccolo gioco di prestigio: usare l’album del concerto come incipit, cercando di rovesciare la classica prospettiva della biografia al servizio della musica, seguendo piuttosto il flusso sonoro del live e quello degli eventi in ordine cronologico. Questo processo permette di trasformare quel poliedro di cui parlavo, attraverso la scomposizione e ricomposizione in una nuova forma, quella plasmata dalle note del sassofono di Sanders il 17 novembre del 1975 al Grand Auditorium nello studio 105 della Maison de la Radio.
Lost Record del Live in Paris del 1975, pubblicato e restaurato dall’etichetta discografica Transversales Disques. Sébastien Rosat, co-fondatore dell’etichetta, mi ha spiegato in un breve scambio di mail che l’album è stato come ritrovare un tesoro; già dal primo ascolto si capiva quanto fosse una performance straordinaria. La Transversales Disques ha compiuto in primis un lavoro di restauro sul materiale ritrovato nel 2017 nel caveau di Radio France e a impreziosire l’esperienza c’è la minuzia per la ricerca di fotografie scattate per quella performance. Proprio quando le ricerche stavano per arrivare a un punto morto ci ha pensato la fortuna a fargli ritrovare una foto del concerto in “Jazz Hot” Magazine per mano della fotocamera di Christian Rose che ha fornito un rullino pieno di splendide istantanee dell’evento, arricchendo un’edizione discografica rara e unica; sicuramente realizzata con quel tipo di passione che solo gli amanti del jazz riescono a mettere in ciò che fanno nella vita. Questa storia ci catapulta in una prospettiva romantica nei confronti dell’album, ma diventa un antipasto ricco di proteine per affrontare il viaggio che propongo, ma soprattutto è funzionale a un piccolo gioco di prestigio: usare l’album del concerto come incipit, cercando di rovesciare la classica prospettiva della biografia al servizio della musica, seguendo piuttosto il flusso sonoro del live e quello degli eventi in ordine cronologico. Questo processo permette di trasformare quel poliedro di cui parlavo, attraverso la scomposizione e ricomposizione in una nuova forma, quella plasmata dalle note del sassofono di Sanders il 17 novembre del 1975 al Grand Auditorium nello studio 105 della Maison de la Radio.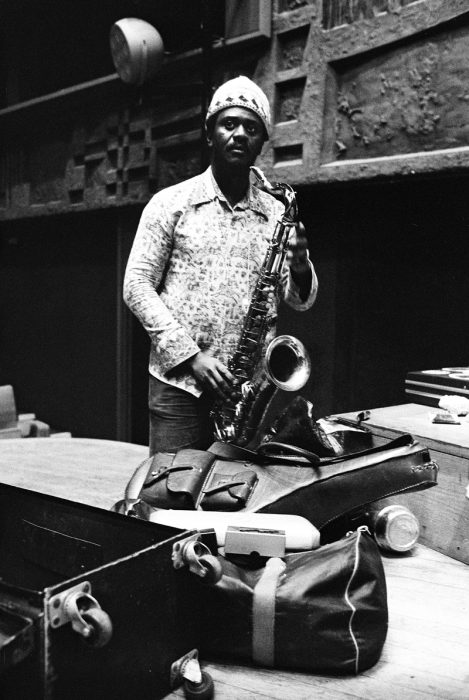 Love is Here part I/part II
Love is Here part I/part II




 Il 13, sempre alla Cavea, appuntamento con una vera e propria leggenda del jazz: Herbie Hancock. Spesso si adopera la parola “leggenda” in modo esagerato ma nel caso in questione non v’è dubbio alcuno che il termine sia più che appropriato. Non è questa la sede adatta per sintetizzare un curriculum assolutamente straordinario; basti solo dire che l’artista di Chicago, oggi ottantunenne, ha attraversato, sempre da protagonista, generi e mode come performer, compositore, arrangiatore, produttore, scopritore di talenti, inventore di nuove tendenze, senza mai perdere una coerenza di fondo. A Roma si è presentato alla testa di una band eccezionale completata da Terence Blanchard alla tromba, Lionel Loueke (chitarra), James Genus (basso) e Justin Tyson (batteria). Ascoltare un concerto di Hancock è come rivivere, in sintesi, buona parte della storia del jazz dal momento che questo artista ha sviluppato un’estetica giocata sempre su una sorta di doppio binario: da un canto virtuoso pianista del jazz acustico, dall’altro estimatore se non fondatore del funky elettronico. E questi due aspetti della sua personalità sono apparsi evidenti anche nel concerto romano; così in una prima parte abbiamo ascoltato alcuni classici del jazz come il sempre verde “Footprints” di Wayne Shorter, un altro giovanotto di 89 anni, omaggiato da Hancock che si alternava al piano e alle tastiere non disdegnando un ricorso mai esagerato al vocoder (ma che comunque se non ci fosse stato nulla avrebbe tolto alla validità del concerto). Nella seconda parte Hancock si richiamava al suo coté più funky e chiudeva il concerto con “Chameleon” brano tratto dal celebre album “Head Hunters” del 1973, scatenando l’entusiasmo del pubblico che si è accalcato a ballare sotto il palco.
Il 13, sempre alla Cavea, appuntamento con una vera e propria leggenda del jazz: Herbie Hancock. Spesso si adopera la parola “leggenda” in modo esagerato ma nel caso in questione non v’è dubbio alcuno che il termine sia più che appropriato. Non è questa la sede adatta per sintetizzare un curriculum assolutamente straordinario; basti solo dire che l’artista di Chicago, oggi ottantunenne, ha attraversato, sempre da protagonista, generi e mode come performer, compositore, arrangiatore, produttore, scopritore di talenti, inventore di nuove tendenze, senza mai perdere una coerenza di fondo. A Roma si è presentato alla testa di una band eccezionale completata da Terence Blanchard alla tromba, Lionel Loueke (chitarra), James Genus (basso) e Justin Tyson (batteria). Ascoltare un concerto di Hancock è come rivivere, in sintesi, buona parte della storia del jazz dal momento che questo artista ha sviluppato un’estetica giocata sempre su una sorta di doppio binario: da un canto virtuoso pianista del jazz acustico, dall’altro estimatore se non fondatore del funky elettronico. E questi due aspetti della sua personalità sono apparsi evidenti anche nel concerto romano; così in una prima parte abbiamo ascoltato alcuni classici del jazz come il sempre verde “Footprints” di Wayne Shorter, un altro giovanotto di 89 anni, omaggiato da Hancock che si alternava al piano e alle tastiere non disdegnando un ricorso mai esagerato al vocoder (ma che comunque se non ci fosse stato nulla avrebbe tolto alla validità del concerto). Nella seconda parte Hancock si richiamava al suo coté più funky e chiudeva il concerto con “Chameleon” brano tratto dal celebre album “Head Hunters” del 1973, scatenando l’entusiasmo del pubblico che si è accalcato a ballare sotto il palco. Il 12 luglio una vecchia e cara conoscenza del pubblico romano: John Scofield. Il chitarrista può a ben ragione essere considerato una delle massime espressioni della chitarra jazz degli ultimi decenni. Musicista eclettico, voglioso sempre di sperimentare strade nuove, questa volta si è presentato con un progetto del tutto nuovo, “Yankee Go Home”, con cui torna alle radici del rock americano, riscoprendo classici fra il folk e il rock’n’roll. Accanto a lui Jon Cowherd (pianoforte e tastiere), Vicente Archer (contrabbasso)e Josh Dion (batteria). E’ lo stesso Scofield a illustrare il senso di questo nuovo progetto, non senza elogiare i suoi compagni di viaggio: “L’idea –afferma Scofield – è di coprire successi americani/rock e canzoni folk jazz, più alcuni dei miei brani originali scritti in quel modo. Mi sto riconnettendo con molte delle mie radici Rock ‘n Roll da adolescente, naturalmente colorate dai miei 50 anni di pratica Jazz…. Questi ragazzi sono straordinariamente versatili, altrettanto bravi quando si tratta di suonare in modo interattivo e creativo. Stiamo esplorando rock, funk, country, jazz e musica libera e ci divertiamo moltissimo. Sono entusiasta di questa collaborazione”. Risultato raggiunto? Assolutamente sì; il repertorio, comprendente brani tra gli altri di Bob Dylan, Neil Young, Grateful Dead, B.B. King, Buddy Holly, viene declinato attraverso quella maestria strumentale che ben conosciamo oramai da tanti anni. Scofield è sempre lì a tessere le fila del discorso, con un solismo preciso, elegante, raffinato mai soverchiante cosicché tutti i suoi compagni di viaggio hanno la possibilità di mettersi in luce. I vari pezzi vengono riletti alla luce di quelle esperienze cui lo stesso Scofield faceva riferimento ridando loro una sorta di nuova linfa e il pubblico dimostra di apprezzare con lunghi appalusi a scena aperta. Immancabile il bis: un coinvolgente blues che evidenzia come Scofield rimanga solidamente ancorato anche alle radici della musica afro-americana.
Il 12 luglio una vecchia e cara conoscenza del pubblico romano: John Scofield. Il chitarrista può a ben ragione essere considerato una delle massime espressioni della chitarra jazz degli ultimi decenni. Musicista eclettico, voglioso sempre di sperimentare strade nuove, questa volta si è presentato con un progetto del tutto nuovo, “Yankee Go Home”, con cui torna alle radici del rock americano, riscoprendo classici fra il folk e il rock’n’roll. Accanto a lui Jon Cowherd (pianoforte e tastiere), Vicente Archer (contrabbasso)e Josh Dion (batteria). E’ lo stesso Scofield a illustrare il senso di questo nuovo progetto, non senza elogiare i suoi compagni di viaggio: “L’idea –afferma Scofield – è di coprire successi americani/rock e canzoni folk jazz, più alcuni dei miei brani originali scritti in quel modo. Mi sto riconnettendo con molte delle mie radici Rock ‘n Roll da adolescente, naturalmente colorate dai miei 50 anni di pratica Jazz…. Questi ragazzi sono straordinariamente versatili, altrettanto bravi quando si tratta di suonare in modo interattivo e creativo. Stiamo esplorando rock, funk, country, jazz e musica libera e ci divertiamo moltissimo. Sono entusiasta di questa collaborazione”. Risultato raggiunto? Assolutamente sì; il repertorio, comprendente brani tra gli altri di Bob Dylan, Neil Young, Grateful Dead, B.B. King, Buddy Holly, viene declinato attraverso quella maestria strumentale che ben conosciamo oramai da tanti anni. Scofield è sempre lì a tessere le fila del discorso, con un solismo preciso, elegante, raffinato mai soverchiante cosicché tutti i suoi compagni di viaggio hanno la possibilità di mettersi in luce. I vari pezzi vengono riletti alla luce di quelle esperienze cui lo stesso Scofield faceva riferimento ridando loro una sorta di nuova linfa e il pubblico dimostra di apprezzare con lunghi appalusi a scena aperta. Immancabile il bis: un coinvolgente blues che evidenzia come Scofield rimanga solidamente ancorato anche alle radici della musica afro-americana. La band inizia a suonare senza presentare alcunché; McCraven è uomo di poche parole, e non si concede quasi mai pause, tranne una ogni tre pezzi circa per presentare e ringraziare la sua band e per annunciare – qualche volta – il nome del prossimo pezzo. Per il resto è stata una serata di pura musica ed energia: non solo di McCraven, il cui vigore era pari alla sua abilità – mai sentito un batterista che suonasse per circa un’ora e mezza, senza mai smettere di percuotere pelli e piatti con tanta ininterrotta energia – ma anche di tutti gli altri musicisti, che durante il concerto si cimentavano con diversi tipi di percussioni. Altra nota di merito va alla varietà di brani suonati: si passa da pezzi ormai diventati standard del jazz, come “Autumn in New York”, Frank’s Tune” di Frank Strzier o “A Slice of the Top” a pezzi originali di McCraven, come “In These Times”, “The Bounce!” e un inedito tratto dal suo prossimo album in uscita a settembre.
La band inizia a suonare senza presentare alcunché; McCraven è uomo di poche parole, e non si concede quasi mai pause, tranne una ogni tre pezzi circa per presentare e ringraziare la sua band e per annunciare – qualche volta – il nome del prossimo pezzo. Per il resto è stata una serata di pura musica ed energia: non solo di McCraven, il cui vigore era pari alla sua abilità – mai sentito un batterista che suonasse per circa un’ora e mezza, senza mai smettere di percuotere pelli e piatti con tanta ininterrotta energia – ma anche di tutti gli altri musicisti, che durante il concerto si cimentavano con diversi tipi di percussioni. Altra nota di merito va alla varietà di brani suonati: si passa da pezzi ormai diventati standard del jazz, come “Autumn in New York”, Frank’s Tune” di Frank Strzier o “A Slice of the Top” a pezzi originali di McCraven, come “In These Times”, “The Bounce!” e un inedito tratto dal suo prossimo album in uscita a settembre. Il 23 la Casa de Jazz proponeva un quesito intrigante: può la sofisticata poetica di un Pieranunzi coniugarsi con l’incredibile carica energetica di Antonello Salis? In altri termini possono coesistere due musicisti stilisticamente quasi all’opposto, uniti solo dalla grande passione e dedizione alla musica? Ciò perché il concerto in programma prevedeva per l’appunto un duo di piano composto da questi due artisti che mai avevano avuto modo di incontrarsi sul palco. Grande attesa, quindi, e non a caso grande affluenza di pubblico…ripagato da un concerto sicuramente interessante. Seduti l’uno di fronte all’altro i due hanno suonato per circa un’ora e mezza sciorinando un’intesa che non era facile prevedere. Spesso si partiva da un tema che veniva sviluppato, esaminato, sviscerato fin nelle sue più intime pieghe e quindi riproposto in una veste totalmente diversa che traeva nelle capacità improvvisative dei due nuova linfa vitale. E questa volta non si può dire che l’uno si sia piegato alle esigenze dell’altro in quanto ambedue hanno sviluppato appieno le proprie tematiche che finivano con l’incontrarsi su un terreno ben frequentato sia da Enrico sia da Antonello: l’improvvisazione pura o forse meglio la capacità di creare musica strada facendo. In effetti, oltre che partire da un dato tema, i due si sono spesso avventurati anche sul foglio bianco, vale a dire cominciando a suonare senza conoscere il punto di approdo, con una maestria che solo pochi posseggono.
Il 23 la Casa de Jazz proponeva un quesito intrigante: può la sofisticata poetica di un Pieranunzi coniugarsi con l’incredibile carica energetica di Antonello Salis? In altri termini possono coesistere due musicisti stilisticamente quasi all’opposto, uniti solo dalla grande passione e dedizione alla musica? Ciò perché il concerto in programma prevedeva per l’appunto un duo di piano composto da questi due artisti che mai avevano avuto modo di incontrarsi sul palco. Grande attesa, quindi, e non a caso grande affluenza di pubblico…ripagato da un concerto sicuramente interessante. Seduti l’uno di fronte all’altro i due hanno suonato per circa un’ora e mezza sciorinando un’intesa che non era facile prevedere. Spesso si partiva da un tema che veniva sviluppato, esaminato, sviscerato fin nelle sue più intime pieghe e quindi riproposto in una veste totalmente diversa che traeva nelle capacità improvvisative dei due nuova linfa vitale. E questa volta non si può dire che l’uno si sia piegato alle esigenze dell’altro in quanto ambedue hanno sviluppato appieno le proprie tematiche che finivano con l’incontrarsi su un terreno ben frequentato sia da Enrico sia da Antonello: l’improvvisazione pura o forse meglio la capacità di creare musica strada facendo. In effetti, oltre che partire da un dato tema, i due si sono spesso avventurati anche sul foglio bianco, vale a dire cominciando a suonare senza conoscere il punto di approdo, con una maestria che solo pochi posseggono. Guidati dal funambolico sassofonista Shabaka Hutchings, il quartetto (completato dal basso tuba di Theon Cross e ben due batterie nelle mani di Eddie Hick e della giovanissima e bravissima Jas Keyser in sostituzione di Tom Skinner in tour con Thom Yorke) ha sciorinato una musica di grande intensità, basata sul fitto tappeto ritmico intessuto dalle due batterie su cui svolgevano i loro interventi i due fiati. In particolare il sax del leader, spesso effettato con delay o reverberi, non disegnava lunghe linee melodiche ma intonava frasi ritmiche e frammenti melodici ripetuti più volte mentre il basso tuba contribuiva in maniera determinante a completare il tessuto ritmico delle due batterie. Il tutto ‘condito’ da un volume molto, molto elevato a creare una musica che raggiungesse l’obiettivo di portare al massimo l’eccitazione dell’uditorio e di coinvolgerlo in una sorta di rito collettivo in cui i richiami all’Africa erano ben evidenti. Si tenga presente che il concerto si è sviluppato su una linea di continuità ininterrotta tranne due momenti in cui Shabaka Hutchings ha imbracciato un flauto di legno per intonare una splendida melodia di origine africana e il tubista si è espresso in solitudine. Obiettivo raggiunto? Quanto al coinvolgimento direi proprio di sì… anche se non al cento per cento. Nel senso che, ad esempio, il vostro cronista non si è sentito coinvolto dalla musica dei Sons of Kemet. Ed il perché non è difficile da spiegare: avendo avuto la fortuna di ascoltare anche dal vivo alcuni dei più grandi musicisti – per intenderci quelli che hanno scritto davvero la storia del jazz – non è facile lasciarsi impressionare da qualcuno che pur suonando bene non raggiunge quei vertici cui prima si faceva riferimento. Quanto ai messaggi che questa musica così aggressiva intende veicolare, ci viene in soccorso lo stesso Shabaka Hutchings affermando che “Black to the Future (ultimo album del gruppo) è un poema sonoro di invocazione del potere, del ricordo e della guarigione. Raffigura un movimento, quello della ridefinizione e riaffermazione di cosa significa lottare per il black power”. Ma anche sotto questo aspetto non riusciamo a vedere una grande novità dal momento che il jazz come musica di protesta non è certo cosa di oggi.
Guidati dal funambolico sassofonista Shabaka Hutchings, il quartetto (completato dal basso tuba di Theon Cross e ben due batterie nelle mani di Eddie Hick e della giovanissima e bravissima Jas Keyser in sostituzione di Tom Skinner in tour con Thom Yorke) ha sciorinato una musica di grande intensità, basata sul fitto tappeto ritmico intessuto dalle due batterie su cui svolgevano i loro interventi i due fiati. In particolare il sax del leader, spesso effettato con delay o reverberi, non disegnava lunghe linee melodiche ma intonava frasi ritmiche e frammenti melodici ripetuti più volte mentre il basso tuba contribuiva in maniera determinante a completare il tessuto ritmico delle due batterie. Il tutto ‘condito’ da un volume molto, molto elevato a creare una musica che raggiungesse l’obiettivo di portare al massimo l’eccitazione dell’uditorio e di coinvolgerlo in una sorta di rito collettivo in cui i richiami all’Africa erano ben evidenti. Si tenga presente che il concerto si è sviluppato su una linea di continuità ininterrotta tranne due momenti in cui Shabaka Hutchings ha imbracciato un flauto di legno per intonare una splendida melodia di origine africana e il tubista si è espresso in solitudine. Obiettivo raggiunto? Quanto al coinvolgimento direi proprio di sì… anche se non al cento per cento. Nel senso che, ad esempio, il vostro cronista non si è sentito coinvolto dalla musica dei Sons of Kemet. Ed il perché non è difficile da spiegare: avendo avuto la fortuna di ascoltare anche dal vivo alcuni dei più grandi musicisti – per intenderci quelli che hanno scritto davvero la storia del jazz – non è facile lasciarsi impressionare da qualcuno che pur suonando bene non raggiunge quei vertici cui prima si faceva riferimento. Quanto ai messaggi che questa musica così aggressiva intende veicolare, ci viene in soccorso lo stesso Shabaka Hutchings affermando che “Black to the Future (ultimo album del gruppo) è un poema sonoro di invocazione del potere, del ricordo e della guarigione. Raffigura un movimento, quello della ridefinizione e riaffermazione di cosa significa lottare per il black power”. Ma anche sotto questo aspetto non riusciamo a vedere una grande novità dal momento che il jazz come musica di protesta non è certo cosa di oggi. Smaltita la sbornia dell’“Afrofuturism” (così viene definita la musica di Sons of Kemet da chi se ne intende), ecco il 27 sempre alla Casa del Jazz, la giovane e brava sassofonista Nubya Garcia, reduce dallo straordinario successo ottenuto dal suo primo album “Source” su etichetta Concord. Bel concerto questo con una musica sì proiettata verso il futuro ma sempre memore di ciò che il jazz ha rappresentato fino ad oggi. Anche la Garcia viene fuori dalla tumultuosa scena londinese di questi ultimi anni affermandosi passo dopo passo come una delle strumentiste più preparate e fantasiose del pur vasto panorama. In effetti Nubya frequenta il sax da tanti anni riuscendo così a raggiungere una tecnica tutt’altro che banale, una tecnica comunque sempre messa al servizio dell’espressività e di una concezione musicale fortemente inclusiva dal momento che nelle sue performances sono ben riscontrabili echi di jazz spirituale, dub, reggae, ritmi latini e suoni africani. Così il concerto si è sviluppato lungo modalità contrassegnate da notevoli assolo non solo della leader ma anche del pianista-tastierista Alastair MacSween mentre la sezione ritmica (Daniel Casimir contrabbasso e Sam Jones batteria) forniva un supporto sempre preciso, puntuale, propositivo. E a proposito di ritmo, da sottolineare la sensualità dei ritmi colombiani rinverdita dalla Nubya nella riproposizione di uno dei brani più riusciti dell’intera serata, “La Cumbia Me Está Llamando”, scritta con il trio colombiano al femminile “La Perla”.
Smaltita la sbornia dell’“Afrofuturism” (così viene definita la musica di Sons of Kemet da chi se ne intende), ecco il 27 sempre alla Casa del Jazz, la giovane e brava sassofonista Nubya Garcia, reduce dallo straordinario successo ottenuto dal suo primo album “Source” su etichetta Concord. Bel concerto questo con una musica sì proiettata verso il futuro ma sempre memore di ciò che il jazz ha rappresentato fino ad oggi. Anche la Garcia viene fuori dalla tumultuosa scena londinese di questi ultimi anni affermandosi passo dopo passo come una delle strumentiste più preparate e fantasiose del pur vasto panorama. In effetti Nubya frequenta il sax da tanti anni riuscendo così a raggiungere una tecnica tutt’altro che banale, una tecnica comunque sempre messa al servizio dell’espressività e di una concezione musicale fortemente inclusiva dal momento che nelle sue performances sono ben riscontrabili echi di jazz spirituale, dub, reggae, ritmi latini e suoni africani. Così il concerto si è sviluppato lungo modalità contrassegnate da notevoli assolo non solo della leader ma anche del pianista-tastierista Alastair MacSween mentre la sezione ritmica (Daniel Casimir contrabbasso e Sam Jones batteria) forniva un supporto sempre preciso, puntuale, propositivo. E a proposito di ritmo, da sottolineare la sensualità dei ritmi colombiani rinverdita dalla Nubya nella riproposizione di uno dei brani più riusciti dell’intera serata, “La Cumbia Me Está Llamando”, scritta con il trio colombiano al femminile “La Perla”.