da Redazione | 23/Mar/2023 | News, Primo piano, Recensioni
Dal nostro inviato speciale a Bergamo, Massi Boscarol
BERGAMO – il trade union tra il Film Festival e quello Jazz è fissato per un interminabile pomeriggio di domenica diciannove marzo all’Auditorium di Piazza della Libertà: Les félins + L’inferno. Protagonisti assoluti Alain Delon, prima – Simone Graziano, dopo.
Tutto rigorosamente b/n nonostante mezzo secolo e diverse generazioni di cineasti che li separano, i titoli di testa aprono con un classico catwalk di Lalo Schifrin su espressione non ancora completamente glaciale modello lama di Toledo del divo francese per eccellenza, del quale si nota come si stia già affinando nell’arte della proverbiale quanto invidiabile e perfetta inespressività. Jane Fonda, che a quel tempo nell’atto di emanciparsi dall’essere la figlia di Henry, lo guarda con innocenza attonita mentre faccia d’angelo (solo la faccia, sia chiaro) si corrompe costruendosi da sé medesimo o quasi una prigione che non è assolutamente fuori luogo definire infernale.
Dall’altra parte, ovvero qualche ora dopo e tanto per rimanere in tema, i cent’anni (centododici per la precisione) de L’inferno di Dante trasposto su pellicola dalla triade costituita da Francesco Bertolini, Giuseppe De Liguoro e Adolfo Padovan sono sottolineati, riespressi, amplificati dalla creatività vulcanica di Simone Graziano.
Mezzacoda scoperto, preparazione creativa sulle orme di John Cage e di altri grandi predecessori della sperimentazione pianistica, al parterre scorre circa un’ora accompagnata dal Sommo Poeta, Virgilio, il già citato Graziano appunto e un nugolo di dannati perennemente mezzi nudi che per l’epoca si sarebbero comunque guadagnati l’accesso ai gironi con le temperature più elevate, se non altro per la morale dei costumi
Pianismo lirico, a volte appena accennato, l’ottantotto tasti che saltuariamente funge da strumento percussivo di primitiva creazione, offre tuffi nelle profondità degli inferi alternati a impercettibili cenni di speranza: il conte Ugolino, Paolo & Francesca, Pier della Vigna, Lucifero a chiudere con effetti speciali primordiali che ora ci appaiono tanto improbabili ed ingenui quanto suggestivi. Già, quell’inferno religioso ed ancestrale fa quasi più paura dell’odierno, tecnologico. Quasi.
 Si diceva, un punto di unione, uno scambio, un passaggio. Alain Delon, perché cinematografico e jazz. Cinematografico – icona assoluta adorata dal pubblico, in particolare da un certo pubblico, piuttosto disprezzata dalla critica, cosa che però non gli ha mai fatto perdere il sonno. E jazz – irriverente, sfrontato, impassibile e naturalmente bello. Qui, si diceva, con l’argento vivo del personaggio che interpreta cullato dalle note del compositore dei poi Callaghan, qualche anno più tardi assieme a Charles Bronson e quella loro straordinaria complicità con il sound funky e perentorio composée par François de Roubaix. E poi L’inferno, anch’esso cinematografico e jazz. Cinematografico – non serve neanche dirlo e jazz – nato come endecasillabo, piuttosto formale, rigido e rigoroso, nella versione della colonna sonora in differita di Graziano, apre con spunti di turbolenze armoniche esaltate dalla tecnica sopraffina dell’esecutore, piani e forti che nelle didascalie originali della pellicola Dante stesso faticherebbe a riconoscere ed improvvisazioni sempre piuttosto sulfuree e definitive, così come la tragica sorte di coloro che percorrono quei gironi a cono rovesciato.
Si diceva, un punto di unione, uno scambio, un passaggio. Alain Delon, perché cinematografico e jazz. Cinematografico – icona assoluta adorata dal pubblico, in particolare da un certo pubblico, piuttosto disprezzata dalla critica, cosa che però non gli ha mai fatto perdere il sonno. E jazz – irriverente, sfrontato, impassibile e naturalmente bello. Qui, si diceva, con l’argento vivo del personaggio che interpreta cullato dalle note del compositore dei poi Callaghan, qualche anno più tardi assieme a Charles Bronson e quella loro straordinaria complicità con il sound funky e perentorio composée par François de Roubaix. E poi L’inferno, anch’esso cinematografico e jazz. Cinematografico – non serve neanche dirlo e jazz – nato come endecasillabo, piuttosto formale, rigido e rigoroso, nella versione della colonna sonora in differita di Graziano, apre con spunti di turbolenze armoniche esaltate dalla tecnica sopraffina dell’esecutore, piani e forti che nelle didascalie originali della pellicola Dante stesso faticherebbe a riconoscere ed improvvisazioni sempre piuttosto sulfuree e definitive, così come la tragica sorte di coloro che percorrono quei gironi a cono rovesciato.
Cala il sipario, non c’è speranza per nessuno. E quindi – questo fine settimana – uscimmo a riveder le stelle: Amaro Freitas, Paolo Fresu, Richard Galliano, Richard Bona, per citarne solo alcune. Le stelle del jazz!
Massi Boscarol
da Gerlando Gatto | 11/Mar/2023 | I nostri CD, Primo piano, Recensioni
Dopo le numerose escursioni di Amedeo Furfaro intorno al jazz italiano, questa volta soffermiamo la nostra attenzione sulle novità che arrivano dall’estero.
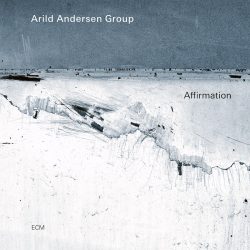 Arild Andersen Group – “Affirmation” – ECM
Arild Andersen Group – “Affirmation” – ECM
Arild Andersen, contrabbassista norvegese, è uno di quei rari musicisti che non sbaglia un colpo. Ogni suo album è frutto di lunga meditazione quindi di sicura riuscita…almeno dal punto di vista artistico, ché come sappiamo il gradimento del pubblico è altra cosa. Ad accompagnarlo in questa nuova impresa musicisti quasi tutti molto più giovani: il pianista quarantasettenne Helge Lien, l’altro quarantasettenne Hakon Mjaset Johansen alla batteria e il trentaseienne Marius Neset al sax. Il repertorio è suddiviso in due parti, ciascuna delle quali comprende alcuni momenti numerati – quattro per la Part I e tre per la Part II; a chiudere l’unica composizione “scritta” dallo stesso Andersen, “Short Story”. A questo punto avrete già capito che l’album si basa su una lunga improvvisazione di gruppo che, però, nulla ha a che vedere con le infocate sedute del free storico. Qui l’atmosfera è completamente diversa, intimista, meditativa con i quattro musicisti che dimostrano di conoscersi assai bene, districandosi come meglio non potrebbero nelle pieghe di una tessitura tanto lieve quanto complessa, in cui le pause, il silenzio hanno un loro perché. L’ultimo brano, “Short Story”, si basa su una melodia splendidamente scritta dal leader e altrettanto splendidamente eseguita dai quattro, con sassofonista e pianista in primissimo piano.
 Onur Aymergen Quintet – “Lunar” – Losen
Onur Aymergen Quintet – “Lunar” – Losen
E’ con vero piacere che vi presentiamo questo gruppo proveniente dalla Turchia e composto da Onur Aymergen leader alla chitarra, Can Çankaya piano, Tolga Bilgin tromba, Apostolos Sideris contrabbasso, Turgut Alp Bekoğlu batteria. Anche se ancora poco noto nel nostro Paese, Onur Aymergen può già vantare una solida preparazione: ha cominciato a studiare chitarra classica con Özhan Gölebatmaz approfondendo anche il flamenco classico con Suat Demirkıran, fino a quando ha deciso di convogliare i suoi interessi verso il rock, il funk e il jazz. In questo suo album d’esordio, Onur dimostra di avere le carte in regola per un futuro luminoso: intendiamoci, nulla di trascendentale, ma un musicista che conosce assai bene lo strumento, il linguaggio che adopera, il patrimonio musicale del suo Paese che ogni tanto fa capolino dalle linee esposte dal gruppo. E non a caso si è citato il gruppo in quanto, nei suoi sapidi arrangiamenti, il leader ha lasciato ad ogni compagno d’avventura lo spazio per porsi in evidenza. E quanto sin qui detto appare evidente sin dal primo brano in programma, “Yeditepe”, scritto, così come gli altri sette pezzi in repertorio, dal leader che evidenzia, in tal modo, una notevolissima capacità di scrittura.
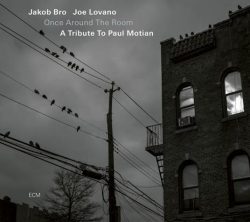 Jakob Bro, Joe Lovano –“Once Around The Room” – A Tribute to Paul Motian” – ECM
Jakob Bro, Joe Lovano –“Once Around The Room” – A Tribute to Paul Motian” – ECM
Il chitarrista Jakob Bro e il tenorsassofonista Joe Lovano sono i cofirmatari di questo album esplicitamente dedicato a Paul Motian, già loro compagno in tante avventure. Ad assecondare i due, i contrabbassisti Larry Grenadier e Thomas Morgan, Anders Christensen al basso elettrico e i due batteristi Joey Baron e Jorge Rossi. Un organico anomalo, quindi, per una musica che di anomalo nulla propone data la maestria dei singoli e quindi dell’intera formazione. Lovano e Motian hanno collaborato per una decina d’anni e personalmente ricordiamo di averli ascoltati, tra l’altro, a Stavanger in Norvegia nei primissimi anni ’80. E ciò potrebbe spiegare assai bene il perché di questo album. Quanto poi all’immediata ricerca del drumming di Motian nella musica dell’album, si tratta di operazione, come al solito, assai difficile anche perché soprattutto Lovano non ha alcuna intenzione di scrivere una pagina calligrafica. Anzi! Ed è lo stesso sassofonista a spiegare cosa per lui significhi questo album: “Con Motian suonavamo degli standard ma cercavamo in ogni modo di farli nostri. Ecco noi suonavamo con fiducia con attitudine, con un approccio che potesse rendere al massimo le nostre intenzioni. Ecco è proprio questo stesso feeling che ho tenuto durante la registrazione dell’album”. Diverso l’atteggiamento di Jakob Bro che ha scritto due brani di sapore quasi opposto in cui si avverte chiaramente una profonda malinconia, una tristezza di fondo per la scomparsa di Motian. Qui il gruppo abbandona lo spirito improvvisativo che ha caratterizzato i primi tre pezzi, per immergersi nella scrittura di Bro che trova sia in “Song To An Old Friend” sia in “Pause” una dolce melodia. Chitarra e sassofono dialogano soavemente ben sostenuti da bassi e batterie. Nel brano conclusivo particolarmente apprezzabile il lavoro del chitarrista che disegna con delicatezza una splendida e toccante linea melodica. Ad intervallare i due brani, l’unica composizione di Paul Motian, “Drum Music”, caratterizzata da una lunga intro disegnata dai due batteristi che lasciano il posto a sax e chitarra, quest’ultima con una sonorità assi vicina a quella del sax per effetto dell’elettronica.
 Eik Trio – “Eik Trio” – Losen
Eik Trio – “Eik Trio” – Losen
Sempre prodotto dalla norvegese “Losen” ecco questo nuovo trio composto dal pianista Ole Fredrik Norbye, dalla vocalist Elisabeth Karsten e dal contrabbassista John Børge Askeland, cui si aggiungono alcuni dei migliori jazzisti norvegesi ed europei quali il sassofonista Bendik Hofseth al sax tenore in tre brani, il trombettista Nils Petter Molvaer nel celeberrimo “I Love Paris” e il fisarmonicista Heine Bugge in “For Once in My Life”, mentre quasi tutti gli arrangiamenti sono curati da Fredrik Norbye. Dai titoli citati avrete forse già capito che tutto l’album è incentrato sulla riproposizione di standard, dieci pezzi che davvero hanno fatto la storia della musica che ci piace, interpretati senza alcuna voglia di sperimentalismo ma con il massimo del rispetto che meritano. Ferma restando la capacità della cantante di rendere al massimo ogni linea melodica, ogni più piccolo risvolto di queste immortali melodie, tra i brani siamo rimasti particolarmente colpito dal già citato “I Love Paris” per il fraseggio del pianista Ole Fredrik Norbye e il maiuscolo apporto di Nils Petter Molvaer
 Mette Henriette – “Drifting” – ECM
Mette Henriette – “Drifting” – ECM
Trio di grande spessore quello che si ascolta in “Drifting”: a guidarlo è la sassofonista Mette Henriette coadiuvata da Johan Lindvall al pianoforte e Judith Hamann al violoncello. In repertorio quindici brani tutti scritti dalla sassofonista (l’ultimo in collaborazione con Lindvall). Dopo l’album d’esordio, registrato sempre per ECM nel 2013 ma pubblicato due anni dopo, la sassofonista norvegese torna sempre in compagnia del pianista ma con l’aggiunta della validissima violoncellista Judith Hamman. L’atmosfera è quanto mai rarefatta con i tre che letteralmente distillano ogni singola nota che acquista così un peso specifico. I brani si susseguono legati da un filo ben preciso che si snoda attraverso le sapienti mani dei tre musicisti. Così se l’impianto melodico è spesso affidato alla leader, il pianoforte si incarica di sottolinearne le parti salienti con il violoncello impegnato in una non facile operazione di ricucitura. Il tutto a disegnare un quadro difficilmente classificabile: certo non si tratta di jazz nell’accezione più usata del termine, né di musica classica tout court…piuttosto di una sorta di esplorazione sonora che induce anche l’ascoltare a guardarsi dentro, a lasciarsi andare alle sensazioni che la musica gli propone. Senza preoccuparsi di capire dove la pagina scritta lascia il posto all’improvvisazione. E se anche chi ci legge seguirà questa metodologia, siamo sicuri che l’album risulterà di notevole interesse.
 Anders Jormin, Lena Willemark – “Pasado en claro” – ECM
Anders Jormin, Lena Willemark – “Pasado en claro” – ECM
Album molto impegnativo questo “Pasado en claro” in cui il contrabbassista svedese Anders Jormin, in collaborazione con la vocalist, violinista e violista Lena Willemark guida un quartetto completato da Karin Nakagawa al koto e Jon Fält alla batteria, già con il leader nel trio di Bobo Stenson. La complessità di cui in apertura è determinata dal fatto che il leader ha voluto trarre ispirazione da una serie di poeti tra i più diversi della letteratura mondiale: ecco quindi testi da antiche fonti cinesi e giapponesi, accanto a poeti scandinavi contemporanei, senza per questo trascurare lo scrittore messicano Octavio Paz (dalla cui opera è tratto il titolo dell’album) e il “nostro” Francesco Petrarca. Insomma un panorama di riferimento da far apparire impossibile una qualsivoglia unità dell’album E invece il quartetto ci riesce grazie soprattutto all’interpretazione della vocalist. Su un tappeto costituito da una valida struttura sonora ben scritta e altrettanto ben arrangiata, ricca di nuances, Lena Willemark si produce in una prova di grande maturità alternando l’uso della voce all’altro strumento a sua disposizione (il violino); esemplare al riguardo “Tho Woman of the Long Ice” musica e testo della stessa Willemark . Insomma è come se nella voce di Lena si ritrovasse allo stesso tempo, il passato, il presente e il futuro di una musica il cui flusso mai si interrompe.
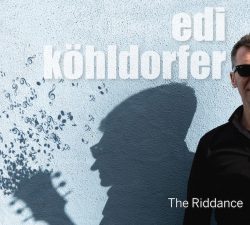 Edi Köhldorfer – “The Riddance” – Ats Records
Edi Köhldorfer – “The Riddance” – Ats Records
Personaggio sicuramente interessante questo chitarrista austriaco Edi Köhldorfer il quale, dopo aver studiato chitarra classica, ha intrapreso la strada del musicista professionista suonando nei contesti più vari, dalle orchestre classiche al folk, dal funk al pop…fino al jazz collaborando con alcuni artisti di fama mondiale come Biréli Lagrène, Dee Dee Bridgewater, Stephane Grappelli. Di qui una personalità compiuta non solo a livello musicale, esplicitata appieno in questo album che risponde ad una grande esigenza di fondo: evidenziare quanto può accadere quando musicisti di provenienza diversa si riuniscono per un comune progetto, e soprattutto liberarsi dalla schiavitù di una pandemia che ha costretto all’immobilismo moltissimi artisti. Per raggiungere questo obbiettivo, Edi ha contattato 26 musicisti di 4 continenti e nessuno si è tirato indietro dando vita ad una produzione assai particolare. Ascoltando l’album, in effetti, non si può non rilevare la gioia, la forza, l’entusiasmo il dinamismo che promana da questi brani cosicché è davvero arduo sceglierne qualcuno in particolare. Tuttavia dobbiamo ammettere che ci hanno particolarmente colpiio “Goodbye Armando” un sentito omaggio a Chick Corea con un fantastico assolo del pianista Ui Datler richiamante “La Fiesta” e “Midwest” impreziosito da un lungo e centrato assolo del bassista colombiano Juan Garcia-Herreros meglio noto come “The Snow Owl”, che suona un basso elettrico personalizzato a sei corde; all’età di 37 anni, Juan ha ottenuto una nomination, per il Latin Grammy Award nella categoria Best Latin Jazz Album, per il suo terzo CD intitolato “Normas”.
 Benjamin Lackner – “Last decade” – ECM
Benjamin Lackner – “Last decade” – ECM
Probabilmente il pianista tedesco Benjamin Lackner non è molto noto al pubblico italiano anche se può già vantare un’invidiabile carriera che lo porta ad esordire oggi in casa ECM. Lackner è tornato da poco a Berlino, dopo un lungo periodo trascorso negli Stati Uniti dove ha avuto modo di studiare con “maestri” quali Charlie Haden e Brad Mehldau. Per questo album il pianista è affiancato da tre grandi artisti: il trombettista Mathias Eick, il batterista Manu Katché e il contrabbassista Jérôme Regard, già con Lackner dal 2006. Il risultato c’è ed è a tutto tondo. In effetti appare chiaro sin dalla primissime note come l’intendimento principale del trio sia quello di proporre una musica caratterizzata dalla ricerca della linea melodica. Una linea che risulti dolce, fors’anche accattivante, ma non per questo banale o scontata. Di qui un repertorio di nove brani (tutti composti dal leader ad eccezione di “Emile” scritta da Jérôme Regard) in cui la musica scorre in perenne equilibrio fra i quattro, con nessuna voglia particolare del leader di mettersi in luce ché anzi molto spesso ascoltiamo in primo piano la bella voce della tromba di Eick sempre sorretta da una sezione ritmica assolutamente funzionale all’intento del leader. Tra i brani particolarmente suggestivo e sofisticato è “Hang Up on That Ghost” tutto giocato su un fitto dialogo tra pianoforte, batteria e contrabbasso mentre Mathias alterna la sua voce a quella della tromba con effetti di estrema delicatezza.
 Ieremy Lirola – “Mock the Borders” –
Ieremy Lirola – “Mock the Borders” –
Dopo “Uptown Desire” il contrabbassista francese si ripresenta al pubblico con questo “Mock the Borders” in cui è possibile ascoltare anche il piano di Maxime Sanchez, il sax di Denis Guivarc’h e la batteria di Nicolas Larmignat, questi ultimi due già presenti nel citato lavoro “Uptown Desire”.
Il titolo è quanto mai esplicativo: “Ridicolizza il confine” appare come una sorta di manifesto programmatico che dovrebbe informare il senso dell’album. Ma è davvero così? Francamente non ci sembra che l’artista abbia voluto andare oltre la lezione di Coleman; piuttosto la sua idea, conclamata in musica, è quella di una libertà che prescinda dalle etichette, dalle mode, per dare pieno diritto di cittadinanza ad ogni forma espressiva. Insomma per Lirola la musica tonale può coesistere con escursioni nel mondo del free. Di qui un album dai colori cangianti, dalle atmosfere variegate in cui si avverte l’urgenza di nulla trascurare delle passate esperienze: guadare avanti non significa necessariamente trascurare ciò che c’è stato e che continua ad esserci. Insomma una visione oserei dire filosofica e non solo musicale che informa questo interessante lavoro. Tra i vari brani eccellente l’apertura con “Mock the lines” impreziosito dal lavoro del sassofonista. Ma nello svolgimento dell’album il leader lascia ampio spazio ai compagni d’avventura che hanno così modo di esprimere appieno le proprie potenzialità.
 Stephan Micus – “Thunder” – ECM
Stephan Micus – “Thunder” – ECM
Nessuna sorpresa per questo ennesimo ottimo album di Stephan Micus, un vero ricercatore di note che abbiamo imparato ad ammirare oramai nel corso di lunghi anni. Questa volta il suo interesse si focalizza, come da lui stesso sottolineato, sulla musica dei monasteri tibetani, meta di molte visite da parte del musicista. Stephan rimane particolarmente colpito dal particolare strumento che si usa in queste cerimonie, il dung-chen, una sorta di tromba lunga circa quattro metri, cui affianca il ki kun ki, uno strumento a fiato – ci spiega lo stesso Micus – molto semplice, costruito con un unico stelo ligneo che cresce in alcune foreste siberiane del lontano Oriente e il nahkan, una specie di flauto di provenienza giapponese. Mescolate questi straordinari elementi e la ricetta è pronta: una musica ancora una volta affascinante, dai suoni allo stesso tempo primordiali e di attualità che ci trasportano in un mondo virtuale apparentemente alla nostra portata ma che mai riusciamo ad abbracciare davvero. E credo sia questo il segreto di Micus: sintetizzare gli universi musicali più disparati per ricondurli ad una unità senza spazio, senza tempo ove solo il suo credo ha diritto di cittadinanza. Per tornare al contenuto dell’album è comunque lo stesso Micus a fornirci una chiave di lettura ove afferma che l’album è dedicato alla grande famiglia delle divinità dei tuoni cui hanno creduto intere popolazioni con la speranza che il loro distruttivo potere possa in qualche modo essere placato dalla musica.
 Arvo Pärt – “Tintinnabuli” – Billant Corners
Arvo Pärt – “Tintinnabuli” – Billant Corners
Con il termine “Tintinnabuli” ci si intende riferire allo stile compositivo creato dal compositore estone Arvo Pärt, introdotto nella sua “Für Alina” (1976) e riutilizzato in “Spiegel im Spiegel” (1978). Caratteristiche che ritroviamo appieno in questo splendido album che vede come protagonisti Jeroen van Veen al piano, Joachim Eijlander al violoncello e in un brano la moglie di Jeroen, Sandra van Veen, anch’essa pianista. L’album è una sorta di summa delle caratteristiche che hanno sempre connotato la musica di Arvo Pärt, vale a dire la quiete estatica e il saper racchiudere lo spirito dei tempi grazie anche alle esperienze mistiche con la musica dei canti religiosi. Risultato: composizioni senza tempo che appaiono in egual misura antiche e contemporanee, religiose e profane, non immuni da una marcata influenza da parte del movimento minimalista. L’album si apre con “Fratres” cui fa immediatamente seguito uno dei brani più importanti di Arvo, quel “Für Alina” cui si è già fatto cenno. “Ukuaru Valss” ci fa conoscere un lato più “leggero” della personalità di Pärt mentre il conclusivo lungo “Partomania” è preceduto da “Spiegel im Spiegel” anch’esso citato in precedenza quale pietra miliare nel percorso compositivo dell’artista estone: ascoltandolo ancora oggi, dopo tanto tempo, impressiona il modo in cui le note sono letteralmente distillate una dopo l’altra a conferma di una maestria compositiva difficilmente eguagliabile.
 Sebastian Rochford, Kit Downes – “A Short Diary” – ECM
Sebastian Rochford, Kit Downes – “A Short Diary” – ECM
Ecco un album non facile da recensire in quanto gli usuali strumenti che si adoperano per illustrare una produzione discografica, in questo caso non sono sufficienti. In ballo ci sono, infatti, motivazioni che vanno ben al di là del fatto musicale e che coinvolgono direttamente i sentimenti più profondi di Rochford, non a caso compositore di tutti i brani in programma. In effetti l’album è una appassionata e sentita dedica che il cinquantenne batterista scozzese rivolge al padre, Gerard Rochford, grande poeta morto nel 2019. Alla luce di questa realtà, la musica assume una valenza tutta particolare. E’ facile immaginare come l’autore, nello scrivere, si sia lasciato andare ai ricordi della sua infanzia, degli anni trascorsi con il padre e di ciò che questo ha voluto dire per la sua crescita. Di qui l’originalità di un discorso che ha una sua compiutezza dall’inizio alla fine, ben sorretto dal partner di Rochford, ovvero Kit Downes che in precedenti occasioni aveva evidenziato tutto il suo talento. Talento che qui si manifesta nell’aver saputo mirabilmente arrangiare il tutto costruendo un coinvolgente percorso melodico-armonico in cui non esageriamo affermando che sotto alcuni aspetti ascoltare questo album è come sfogliare un album le cui pagine sono costituite dai ricordi dolcemente custodite da Sebastian. Quanto ai brani particolarmente significativo “Our Time Is Still”: un pezzo essenziale, scarnificato fino al limite massimo, tutto giocato sulla sottrazione ma con una carica di tristezza, di emozionalità, di sentimento davvero toccante.
 Rubber Soul Quartet – “Something” – Losen
Rubber Soul Quartet – “Something” – Losen
E’ ancora possibile eseguire in chiave jazzistica un repertorio ‘beatlesiano’ senza scadere nel già sentito, nello scontato? Certo che sì, ma si tratta sicuramente di un’impresa estremamente complessa dato che i brani dei Beatles oramai da molti anni sono entrati nel repertorio di grandi jazzisti. A provarci, adesso, sono quattro musicisti norvegesi, Bård Helgerud chitarra e vocale, Håvard Fossum sax, flauto, clarinetto, Andreas Dreier contrabbasso e e vocale, Torstein Ellingsen batteria e percussioni. In cartellone, come già accenato, undici composizioni dei Beatles per un viaggio all’indietro che si preannuncia tanto entusiasmante quanto colmo di insidie. Il quartetto cerca di evitare gli scogli proponendo una chiave di lettura originale: combinare le melodie ben note con arrangiamenti che si rifanno espressamente alla lezione dei grandi jazzisti made in USA, il tutto condito da una forte carica di swing e una buona dose di improvvisazione. Obiettivo raggiunto? Francamente non del tutto in quanto, indipendentemente dall’arrangiamento, la carica melodica dei brani è troppo forte cosicché resta lì, a farla da padrona e quindi a spedire in secondo piano esecuzione e arrangiamento, a meno che non si tratti davvero di grandi musicisti quali, tanto per fare due soli nomi, Brad Mehldau e Sarah Vaughan
 Salon Odjilà – “TangoRomaBalkanJazz” – ATS Records
Salon Odjilà – “TangoRomaBalkanJazz” – ATS Records
Un’elegante mistura di oriente e occidente, di jazz e folk, di euforia e malinconia definisce il clima di questo album interpretato da un quartetto di assoluto livello: Wolfgang e Werner Weissengruber sono multistrumentisti che oramai da anni si dedicano con passione al jazz, Manuela Kloibmüller è fisarmonicista che frequenta con assiduità sia i terreni classici sia quelli jazz nonché vocalist di riconosciuto spessore, Matthias Eglseer è batterista fantasioso e preciso (lo si ascolti, ad esempio, in “Cetvorno Sopsko Horo”). In repertorio tre classici di Piazzolla, un originale di Wolfgang Weissengruber e sei ‘traditional’. Ciò premesso la musica rispetta perfettamente le premesse contenute nel titolo vale a dire un tango ma con quel forte imprinting che caratterizza la musica balcanica. Ciò grazie ad arrangiamenti particolarmente indovinati che riescono a valorizzare appieno l’originalità del gruppo anche quando si avventura su pezzi non sempre consigliabili. E’ il caso dei tre brani di Piazzolla e in particolare di “Libertango” il brano forse più celebre del compositore argentino: introdotto dal contrabbasso, il brano prende man mano spessore con la Kloibmüller che si produce in un vibrante assolo ben sostenuta da tutto il gruppo per una interpretazione convincente.
 Solis String Quartet & Sarah Jane Morris – “All You Need Is Love” – Irma
Solis String Quartet & Sarah Jane Morris – “All You Need Is Love” – Irma
E dopo il cd del Rubber Soul Quartet ecco un altro album interamente dedicato ai Beatles. Ad interpretare le melodie di John Lennon e Paul McCartney è però questa volta una delle voci, a nostro avviso, più belle e convincenti dell’intero panorama vocale internazionale. Oramai sulla cresta dell’onda da molti anni, la Morris mai delude; chi scrive l’ha sentita in concerto svariate volte e ha sempre trovato un’artista straordinariamente generosa, capace di interpretare ogni brano alla sua maniera andando a visitare anche le più intime pieghe delle melodie senza trascurarne la valenza ritmica. E la stessa cosa accade anche questa volta: la vocalist affronta ogni tema con gande rispetto ma allo stesso tempo con la sicurezza che le deriva da tanti anni di carriera. Di qui interpretazioni che senza alcunché togliere all’originale fascino, rivestono i brani di una veste originale. Il che, non sarebbe stato possibile, se la vocalist non fosse stata adeguatamente supportata da uno straordinario Solis String Quartet, al secolo Vincenzo Di Donna e Luigi De Maio, violini, Gerardo Morrone viola e Antonio Di Francia cello e chitarra, con quest’ultimo impegnato in una preziosa opera di ri-arrangiamento che non ha fatto sentire la mancanza di quella sezione ritmica, viceversa tanto importante nella produzione originale. Tra i brani particolarmente riuscita la versione di “The Fool on The Hill” che resta una delle più belle composizioni dei Beatles.
Gerlando Gatto
da Amedeo Furfaro | 13/Set/2022 | I nostri CD, Primo piano, Recensioni
Si viaggiare. Con i dischi lo si può fare low cost, a rischio zero quanto a code, disdette, scioperi, ritardi, scali, turbolenze e chi ne ha più ne metta. Basta avere gli album giusti dove ci si trova ed un po’ di fantasia da stimolare attraverso l’ascolto. Eccone alcuni di quelli utili a immaginare viaggi virtuali verso mete vicine o lontane.
Parlando di Jazz di Viaggio, non potevamo non iniziare con la recensione di un cd inviataci da un critico musicale italiano che vive da tempo a Hong Kong. Il suo nome è Franco Savadori, esperto di jazz, diplomato al Conservatorio G. Tartini di Trieste in timpani e strumenti a percussione e da oltre 25 anni qualificato mercante d’arte e manager di importanti gallerie. Savadori recensisce il cd dei Green Tea inFusion, gruppo del Nord-Est formatosi di recente che annovera tra i suoi componenti tre veterani della fusion e un giovanissimo talento. (Redazione)
GreenTea inFusion, “GreenTea inFusion” (Autop.)
 È proprio vero: le vecchie abitudini sono dure a morire… E così, in maniera a dir vero inaspettata, spunta questa nuovissima raccolta di tracce sonore svolte ed elaborate dagli immaginifici fratelli Fabris, Franco alle tastiere e Maurizio alle percussioni, integrati, per volere di sincronico destino, dal polistrumentista Gianni Iardino, nonché dal tornito e solido basso del giovanissimo Pietro Liut. Come d’abitudine propria al navigato Franco, non a caso forgiatosi anche sui campi di calcio, anche in questa circostanza è stata data piena preminenza al gioco di squadra collettivo, in un contesto di perfetta parità all’interno dei singoli ruoli esecutivi, per quanto sei degli otto brani incisi siano nati dalla felice vena compositiva di Gianni Iardino, pianista d’estrazione accademica, ma saxofonista per immagamento timbrico, come ben si può cogliere dall’ascolto di questa manciata di acquarelli timbrico-armonici. Una musica, questa, veramente posta in (in)fusione), ove le sensazioni speziate delle sonorità riportano ad un mélange ricco di rimandi, ispirazioni, citazioni appena accennate, fondali sonori che in parte inducono alla nostalgia per gusti antichi, all’improvviso riaffiorati per via retronasale, di quelli celati negli anfratti più reconditi di memorie archiviate, ma mai del tutto sopite. Tutto può accadere, e tutto accade, entro le mura all’apparenza ordinate di questi brani. La celebrazione della post-post-modernità in musica? L’amore per il bricolage di generi, stili e prassi organizzative? Forse, può darsi: ma lungi dall’essere una musica preparata “a tavolino”, questi brani procedono lisci e senza alcuna forzatura proprio al pari d’una suadente e profumata tisana dai risvolti concilianti e dagli intenti lenitivi.
È proprio vero: le vecchie abitudini sono dure a morire… E così, in maniera a dir vero inaspettata, spunta questa nuovissima raccolta di tracce sonore svolte ed elaborate dagli immaginifici fratelli Fabris, Franco alle tastiere e Maurizio alle percussioni, integrati, per volere di sincronico destino, dal polistrumentista Gianni Iardino, nonché dal tornito e solido basso del giovanissimo Pietro Liut. Come d’abitudine propria al navigato Franco, non a caso forgiatosi anche sui campi di calcio, anche in questa circostanza è stata data piena preminenza al gioco di squadra collettivo, in un contesto di perfetta parità all’interno dei singoli ruoli esecutivi, per quanto sei degli otto brani incisi siano nati dalla felice vena compositiva di Gianni Iardino, pianista d’estrazione accademica, ma saxofonista per immagamento timbrico, come ben si può cogliere dall’ascolto di questa manciata di acquarelli timbrico-armonici. Una musica, questa, veramente posta in (in)fusione), ove le sensazioni speziate delle sonorità riportano ad un mélange ricco di rimandi, ispirazioni, citazioni appena accennate, fondali sonori che in parte inducono alla nostalgia per gusti antichi, all’improvviso riaffiorati per via retronasale, di quelli celati negli anfratti più reconditi di memorie archiviate, ma mai del tutto sopite. Tutto può accadere, e tutto accade, entro le mura all’apparenza ordinate di questi brani. La celebrazione della post-post-modernità in musica? L’amore per il bricolage di generi, stili e prassi organizzative? Forse, può darsi: ma lungi dall’essere una musica preparata “a tavolino”, questi brani procedono lisci e senza alcuna forzatura proprio al pari d’una suadente e profumata tisana dai risvolti concilianti e dagli intenti lenitivi.
Queste composizioni sono toccate e benedette dalla capacità comune all’intero gruppo di tendere ad una sorta di laconicità opulenta, tra cetre russe, kalimbe equatoriali, koti estremo orientali e tanto altro ancora, che, ben si noti, trova la propria base nel mozartiano lavoro compiuto da Maurizio Fabris alle percussioni, dove la pesantezza batteristica viene sostituita da una elegantissima levità percussiva, tanto timbricamente varia quanto dinamicamente contenuta nell’alveo della sonorità generale. Bello pure l’intreccio dei fondali, distribuiti tra le tastiere di Franco e Gianni, a supporto del traboccante itinerare del contralto dello stesso Iardino, mai dimentico della passionalità melodica, con probabilità la vera carta vincente della godibilità totale di questo fresco e delicato lavoro. Un’operazione portata a termine da quattro anime empaticamente musicali, il cui scopo primario era quello di riuscire a replicare su CD una musica scaturita per il puro gusto di creare assieme la giusta miscela timbrica per le vostre assetate orecchie. Quindi: buon ascolto e buona bevuta. (Franco Savadori)
*** ed ora, spazio alle recensioni di Amedeo Furfaro
Tatiana Valle & Giovanni Guaccero – “Canto Estrangeiro” – Encore Music
 E’ come se alla storia piacesse … shakerare e sperimentare, nel proprio scorrere, nuovi cocktail. L’alchimia è avvenuta con la musica del Brasile dove la cultura dei conquistadores portoghesi, mixata con “spezie” locali, ha plasmato uno specifico heritage generando forme come choro, maxixe e samba, così “distanti” da fado e fandango, a volerne sottolineare la distanza dall’eredità culturale della madrepatria. Con la quale peraltro il rapporto è continuato ad esistere e vive tuttora in Europa, Italia compresa, a causa dell’approdarvi di artisti brasiliani in analogia ad altri colleghi ispanoamericani. Canto Estrangeiro, album della Encore Music a firma della vocalist Tatiana Valle e del pianista Giovanni Guaccero, è una tela sonora e canora del Brasile fuori dal Brasile, un paese-doppio, un’immagine riflessa richiamata e ricamata da Guaccero sui versi di Luis Elòi Stein a partire da Lingua Minha che precede una dozzina di splendide composizioni. Ne ha scritto la musica da “straniero” che ha assimilato Jobim, de Hollanda, Nascimento, il poeta de Moraes….per un viaggio “di ritorno” verso il Rio Grande do Sul, dal Tevere, il cui “voucher” è un compact carioca curato in ogni particolare. Vi hanno partecipato il batterista Bruno Marcozzi, la flautista Barbara Piperno, il chitarrista-mandolinista Marco Ruviaro, con ospiti Giancarlo Bianchetti alla chitarra elettrica, Henrique Cazes al cavaquinho, Fred Martins al canto, Carlos Cèsar Motta alle percussioni e Francesco Maria Parazzoli al cello. Nell’insieme il Brasile di Guaccero-Stein e della Valle non risulta oleografico né saporifero di vintage bensì è partecipe dell’oggi in ruoli di protagonista fra le nuove correnti della musica tropicale ad influsso jazz che spirano forti oltre l’Atlantico.
E’ come se alla storia piacesse … shakerare e sperimentare, nel proprio scorrere, nuovi cocktail. L’alchimia è avvenuta con la musica del Brasile dove la cultura dei conquistadores portoghesi, mixata con “spezie” locali, ha plasmato uno specifico heritage generando forme come choro, maxixe e samba, così “distanti” da fado e fandango, a volerne sottolineare la distanza dall’eredità culturale della madrepatria. Con la quale peraltro il rapporto è continuato ad esistere e vive tuttora in Europa, Italia compresa, a causa dell’approdarvi di artisti brasiliani in analogia ad altri colleghi ispanoamericani. Canto Estrangeiro, album della Encore Music a firma della vocalist Tatiana Valle e del pianista Giovanni Guaccero, è una tela sonora e canora del Brasile fuori dal Brasile, un paese-doppio, un’immagine riflessa richiamata e ricamata da Guaccero sui versi di Luis Elòi Stein a partire da Lingua Minha che precede una dozzina di splendide composizioni. Ne ha scritto la musica da “straniero” che ha assimilato Jobim, de Hollanda, Nascimento, il poeta de Moraes….per un viaggio “di ritorno” verso il Rio Grande do Sul, dal Tevere, il cui “voucher” è un compact carioca curato in ogni particolare. Vi hanno partecipato il batterista Bruno Marcozzi, la flautista Barbara Piperno, il chitarrista-mandolinista Marco Ruviaro, con ospiti Giancarlo Bianchetti alla chitarra elettrica, Henrique Cazes al cavaquinho, Fred Martins al canto, Carlos Cèsar Motta alle percussioni e Francesco Maria Parazzoli al cello. Nell’insieme il Brasile di Guaccero-Stein e della Valle non risulta oleografico né saporifero di vintage bensì è partecipe dell’oggi in ruoli di protagonista fra le nuove correnti della musica tropicale ad influsso jazz che spirano forti oltre l’Atlantico.
Aiòn – “Me vs Myself” – Alterjinga
 Ricorda a momenti le elucubrazioni fonetiche di Bobby McFerrin l’album di Aiòn Me Vs Myself (Giorgio Pinardi) edito da Alterjinga, per lo scavo, a livello di vocalizzazione, effettuato su realtà musicali remote. Non cambia l’approccio sia che provengano dall’Africa della tribù Dagara in “Yelbongura” o dal gaelico in “Scriob” o dal danese arcaico di “Hyggelig”. C’è, in genere, una “manipolazione” dei materiali musicali trattati – e questo accade ancora in “Leys” – che forse lo stesso Demetrio Stratos oggi non avrebbe disdegnato nelle proprie “investigazioni” tendenti a far “cantare la voce”. Il lavoro continua con “Waldeinsamkeit”, impronunciabile termine tedesco che non ha una diretta traduzione in inglese e che vuol dire essere in connessione con la natura (e con la musica) e con “Rwty” (Sfinge in antico egiziano) a riprova di come, in musica, la ricerca etimologica si possa coniugare con quella etnologica. Chiudono l’album il desertico “Kamtar” quindi “aPHaSIa” (stesso significato in italiano) e “Nèkya” ovverossia la discesa agli inferi dei greci, detta in termini psicanalitici il processo younghiano di scoperta dell’inconscio.
Ricorda a momenti le elucubrazioni fonetiche di Bobby McFerrin l’album di Aiòn Me Vs Myself (Giorgio Pinardi) edito da Alterjinga, per lo scavo, a livello di vocalizzazione, effettuato su realtà musicali remote. Non cambia l’approccio sia che provengano dall’Africa della tribù Dagara in “Yelbongura” o dal gaelico in “Scriob” o dal danese arcaico di “Hyggelig”. C’è, in genere, una “manipolazione” dei materiali musicali trattati – e questo accade ancora in “Leys” – che forse lo stesso Demetrio Stratos oggi non avrebbe disdegnato nelle proprie “investigazioni” tendenti a far “cantare la voce”. Il lavoro continua con “Waldeinsamkeit”, impronunciabile termine tedesco che non ha una diretta traduzione in inglese e che vuol dire essere in connessione con la natura (e con la musica) e con “Rwty” (Sfinge in antico egiziano) a riprova di come, in musica, la ricerca etimologica si possa coniugare con quella etnologica. Chiudono l’album il desertico “Kamtar” quindi “aPHaSIa” (stesso significato in italiano) e “Nèkya” ovverossia la discesa agli inferi dei greci, detta in termini psicanalitici il processo younghiano di scoperta dell’inconscio.
Bincoletto-Vio-Trabucco-Drago – “Duende” – Abeat Records
 Il Duende, per Garcia Lorca, è un imprecisato non so che proprio di alcuni toreri, pittori, poeti, musicisti, uno “stile vivo”, “creaciòn en acto”, fluido irresistibile che arriva al pubblico e che, nei “suoni neri” del jazz, è stato da alcuni associato alla Holiday ed a Miles Davis. Il ribattezzare Duende un progetto discografico, come hanno fatto la vocalist Rita Bincoletto, il chitarrista Diego Vio, il percussionista Max Trabucco e l’ospite Anais Drago, violinista, assume l’intento di traslare la cultura flamenca del poeta spagnolo ricercando le relazioni di quel “potere” nel pianeta liquido del Mediterraneo. La loro traversata geOnirica in un ondoso campo largo li porta fino alla Grecia del traditional “Amygdalaki Tsakisa” ed al Medio Oriente di “Isfahan Trip”; quindi, tramite “Desert Way”, eccoli incrociare figure reali (“Isola”) e mitologiche (“Tres Sirenas”). Un lavoro “waterworld” pubblicato da Abeat Records che consta di nove brani in tutto per la maggior parte scritti e/o arrangiati da Bincoletto, Vio e Trabucco, navigatori fra i suoni marini.
Il Duende, per Garcia Lorca, è un imprecisato non so che proprio di alcuni toreri, pittori, poeti, musicisti, uno “stile vivo”, “creaciòn en acto”, fluido irresistibile che arriva al pubblico e che, nei “suoni neri” del jazz, è stato da alcuni associato alla Holiday ed a Miles Davis. Il ribattezzare Duende un progetto discografico, come hanno fatto la vocalist Rita Bincoletto, il chitarrista Diego Vio, il percussionista Max Trabucco e l’ospite Anais Drago, violinista, assume l’intento di traslare la cultura flamenca del poeta spagnolo ricercando le relazioni di quel “potere” nel pianeta liquido del Mediterraneo. La loro traversata geOnirica in un ondoso campo largo li porta fino alla Grecia del traditional “Amygdalaki Tsakisa” ed al Medio Oriente di “Isfahan Trip”; quindi, tramite “Desert Way”, eccoli incrociare figure reali (“Isola”) e mitologiche (“Tres Sirenas”). Un lavoro “waterworld” pubblicato da Abeat Records che consta di nove brani in tutto per la maggior parte scritti e/o arrangiati da Bincoletto, Vio e Trabucco, navigatori fra i suoni marini.
Vincenzo Caruso – “Chansons sous les Doigts” – Dodicilune
 Chansons sous les doigts è una selezione di 19 canzoni francesi arrangiate per piano da Vincenzo Caruso che ci ricorda quanto ci siano vicini, in musica, i cugini transalpini. Sono tratteggiate, nell’album Dodicilune, in modo essenziale, scarnificate del testo con focus sulla melodia e l’armonizzazione con sensibilità moderna. Caruso se ne innamorò giovanissimo tramite gli spartiti inviatigli dallo zio Antonio Di Domenico, chansonnier ed editore a Parigi, coltivando nel tempo una passione pianistica che lo avrebbe portato a collaborare a Irma la Douce, la famosa commedia musicata da Marguerite Monnot, di cui ripropone nel disco la “Piccola Suite per Piano”. I temi proposti sono di nomi altisonanti come Henry Salvador (“Syracuse”), Gilbert Becaud (“Quand il est mort le poète”), Georges Brassens (“J’ai rendez vous avec vous”) … L’antologia rappresenta un omaggio alla chanson in cui il pianoforte contende lo scettro di strumento principe alla fisarmonica e, nel contempo, ne offre un’ampia gamma – “Le tango corse”, lo swing di “On est pas là pour se faire engueler”, l’incipit musorgskiano di “Comèdie”, il walzer di “Domani”, il distillar note alla Satie di “Le deserteur” – che ne saggia la tavolozza espressiva e coloristica. Il disco è chiuso da “Après l’ourage” che potrebbe, perche no, commentare un film di Méliès, muto, tanto la narrazione è affidata alle dieci dita, les doigts, sulla tastiera.
Chansons sous les doigts è una selezione di 19 canzoni francesi arrangiate per piano da Vincenzo Caruso che ci ricorda quanto ci siano vicini, in musica, i cugini transalpini. Sono tratteggiate, nell’album Dodicilune, in modo essenziale, scarnificate del testo con focus sulla melodia e l’armonizzazione con sensibilità moderna. Caruso se ne innamorò giovanissimo tramite gli spartiti inviatigli dallo zio Antonio Di Domenico, chansonnier ed editore a Parigi, coltivando nel tempo una passione pianistica che lo avrebbe portato a collaborare a Irma la Douce, la famosa commedia musicata da Marguerite Monnot, di cui ripropone nel disco la “Piccola Suite per Piano”. I temi proposti sono di nomi altisonanti come Henry Salvador (“Syracuse”), Gilbert Becaud (“Quand il est mort le poète”), Georges Brassens (“J’ai rendez vous avec vous”) … L’antologia rappresenta un omaggio alla chanson in cui il pianoforte contende lo scettro di strumento principe alla fisarmonica e, nel contempo, ne offre un’ampia gamma – “Le tango corse”, lo swing di “On est pas là pour se faire engueler”, l’incipit musorgskiano di “Comèdie”, il walzer di “Domani”, il distillar note alla Satie di “Le deserteur” – che ne saggia la tavolozza espressiva e coloristica. Il disco è chiuso da “Après l’ourage” che potrebbe, perche no, commentare un film di Méliès, muto, tanto la narrazione è affidata alle dieci dita, les doigts, sulla tastiera.
TMR – “Tuscany Music Revolution” – Aut Records
 Ci sono tre quarti d’ora buoni di musica nell’album TMR Tuscany Music Revolution, prodotto dalla label tedesca Aut Records, divisa in sette parti di durata varia che va dai due agli otto minuti. Ne è protagonista l’Improvvisazione con consonanze (II) e minimalismi (III), africanerie (IV) e simil-musica d’oggi (V)… Il parterre artistico internazionale (V. Sutera, v; M. Mazzini, cl; E. Novali, pf; A. Braida, pf; F. Calcagno, cl; A. Bolzoni, g; L. Pissavini, cb; S. Di Benedetto, cb; D. Koutè (perc); S. Scucces (vib.), G. Lattuada (perc); L. D’Erasmo (frame dr); S. Grasso (dr) non “inscena” un ritorno al postfree semmai si pone in termini di attualizzazione e “rivoluzionaria” evoluzione di quell’area creativa che l’ Europa, Italia compresa, ha espresso anche in anni recenti dall’asse anglo-olandese fin giù a scendere sulla cartina geomusicale. Il collettivo è un esempio di interazione democratica e paritaria che, al pari di stormi liberi ma coordinati, delinea impreviste dinamie sonore e traiettorie mutaforma, in un fluttuare a volte sincronico altre no comunque ancorato alla struttura dei vari insiemi che si avvicendano.
Ci sono tre quarti d’ora buoni di musica nell’album TMR Tuscany Music Revolution, prodotto dalla label tedesca Aut Records, divisa in sette parti di durata varia che va dai due agli otto minuti. Ne è protagonista l’Improvvisazione con consonanze (II) e minimalismi (III), africanerie (IV) e simil-musica d’oggi (V)… Il parterre artistico internazionale (V. Sutera, v; M. Mazzini, cl; E. Novali, pf; A. Braida, pf; F. Calcagno, cl; A. Bolzoni, g; L. Pissavini, cb; S. Di Benedetto, cb; D. Koutè (perc); S. Scucces (vib.), G. Lattuada (perc); L. D’Erasmo (frame dr); S. Grasso (dr) non “inscena” un ritorno al postfree semmai si pone in termini di attualizzazione e “rivoluzionaria” evoluzione di quell’area creativa che l’ Europa, Italia compresa, ha espresso anche in anni recenti dall’asse anglo-olandese fin giù a scendere sulla cartina geomusicale. Il collettivo è un esempio di interazione democratica e paritaria che, al pari di stormi liberi ma coordinati, delinea impreviste dinamie sonore e traiettorie mutaforma, in un fluttuare a volte sincronico altre no comunque ancorato alla struttura dei vari insiemi che si avvicendano.
Pietro Lazazzara – “Gypsy Jazz Style” – Stradivarius
 Il chitarrismo manouche, quello praticato a livelli alti di nomadismo dei polpastrelli, può talora lasciar trasparire una certa patina di “monadismo”, per così dire, quando vi si riscontra unità inclusiva del connotato stilistico di base. E’ il caso dell’album Gypsy Jazz Style di Pietro Lazazzara (Stradivarius), seconda uscita discografica a sua firma, con una dozzina di inediti eseguiti all’insegna della convergenza di varietà e contaminazioni. L’ ensemble annovera Antonio Solazzo al basso, Francesco Clemente e Sabrina Loforese al volino, Maria Pia Lazazzara al violoncello, Luigi Vania alla viola, Nicoletta Di Sabato al flauto e Giuseppe Magistro al tamburello. Campeggia sullo sfondo, sin dal primo brano “Mister Swing”, l’ologramma di Django. Poi la musica, strada facendo, si fa intima in “Precious”, intinta di classico in “La via di Pia”, melò in “Walk with Me”, walzer notturno in “The Tale of the Moon”, flamenco in “La tela di Picasso”, tarant(ell)a in “Puglia”, moderato swing in “Blue Night”, sostenuto in “La joie de vivre”, è balcanica in “Circus”, tutta coracon in “Spanish Boulevard”, infine tripudio di note in “Impro in D Minor” con il gruppo che si trasforma in Gypsy Jazz Style Kings.
Il chitarrismo manouche, quello praticato a livelli alti di nomadismo dei polpastrelli, può talora lasciar trasparire una certa patina di “monadismo”, per così dire, quando vi si riscontra unità inclusiva del connotato stilistico di base. E’ il caso dell’album Gypsy Jazz Style di Pietro Lazazzara (Stradivarius), seconda uscita discografica a sua firma, con una dozzina di inediti eseguiti all’insegna della convergenza di varietà e contaminazioni. L’ ensemble annovera Antonio Solazzo al basso, Francesco Clemente e Sabrina Loforese al volino, Maria Pia Lazazzara al violoncello, Luigi Vania alla viola, Nicoletta Di Sabato al flauto e Giuseppe Magistro al tamburello. Campeggia sullo sfondo, sin dal primo brano “Mister Swing”, l’ologramma di Django. Poi la musica, strada facendo, si fa intima in “Precious”, intinta di classico in “La via di Pia”, melò in “Walk with Me”, walzer notturno in “The Tale of the Moon”, flamenco in “La tela di Picasso”, tarant(ell)a in “Puglia”, moderato swing in “Blue Night”, sostenuto in “La joie de vivre”, è balcanica in “Circus”, tutta coracon in “Spanish Boulevard”, infine tripudio di note in “Impro in D Minor” con il gruppo che si trasforma in Gypsy Jazz Style Kings.
Giovanni Angelini – “Freedom Rhythm” – A.MA Records
 “Voyager” è uno dei brani di punta del secondo album firmato dal batterista Giovanni Angelini dal titolo Freedom Rhythm, otto brani, scritti di proprio pugno, dal groove eclettico che mette assieme jazz funk afro soul e che non disdegna il guardare indietro, fino ai fab ’70. Ovviamente si tratta di un jazzista moderno ma con il piacere di far “viaggiare” la propria musica nello spaziotempo pilotandola da bandleader. Piace pensare che il “ritmo in libertà” sia anche quello del drummer che si svincola, crea, costruisce, si autointerpreta. Ed è infatti la veste di compositore quella che vi rispecchia le qualità di ideatore di strutture compless(iv)e caratterizzate da franca immediatezza e circolarità di un suono plasmato con Vince Abbracciante al piano, Dario Giacovelli al basso, Alberto Parmegiani alla chitarra, Gaetano Partipilo all’alto sax, Giuseppe Todisco alla tromba, Antonio Fallacara al trombone quindi Giovanni Astorino al cello. Ai quali si aggiunge il canto di Simona Severini con la “gemma” di “I Need Your Smile”. La sezione dei tre fiati assume un ruolo energico nello sviluppo dei temi (e nell’alternarsi improvvisativo) dalle linee melodiche che effettivamente rimangono impresse, un po’ tutte, da “Subway” fino a “Unity”, “Release The Monkey”, “Wuelva”, “Compass”, e nel contempo si muovono su scansioni metriche e schemi accordali nient’affatto scontati. Insomma ancora un bel prodotto del catalogo A.Ma Records!
“Voyager” è uno dei brani di punta del secondo album firmato dal batterista Giovanni Angelini dal titolo Freedom Rhythm, otto brani, scritti di proprio pugno, dal groove eclettico che mette assieme jazz funk afro soul e che non disdegna il guardare indietro, fino ai fab ’70. Ovviamente si tratta di un jazzista moderno ma con il piacere di far “viaggiare” la propria musica nello spaziotempo pilotandola da bandleader. Piace pensare che il “ritmo in libertà” sia anche quello del drummer che si svincola, crea, costruisce, si autointerpreta. Ed è infatti la veste di compositore quella che vi rispecchia le qualità di ideatore di strutture compless(iv)e caratterizzate da franca immediatezza e circolarità di un suono plasmato con Vince Abbracciante al piano, Dario Giacovelli al basso, Alberto Parmegiani alla chitarra, Gaetano Partipilo all’alto sax, Giuseppe Todisco alla tromba, Antonio Fallacara al trombone quindi Giovanni Astorino al cello. Ai quali si aggiunge il canto di Simona Severini con la “gemma” di “I Need Your Smile”. La sezione dei tre fiati assume un ruolo energico nello sviluppo dei temi (e nell’alternarsi improvvisativo) dalle linee melodiche che effettivamente rimangono impresse, un po’ tutte, da “Subway” fino a “Unity”, “Release The Monkey”, “Wuelva”, “Compass”, e nel contempo si muovono su scansioni metriche e schemi accordali nient’affatto scontati. Insomma ancora un bel prodotto del catalogo A.Ma Records!
Massimo Barbiero – “In Hora Mortis”
 Con In Hora Mortis la ricerca musicale del percussionista Massimo Barbiero, ancora una volta al confine fra filosofia e psicanalisi, si ritrova ad investigare, per il tramite del suono inteso come elemento vitale primario, il momento terminale del vivere. Un argomento che da Platone a Epicuro a Freud ha appassionato e arrovellato il pensiero umano antico e moderno. Barbiero lo affronta con gli “strumenti” che gli sono più congeniali e cioè quelli del suo ricco set percussivo. Per l’occasione suddivide l’hora in più momenti temporali gradualizzandola secondo una scala emotiva augmentante che non tradisce pathos mortiferi o pianti greci. La musica “domina” la possibile angoscia, la esorcizza, prende atto che i minuti che preludono all’ultimo atto dell’esistenza sono vita tout court e come tali possono essere vissuti magari riprodotti e sonorizzati da gong campane ritmi… Barbiero materializza così la propria “fantasia di sparizione” (Fagioli) in un disco coraggioso per Il tema che affronta e offre una lettura del tutto originale del fine vita che va ad installarsi in un percorso artistico di sperimentata coerenza culturale.
Con In Hora Mortis la ricerca musicale del percussionista Massimo Barbiero, ancora una volta al confine fra filosofia e psicanalisi, si ritrova ad investigare, per il tramite del suono inteso come elemento vitale primario, il momento terminale del vivere. Un argomento che da Platone a Epicuro a Freud ha appassionato e arrovellato il pensiero umano antico e moderno. Barbiero lo affronta con gli “strumenti” che gli sono più congeniali e cioè quelli del suo ricco set percussivo. Per l’occasione suddivide l’hora in più momenti temporali gradualizzandola secondo una scala emotiva augmentante che non tradisce pathos mortiferi o pianti greci. La musica “domina” la possibile angoscia, la esorcizza, prende atto che i minuti che preludono all’ultimo atto dell’esistenza sono vita tout court e come tali possono essere vissuti magari riprodotti e sonorizzati da gong campane ritmi… Barbiero materializza così la propria “fantasia di sparizione” (Fagioli) in un disco coraggioso per Il tema che affronta e offre una lettura del tutto originale del fine vita che va ad installarsi in un percorso artistico di sperimentata coerenza culturale.
Amedeo Furfaro
da Gerlando Gatto | 04/Set/2022 | I nostri libri, Primo piano, Recensioni

Angela Davis – “Blues e femminismo nero” – Alegre – pgg. 320 – € 20,00
 Quando si parla di Angela Davis il pensiero corre immediatamente all’attivista afro-americana che, nei decenni scorsi, fu protagonista di tante battaglie per l’emancipazione della gente di colore. Attività che si svolse anche attraverso importanti contributi letterari tra cui “Blues Legacies and Black Feminism” pubblicato nel 1998 e che adesso possiamo leggere in italiano grazie all’ottima traduzione di Mari Moise e Angelica Pesarini.
Quando si parla di Angela Davis il pensiero corre immediatamente all’attivista afro-americana che, nei decenni scorsi, fu protagonista di tante battaglie per l’emancipazione della gente di colore. Attività che si svolse anche attraverso importanti contributi letterari tra cui “Blues Legacies and Black Feminism” pubblicato nel 1998 e che adesso possiamo leggere in italiano grazie all’ottima traduzione di Mari Moise e Angelica Pesarini.
Della storia del blues si occupa compiutamente Ted Gioia nel volume che analizziamo qui di seguito. Questo volume analizza viceversa un aspetto particolare ma molto, molto importante del blues: il ruolo di tre vocalist – Gertrude “Ma” Rainey, Bessie Smith e Billie Holiday, appartenenti a tre generazioni diverse – nell’interpretare questo genere, sostanziandolo di contenuti che avrebbero influenzato lo sviluppo sociale nel suo insieme. Stiamo, infatti, parlando di un tema ancora oggi di attualità come l’emancipazione delle donne e l’importanza del loro ruolo.
Angela Davis, con la sua prosa partecipativa, analizza i testi dei brani interpretati dalle tre blueswoman e le loro performances, ricavandone tracce di tradizioni culturali risalenti al passato schiavista. Di qui un quadro esauriente di quali fossero le condizioni in cui le citate vocalist si sono trovate ad operare, un ambiente in cui era molto molto difficile contestare gli assunti patriarcali sul ruolo delle donne specie per quanto concerneva la sessualità. Per non parlare della marginalità che avevano gli artisti di colore nella nascente industria discografica. Ebbene queste tre artiste rivoluzionarono letteralmente l’industria discografica di massa assegnando un ruolo ben preciso e importante alle donne in genere, a quelle di colore in particolare. E si badi bene, si parla di musica, ma l’azione ‘rivoluzionaria’ qui accennata spinse i suoi orizzonti ben al di là del jazz degli anni Venti in quanto vi possiamo trovare i prodromi di quel femminismo che, come si accennava in apertura, avrebbe posto in primo piano il problema dell’emancipazione femminile, indipendentemente dal colore della pelle. Come a dire che sarebbe errato consegnare il monopolio della lotta femminista alle sole donne bianche della middle class, anche se “attribuire una coscienza femminista per come la definiamo oggi a Ma Rainey, Bessie Smith e Billie Holiday sarebbe insensato e poco interessante”. A dirlo è la stessa Angela Davis nell’introduzione al suo libro, affermando subito dopo: “Ciò che è più interessante e provocatorio della produzione artistica che ognuna di queste donne ha lasciato è il modo in cui dalla loro musica emergono – attraverso delle crepe all’interno dei discorsi patriarcali – tracce di un’indole femminista”.
E crediamo che questa sia una chiave di lettura assai utile per chi voglia intraprendere un viaggio nel tempo attraverso le parole di Angela Davis.
Amedeo Furfaro – “100 dischi di jazz italiano” – The Writer – pgg. 128 – € 12,00
 Si succedono le fatiche editoriali del nostro collaboratore Amedeo Furfaro dedicate prevalentemente alla discografia. Quest’ultimo volume si pone come occasione di riflessione sulla produzione discografica compresa fra 2020 e inizio 2022, un periodo quindi particolarmente delicato e non solo per il jazz e i suoi musicisti.
Si succedono le fatiche editoriali del nostro collaboratore Amedeo Furfaro dedicate prevalentemente alla discografia. Quest’ultimo volume si pone come occasione di riflessione sulla produzione discografica compresa fra 2020 e inizio 2022, un periodo quindi particolarmente delicato e non solo per il jazz e i suoi musicisti.
Ecco quindi una selezione di album, successiva ai cinque tomi de “Il giro del jazz italiano in ottanta dischi”, in cui l’Autore ha messo assieme materiali sparsi per rappresentare il jazz italiano su disco in era pandemica. Un jazz, quello italiano, le cui quotazioni sono in netto rialzo anche a livello discografico grazie ai grandi maestri, alla “generazione di mezzo” e alle nuove leve che hanno saputo coniugare preparazione tecnica e originalità dei progetti attuati.
In effetti i musicisti italiani di jazz, pure in un momento di difficoltà operativa e di graduale ripresa dei rapporti col pubblico, non hanno rinunciato al proprio ruolo ritrovando proprio nei lavori discografici momenti di rivalsa verso le difficoltà esterne. Certo, non tutte le produzioni discografiche del periodo assurgono ad un eccellente livello, ma in linea di massima siamo su standard qualitativi più che accettabili.
Il merito è sicuramente ascrivibile ai musicisti…ma non solo ché rilevante è stato anche il contributo di altre componenti quali le label che hanno acquisito una levatura professionale che le proietta sempre più spesso sul mercato internazionale e gli staff che in varie fasi hanno concorso a confezionare il prodotto discografico. Monitorando il jazz nazionale di inizio millennio l’Autore ha individuato alcune macro-tendenze, da quelle più attente alla tradizione afroamericana a quelle più radicali, da quelle affondate nell’humus del territorio alle più contaminate stilisticamente.
Dal turn over emerso si sono evidenziati interessanti talenti ma è un po’ tutto il “sistema” jazzistico italiano che si va riconfigurando, a partire da festival e rassegne che sono poi il campo in cui le idee si confrontano e ricevono il riscontro della critica e del pubblico. Quel pubblico che è anche acquirente di dischi in cui cerca di riassaporare il gusto di un live, di un contatto ravvicinato con i propri beniamini. Il saggio è impreziosito dall’inserto fotografico curato da Maria Gabriella Sartini.
Ted Gioia – “Delta Blues” – EDT, Siena Jazz – pgg. 460 – € 26,00
 Prima di addentrarmi nelle valutazioni su quest’altro importante volume di Ted Gioia, vorrei premettere alcune considerazioni che mi sembrano importanti.
Prima di addentrarmi nelle valutazioni su quest’altro importante volume di Ted Gioia, vorrei premettere alcune considerazioni che mi sembrano importanti.
Innanzitutto devo confessare che pur amando il blues non ne sono un esperto per cui il volume in oggetto è stato come una sorta di manna avendomi fornita una messe enorme di informazioni che non possedevo.
In secondo luogo è straordinario il modo in cui Gioia è riuscito ad includere in questo volume quella messe enorme di informazioni cui prima facevo riferimento: tenete presente che il sottoscritto è da due anni che cerca di completare la biografia di un grande pianista ancora in esercizio, senza riuscirvi proprio per la difficoltà di trovare e sistematizzare dati biografici.
A questo punto vi sarete già fatta un’idea di quanto potrete trovare in “Delta Blues” ma vi assicuro che l’integrale lettura del libro sarà di gran lunga superiore alle vostre più rosee aspettative.
In effetti Gioia, nel tracciare la storia del Blues partendo da quegli artisti provenienti dalle zone poverissime del Delta del Mississippi a partire dai primi anni Venti del secolo scorso, in realtà ci racconta la storia di un genere musicale che ha avuto una influenza determinante sulla musica degli anni a venire. Ecco quindi i primi straordinari personaggi come Charley Patton, Son House, Skip James e Robert Johnson che hanno lasciato i primi semi fatti poi germogliare da artisti di caratura internazionale che hanno portato il blues al successo mondiale, da Muddy Waters a Howlin’ Wolf, da John Lee Hooker a B. B. King, fino al blues revival degli anni Sessanta, il tutto senza trascurare la scena contemporanea del Delta fino agli anni Duemila.
Insomma Ted Gioia, dopo aver tracciato un quadro esauriente di cosa fosse la regione del Delta agli inizi del secolo scorso, con una agricoltura ridotta ai minimi termini per la concorrenza del cotone proveniente dall’Asia e senza speranza di sviluppo data anche la mancanza di rilevanti fermenti culturali, ci fa capire passo dopo passo come proprio in questa poverissima regione siano da ricercare le radici della musica nera, fosse la stessa chiamata jazz, funky o rock’n’roll.
Ancora una volta, comunque, almeno a mio avviso, il volume di Gioia si caratterizza oltre che per la competenza (ma su questo non credo ci sia bisogno di aggiungere altro) anche – e forse soprattutto – per lo stile di scrittura, uno stile assolutamente piano ma non banale, comprensibile a tutti, in cui le vite e le azioni dei vari artisti si inseriscono a perfezione nelle trame di un racconto tanto appassionante quanto di straordinaria vivacità. Ci sembra quasi di vedere con i nostri occhi il contesto socio-economico in cui si svolge la vicenda, le piantagioni in cui i primi bluesmen operavano, le prigioni in cui molti di essi trascorsero del tempo, i locali in cui accorreva una massa di povera gente per ascoltare i loro eroi. E in questo racconto trovano il loro posto anche le altre figure che hanno contribuito all’affermazione del blues: i produttori, i discografici, i ricercatori grazie ai quali si devono importanti scoperte, i musicologi che hanno cercato di interpretare i più reconditi anfratti di questa musica. E a questo punto è doverosa una precisazione: se lo stile di Gioia risulta tanto potente anche nella nostra lingua lo si deve all’ottima traduzione operata da Francesco Martinelli non nuovo ad operazioni del genere, e in questo caso “responsabile” anche di un prezioso glossario, pubblicato alla fine del volume, in cui si spiegano molti termini che ai più potrebbero risultare assolutamente incomprensibili.
Il volume è arricchito, infine, da un indice analitico sempre opportuno, una discografia selezionata (i 100 ascolti imprescindibili) e una ricca bibliografia, in cui gli appassionati troveranno pane per i loro denti.
Leonardo Lodato – “Cielo, la mia musica!” – Domenico Sanfilippo Editore e Compagnia Nuove Indye – pgg. 145 – € 20,00
 Dal Mississippi alla Sicilia: il salto è notevole ma non privo di qualche suggestione. A condurci per mano in questo immaginario viaggio attraverso una delle isole più belle del mondo, è Leonardo Lodato, giornalista e saggista ovviamente siciliano, capo servizio Cultura e Spettacolo del quotidiano “La Sicilia” di Catania, che oramai da tempo dedica la sua attenzione al mondo musicale nelle sue più svariate accezioni.
Dal Mississippi alla Sicilia: il salto è notevole ma non privo di qualche suggestione. A condurci per mano in questo immaginario viaggio attraverso una delle isole più belle del mondo, è Leonardo Lodato, giornalista e saggista ovviamente siciliano, capo servizio Cultura e Spettacolo del quotidiano “La Sicilia” di Catania, che oramai da tempo dedica la sua attenzione al mondo musicale nelle sue più svariate accezioni.
La genesi del libro, giunto alla seconda edizione, è spiegata assai bene dallo stesso Lodato nel corso di un’intervista: “guardavo il cielo stellato e ascoltavo la mia musica preferita. E’ nato un gioco. Ogni stella veniva associata ad un artista o ad una canzone che avesse a che fare con il cielo, con la luce, con i colori. All’improvviso mi è venuto un flash e ho pensato: ma perché non costruire una piccola costellazione di artisti siciliani? E questo è il risultato”.
In particolare, l’autore è partito da una serie di domande davvero originali che tendono a coniugare il cielo con la musica (da cui il titolo): quanto influiscono la luce del sole, il suo calore, nell’essere siciliani? E tutto ciò quanto in particolare se si è musicisti? E il cielo, soprattutto, come lo vede chi suona, chi canta, chi compone? Insomma come influiscono sulla musica due delle principali caratteristiche del mondo siculo quali il calore del sole e la bellezza del cielo? Per offrire esaurienti risposte a tali interrogativi Lodato ha intervistato dodici musicisti, fortemente legati all’Isola, che citiamo uno per uno: Bob Salmieri (Milagro Acustico e Erodoto Project), Andrea Cantieri, Caterina Anastasi (Babil On Suite), Compagnia d’Encelado Superbo, Giuseppina Torre, Lello Analfino, Marian Trapassi, Mario Venuti, Paolo Buonvino, Pupi di Surfaro, Roberta Finocchiaro e Rosalba Bentivoglio.
Questi artisti, appartenenti a diversi generi musicali (tra cui ovviamente anche il jazz) hanno risposto cercando di offrire una propria personalissima visione di quale può essere per un artista il rapporto con gli elementi naturali che ci accompagnano giorno dopo giorno. Di qui interviste che si distanziano dal classico cliché per rappresentarci non tanto e non solo l’artista quanto l’uomo, la donna che vivono compiutamente la propria vita ponendosi interrogativi non banali. Ecco quindi, ad esempio, la vocalist jazz Rosalba Bentivoglio che afferma:” Questo è il cielo che sogna la terra e mi domando: è il cielo di tutti o solo il mio a darmi questa vertigine e farmi presentire l’essere mortale? Il mondo materiale che appare così solido alla percezione dei nostri cinque sensi è un universo di energia in movimento. Il macrocosmo ripete se stesso nell’uomo e il microcosmo è a sua volta riflesso in tutti gli atomi minori”. Alla successiva domanda di Lodato se esiste un altrove dove cercare Dio, la Bentivoglio risponde semplicemente “Questo, forse, taumaturgicamente, è la ricerca di Dio”.
Questa nuova edizione di “Cielo, la mia musica” è arricchita da una playlist, ascoltabile su Spotify, con i brani scelti dall’autore per raccontare il cammino che ha portato alla stesura del libro, mentre la prefazione è firmata dal tastierista dei Rockets, Fabrice Quagliotti.
Gerlando Gatto
da Amedeo Furfaro | 03/Ago/2022 | Editoriali, News, Primo piano
La televisione è stata spesso oggetto di critiche in quanto possibile veicolo di regresso culturale delle masse. Umberto Eco, a proposito dell’uomo circuìto dai mass media, scriveva che “poiché uno dei compensi narcotici a cui ha diritto è l’evasione nel sogno, gli vengono presentati di solito degli ideali tra lui e quelli con cui si possa stabilire una tensione” (Diario Minimo, 1961). La tematica dei rapporti fra musica e mass media investe anche un genere non definibile “narcotizzante” come il jazz nella sua relazione con la tv. In proposito, in Italia, si sono verificati dei momenti di avvicinamento fra i due termini del rapporto che consentono di abbozzare dei lineamenti di storia televisiva “vista” attraverso il fil rouge delle sigle jazz.
—
Donald Bogle ha osservato che “attorno al 1950 i sets tv arrivavano nelle case degli americani trasformandone gradualmente abitudini e prospettive” (Blacks in American Films and Television, New York, Fireside, 1989). E David Johnson di recente ha annotato che “come la tv si insinuava nell’entertainment dell’America di metà 900, musicisti e compositori, molti con esperienze jazz, venivano chiamati a scrivere temi ed “attacchi” per varietà e programmi” (Heard It On The Tv: Jazz Takes On Television Themes, indianapublicmedia.org, 12/5/2021). Osservazioni in parte trasferibili, con le dovute proporzioni, all’Italia che, dal 1954, dai primi vagiti della neonata tv, subiva il modificarsi di usi, linguaggio, immaginario collettivo in un contesto di rapida trasformazione economica, sociale e culturale, a causa anche alla spinta dei mass media. Su queste colonne, fra le sottotracce della nostra storia televisiva, abbiamo provato a “rintracciare” un argomento abbastanza sottaciuto, quello delle sigle (e intersigle) che sono poi l’antipasto e il post prandium del programma televisivo, nello specifico quelle dialoganti lato sensu in jazz o comunque prodotte od associabili a jazzisti. Come “la radio degli anni Cinquanta è a cavallo tra conservazione e trasformazione” (cfr. sub voce Cultura e educazione, l’Universale Radio, Milano, 2006) così il nuovo medium, già dai primi anni di vita, attenzionava sonorità che erano espressione di differenti musiche del mondo. Su un tale sfondo il jazz riusciva man mano a ritagliarsi spazi nei palinsesti e ad essere presente in filmati, notiziari, dossier, speciali, spot e jingle (cfr. Jazz e pubblicità, “A proposito di Jazz”, 9/4/2021), programmi a quiz, a premi e a cotillon, varietà, sceneggiati e “originali televisivi”, serie tv. Già nell’Italia della ricostruzione postbellica la dimensione locale non più autarchica si era confrontata sulla globale “importando” liberamente musica che durante il regime era proibita. Con l’avvento del medium tv le sigle di fatto fungevano da possibile cavallo di Troia per conquistare al jazz spazio in audio/video e lasciar trapelare le note di Woody Herman, Stan Kenton, Duke Ellington, Toots Thielemans … e vari artefici di una musica che in quegli anni non veniva più percepita solo come intrattenimento omologante bensì anche quale propaggine di quella cultura neroamericana propria di una comunità oppressa non dominante. Una comunità in fibrillante opposizione politica e spiccato antagonismo sociale i cui risvolti rimbalzavano nelle lettere, nelle arti, nella musica. Ma entriamo nel dettaglio. In Italia, nel 1957, coetanea di Carosello, vedeva la luce in tv Telematch. La trasmissione a premi era introdotta dalle note di “Marching Strings” dell’orchestra di Ray Martin, il bandleader di “The Swingin’ Marchin’ Band” (RCA, 1958). Light music, la sua, che rappresentava però un’apertura internazionale verso la musica easy listening d’oltrefrontiera sul Programma Nazionale e in prima serata. Parallelamente, alla radio, nel 1960, Adriano Mazzoletti, da un anno collaboratore della Rai, debuttava con la Coppa del Jazz promuovendo in tal modo una più stabile programmazione in senso jazzistico sul mezzo radiofonico i cui primordi risalgono all’antenato Eiar Jazz del 1929.
 A dire il vero, dopo il primo melodico Sanremo del ’51, una decisa aura jazz si era avvertita in Nati per la Musica, un programma con Jula De Palma, Quartetto Cetra, Teddy Reno che si avvaleva delle orchestre di ritmi moderni di Gorni Kramer e Lelio Luttazzi, la cui sigla è ascoltabile sul Portale della Canzone Italiana dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi (www.canzone italiana.it/1zlns). Sorella Radio avrebbe dato anche in seguito significativi contributi alla causa jazzistica – si pensi all’uso fatto da Radio1 dello stacco di “Country“ tratto dal cd “My Song” di Jarrett con Garbarek, Danielson e Christensen (ECM, 1977) – ma il copioso materiale di Mamma Rai, con il ricchissimo archivio sonoro ad oggi digitalizzato, meriterebbe di essere approfondito in altra sede. Torniamo allora al come eravamo tramite il cosa guardavamo. Dopo la vittoria di Modugno all’Ariston nel ’58, con una “Nel blu dipinto di blu” a ritmo swing, nell’anno di grazia televisivo 1961 passavano in video le immagini di Moderato Swing che era anche il titolo della sigla di Piero Umiliani. Un biennio ancora per poi sentire il canto e la tromba di Nini Rosso echeggiare in “I ragazzi del jazz”, sigla di Fuori I ’Orchestra, epica trasmissione, per la regia di Lino Procacci, che si avvaleva della direzione musicale dello stesso Umiliani. Si trattava di una rubrica che si occupava “di musica equidistante fra quella leggerissima e quella classica“ (www.umiliani.com) che rimane una pietra miliare della televisione italiana. Fra i numeri fissi c’erano quello dedicato al Jazz made in Italy ed l’altro spazio denominato Parole e musica che registrava partecipazioni lussuose tipo la cantante Helen Merrill. Da segnalare che Umiliani avrebbe poi collaborato con I Marc 4 (acronimo di Maurizio Majorana, Antonello Vannucchi, Roberto Podio, Carlo Pes), gruppo operante fra ’60 e ’76, a cui è da ascrivere la sigla di Prima Visione (su album Ricordi, 1974). Il 1963 resta un anno significativo per il jazz sul piccolo schermo anche perché decollava in Italia, con TV7, l’idea di utilizzare un brano jazz come intro di un programma d’inchiesta. Per l’occasione la scelta cadeva su “Intermission Riff” di Stan Kenton, poi sostituita con una storica versione dell’Equipe 84. A fine decennio toccava alla serie tv Nero Wolf diretta da Giuliana Berlinguer con Tino Buazzelli, vedere impressi i titoli di testa e di coda dalla tromba di Nunzio Rotondo sulla base elettronica di Romolo Grano, musica da noir con echi dal lungometraggio di Louis Malle Ascenseur pour l’échafaud, del ’58, sonorizzato da Miles Davis, trombettista a cui Rotondo è stato spesso accostato. Ed avrebbe “aperto” un thriller televisivo il compositore Berto Pisano con la sua “Blue Shadow”, sigla lounge dello sceneggiato Ho incontrato un’ombra del 1974, che figura nella classifica stilata da “Rolling Stone” il 26 agosto 2020 in Fantasmi e storie maledette. Le migliori sigle della tv italiana del mistero degli anni ’70. In tema di rotocalchi da menzionare che AZ un fatto come e perché (in onda dal ‘70 fino al luglio ’76) adottava un pezzo del repertorio jazz, esattamente “Hard to Keep My Mind of You”, di Woody Herman.
A dire il vero, dopo il primo melodico Sanremo del ’51, una decisa aura jazz si era avvertita in Nati per la Musica, un programma con Jula De Palma, Quartetto Cetra, Teddy Reno che si avvaleva delle orchestre di ritmi moderni di Gorni Kramer e Lelio Luttazzi, la cui sigla è ascoltabile sul Portale della Canzone Italiana dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi (www.canzone italiana.it/1zlns). Sorella Radio avrebbe dato anche in seguito significativi contributi alla causa jazzistica – si pensi all’uso fatto da Radio1 dello stacco di “Country“ tratto dal cd “My Song” di Jarrett con Garbarek, Danielson e Christensen (ECM, 1977) – ma il copioso materiale di Mamma Rai, con il ricchissimo archivio sonoro ad oggi digitalizzato, meriterebbe di essere approfondito in altra sede. Torniamo allora al come eravamo tramite il cosa guardavamo. Dopo la vittoria di Modugno all’Ariston nel ’58, con una “Nel blu dipinto di blu” a ritmo swing, nell’anno di grazia televisivo 1961 passavano in video le immagini di Moderato Swing che era anche il titolo della sigla di Piero Umiliani. Un biennio ancora per poi sentire il canto e la tromba di Nini Rosso echeggiare in “I ragazzi del jazz”, sigla di Fuori I ’Orchestra, epica trasmissione, per la regia di Lino Procacci, che si avvaleva della direzione musicale dello stesso Umiliani. Si trattava di una rubrica che si occupava “di musica equidistante fra quella leggerissima e quella classica“ (www.umiliani.com) che rimane una pietra miliare della televisione italiana. Fra i numeri fissi c’erano quello dedicato al Jazz made in Italy ed l’altro spazio denominato Parole e musica che registrava partecipazioni lussuose tipo la cantante Helen Merrill. Da segnalare che Umiliani avrebbe poi collaborato con I Marc 4 (acronimo di Maurizio Majorana, Antonello Vannucchi, Roberto Podio, Carlo Pes), gruppo operante fra ’60 e ’76, a cui è da ascrivere la sigla di Prima Visione (su album Ricordi, 1974). Il 1963 resta un anno significativo per il jazz sul piccolo schermo anche perché decollava in Italia, con TV7, l’idea di utilizzare un brano jazz come intro di un programma d’inchiesta. Per l’occasione la scelta cadeva su “Intermission Riff” di Stan Kenton, poi sostituita con una storica versione dell’Equipe 84. A fine decennio toccava alla serie tv Nero Wolf diretta da Giuliana Berlinguer con Tino Buazzelli, vedere impressi i titoli di testa e di coda dalla tromba di Nunzio Rotondo sulla base elettronica di Romolo Grano, musica da noir con echi dal lungometraggio di Louis Malle Ascenseur pour l’échafaud, del ’58, sonorizzato da Miles Davis, trombettista a cui Rotondo è stato spesso accostato. Ed avrebbe “aperto” un thriller televisivo il compositore Berto Pisano con la sua “Blue Shadow”, sigla lounge dello sceneggiato Ho incontrato un’ombra del 1974, che figura nella classifica stilata da “Rolling Stone” il 26 agosto 2020 in Fantasmi e storie maledette. Le migliori sigle della tv italiana del mistero degli anni ’70. In tema di rotocalchi da menzionare che AZ un fatto come e perché (in onda dal ‘70 fino al luglio ’76) adottava un pezzo del repertorio jazz, esattamente “Hard to Keep My Mind of You”, di Woody Herman.
 Dal giornalismo d’inchiesta a quello sportivo: nel ’78 era il turno di Jazz Band di Hengel Gualdi a far da “preludio” a Novantesimo minuto, storica rubrica di RaiSport, e come non citare, dal campionario di La Domenica Sportiva, “Dribbling” di Piero Umiliani (1967), “Winning The West” della Buddy Rich Big Band (1973), “Mexico” di Danilo Rea e Roberto Gatto (1985), “Breakout” di Spyro Gira (1991)? Spostandoci alla “pagina” spettacoli, fra il ’76 e il ‘78, Rete 2 dava spazio in Odeon al pianista Keith Emerson (senza Lake e Palmer) in “Odeon Rag” arrangiamento di “Maple Leaf Rag” di Scott Joplin, subentrato in luogo del precedente “Honky Tonk Train Blues”, autore il pianista Meade Lux Lewis. Il filone spettacolistico avrebbe registrato più in là significativi esempi con lo scat di Lucio Dalla con gli Stadio che annuncia Lunedifilm per un buon ventennio fino al 2002 e l’ellingtoniano “Take The A Train” di Strayhorn a fare da intro ai trailer cinematografici assemblati da AnicaFlash per la rassegna delle novità cinematografiche “di stagione”. Si diceva come luogo fertile per la semina tv di suoni jazz da filtrare nelle orecchie dei telespettatori fosse l’informazione. Gettonatissima rimane al riguardo la sigla di Mixer (1980-1996) ovvero “Jazz Carnival” dei brasiliani Azimuth, specialisti del samba doido, genere fusion-funky. Latin come nelle radiocronache di Tutto il calcio minuto per minuto, dove Herb Alpert e Tijuana Brass interpretano “A Taste of Honey”, brano di stampo pop, in repertorio a Beatles e Giganti (“In paese è festa”). Per la tv italiana va ricordato che, fuori dal reticolo giornalistico, si contano altre occasioni più dirette di esposizione per la musica jazz filtrata tramite il piccolo schermo. La Portobello Jazz Band di Lino Patruno “presentava” il programma di Enzo Tortora (cfr. La tana delle sigle in tds.sigletv.net) nel 1978, stesso anno dello sceneggiato in 3 puntate Jazz Band di Pupi Avati, colonna sonora di Amedeo Tommasi, con il clarino di Hengel Gualdi in evidenza nelle sigle di apertura e chiusura, “Jazz Band” e “Swing Time” ; poi ancora Di Jazz in Jazz, programma “dedicato” con relativa sigla a cura dell’Orchestra Big Band della Rai diretta da Giampiero Boneschi e Franco Cerri (www.teche.rai.it). “Schegge”, queste ultime, che costituivano una vetrina per il jazz di casa nostra in una situazione in cui il format varietà si teneva alquanto distante, a differenza di quanto avveniva negli U.S.A. . Dalle nostre parti vanno citati comunque Milleluci, show datato 1974, nella cui sigla finale “Non gioco più” Mina duetta con l’armonica di Toots Thielemans, Palcoscenico, in onda fra 1980 e 1981, con Milva accompagnata da Astor Piazzolla mentre scorrono i titoli di coda in “Fumo e odore di caffè” e Premiatissima del 1985 dove il crooner Johnny Dorelli canta “La cosa si fa“ su base swing “metropolitano. Lo sdoganamento delle sigle jazz nei varietà proseguiva con Renzo Arbore (e Gegè Telesforo) a cui si deve “Smorza e’ lights (Such a night)” incipit di Telepatria International, inizio trasmissioni il 6 dicembre 1981 (www.arboristeria.it – Renzo Arbore Channel). Per la cronaca il 18 marzo 1981, e fino al 1989, sarebbe andata in onda la prima edizione di Quark di Piero Angela, conduttore nonché apprezzato pianista jazz. La trasmissione di divulgazione scientifica sarebbe stata simbioticamente legata alla sigla, la “Air for G String” di Bach, eseguita da The Swingle Singers, pubblicata nell’album “Jazz Sèbastian Bach” (1963), peraltro incisa anche insieme al Modern Jazz Quartet in “Place Vendòme”, album del ’68 della Philips. Terminiamo questa breve carrellata, che non include per sintesi le emittenti private/commerciali pro-tempore, per ricordare la sigla swing di DOC Musica e altro a denominazione d’origine controllata (1987-1988) di Arbore, Telesforo e Monica Nannini, esempio di come coinvolgere il jazz in un contenitore di buona musica. Il breve excursus è stato uno squarcio fugace su una jazz age, grossomodo racchiusa fra ’54 e ’94, un fugace momento di (bel) spaesizzazione musicale segnato, al proprio interno, dal passaggio dall’analogico al digitale, fase che precedeva la successiva della tv satellite e quella attuale della connessione via internet con la diffusione dei social e di new media come le web-tv con piattaforme on demand. E’ stato osservato che nella tv generalista di oggi “il jazz non ha più la stessa presa pubblica di un tempo” (cfr. Il jazz e le sigle radiotelevisive, riccardofacchi.wordpress.com, 2/8/2016). E “CiakClub.it” ha pubblicato, a firma di Alberto Candiani, un elenco con Le 20 migliori sigle televisive di sempre: Da Friends a Il trono di spade la lista delle più affascinanti iconiche e meglio congeniate sigle delle serie tv senza che ne compaia qualcuna (simil)jazz. Vero! Ci sono molti set televisivi in cui il jazz fa comparse episodiche. C’è poi che, a causa dell’affinarsi delle tecnologie digitali, molte sigle vengono confezionate a tavolino e, perdendo in istantaneità, sono sempre meno frutto di incisioni live né tantomeno vengono selezionate fra materiali preesistenti. Ed è forse tutto ciò che ammanta quei “primi quarant’anni” di tv “eterea” di un irripetibile sapore amarcord.
Dal giornalismo d’inchiesta a quello sportivo: nel ’78 era il turno di Jazz Band di Hengel Gualdi a far da “preludio” a Novantesimo minuto, storica rubrica di RaiSport, e come non citare, dal campionario di La Domenica Sportiva, “Dribbling” di Piero Umiliani (1967), “Winning The West” della Buddy Rich Big Band (1973), “Mexico” di Danilo Rea e Roberto Gatto (1985), “Breakout” di Spyro Gira (1991)? Spostandoci alla “pagina” spettacoli, fra il ’76 e il ‘78, Rete 2 dava spazio in Odeon al pianista Keith Emerson (senza Lake e Palmer) in “Odeon Rag” arrangiamento di “Maple Leaf Rag” di Scott Joplin, subentrato in luogo del precedente “Honky Tonk Train Blues”, autore il pianista Meade Lux Lewis. Il filone spettacolistico avrebbe registrato più in là significativi esempi con lo scat di Lucio Dalla con gli Stadio che annuncia Lunedifilm per un buon ventennio fino al 2002 e l’ellingtoniano “Take The A Train” di Strayhorn a fare da intro ai trailer cinematografici assemblati da AnicaFlash per la rassegna delle novità cinematografiche “di stagione”. Si diceva come luogo fertile per la semina tv di suoni jazz da filtrare nelle orecchie dei telespettatori fosse l’informazione. Gettonatissima rimane al riguardo la sigla di Mixer (1980-1996) ovvero “Jazz Carnival” dei brasiliani Azimuth, specialisti del samba doido, genere fusion-funky. Latin come nelle radiocronache di Tutto il calcio minuto per minuto, dove Herb Alpert e Tijuana Brass interpretano “A Taste of Honey”, brano di stampo pop, in repertorio a Beatles e Giganti (“In paese è festa”). Per la tv italiana va ricordato che, fuori dal reticolo giornalistico, si contano altre occasioni più dirette di esposizione per la musica jazz filtrata tramite il piccolo schermo. La Portobello Jazz Band di Lino Patruno “presentava” il programma di Enzo Tortora (cfr. La tana delle sigle in tds.sigletv.net) nel 1978, stesso anno dello sceneggiato in 3 puntate Jazz Band di Pupi Avati, colonna sonora di Amedeo Tommasi, con il clarino di Hengel Gualdi in evidenza nelle sigle di apertura e chiusura, “Jazz Band” e “Swing Time” ; poi ancora Di Jazz in Jazz, programma “dedicato” con relativa sigla a cura dell’Orchestra Big Band della Rai diretta da Giampiero Boneschi e Franco Cerri (www.teche.rai.it). “Schegge”, queste ultime, che costituivano una vetrina per il jazz di casa nostra in una situazione in cui il format varietà si teneva alquanto distante, a differenza di quanto avveniva negli U.S.A. . Dalle nostre parti vanno citati comunque Milleluci, show datato 1974, nella cui sigla finale “Non gioco più” Mina duetta con l’armonica di Toots Thielemans, Palcoscenico, in onda fra 1980 e 1981, con Milva accompagnata da Astor Piazzolla mentre scorrono i titoli di coda in “Fumo e odore di caffè” e Premiatissima del 1985 dove il crooner Johnny Dorelli canta “La cosa si fa“ su base swing “metropolitano. Lo sdoganamento delle sigle jazz nei varietà proseguiva con Renzo Arbore (e Gegè Telesforo) a cui si deve “Smorza e’ lights (Such a night)” incipit di Telepatria International, inizio trasmissioni il 6 dicembre 1981 (www.arboristeria.it – Renzo Arbore Channel). Per la cronaca il 18 marzo 1981, e fino al 1989, sarebbe andata in onda la prima edizione di Quark di Piero Angela, conduttore nonché apprezzato pianista jazz. La trasmissione di divulgazione scientifica sarebbe stata simbioticamente legata alla sigla, la “Air for G String” di Bach, eseguita da The Swingle Singers, pubblicata nell’album “Jazz Sèbastian Bach” (1963), peraltro incisa anche insieme al Modern Jazz Quartet in “Place Vendòme”, album del ’68 della Philips. Terminiamo questa breve carrellata, che non include per sintesi le emittenti private/commerciali pro-tempore, per ricordare la sigla swing di DOC Musica e altro a denominazione d’origine controllata (1987-1988) di Arbore, Telesforo e Monica Nannini, esempio di come coinvolgere il jazz in un contenitore di buona musica. Il breve excursus è stato uno squarcio fugace su una jazz age, grossomodo racchiusa fra ’54 e ’94, un fugace momento di (bel) spaesizzazione musicale segnato, al proprio interno, dal passaggio dall’analogico al digitale, fase che precedeva la successiva della tv satellite e quella attuale della connessione via internet con la diffusione dei social e di new media come le web-tv con piattaforme on demand. E’ stato osservato che nella tv generalista di oggi “il jazz non ha più la stessa presa pubblica di un tempo” (cfr. Il jazz e le sigle radiotelevisive, riccardofacchi.wordpress.com, 2/8/2016). E “CiakClub.it” ha pubblicato, a firma di Alberto Candiani, un elenco con Le 20 migliori sigle televisive di sempre: Da Friends a Il trono di spade la lista delle più affascinanti iconiche e meglio congeniate sigle delle serie tv senza che ne compaia qualcuna (simil)jazz. Vero! Ci sono molti set televisivi in cui il jazz fa comparse episodiche. C’è poi che, a causa dell’affinarsi delle tecnologie digitali, molte sigle vengono confezionate a tavolino e, perdendo in istantaneità, sono sempre meno frutto di incisioni live né tantomeno vengono selezionate fra materiali preesistenti. Ed è forse tutto ciò che ammanta quei “primi quarant’anni” di tv “eterea” di un irripetibile sapore amarcord.
Amedeo Furfaro
da Gerlando Gatto | 02/Ago/2022 | Eventi, News, Primo piano
Dopo un periodo di relativa stasi per motivi facilmente individuabili, Roma è tornata ad essere attrattiva per gli passionati di jazz. Così da un canto l’Auditorium (con pochi ma eccellenti appuntamenti) dall’altro la Casa del Jazz con la sua consueta rassegna estiva, stanno fornendo ai cultori del jazz parecchi appuntamenti degni di rilievo, su alcuni dei quali mi soffermerò qui di seguito.
Il 10 luglio, alla Cavea dell’Auditorium, appuntamento con Gregory Porter. Sono oramai parecchi anni che conosco ad apprezzo questo vocalist e ancora una volta la sua performance ha corrisposto in pieno alle mie aspettative. La sua musicalità, il feeling che riesce a trasmettere agli ascoltatori, il suo senso del ritmo, il modo in cui riesce ad interpretare qualsiasi testo sono davvero straordinari. E non è certo un caso che la sua carriera artistica sia costellata da grandi successi e riconoscimenti tra cui due Grammy Awards per Miglior Album Vocale.

Per celebrare un decennio di successi, Gregory Porter ha pubblicato “Still Rising”, un doppio album contenente 34 tracce tra brani inediti, covers, duetti e una selezione speciale delle sue canzoni più amate. Ed è proprio sul repertorio di quest’ultimo doppio album che si è incentrata la performance romana. Ben coadiuvato da Hip Crawford al piano, Tivon Pennicott al sax tenore, Emanuel Harrold alla batteria, Jahmal Nichols al basso elettrico e Ondrej Pivec all’organo (gli stessi che l’hanno accompagnato nella già citata ultima fatica discografica) Porter ha dato ancora una volta un saggio di bravura proponendo una musica in cui era facile scorgere echi di soul, di gospel, di blues, financo di pop, mescolati in un unicum tanto originale quanto suggestivo. Ed è stato a tratti entusiasmante sentirlo duettare con alcuni dei suoi compagni di viaggio in un concerto tutto sommato breve ma di grande intensità.
Ascoltando Porter viene naturale un parallelo con i nostri giovani rampanti: beh, penso che ai vari San Giovanni, Albe, LDA, Ultimo e via discorrendo non farebbe male ascoltare qualche disco di chi sa cantare veramente bene. Ma questo è un tema che mi sollecita oramai da tempo e su cui prima o poi vorrò intervenire.
 Il 13, sempre alla Cavea, appuntamento con una vera e propria leggenda del jazz: Herbie Hancock. Spesso si adopera la parola “leggenda” in modo esagerato ma nel caso in questione non v’è dubbio alcuno che il termine sia più che appropriato. Non è questa la sede adatta per sintetizzare un curriculum assolutamente straordinario; basti solo dire che l’artista di Chicago, oggi ottantunenne, ha attraversato, sempre da protagonista, generi e mode come performer, compositore, arrangiatore, produttore, scopritore di talenti, inventore di nuove tendenze, senza mai perdere una coerenza di fondo. A Roma si è presentato alla testa di una band eccezionale completata da Terence Blanchard alla tromba, Lionel Loueke (chitarra), James Genus (basso) e Justin Tyson (batteria). Ascoltare un concerto di Hancock è come rivivere, in sintesi, buona parte della storia del jazz dal momento che questo artista ha sviluppato un’estetica giocata sempre su una sorta di doppio binario: da un canto virtuoso pianista del jazz acustico, dall’altro estimatore se non fondatore del funky elettronico. E questi due aspetti della sua personalità sono apparsi evidenti anche nel concerto romano; così in una prima parte abbiamo ascoltato alcuni classici del jazz come il sempre verde “Footprints” di Wayne Shorter, un altro giovanotto di 89 anni, omaggiato da Hancock che si alternava al piano e alle tastiere non disdegnando un ricorso mai esagerato al vocoder (ma che comunque se non ci fosse stato nulla avrebbe tolto alla validità del concerto). Nella seconda parte Hancock si richiamava al suo coté più funky e chiudeva il concerto con “Chameleon” brano tratto dal celebre album “Head Hunters” del 1973, scatenando l’entusiasmo del pubblico che si è accalcato a ballare sotto il palco.
Il 13, sempre alla Cavea, appuntamento con una vera e propria leggenda del jazz: Herbie Hancock. Spesso si adopera la parola “leggenda” in modo esagerato ma nel caso in questione non v’è dubbio alcuno che il termine sia più che appropriato. Non è questa la sede adatta per sintetizzare un curriculum assolutamente straordinario; basti solo dire che l’artista di Chicago, oggi ottantunenne, ha attraversato, sempre da protagonista, generi e mode come performer, compositore, arrangiatore, produttore, scopritore di talenti, inventore di nuove tendenze, senza mai perdere una coerenza di fondo. A Roma si è presentato alla testa di una band eccezionale completata da Terence Blanchard alla tromba, Lionel Loueke (chitarra), James Genus (basso) e Justin Tyson (batteria). Ascoltare un concerto di Hancock è come rivivere, in sintesi, buona parte della storia del jazz dal momento che questo artista ha sviluppato un’estetica giocata sempre su una sorta di doppio binario: da un canto virtuoso pianista del jazz acustico, dall’altro estimatore se non fondatore del funky elettronico. E questi due aspetti della sua personalità sono apparsi evidenti anche nel concerto romano; così in una prima parte abbiamo ascoltato alcuni classici del jazz come il sempre verde “Footprints” di Wayne Shorter, un altro giovanotto di 89 anni, omaggiato da Hancock che si alternava al piano e alle tastiere non disdegnando un ricorso mai esagerato al vocoder (ma che comunque se non ci fosse stato nulla avrebbe tolto alla validità del concerto). Nella seconda parte Hancock si richiamava al suo coté più funky e chiudeva il concerto con “Chameleon” brano tratto dal celebre album “Head Hunters” del 1973, scatenando l’entusiasmo del pubblico che si è accalcato a ballare sotto il palco.
E veniamo adesso ai concerti alla Casa del Jazz.
 Il 12 luglio una vecchia e cara conoscenza del pubblico romano: John Scofield. Il chitarrista può a ben ragione essere considerato una delle massime espressioni della chitarra jazz degli ultimi decenni. Musicista eclettico, voglioso sempre di sperimentare strade nuove, questa volta si è presentato con un progetto del tutto nuovo, “Yankee Go Home”, con cui torna alle radici del rock americano, riscoprendo classici fra il folk e il rock’n’roll. Accanto a lui Jon Cowherd (pianoforte e tastiere), Vicente Archer (contrabbasso)e Josh Dion (batteria). E’ lo stesso Scofield a illustrare il senso di questo nuovo progetto, non senza elogiare i suoi compagni di viaggio: “L’idea –afferma Scofield – è di coprire successi americani/rock e canzoni folk jazz, più alcuni dei miei brani originali scritti in quel modo. Mi sto riconnettendo con molte delle mie radici Rock ‘n Roll da adolescente, naturalmente colorate dai miei 50 anni di pratica Jazz…. Questi ragazzi sono straordinariamente versatili, altrettanto bravi quando si tratta di suonare in modo interattivo e creativo. Stiamo esplorando rock, funk, country, jazz e musica libera e ci divertiamo moltissimo. Sono entusiasta di questa collaborazione”. Risultato raggiunto? Assolutamente sì; il repertorio, comprendente brani tra gli altri di Bob Dylan, Neil Young, Grateful Dead, B.B. King, Buddy Holly, viene declinato attraverso quella maestria strumentale che ben conosciamo oramai da tanti anni. Scofield è sempre lì a tessere le fila del discorso, con un solismo preciso, elegante, raffinato mai soverchiante cosicché tutti i suoi compagni di viaggio hanno la possibilità di mettersi in luce. I vari pezzi vengono riletti alla luce di quelle esperienze cui lo stesso Scofield faceva riferimento ridando loro una sorta di nuova linfa e il pubblico dimostra di apprezzare con lunghi appalusi a scena aperta. Immancabile il bis: un coinvolgente blues che evidenzia come Scofield rimanga solidamente ancorato anche alle radici della musica afro-americana.
Il 12 luglio una vecchia e cara conoscenza del pubblico romano: John Scofield. Il chitarrista può a ben ragione essere considerato una delle massime espressioni della chitarra jazz degli ultimi decenni. Musicista eclettico, voglioso sempre di sperimentare strade nuove, questa volta si è presentato con un progetto del tutto nuovo, “Yankee Go Home”, con cui torna alle radici del rock americano, riscoprendo classici fra il folk e il rock’n’roll. Accanto a lui Jon Cowherd (pianoforte e tastiere), Vicente Archer (contrabbasso)e Josh Dion (batteria). E’ lo stesso Scofield a illustrare il senso di questo nuovo progetto, non senza elogiare i suoi compagni di viaggio: “L’idea –afferma Scofield – è di coprire successi americani/rock e canzoni folk jazz, più alcuni dei miei brani originali scritti in quel modo. Mi sto riconnettendo con molte delle mie radici Rock ‘n Roll da adolescente, naturalmente colorate dai miei 50 anni di pratica Jazz…. Questi ragazzi sono straordinariamente versatili, altrettanto bravi quando si tratta di suonare in modo interattivo e creativo. Stiamo esplorando rock, funk, country, jazz e musica libera e ci divertiamo moltissimo. Sono entusiasta di questa collaborazione”. Risultato raggiunto? Assolutamente sì; il repertorio, comprendente brani tra gli altri di Bob Dylan, Neil Young, Grateful Dead, B.B. King, Buddy Holly, viene declinato attraverso quella maestria strumentale che ben conosciamo oramai da tanti anni. Scofield è sempre lì a tessere le fila del discorso, con un solismo preciso, elegante, raffinato mai soverchiante cosicché tutti i suoi compagni di viaggio hanno la possibilità di mettersi in luce. I vari pezzi vengono riletti alla luce di quelle esperienze cui lo stesso Scofield faceva riferimento ridando loro una sorta di nuova linfa e il pubblico dimostra di apprezzare con lunghi appalusi a scena aperta. Immancabile il bis: un coinvolgente blues che evidenzia come Scofield rimanga solidamente ancorato anche alle radici della musica afro-americana.
Il 21 uno dei concerti inseriti nell’ambito della rassegna, tutta dedicata alle nuove tendenze e, dunque, alle più interessanti proposte di jazz contemporaneo. Un mondo affascinante, in cui si incontrano jazz, soul, funk, hip-hop, elettronica e spoken word.
In particolare giovedì 21 di scena il batterista Makaya McCraven produttore e batterista emergente, definito da Down Beat come uno dei più influenti musicisti del prossimo decennio.
In effetti Makaya McCraven, figlio di Stephen McCraven, batterista di Archie Shepp tra gli altri, è tutto questo e molto di più: americano di Parigi classe ‘83, iniziato alla musica jazz dal padre, cresciuto tra gli altri con la formazione derivante dal già citato Shepp, inizia a collaborare con artisti del calibro di Kris Delmhorst e gli Apollo Sunshine, prima di stabilire un suo complesso con il bassista Junius Paul, il chitarrista Matt Gold e il trombettista già attivo autonomamente Marquis Hill, formazione con cui si è presentato alla Casa del Jazz, per un concerto che ha soddisfatto appieno le più rosee aspettative.
 La band inizia a suonare senza presentare alcunché; McCraven è uomo di poche parole, e non si concede quasi mai pause, tranne una ogni tre pezzi circa per presentare e ringraziare la sua band e per annunciare – qualche volta – il nome del prossimo pezzo. Per il resto è stata una serata di pura musica ed energia: non solo di McCraven, il cui vigore era pari alla sua abilità – mai sentito un batterista che suonasse per circa un’ora e mezza, senza mai smettere di percuotere pelli e piatti con tanta ininterrotta energia – ma anche di tutti gli altri musicisti, che durante il concerto si cimentavano con diversi tipi di percussioni. Altra nota di merito va alla varietà di brani suonati: si passa da pezzi ormai diventati standard del jazz, come “Autumn in New York”, Frank’s Tune” di Frank Strzier o “A Slice of the Top” a pezzi originali di McCraven, come “In These Times”, “The Bounce!” e un inedito tratto dal suo prossimo album in uscita a settembre.
La band inizia a suonare senza presentare alcunché; McCraven è uomo di poche parole, e non si concede quasi mai pause, tranne una ogni tre pezzi circa per presentare e ringraziare la sua band e per annunciare – qualche volta – il nome del prossimo pezzo. Per il resto è stata una serata di pura musica ed energia: non solo di McCraven, il cui vigore era pari alla sua abilità – mai sentito un batterista che suonasse per circa un’ora e mezza, senza mai smettere di percuotere pelli e piatti con tanta ininterrotta energia – ma anche di tutti gli altri musicisti, che durante il concerto si cimentavano con diversi tipi di percussioni. Altra nota di merito va alla varietà di brani suonati: si passa da pezzi ormai diventati standard del jazz, come “Autumn in New York”, Frank’s Tune” di Frank Strzier o “A Slice of the Top” a pezzi originali di McCraven, come “In These Times”, “The Bounce!” e un inedito tratto dal suo prossimo album in uscita a settembre.
Riguardo alla performance dell’”archeologo del beat”, (come si definisce lo stesso batterista), essa nel suo complesso si basava su due punti di forza: la leadership di McCraven, che con grande forza e precisione trascinava sia i suoi musicisti sia il pubblico durante le esibizioni, nonché l’approccio inedito da DJ dello stesso McCraven specie nelle sue composizioni: infatti in gran parte dei brani veniva ripetuto un leitmotif al basso, che diventava il vero centro motore della situazione, attorno a cui venivano aggiunte gradualmente la batteria, la chitarra, la tromba e varie percussioni; in seguito si passava ad una graduale elaborazione dei motiv aggiunti alla linea di basso che, rimanendo sempre costante, forniva all’ascoltatore un filo rosso che legava le varie elaborazioni e improvvisazioni e un senso di familiarità all’interno della composizione. Quest’operazione coniuga a mio parere il processo creativo di numerose canzoni house, dance ed EDM con l’improvvisazione tipica del jazz: inoltre l’enfasi posta sulle percussioni nel concerto è caratteristica anche dei beat dei brani hip hop, dove il ritmo della base è cruciale per orientare il rapper durante il brano in questione.
 Il 23 la Casa de Jazz proponeva un quesito intrigante: può la sofisticata poetica di un Pieranunzi coniugarsi con l’incredibile carica energetica di Antonello Salis? In altri termini possono coesistere due musicisti stilisticamente quasi all’opposto, uniti solo dalla grande passione e dedizione alla musica? Ciò perché il concerto in programma prevedeva per l’appunto un duo di piano composto da questi due artisti che mai avevano avuto modo di incontrarsi sul palco. Grande attesa, quindi, e non a caso grande affluenza di pubblico…ripagato da un concerto sicuramente interessante. Seduti l’uno di fronte all’altro i due hanno suonato per circa un’ora e mezza sciorinando un’intesa che non era facile prevedere. Spesso si partiva da un tema che veniva sviluppato, esaminato, sviscerato fin nelle sue più intime pieghe e quindi riproposto in una veste totalmente diversa che traeva nelle capacità improvvisative dei due nuova linfa vitale. E questa volta non si può dire che l’uno si sia piegato alle esigenze dell’altro in quanto ambedue hanno sviluppato appieno le proprie tematiche che finivano con l’incontrarsi su un terreno ben frequentato sia da Enrico sia da Antonello: l’improvvisazione pura o forse meglio la capacità di creare musica strada facendo. In effetti, oltre che partire da un dato tema, i due si sono spesso avventurati anche sul foglio bianco, vale a dire cominciando a suonare senza conoscere il punto di approdo, con una maestria che solo pochi posseggono.
Il 23 la Casa de Jazz proponeva un quesito intrigante: può la sofisticata poetica di un Pieranunzi coniugarsi con l’incredibile carica energetica di Antonello Salis? In altri termini possono coesistere due musicisti stilisticamente quasi all’opposto, uniti solo dalla grande passione e dedizione alla musica? Ciò perché il concerto in programma prevedeva per l’appunto un duo di piano composto da questi due artisti che mai avevano avuto modo di incontrarsi sul palco. Grande attesa, quindi, e non a caso grande affluenza di pubblico…ripagato da un concerto sicuramente interessante. Seduti l’uno di fronte all’altro i due hanno suonato per circa un’ora e mezza sciorinando un’intesa che non era facile prevedere. Spesso si partiva da un tema che veniva sviluppato, esaminato, sviscerato fin nelle sue più intime pieghe e quindi riproposto in una veste totalmente diversa che traeva nelle capacità improvvisative dei due nuova linfa vitale. E questa volta non si può dire che l’uno si sia piegato alle esigenze dell’altro in quanto ambedue hanno sviluppato appieno le proprie tematiche che finivano con l’incontrarsi su un terreno ben frequentato sia da Enrico sia da Antonello: l’improvvisazione pura o forse meglio la capacità di creare musica strada facendo. In effetti, oltre che partire da un dato tema, i due si sono spesso avventurati anche sul foglio bianco, vale a dire cominciando a suonare senza conoscere il punto di approdo, con una maestria che solo pochi posseggono.
Ed è stato lo stesso Pieranunzi a svelare come la musica eseguita sia stata tutta improvvisata. Tra i brani eseguiti, da ricordare una sempre suggestiva “Moon River” di Henry Mancini, una “Well, you needn’t” di Thelonious Monk che nulla ha perso dell’originario fascino, una memorabile versione di “Naima” di John Coltrane, nonché un sentito omaggio ad Ennio Morricone con “Il clan dei siciliani”.
E a conferma della splendida atmosfera che si respirava sul palco, Pieranunzi è apparso particolarmente in forma anche quando ha intrattenuto il pubblico con sagaci commenti sulla “strumentazione” di Antonello (tra cui una latta di tonno Callipo) e con un sentito ricordo della sua esperienza a fianco di Morricone.
Ed eccoci alla serata di lunedì 25. Mi reco alla Casa del Jazz al solito orario e noto immediatamente una sorta di novità: una fila interminabile di auto parcheggiate sul marciapiedi a indicare una straordinaria affluenza di pubblico. Cosa che verifico subito: i giardini della Casa del Jazz sono letteralmente invasi da una massa di giovani festanti in attesa dell’evento: il concerto di “Sons of Kemet”.
La band inglese è giunta a Roma preceduta da una formidabile campagna di stampa che la indicava come una delle massime espressioni del cosiddetto nu jazz; a richiamare il pubblico anche la considerazione che si trattava dell’ultima tournée del gruppo che nei prossimi mesi dovrebbe sciogliersi. Insomma tutto pronto per un grande successo di pubblico… che puntualmente è arrivato.
 Guidati dal funambolico sassofonista Shabaka Hutchings, il quartetto (completato dal basso tuba di Theon Cross e ben due batterie nelle mani di Eddie Hick e della giovanissima e bravissima Jas Keyser in sostituzione di Tom Skinner in tour con Thom Yorke) ha sciorinato una musica di grande intensità, basata sul fitto tappeto ritmico intessuto dalle due batterie su cui svolgevano i loro interventi i due fiati. In particolare il sax del leader, spesso effettato con delay o reverberi, non disegnava lunghe linee melodiche ma intonava frasi ritmiche e frammenti melodici ripetuti più volte mentre il basso tuba contribuiva in maniera determinante a completare il tessuto ritmico delle due batterie. Il tutto ‘condito’ da un volume molto, molto elevato a creare una musica che raggiungesse l’obiettivo di portare al massimo l’eccitazione dell’uditorio e di coinvolgerlo in una sorta di rito collettivo in cui i richiami all’Africa erano ben evidenti. Si tenga presente che il concerto si è sviluppato su una linea di continuità ininterrotta tranne due momenti in cui Shabaka Hutchings ha imbracciato un flauto di legno per intonare una splendida melodia di origine africana e il tubista si è espresso in solitudine. Obiettivo raggiunto? Quanto al coinvolgimento direi proprio di sì… anche se non al cento per cento. Nel senso che, ad esempio, il vostro cronista non si è sentito coinvolto dalla musica dei Sons of Kemet. Ed il perché non è difficile da spiegare: avendo avuto la fortuna di ascoltare anche dal vivo alcuni dei più grandi musicisti – per intenderci quelli che hanno scritto davvero la storia del jazz – non è facile lasciarsi impressionare da qualcuno che pur suonando bene non raggiunge quei vertici cui prima si faceva riferimento. Quanto ai messaggi che questa musica così aggressiva intende veicolare, ci viene in soccorso lo stesso Shabaka Hutchings affermando che “Black to the Future (ultimo album del gruppo) è un poema sonoro di invocazione del potere, del ricordo e della guarigione. Raffigura un movimento, quello della ridefinizione e riaffermazione di cosa significa lottare per il black power”. Ma anche sotto questo aspetto non riusciamo a vedere una grande novità dal momento che il jazz come musica di protesta non è certo cosa di oggi.
Guidati dal funambolico sassofonista Shabaka Hutchings, il quartetto (completato dal basso tuba di Theon Cross e ben due batterie nelle mani di Eddie Hick e della giovanissima e bravissima Jas Keyser in sostituzione di Tom Skinner in tour con Thom Yorke) ha sciorinato una musica di grande intensità, basata sul fitto tappeto ritmico intessuto dalle due batterie su cui svolgevano i loro interventi i due fiati. In particolare il sax del leader, spesso effettato con delay o reverberi, non disegnava lunghe linee melodiche ma intonava frasi ritmiche e frammenti melodici ripetuti più volte mentre il basso tuba contribuiva in maniera determinante a completare il tessuto ritmico delle due batterie. Il tutto ‘condito’ da un volume molto, molto elevato a creare una musica che raggiungesse l’obiettivo di portare al massimo l’eccitazione dell’uditorio e di coinvolgerlo in una sorta di rito collettivo in cui i richiami all’Africa erano ben evidenti. Si tenga presente che il concerto si è sviluppato su una linea di continuità ininterrotta tranne due momenti in cui Shabaka Hutchings ha imbracciato un flauto di legno per intonare una splendida melodia di origine africana e il tubista si è espresso in solitudine. Obiettivo raggiunto? Quanto al coinvolgimento direi proprio di sì… anche se non al cento per cento. Nel senso che, ad esempio, il vostro cronista non si è sentito coinvolto dalla musica dei Sons of Kemet. Ed il perché non è difficile da spiegare: avendo avuto la fortuna di ascoltare anche dal vivo alcuni dei più grandi musicisti – per intenderci quelli che hanno scritto davvero la storia del jazz – non è facile lasciarsi impressionare da qualcuno che pur suonando bene non raggiunge quei vertici cui prima si faceva riferimento. Quanto ai messaggi che questa musica così aggressiva intende veicolare, ci viene in soccorso lo stesso Shabaka Hutchings affermando che “Black to the Future (ultimo album del gruppo) è un poema sonoro di invocazione del potere, del ricordo e della guarigione. Raffigura un movimento, quello della ridefinizione e riaffermazione di cosa significa lottare per il black power”. Ma anche sotto questo aspetto non riusciamo a vedere una grande novità dal momento che il jazz come musica di protesta non è certo cosa di oggi.
Quindi ben vengano gruppi del genere ma se mi si dice che questa è la nuova strada che il jazz si avvia a percorrere devo confessare che il jazz dei prossimi anni non mi avrà tra i suoi massimi sostenitori. Ovviamente la cosa poco importerà ai più ma a mio avviso il ruolo di un cronista-critico non è quello di affermare sempre che tutto va bene, ma anche di esprimere qualche perplessità, sempre motivandole, è ovvio.
 Smaltita la sbornia dell’“Afrofuturism” (così viene definita la musica di Sons of Kemet da chi se ne intende), ecco il 27 sempre alla Casa del Jazz, la giovane e brava sassofonista Nubya Garcia, reduce dallo straordinario successo ottenuto dal suo primo album “Source” su etichetta Concord. Bel concerto questo con una musica sì proiettata verso il futuro ma sempre memore di ciò che il jazz ha rappresentato fino ad oggi. Anche la Garcia viene fuori dalla tumultuosa scena londinese di questi ultimi anni affermandosi passo dopo passo come una delle strumentiste più preparate e fantasiose del pur vasto panorama. In effetti Nubya frequenta il sax da tanti anni riuscendo così a raggiungere una tecnica tutt’altro che banale, una tecnica comunque sempre messa al servizio dell’espressività e di una concezione musicale fortemente inclusiva dal momento che nelle sue performances sono ben riscontrabili echi di jazz spirituale, dub, reggae, ritmi latini e suoni africani. Così il concerto si è sviluppato lungo modalità contrassegnate da notevoli assolo non solo della leader ma anche del pianista-tastierista Alastair MacSween mentre la sezione ritmica (Daniel Casimir contrabbasso e Sam Jones batteria) forniva un supporto sempre preciso, puntuale, propositivo. E a proposito di ritmo, da sottolineare la sensualità dei ritmi colombiani rinverdita dalla Nubya nella riproposizione di uno dei brani più riusciti dell’intera serata, “La Cumbia Me Está Llamando”, scritta con il trio colombiano al femminile “La Perla”.
Smaltita la sbornia dell’“Afrofuturism” (così viene definita la musica di Sons of Kemet da chi se ne intende), ecco il 27 sempre alla Casa del Jazz, la giovane e brava sassofonista Nubya Garcia, reduce dallo straordinario successo ottenuto dal suo primo album “Source” su etichetta Concord. Bel concerto questo con una musica sì proiettata verso il futuro ma sempre memore di ciò che il jazz ha rappresentato fino ad oggi. Anche la Garcia viene fuori dalla tumultuosa scena londinese di questi ultimi anni affermandosi passo dopo passo come una delle strumentiste più preparate e fantasiose del pur vasto panorama. In effetti Nubya frequenta il sax da tanti anni riuscendo così a raggiungere una tecnica tutt’altro che banale, una tecnica comunque sempre messa al servizio dell’espressività e di una concezione musicale fortemente inclusiva dal momento che nelle sue performances sono ben riscontrabili echi di jazz spirituale, dub, reggae, ritmi latini e suoni africani. Così il concerto si è sviluppato lungo modalità contrassegnate da notevoli assolo non solo della leader ma anche del pianista-tastierista Alastair MacSween mentre la sezione ritmica (Daniel Casimir contrabbasso e Sam Jones batteria) forniva un supporto sempre preciso, puntuale, propositivo. E a proposito di ritmo, da sottolineare la sensualità dei ritmi colombiani rinverdita dalla Nubya nella riproposizione di uno dei brani più riusciti dell’intera serata, “La Cumbia Me Está Llamando”, scritta con il trio colombiano al femminile “La Perla”.
Gerlando & Beny Gatto
 Si diceva, un punto di unione, uno scambio, un passaggio. Alain Delon, perché cinematografico e jazz. Cinematografico – icona assoluta adorata dal pubblico, in particolare da un certo pubblico, piuttosto disprezzata dalla critica, cosa che però non gli ha mai fatto perdere il sonno. E jazz – irriverente, sfrontato, impassibile e naturalmente bello. Qui, si diceva, con l’argento vivo del personaggio che interpreta cullato dalle note del compositore dei poi Callaghan, qualche anno più tardi assieme a Charles Bronson e quella loro straordinaria complicità con il sound funky e perentorio composée par François de Roubaix. E poi L’inferno, anch’esso cinematografico e jazz. Cinematografico – non serve neanche dirlo e jazz – nato come endecasillabo, piuttosto formale, rigido e rigoroso, nella versione della colonna sonora in differita di Graziano, apre con spunti di turbolenze armoniche esaltate dalla tecnica sopraffina dell’esecutore, piani e forti che nelle didascalie originali della pellicola Dante stesso faticherebbe a riconoscere ed improvvisazioni sempre piuttosto sulfuree e definitive, così come la tragica sorte di coloro che percorrono quei gironi a cono rovesciato.
Si diceva, un punto di unione, uno scambio, un passaggio. Alain Delon, perché cinematografico e jazz. Cinematografico – icona assoluta adorata dal pubblico, in particolare da un certo pubblico, piuttosto disprezzata dalla critica, cosa che però non gli ha mai fatto perdere il sonno. E jazz – irriverente, sfrontato, impassibile e naturalmente bello. Qui, si diceva, con l’argento vivo del personaggio che interpreta cullato dalle note del compositore dei poi Callaghan, qualche anno più tardi assieme a Charles Bronson e quella loro straordinaria complicità con il sound funky e perentorio composée par François de Roubaix. E poi L’inferno, anch’esso cinematografico e jazz. Cinematografico – non serve neanche dirlo e jazz – nato come endecasillabo, piuttosto formale, rigido e rigoroso, nella versione della colonna sonora in differita di Graziano, apre con spunti di turbolenze armoniche esaltate dalla tecnica sopraffina dell’esecutore, piani e forti che nelle didascalie originali della pellicola Dante stesso faticherebbe a riconoscere ed improvvisazioni sempre piuttosto sulfuree e definitive, così come la tragica sorte di coloro che percorrono quei gironi a cono rovesciato.
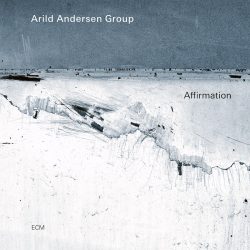 Arild Andersen Group – “Affirmation” – ECM
Arild Andersen Group – “Affirmation” – ECM Onur Aymergen Quintet – “Lunar” – Losen
Onur Aymergen Quintet – “Lunar” – Losen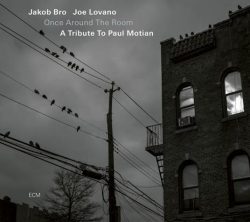 Jakob Bro, Joe Lovano –“Once Around The Room” – A Tribute to Paul Motian” – ECM
Jakob Bro, Joe Lovano –“Once Around The Room” – A Tribute to Paul Motian” – ECM Eik Trio – “Eik Trio” – Losen
Eik Trio – “Eik Trio” – Losen Mette Henriette – “Drifting” – ECM
Mette Henriette – “Drifting” – ECM Anders Jormin, Lena Willemark – “Pasado en claro” – ECM
Anders Jormin, Lena Willemark – “Pasado en claro” – ECM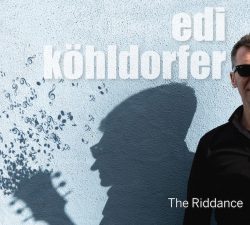 Edi Köhldorfer – “The Riddance” – Ats Records
Edi Köhldorfer – “The Riddance” – Ats Records Benjamin Lackner – “Last decade” – ECM
Benjamin Lackner – “Last decade” – ECM Ieremy Lirola – “Mock the Borders” –
Ieremy Lirola – “Mock the Borders” –  Stephan Micus – “Thunder” – ECM
Stephan Micus – “Thunder” – ECM Arvo Pärt – “Tintinnabuli” – Billant Corners
Arvo Pärt – “Tintinnabuli” – Billant Corners Sebastian Rochford, Kit Downes – “A Short Diary” – ECM
Sebastian Rochford, Kit Downes – “A Short Diary” – ECM Rubber Soul Quartet – “Something” – Losen
Rubber Soul Quartet – “Something” – Losen Salon Odjilà – “TangoRomaBalkanJazz” – ATS Records
Salon Odjilà – “TangoRomaBalkanJazz” – ATS Records Solis String Quartet & Sarah Jane Morris – “All You Need Is Love” – Irma
Solis String Quartet & Sarah Jane Morris – “All You Need Is Love” – Irma È proprio vero: le vecchie abitudini sono dure a morire… E così, in maniera a dir vero inaspettata, spunta questa nuovissima raccolta di tracce sonore svolte ed elaborate dagli immaginifici fratelli Fabris, Franco alle tastiere e Maurizio alle percussioni, integrati, per volere di sincronico destino, dal polistrumentista Gianni Iardino, nonché dal tornito e solido basso del giovanissimo Pietro Liut. Come d’abitudine propria al navigato Franco, non a caso forgiatosi anche sui campi di calcio, anche in questa circostanza è stata data piena preminenza al gioco di squadra collettivo, in un contesto di perfetta parità all’interno dei singoli ruoli esecutivi, per quanto sei degli otto brani incisi siano nati dalla felice vena compositiva di Gianni Iardino, pianista d’estrazione accademica, ma saxofonista per immagamento timbrico, come ben si può cogliere dall’ascolto di questa manciata di acquarelli timbrico-armonici. Una musica, questa, veramente posta in (in)fusione), ove le sensazioni speziate delle sonorità riportano ad un mélange ricco di rimandi, ispirazioni, citazioni appena accennate, fondali sonori che in parte inducono alla nostalgia per gusti antichi, all’improvviso riaffiorati per via retronasale, di quelli celati negli anfratti più reconditi di memorie archiviate, ma mai del tutto sopite. Tutto può accadere, e tutto accade, entro le mura all’apparenza ordinate di questi brani. La celebrazione della post-post-modernità in musica? L’amore per il bricolage di generi, stili e prassi organizzative? Forse, può darsi: ma lungi dall’essere una musica preparata “a tavolino”, questi brani procedono lisci e senza alcuna forzatura proprio al pari d’una suadente e profumata tisana dai risvolti concilianti e dagli intenti lenitivi.
È proprio vero: le vecchie abitudini sono dure a morire… E così, in maniera a dir vero inaspettata, spunta questa nuovissima raccolta di tracce sonore svolte ed elaborate dagli immaginifici fratelli Fabris, Franco alle tastiere e Maurizio alle percussioni, integrati, per volere di sincronico destino, dal polistrumentista Gianni Iardino, nonché dal tornito e solido basso del giovanissimo Pietro Liut. Come d’abitudine propria al navigato Franco, non a caso forgiatosi anche sui campi di calcio, anche in questa circostanza è stata data piena preminenza al gioco di squadra collettivo, in un contesto di perfetta parità all’interno dei singoli ruoli esecutivi, per quanto sei degli otto brani incisi siano nati dalla felice vena compositiva di Gianni Iardino, pianista d’estrazione accademica, ma saxofonista per immagamento timbrico, come ben si può cogliere dall’ascolto di questa manciata di acquarelli timbrico-armonici. Una musica, questa, veramente posta in (in)fusione), ove le sensazioni speziate delle sonorità riportano ad un mélange ricco di rimandi, ispirazioni, citazioni appena accennate, fondali sonori che in parte inducono alla nostalgia per gusti antichi, all’improvviso riaffiorati per via retronasale, di quelli celati negli anfratti più reconditi di memorie archiviate, ma mai del tutto sopite. Tutto può accadere, e tutto accade, entro le mura all’apparenza ordinate di questi brani. La celebrazione della post-post-modernità in musica? L’amore per il bricolage di generi, stili e prassi organizzative? Forse, può darsi: ma lungi dall’essere una musica preparata “a tavolino”, questi brani procedono lisci e senza alcuna forzatura proprio al pari d’una suadente e profumata tisana dai risvolti concilianti e dagli intenti lenitivi. E’ come se alla storia piacesse … shakerare e sperimentare, nel proprio scorrere, nuovi cocktail. L’alchimia è avvenuta con la musica del Brasile dove la cultura dei conquistadores portoghesi, mixata con “spezie” locali, ha plasmato uno specifico heritage generando forme come choro, maxixe e samba, così “distanti” da fado e fandango, a volerne sottolineare la distanza dall’eredità culturale della madrepatria. Con la quale peraltro il rapporto è continuato ad esistere e vive tuttora in Europa, Italia compresa, a causa dell’approdarvi di artisti brasiliani in analogia ad altri colleghi ispanoamericani. Canto Estrangeiro, album della Encore Music a firma della vocalist Tatiana Valle e del pianista Giovanni Guaccero, è una tela sonora e canora del Brasile fuori dal Brasile, un paese-doppio, un’immagine riflessa richiamata e ricamata da Guaccero sui versi di Luis Elòi Stein a partire da Lingua Minha che precede una dozzina di splendide composizioni. Ne ha scritto la musica da “straniero” che ha assimilato Jobim, de Hollanda, Nascimento, il poeta de Moraes….per un viaggio “di ritorno” verso il Rio Grande do Sul, dal Tevere, il cui “voucher” è un compact carioca curato in ogni particolare. Vi hanno partecipato il batterista Bruno Marcozzi, la flautista Barbara Piperno, il chitarrista-mandolinista Marco Ruviaro, con ospiti Giancarlo Bianchetti alla chitarra elettrica, Henrique Cazes al cavaquinho, Fred Martins al canto, Carlos Cèsar Motta alle percussioni e Francesco Maria Parazzoli al cello. Nell’insieme il Brasile di Guaccero-Stein e della Valle non risulta oleografico né saporifero di vintage bensì è partecipe dell’oggi in ruoli di protagonista fra le nuove correnti della musica tropicale ad influsso jazz che spirano forti oltre l’Atlantico.
E’ come se alla storia piacesse … shakerare e sperimentare, nel proprio scorrere, nuovi cocktail. L’alchimia è avvenuta con la musica del Brasile dove la cultura dei conquistadores portoghesi, mixata con “spezie” locali, ha plasmato uno specifico heritage generando forme come choro, maxixe e samba, così “distanti” da fado e fandango, a volerne sottolineare la distanza dall’eredità culturale della madrepatria. Con la quale peraltro il rapporto è continuato ad esistere e vive tuttora in Europa, Italia compresa, a causa dell’approdarvi di artisti brasiliani in analogia ad altri colleghi ispanoamericani. Canto Estrangeiro, album della Encore Music a firma della vocalist Tatiana Valle e del pianista Giovanni Guaccero, è una tela sonora e canora del Brasile fuori dal Brasile, un paese-doppio, un’immagine riflessa richiamata e ricamata da Guaccero sui versi di Luis Elòi Stein a partire da Lingua Minha che precede una dozzina di splendide composizioni. Ne ha scritto la musica da “straniero” che ha assimilato Jobim, de Hollanda, Nascimento, il poeta de Moraes….per un viaggio “di ritorno” verso il Rio Grande do Sul, dal Tevere, il cui “voucher” è un compact carioca curato in ogni particolare. Vi hanno partecipato il batterista Bruno Marcozzi, la flautista Barbara Piperno, il chitarrista-mandolinista Marco Ruviaro, con ospiti Giancarlo Bianchetti alla chitarra elettrica, Henrique Cazes al cavaquinho, Fred Martins al canto, Carlos Cèsar Motta alle percussioni e Francesco Maria Parazzoli al cello. Nell’insieme il Brasile di Guaccero-Stein e della Valle non risulta oleografico né saporifero di vintage bensì è partecipe dell’oggi in ruoli di protagonista fra le nuove correnti della musica tropicale ad influsso jazz che spirano forti oltre l’Atlantico. Ricorda a momenti le elucubrazioni fonetiche di Bobby McFerrin l’album di Aiòn Me Vs Myself (Giorgio Pinardi) edito da Alterjinga, per lo scavo, a livello di vocalizzazione, effettuato su realtà musicali remote. Non cambia l’approccio sia che provengano dall’Africa della tribù Dagara in “Yelbongura” o dal gaelico in “Scriob” o dal danese arcaico di “Hyggelig”. C’è, in genere, una “manipolazione” dei materiali musicali trattati – e questo accade ancora in “Leys” – che forse lo stesso Demetrio Stratos oggi non avrebbe disdegnato nelle proprie “investigazioni” tendenti a far “cantare la voce”. Il lavoro continua con “Waldeinsamkeit”, impronunciabile termine tedesco che non ha una diretta traduzione in inglese e che vuol dire essere in connessione con la natura (e con la musica) e con “Rwty” (Sfinge in antico egiziano) a riprova di come, in musica, la ricerca etimologica si possa coniugare con quella etnologica. Chiudono l’album il desertico “Kamtar” quindi “aPHaSIa” (stesso significato in italiano) e “Nèkya” ovverossia la discesa agli inferi dei greci, detta in termini psicanalitici il processo younghiano di scoperta dell’inconscio.
Ricorda a momenti le elucubrazioni fonetiche di Bobby McFerrin l’album di Aiòn Me Vs Myself (Giorgio Pinardi) edito da Alterjinga, per lo scavo, a livello di vocalizzazione, effettuato su realtà musicali remote. Non cambia l’approccio sia che provengano dall’Africa della tribù Dagara in “Yelbongura” o dal gaelico in “Scriob” o dal danese arcaico di “Hyggelig”. C’è, in genere, una “manipolazione” dei materiali musicali trattati – e questo accade ancora in “Leys” – che forse lo stesso Demetrio Stratos oggi non avrebbe disdegnato nelle proprie “investigazioni” tendenti a far “cantare la voce”. Il lavoro continua con “Waldeinsamkeit”, impronunciabile termine tedesco che non ha una diretta traduzione in inglese e che vuol dire essere in connessione con la natura (e con la musica) e con “Rwty” (Sfinge in antico egiziano) a riprova di come, in musica, la ricerca etimologica si possa coniugare con quella etnologica. Chiudono l’album il desertico “Kamtar” quindi “aPHaSIa” (stesso significato in italiano) e “Nèkya” ovverossia la discesa agli inferi dei greci, detta in termini psicanalitici il processo younghiano di scoperta dell’inconscio. Il Duende, per Garcia Lorca, è un imprecisato non so che proprio di alcuni toreri, pittori, poeti, musicisti, uno “stile vivo”, “creaciòn en acto”, fluido irresistibile che arriva al pubblico e che, nei “suoni neri” del jazz, è stato da alcuni associato alla Holiday ed a Miles Davis. Il ribattezzare Duende un progetto discografico, come hanno fatto la vocalist Rita Bincoletto, il chitarrista Diego Vio, il percussionista Max Trabucco e l’ospite Anais Drago, violinista, assume l’intento di traslare la cultura flamenca del poeta spagnolo ricercando le relazioni di quel “potere” nel pianeta liquido del Mediterraneo. La loro traversata geOnirica in un ondoso campo largo li porta fino alla Grecia del traditional “Amygdalaki Tsakisa” ed al Medio Oriente di “Isfahan Trip”; quindi, tramite “Desert Way”, eccoli incrociare figure reali (“Isola”) e mitologiche (“Tres Sirenas”). Un lavoro “waterworld” pubblicato da Abeat Records che consta di nove brani in tutto per la maggior parte scritti e/o arrangiati da Bincoletto, Vio e Trabucco, navigatori fra i suoni marini.
Il Duende, per Garcia Lorca, è un imprecisato non so che proprio di alcuni toreri, pittori, poeti, musicisti, uno “stile vivo”, “creaciòn en acto”, fluido irresistibile che arriva al pubblico e che, nei “suoni neri” del jazz, è stato da alcuni associato alla Holiday ed a Miles Davis. Il ribattezzare Duende un progetto discografico, come hanno fatto la vocalist Rita Bincoletto, il chitarrista Diego Vio, il percussionista Max Trabucco e l’ospite Anais Drago, violinista, assume l’intento di traslare la cultura flamenca del poeta spagnolo ricercando le relazioni di quel “potere” nel pianeta liquido del Mediterraneo. La loro traversata geOnirica in un ondoso campo largo li porta fino alla Grecia del traditional “Amygdalaki Tsakisa” ed al Medio Oriente di “Isfahan Trip”; quindi, tramite “Desert Way”, eccoli incrociare figure reali (“Isola”) e mitologiche (“Tres Sirenas”). Un lavoro “waterworld” pubblicato da Abeat Records che consta di nove brani in tutto per la maggior parte scritti e/o arrangiati da Bincoletto, Vio e Trabucco, navigatori fra i suoni marini. Chansons sous les doigts è una selezione di 19 canzoni francesi arrangiate per piano da Vincenzo Caruso che ci ricorda quanto ci siano vicini, in musica, i cugini transalpini. Sono tratteggiate, nell’album Dodicilune, in modo essenziale, scarnificate del testo con focus sulla melodia e l’armonizzazione con sensibilità moderna. Caruso se ne innamorò giovanissimo tramite gli spartiti inviatigli dallo zio Antonio Di Domenico, chansonnier ed editore a Parigi, coltivando nel tempo una passione pianistica che lo avrebbe portato a collaborare a Irma la Douce, la famosa commedia musicata da Marguerite Monnot, di cui ripropone nel disco la “Piccola Suite per Piano”. I temi proposti sono di nomi altisonanti come Henry Salvador (“Syracuse”), Gilbert Becaud (“Quand il est mort le poète”), Georges Brassens (“J’ai rendez vous avec vous”) … L’antologia rappresenta un omaggio alla chanson in cui il pianoforte contende lo scettro di strumento principe alla fisarmonica e, nel contempo, ne offre un’ampia gamma – “Le tango corse”, lo swing di “On est pas là pour se faire engueler”, l’incipit musorgskiano di “Comèdie”, il walzer di “Domani”, il distillar note alla Satie di “Le deserteur” – che ne saggia la tavolozza espressiva e coloristica. Il disco è chiuso da “Après l’ourage” che potrebbe, perche no, commentare un film di Méliès, muto, tanto la narrazione è affidata alle dieci dita, les doigts, sulla tastiera.
Chansons sous les doigts è una selezione di 19 canzoni francesi arrangiate per piano da Vincenzo Caruso che ci ricorda quanto ci siano vicini, in musica, i cugini transalpini. Sono tratteggiate, nell’album Dodicilune, in modo essenziale, scarnificate del testo con focus sulla melodia e l’armonizzazione con sensibilità moderna. Caruso se ne innamorò giovanissimo tramite gli spartiti inviatigli dallo zio Antonio Di Domenico, chansonnier ed editore a Parigi, coltivando nel tempo una passione pianistica che lo avrebbe portato a collaborare a Irma la Douce, la famosa commedia musicata da Marguerite Monnot, di cui ripropone nel disco la “Piccola Suite per Piano”. I temi proposti sono di nomi altisonanti come Henry Salvador (“Syracuse”), Gilbert Becaud (“Quand il est mort le poète”), Georges Brassens (“J’ai rendez vous avec vous”) … L’antologia rappresenta un omaggio alla chanson in cui il pianoforte contende lo scettro di strumento principe alla fisarmonica e, nel contempo, ne offre un’ampia gamma – “Le tango corse”, lo swing di “On est pas là pour se faire engueler”, l’incipit musorgskiano di “Comèdie”, il walzer di “Domani”, il distillar note alla Satie di “Le deserteur” – che ne saggia la tavolozza espressiva e coloristica. Il disco è chiuso da “Après l’ourage” che potrebbe, perche no, commentare un film di Méliès, muto, tanto la narrazione è affidata alle dieci dita, les doigts, sulla tastiera. Ci sono tre quarti d’ora buoni di musica nell’album TMR Tuscany Music Revolution, prodotto dalla label tedesca Aut Records, divisa in sette parti di durata varia che va dai due agli otto minuti. Ne è protagonista l’Improvvisazione con consonanze (II) e minimalismi (III), africanerie (IV) e simil-musica d’oggi (V)… Il parterre artistico internazionale (V. Sutera, v; M. Mazzini, cl; E. Novali, pf; A. Braida, pf; F. Calcagno, cl; A. Bolzoni, g; L. Pissavini, cb; S. Di Benedetto, cb; D. Koutè (perc); S. Scucces (vib.), G. Lattuada (perc); L. D’Erasmo (frame dr); S. Grasso (dr) non “inscena” un ritorno al postfree semmai si pone in termini di attualizzazione e “rivoluzionaria” evoluzione di quell’area creativa che l’ Europa, Italia compresa, ha espresso anche in anni recenti dall’asse anglo-olandese fin giù a scendere sulla cartina geomusicale. Il collettivo è un esempio di interazione democratica e paritaria che, al pari di stormi liberi ma coordinati, delinea impreviste dinamie sonore e traiettorie mutaforma, in un fluttuare a volte sincronico altre no comunque ancorato alla struttura dei vari insiemi che si avvicendano.
Ci sono tre quarti d’ora buoni di musica nell’album TMR Tuscany Music Revolution, prodotto dalla label tedesca Aut Records, divisa in sette parti di durata varia che va dai due agli otto minuti. Ne è protagonista l’Improvvisazione con consonanze (II) e minimalismi (III), africanerie (IV) e simil-musica d’oggi (V)… Il parterre artistico internazionale (V. Sutera, v; M. Mazzini, cl; E. Novali, pf; A. Braida, pf; F. Calcagno, cl; A. Bolzoni, g; L. Pissavini, cb; S. Di Benedetto, cb; D. Koutè (perc); S. Scucces (vib.), G. Lattuada (perc); L. D’Erasmo (frame dr); S. Grasso (dr) non “inscena” un ritorno al postfree semmai si pone in termini di attualizzazione e “rivoluzionaria” evoluzione di quell’area creativa che l’ Europa, Italia compresa, ha espresso anche in anni recenti dall’asse anglo-olandese fin giù a scendere sulla cartina geomusicale. Il collettivo è un esempio di interazione democratica e paritaria che, al pari di stormi liberi ma coordinati, delinea impreviste dinamie sonore e traiettorie mutaforma, in un fluttuare a volte sincronico altre no comunque ancorato alla struttura dei vari insiemi che si avvicendano. Il chitarrismo manouche, quello praticato a livelli alti di nomadismo dei polpastrelli, può talora lasciar trasparire una certa patina di “monadismo”, per così dire, quando vi si riscontra unità inclusiva del connotato stilistico di base. E’ il caso dell’album Gypsy Jazz Style di Pietro Lazazzara (Stradivarius), seconda uscita discografica a sua firma, con una dozzina di inediti eseguiti all’insegna della convergenza di varietà e contaminazioni. L’ ensemble annovera Antonio Solazzo al basso, Francesco Clemente e Sabrina Loforese al volino, Maria Pia Lazazzara al violoncello, Luigi Vania alla viola, Nicoletta Di Sabato al flauto e Giuseppe Magistro al tamburello. Campeggia sullo sfondo, sin dal primo brano “Mister Swing”, l’ologramma di Django. Poi la musica, strada facendo, si fa intima in “Precious”, intinta di classico in “La via di Pia”, melò in “Walk with Me”, walzer notturno in “The Tale of the Moon”, flamenco in “La tela di Picasso”, tarant(ell)a in “Puglia”, moderato swing in “Blue Night”, sostenuto in “La joie de vivre”, è balcanica in “Circus”, tutta coracon in “Spanish Boulevard”, infine tripudio di note in “Impro in D Minor” con il gruppo che si trasforma in Gypsy Jazz Style Kings.
Il chitarrismo manouche, quello praticato a livelli alti di nomadismo dei polpastrelli, può talora lasciar trasparire una certa patina di “monadismo”, per così dire, quando vi si riscontra unità inclusiva del connotato stilistico di base. E’ il caso dell’album Gypsy Jazz Style di Pietro Lazazzara (Stradivarius), seconda uscita discografica a sua firma, con una dozzina di inediti eseguiti all’insegna della convergenza di varietà e contaminazioni. L’ ensemble annovera Antonio Solazzo al basso, Francesco Clemente e Sabrina Loforese al volino, Maria Pia Lazazzara al violoncello, Luigi Vania alla viola, Nicoletta Di Sabato al flauto e Giuseppe Magistro al tamburello. Campeggia sullo sfondo, sin dal primo brano “Mister Swing”, l’ologramma di Django. Poi la musica, strada facendo, si fa intima in “Precious”, intinta di classico in “La via di Pia”, melò in “Walk with Me”, walzer notturno in “The Tale of the Moon”, flamenco in “La tela di Picasso”, tarant(ell)a in “Puglia”, moderato swing in “Blue Night”, sostenuto in “La joie de vivre”, è balcanica in “Circus”, tutta coracon in “Spanish Boulevard”, infine tripudio di note in “Impro in D Minor” con il gruppo che si trasforma in Gypsy Jazz Style Kings. “Voyager” è uno dei brani di punta del secondo album firmato dal batterista Giovanni Angelini dal titolo Freedom Rhythm, otto brani, scritti di proprio pugno, dal groove eclettico che mette assieme jazz funk afro soul e che non disdegna il guardare indietro, fino ai fab ’70. Ovviamente si tratta di un jazzista moderno ma con il piacere di far “viaggiare” la propria musica nello spaziotempo pilotandola da bandleader. Piace pensare che il “ritmo in libertà” sia anche quello del drummer che si svincola, crea, costruisce, si autointerpreta. Ed è infatti la veste di compositore quella che vi rispecchia le qualità di ideatore di strutture compless(iv)e caratterizzate da franca immediatezza e circolarità di un suono plasmato con Vince Abbracciante al piano, Dario Giacovelli al basso, Alberto Parmegiani alla chitarra, Gaetano Partipilo all’alto sax, Giuseppe Todisco alla tromba, Antonio Fallacara al trombone quindi Giovanni Astorino al cello. Ai quali si aggiunge il canto di Simona Severini con la “gemma” di “I Need Your Smile”. La sezione dei tre fiati assume un ruolo energico nello sviluppo dei temi (e nell’alternarsi improvvisativo) dalle linee melodiche che effettivamente rimangono impresse, un po’ tutte, da “Subway” fino a “Unity”, “Release The Monkey”, “Wuelva”, “Compass”, e nel contempo si muovono su scansioni metriche e schemi accordali nient’affatto scontati. Insomma ancora un bel prodotto del catalogo A.Ma Records!
“Voyager” è uno dei brani di punta del secondo album firmato dal batterista Giovanni Angelini dal titolo Freedom Rhythm, otto brani, scritti di proprio pugno, dal groove eclettico che mette assieme jazz funk afro soul e che non disdegna il guardare indietro, fino ai fab ’70. Ovviamente si tratta di un jazzista moderno ma con il piacere di far “viaggiare” la propria musica nello spaziotempo pilotandola da bandleader. Piace pensare che il “ritmo in libertà” sia anche quello del drummer che si svincola, crea, costruisce, si autointerpreta. Ed è infatti la veste di compositore quella che vi rispecchia le qualità di ideatore di strutture compless(iv)e caratterizzate da franca immediatezza e circolarità di un suono plasmato con Vince Abbracciante al piano, Dario Giacovelli al basso, Alberto Parmegiani alla chitarra, Gaetano Partipilo all’alto sax, Giuseppe Todisco alla tromba, Antonio Fallacara al trombone quindi Giovanni Astorino al cello. Ai quali si aggiunge il canto di Simona Severini con la “gemma” di “I Need Your Smile”. La sezione dei tre fiati assume un ruolo energico nello sviluppo dei temi (e nell’alternarsi improvvisativo) dalle linee melodiche che effettivamente rimangono impresse, un po’ tutte, da “Subway” fino a “Unity”, “Release The Monkey”, “Wuelva”, “Compass”, e nel contempo si muovono su scansioni metriche e schemi accordali nient’affatto scontati. Insomma ancora un bel prodotto del catalogo A.Ma Records! Con In Hora Mortis la ricerca musicale del percussionista Massimo Barbiero, ancora una volta al confine fra filosofia e psicanalisi, si ritrova ad investigare, per il tramite del suono inteso come elemento vitale primario, il momento terminale del vivere. Un argomento che da Platone a Epicuro a Freud ha appassionato e arrovellato il pensiero umano antico e moderno. Barbiero lo affronta con gli “strumenti” che gli sono più congeniali e cioè quelli del suo ricco set percussivo. Per l’occasione suddivide l’hora in più momenti temporali gradualizzandola secondo una scala emotiva augmentante che non tradisce pathos mortiferi o pianti greci. La musica “domina” la possibile angoscia, la esorcizza, prende atto che i minuti che preludono all’ultimo atto dell’esistenza sono vita tout court e come tali possono essere vissuti magari riprodotti e sonorizzati da gong campane ritmi… Barbiero materializza così la propria “fantasia di sparizione” (Fagioli) in un disco coraggioso per Il tema che affronta e offre una lettura del tutto originale del fine vita che va ad installarsi in un percorso artistico di sperimentata coerenza culturale.
Con In Hora Mortis la ricerca musicale del percussionista Massimo Barbiero, ancora una volta al confine fra filosofia e psicanalisi, si ritrova ad investigare, per il tramite del suono inteso come elemento vitale primario, il momento terminale del vivere. Un argomento che da Platone a Epicuro a Freud ha appassionato e arrovellato il pensiero umano antico e moderno. Barbiero lo affronta con gli “strumenti” che gli sono più congeniali e cioè quelli del suo ricco set percussivo. Per l’occasione suddivide l’hora in più momenti temporali gradualizzandola secondo una scala emotiva augmentante che non tradisce pathos mortiferi o pianti greci. La musica “domina” la possibile angoscia, la esorcizza, prende atto che i minuti che preludono all’ultimo atto dell’esistenza sono vita tout court e come tali possono essere vissuti magari riprodotti e sonorizzati da gong campane ritmi… Barbiero materializza così la propria “fantasia di sparizione” (Fagioli) in un disco coraggioso per Il tema che affronta e offre una lettura del tutto originale del fine vita che va ad installarsi in un percorso artistico di sperimentata coerenza culturale.




 A dire il vero, dopo il primo melodico Sanremo del ’51, una decisa aura jazz si era avvertita in Nati per la Musica, un programma con Jula De Palma, Quartetto Cetra, Teddy Reno che si avvaleva delle orchestre di ritmi moderni di Gorni Kramer e Lelio Luttazzi, la cui sigla è ascoltabile sul Portale della Canzone Italiana dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi (www.canzone italiana.it/1zlns). Sorella Radio avrebbe dato anche in seguito significativi contributi alla causa jazzistica – si pensi all’uso fatto da Radio1 dello stacco di “Country“ tratto dal cd “My Song” di Jarrett con Garbarek, Danielson e Christensen (ECM, 1977) – ma il copioso materiale di Mamma Rai, con il ricchissimo archivio sonoro ad oggi digitalizzato, meriterebbe di essere approfondito in altra sede. Torniamo allora al come eravamo tramite il cosa guardavamo. Dopo la vittoria di Modugno all’Ariston nel ’58, con una “Nel blu dipinto di blu” a ritmo swing, nell’anno di grazia televisivo 1961 passavano in video le immagini di Moderato Swing che era anche il titolo della sigla di Piero Umiliani. Un biennio ancora per poi sentire il canto e la tromba di Nini Rosso echeggiare in “I ragazzi del jazz”, sigla di Fuori I ’Orchestra, epica trasmissione, per la regia di Lino Procacci, che si avvaleva della direzione musicale dello stesso Umiliani. Si trattava di una rubrica che si occupava “di musica equidistante fra quella leggerissima e quella classica“ (
A dire il vero, dopo il primo melodico Sanremo del ’51, una decisa aura jazz si era avvertita in Nati per la Musica, un programma con Jula De Palma, Quartetto Cetra, Teddy Reno che si avvaleva delle orchestre di ritmi moderni di Gorni Kramer e Lelio Luttazzi, la cui sigla è ascoltabile sul Portale della Canzone Italiana dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi (www.canzone italiana.it/1zlns). Sorella Radio avrebbe dato anche in seguito significativi contributi alla causa jazzistica – si pensi all’uso fatto da Radio1 dello stacco di “Country“ tratto dal cd “My Song” di Jarrett con Garbarek, Danielson e Christensen (ECM, 1977) – ma il copioso materiale di Mamma Rai, con il ricchissimo archivio sonoro ad oggi digitalizzato, meriterebbe di essere approfondito in altra sede. Torniamo allora al come eravamo tramite il cosa guardavamo. Dopo la vittoria di Modugno all’Ariston nel ’58, con una “Nel blu dipinto di blu” a ritmo swing, nell’anno di grazia televisivo 1961 passavano in video le immagini di Moderato Swing che era anche il titolo della sigla di Piero Umiliani. Un biennio ancora per poi sentire il canto e la tromba di Nini Rosso echeggiare in “I ragazzi del jazz”, sigla di Fuori I ’Orchestra, epica trasmissione, per la regia di Lino Procacci, che si avvaleva della direzione musicale dello stesso Umiliani. Si trattava di una rubrica che si occupava “di musica equidistante fra quella leggerissima e quella classica“ ( Dal giornalismo d’inchiesta a quello sportivo: nel ’78 era il turno di Jazz Band di Hengel Gualdi a far da “preludio” a Novantesimo minuto, storica rubrica di RaiSport, e come non citare, dal campionario di La Domenica Sportiva, “Dribbling” di Piero Umiliani (1967), “Winning The West” della Buddy Rich Big Band (1973), “Mexico” di Danilo Rea e Roberto Gatto (1985), “Breakout” di Spyro Gira (1991)? Spostandoci alla “pagina” spettacoli, fra il ’76 e il ‘78, Rete 2 dava spazio in Odeon al pianista Keith Emerson (senza Lake e Palmer) in “Odeon Rag” arrangiamento di “Maple Leaf Rag” di Scott Joplin, subentrato in luogo del precedente “Honky Tonk Train Blues”, autore il pianista Meade Lux Lewis. Il filone spettacolistico avrebbe registrato più in là significativi esempi con lo scat di Lucio Dalla con gli Stadio che annuncia Lunedifilm per un buon ventennio fino al 2002 e l’ellingtoniano “Take The A Train” di Strayhorn a fare da intro ai trailer cinematografici assemblati da AnicaFlash per la rassegna delle novità cinematografiche “di stagione”. Si diceva come luogo fertile per la semina tv di suoni jazz da filtrare nelle orecchie dei telespettatori fosse l’informazione. Gettonatissima rimane al riguardo la sigla di Mixer (1980-1996) ovvero “Jazz Carnival” dei brasiliani Azimuth, specialisti del samba doido, genere fusion-funky. Latin come nelle radiocronache di Tutto il calcio minuto per minuto, dove Herb Alpert e Tijuana Brass interpretano “A Taste of Honey”, brano di stampo pop, in repertorio a Beatles e Giganti (“In paese è festa”). Per la tv italiana va ricordato che, fuori dal reticolo giornalistico, si contano altre occasioni più dirette di esposizione per la musica jazz filtrata tramite il piccolo schermo. La Portobello Jazz Band di Lino Patruno “presentava” il programma di Enzo Tortora (cfr. La tana delle sigle in tds.sigletv.net) nel 1978, stesso anno dello sceneggiato in 3 puntate Jazz Band di Pupi Avati, colonna sonora di Amedeo Tommasi, con il clarino di Hengel Gualdi in evidenza nelle sigle di apertura e chiusura, “Jazz Band” e “Swing Time” ; poi ancora Di Jazz in Jazz, programma “dedicato” con relativa sigla a cura dell’Orchestra Big Band della Rai diretta da Giampiero Boneschi e Franco Cerri (
Dal giornalismo d’inchiesta a quello sportivo: nel ’78 era il turno di Jazz Band di Hengel Gualdi a far da “preludio” a Novantesimo minuto, storica rubrica di RaiSport, e come non citare, dal campionario di La Domenica Sportiva, “Dribbling” di Piero Umiliani (1967), “Winning The West” della Buddy Rich Big Band (1973), “Mexico” di Danilo Rea e Roberto Gatto (1985), “Breakout” di Spyro Gira (1991)? Spostandoci alla “pagina” spettacoli, fra il ’76 e il ‘78, Rete 2 dava spazio in Odeon al pianista Keith Emerson (senza Lake e Palmer) in “Odeon Rag” arrangiamento di “Maple Leaf Rag” di Scott Joplin, subentrato in luogo del precedente “Honky Tonk Train Blues”, autore il pianista Meade Lux Lewis. Il filone spettacolistico avrebbe registrato più in là significativi esempi con lo scat di Lucio Dalla con gli Stadio che annuncia Lunedifilm per un buon ventennio fino al 2002 e l’ellingtoniano “Take The A Train” di Strayhorn a fare da intro ai trailer cinematografici assemblati da AnicaFlash per la rassegna delle novità cinematografiche “di stagione”. Si diceva come luogo fertile per la semina tv di suoni jazz da filtrare nelle orecchie dei telespettatori fosse l’informazione. Gettonatissima rimane al riguardo la sigla di Mixer (1980-1996) ovvero “Jazz Carnival” dei brasiliani Azimuth, specialisti del samba doido, genere fusion-funky. Latin come nelle radiocronache di Tutto il calcio minuto per minuto, dove Herb Alpert e Tijuana Brass interpretano “A Taste of Honey”, brano di stampo pop, in repertorio a Beatles e Giganti (“In paese è festa”). Per la tv italiana va ricordato che, fuori dal reticolo giornalistico, si contano altre occasioni più dirette di esposizione per la musica jazz filtrata tramite il piccolo schermo. La Portobello Jazz Band di Lino Patruno “presentava” il programma di Enzo Tortora (cfr. La tana delle sigle in tds.sigletv.net) nel 1978, stesso anno dello sceneggiato in 3 puntate Jazz Band di Pupi Avati, colonna sonora di Amedeo Tommasi, con il clarino di Hengel Gualdi in evidenza nelle sigle di apertura e chiusura, “Jazz Band” e “Swing Time” ; poi ancora Di Jazz in Jazz, programma “dedicato” con relativa sigla a cura dell’Orchestra Big Band della Rai diretta da Giampiero Boneschi e Franco Cerri (
 Il 13, sempre alla Cavea, appuntamento con una vera e propria leggenda del jazz: Herbie Hancock. Spesso si adopera la parola “leggenda” in modo esagerato ma nel caso in questione non v’è dubbio alcuno che il termine sia più che appropriato. Non è questa la sede adatta per sintetizzare un curriculum assolutamente straordinario; basti solo dire che l’artista di Chicago, oggi ottantunenne, ha attraversato, sempre da protagonista, generi e mode come performer, compositore, arrangiatore, produttore, scopritore di talenti, inventore di nuove tendenze, senza mai perdere una coerenza di fondo. A Roma si è presentato alla testa di una band eccezionale completata da Terence Blanchard alla tromba, Lionel Loueke (chitarra), James Genus (basso) e Justin Tyson (batteria). Ascoltare un concerto di Hancock è come rivivere, in sintesi, buona parte della storia del jazz dal momento che questo artista ha sviluppato un’estetica giocata sempre su una sorta di doppio binario: da un canto virtuoso pianista del jazz acustico, dall’altro estimatore se non fondatore del funky elettronico. E questi due aspetti della sua personalità sono apparsi evidenti anche nel concerto romano; così in una prima parte abbiamo ascoltato alcuni classici del jazz come il sempre verde “Footprints” di Wayne Shorter, un altro giovanotto di 89 anni, omaggiato da Hancock che si alternava al piano e alle tastiere non disdegnando un ricorso mai esagerato al vocoder (ma che comunque se non ci fosse stato nulla avrebbe tolto alla validità del concerto). Nella seconda parte Hancock si richiamava al suo coté più funky e chiudeva il concerto con “Chameleon” brano tratto dal celebre album “Head Hunters” del 1973, scatenando l’entusiasmo del pubblico che si è accalcato a ballare sotto il palco.
Il 13, sempre alla Cavea, appuntamento con una vera e propria leggenda del jazz: Herbie Hancock. Spesso si adopera la parola “leggenda” in modo esagerato ma nel caso in questione non v’è dubbio alcuno che il termine sia più che appropriato. Non è questa la sede adatta per sintetizzare un curriculum assolutamente straordinario; basti solo dire che l’artista di Chicago, oggi ottantunenne, ha attraversato, sempre da protagonista, generi e mode come performer, compositore, arrangiatore, produttore, scopritore di talenti, inventore di nuove tendenze, senza mai perdere una coerenza di fondo. A Roma si è presentato alla testa di una band eccezionale completata da Terence Blanchard alla tromba, Lionel Loueke (chitarra), James Genus (basso) e Justin Tyson (batteria). Ascoltare un concerto di Hancock è come rivivere, in sintesi, buona parte della storia del jazz dal momento che questo artista ha sviluppato un’estetica giocata sempre su una sorta di doppio binario: da un canto virtuoso pianista del jazz acustico, dall’altro estimatore se non fondatore del funky elettronico. E questi due aspetti della sua personalità sono apparsi evidenti anche nel concerto romano; così in una prima parte abbiamo ascoltato alcuni classici del jazz come il sempre verde “Footprints” di Wayne Shorter, un altro giovanotto di 89 anni, omaggiato da Hancock che si alternava al piano e alle tastiere non disdegnando un ricorso mai esagerato al vocoder (ma che comunque se non ci fosse stato nulla avrebbe tolto alla validità del concerto). Nella seconda parte Hancock si richiamava al suo coté più funky e chiudeva il concerto con “Chameleon” brano tratto dal celebre album “Head Hunters” del 1973, scatenando l’entusiasmo del pubblico che si è accalcato a ballare sotto il palco. Il 12 luglio una vecchia e cara conoscenza del pubblico romano: John Scofield. Il chitarrista può a ben ragione essere considerato una delle massime espressioni della chitarra jazz degli ultimi decenni. Musicista eclettico, voglioso sempre di sperimentare strade nuove, questa volta si è presentato con un progetto del tutto nuovo, “Yankee Go Home”, con cui torna alle radici del rock americano, riscoprendo classici fra il folk e il rock’n’roll. Accanto a lui Jon Cowherd (pianoforte e tastiere), Vicente Archer (contrabbasso)e Josh Dion (batteria). E’ lo stesso Scofield a illustrare il senso di questo nuovo progetto, non senza elogiare i suoi compagni di viaggio: “L’idea –afferma Scofield – è di coprire successi americani/rock e canzoni folk jazz, più alcuni dei miei brani originali scritti in quel modo. Mi sto riconnettendo con molte delle mie radici Rock ‘n Roll da adolescente, naturalmente colorate dai miei 50 anni di pratica Jazz…. Questi ragazzi sono straordinariamente versatili, altrettanto bravi quando si tratta di suonare in modo interattivo e creativo. Stiamo esplorando rock, funk, country, jazz e musica libera e ci divertiamo moltissimo. Sono entusiasta di questa collaborazione”. Risultato raggiunto? Assolutamente sì; il repertorio, comprendente brani tra gli altri di Bob Dylan, Neil Young, Grateful Dead, B.B. King, Buddy Holly, viene declinato attraverso quella maestria strumentale che ben conosciamo oramai da tanti anni. Scofield è sempre lì a tessere le fila del discorso, con un solismo preciso, elegante, raffinato mai soverchiante cosicché tutti i suoi compagni di viaggio hanno la possibilità di mettersi in luce. I vari pezzi vengono riletti alla luce di quelle esperienze cui lo stesso Scofield faceva riferimento ridando loro una sorta di nuova linfa e il pubblico dimostra di apprezzare con lunghi appalusi a scena aperta. Immancabile il bis: un coinvolgente blues che evidenzia come Scofield rimanga solidamente ancorato anche alle radici della musica afro-americana.
Il 12 luglio una vecchia e cara conoscenza del pubblico romano: John Scofield. Il chitarrista può a ben ragione essere considerato una delle massime espressioni della chitarra jazz degli ultimi decenni. Musicista eclettico, voglioso sempre di sperimentare strade nuove, questa volta si è presentato con un progetto del tutto nuovo, “Yankee Go Home”, con cui torna alle radici del rock americano, riscoprendo classici fra il folk e il rock’n’roll. Accanto a lui Jon Cowherd (pianoforte e tastiere), Vicente Archer (contrabbasso)e Josh Dion (batteria). E’ lo stesso Scofield a illustrare il senso di questo nuovo progetto, non senza elogiare i suoi compagni di viaggio: “L’idea –afferma Scofield – è di coprire successi americani/rock e canzoni folk jazz, più alcuni dei miei brani originali scritti in quel modo. Mi sto riconnettendo con molte delle mie radici Rock ‘n Roll da adolescente, naturalmente colorate dai miei 50 anni di pratica Jazz…. Questi ragazzi sono straordinariamente versatili, altrettanto bravi quando si tratta di suonare in modo interattivo e creativo. Stiamo esplorando rock, funk, country, jazz e musica libera e ci divertiamo moltissimo. Sono entusiasta di questa collaborazione”. Risultato raggiunto? Assolutamente sì; il repertorio, comprendente brani tra gli altri di Bob Dylan, Neil Young, Grateful Dead, B.B. King, Buddy Holly, viene declinato attraverso quella maestria strumentale che ben conosciamo oramai da tanti anni. Scofield è sempre lì a tessere le fila del discorso, con un solismo preciso, elegante, raffinato mai soverchiante cosicché tutti i suoi compagni di viaggio hanno la possibilità di mettersi in luce. I vari pezzi vengono riletti alla luce di quelle esperienze cui lo stesso Scofield faceva riferimento ridando loro una sorta di nuova linfa e il pubblico dimostra di apprezzare con lunghi appalusi a scena aperta. Immancabile il bis: un coinvolgente blues che evidenzia come Scofield rimanga solidamente ancorato anche alle radici della musica afro-americana. La band inizia a suonare senza presentare alcunché; McCraven è uomo di poche parole, e non si concede quasi mai pause, tranne una ogni tre pezzi circa per presentare e ringraziare la sua band e per annunciare – qualche volta – il nome del prossimo pezzo. Per il resto è stata una serata di pura musica ed energia: non solo di McCraven, il cui vigore era pari alla sua abilità – mai sentito un batterista che suonasse per circa un’ora e mezza, senza mai smettere di percuotere pelli e piatti con tanta ininterrotta energia – ma anche di tutti gli altri musicisti, che durante il concerto si cimentavano con diversi tipi di percussioni. Altra nota di merito va alla varietà di brani suonati: si passa da pezzi ormai diventati standard del jazz, come “Autumn in New York”, Frank’s Tune” di Frank Strzier o “A Slice of the Top” a pezzi originali di McCraven, come “In These Times”, “The Bounce!” e un inedito tratto dal suo prossimo album in uscita a settembre.
La band inizia a suonare senza presentare alcunché; McCraven è uomo di poche parole, e non si concede quasi mai pause, tranne una ogni tre pezzi circa per presentare e ringraziare la sua band e per annunciare – qualche volta – il nome del prossimo pezzo. Per il resto è stata una serata di pura musica ed energia: non solo di McCraven, il cui vigore era pari alla sua abilità – mai sentito un batterista che suonasse per circa un’ora e mezza, senza mai smettere di percuotere pelli e piatti con tanta ininterrotta energia – ma anche di tutti gli altri musicisti, che durante il concerto si cimentavano con diversi tipi di percussioni. Altra nota di merito va alla varietà di brani suonati: si passa da pezzi ormai diventati standard del jazz, come “Autumn in New York”, Frank’s Tune” di Frank Strzier o “A Slice of the Top” a pezzi originali di McCraven, come “In These Times”, “The Bounce!” e un inedito tratto dal suo prossimo album in uscita a settembre. Il 23 la Casa de Jazz proponeva un quesito intrigante: può la sofisticata poetica di un Pieranunzi coniugarsi con l’incredibile carica energetica di Antonello Salis? In altri termini possono coesistere due musicisti stilisticamente quasi all’opposto, uniti solo dalla grande passione e dedizione alla musica? Ciò perché il concerto in programma prevedeva per l’appunto un duo di piano composto da questi due artisti che mai avevano avuto modo di incontrarsi sul palco. Grande attesa, quindi, e non a caso grande affluenza di pubblico…ripagato da un concerto sicuramente interessante. Seduti l’uno di fronte all’altro i due hanno suonato per circa un’ora e mezza sciorinando un’intesa che non era facile prevedere. Spesso si partiva da un tema che veniva sviluppato, esaminato, sviscerato fin nelle sue più intime pieghe e quindi riproposto in una veste totalmente diversa che traeva nelle capacità improvvisative dei due nuova linfa vitale. E questa volta non si può dire che l’uno si sia piegato alle esigenze dell’altro in quanto ambedue hanno sviluppato appieno le proprie tematiche che finivano con l’incontrarsi su un terreno ben frequentato sia da Enrico sia da Antonello: l’improvvisazione pura o forse meglio la capacità di creare musica strada facendo. In effetti, oltre che partire da un dato tema, i due si sono spesso avventurati anche sul foglio bianco, vale a dire cominciando a suonare senza conoscere il punto di approdo, con una maestria che solo pochi posseggono.
Il 23 la Casa de Jazz proponeva un quesito intrigante: può la sofisticata poetica di un Pieranunzi coniugarsi con l’incredibile carica energetica di Antonello Salis? In altri termini possono coesistere due musicisti stilisticamente quasi all’opposto, uniti solo dalla grande passione e dedizione alla musica? Ciò perché il concerto in programma prevedeva per l’appunto un duo di piano composto da questi due artisti che mai avevano avuto modo di incontrarsi sul palco. Grande attesa, quindi, e non a caso grande affluenza di pubblico…ripagato da un concerto sicuramente interessante. Seduti l’uno di fronte all’altro i due hanno suonato per circa un’ora e mezza sciorinando un’intesa che non era facile prevedere. Spesso si partiva da un tema che veniva sviluppato, esaminato, sviscerato fin nelle sue più intime pieghe e quindi riproposto in una veste totalmente diversa che traeva nelle capacità improvvisative dei due nuova linfa vitale. E questa volta non si può dire che l’uno si sia piegato alle esigenze dell’altro in quanto ambedue hanno sviluppato appieno le proprie tematiche che finivano con l’incontrarsi su un terreno ben frequentato sia da Enrico sia da Antonello: l’improvvisazione pura o forse meglio la capacità di creare musica strada facendo. In effetti, oltre che partire da un dato tema, i due si sono spesso avventurati anche sul foglio bianco, vale a dire cominciando a suonare senza conoscere il punto di approdo, con una maestria che solo pochi posseggono. Guidati dal funambolico sassofonista Shabaka Hutchings, il quartetto (completato dal basso tuba di Theon Cross e ben due batterie nelle mani di Eddie Hick e della giovanissima e bravissima Jas Keyser in sostituzione di Tom Skinner in tour con Thom Yorke) ha sciorinato una musica di grande intensità, basata sul fitto tappeto ritmico intessuto dalle due batterie su cui svolgevano i loro interventi i due fiati. In particolare il sax del leader, spesso effettato con delay o reverberi, non disegnava lunghe linee melodiche ma intonava frasi ritmiche e frammenti melodici ripetuti più volte mentre il basso tuba contribuiva in maniera determinante a completare il tessuto ritmico delle due batterie. Il tutto ‘condito’ da un volume molto, molto elevato a creare una musica che raggiungesse l’obiettivo di portare al massimo l’eccitazione dell’uditorio e di coinvolgerlo in una sorta di rito collettivo in cui i richiami all’Africa erano ben evidenti. Si tenga presente che il concerto si è sviluppato su una linea di continuità ininterrotta tranne due momenti in cui Shabaka Hutchings ha imbracciato un flauto di legno per intonare una splendida melodia di origine africana e il tubista si è espresso in solitudine. Obiettivo raggiunto? Quanto al coinvolgimento direi proprio di sì… anche se non al cento per cento. Nel senso che, ad esempio, il vostro cronista non si è sentito coinvolto dalla musica dei Sons of Kemet. Ed il perché non è difficile da spiegare: avendo avuto la fortuna di ascoltare anche dal vivo alcuni dei più grandi musicisti – per intenderci quelli che hanno scritto davvero la storia del jazz – non è facile lasciarsi impressionare da qualcuno che pur suonando bene non raggiunge quei vertici cui prima si faceva riferimento. Quanto ai messaggi che questa musica così aggressiva intende veicolare, ci viene in soccorso lo stesso Shabaka Hutchings affermando che “Black to the Future (ultimo album del gruppo) è un poema sonoro di invocazione del potere, del ricordo e della guarigione. Raffigura un movimento, quello della ridefinizione e riaffermazione di cosa significa lottare per il black power”. Ma anche sotto questo aspetto non riusciamo a vedere una grande novità dal momento che il jazz come musica di protesta non è certo cosa di oggi.
Guidati dal funambolico sassofonista Shabaka Hutchings, il quartetto (completato dal basso tuba di Theon Cross e ben due batterie nelle mani di Eddie Hick e della giovanissima e bravissima Jas Keyser in sostituzione di Tom Skinner in tour con Thom Yorke) ha sciorinato una musica di grande intensità, basata sul fitto tappeto ritmico intessuto dalle due batterie su cui svolgevano i loro interventi i due fiati. In particolare il sax del leader, spesso effettato con delay o reverberi, non disegnava lunghe linee melodiche ma intonava frasi ritmiche e frammenti melodici ripetuti più volte mentre il basso tuba contribuiva in maniera determinante a completare il tessuto ritmico delle due batterie. Il tutto ‘condito’ da un volume molto, molto elevato a creare una musica che raggiungesse l’obiettivo di portare al massimo l’eccitazione dell’uditorio e di coinvolgerlo in una sorta di rito collettivo in cui i richiami all’Africa erano ben evidenti. Si tenga presente che il concerto si è sviluppato su una linea di continuità ininterrotta tranne due momenti in cui Shabaka Hutchings ha imbracciato un flauto di legno per intonare una splendida melodia di origine africana e il tubista si è espresso in solitudine. Obiettivo raggiunto? Quanto al coinvolgimento direi proprio di sì… anche se non al cento per cento. Nel senso che, ad esempio, il vostro cronista non si è sentito coinvolto dalla musica dei Sons of Kemet. Ed il perché non è difficile da spiegare: avendo avuto la fortuna di ascoltare anche dal vivo alcuni dei più grandi musicisti – per intenderci quelli che hanno scritto davvero la storia del jazz – non è facile lasciarsi impressionare da qualcuno che pur suonando bene non raggiunge quei vertici cui prima si faceva riferimento. Quanto ai messaggi che questa musica così aggressiva intende veicolare, ci viene in soccorso lo stesso Shabaka Hutchings affermando che “Black to the Future (ultimo album del gruppo) è un poema sonoro di invocazione del potere, del ricordo e della guarigione. Raffigura un movimento, quello della ridefinizione e riaffermazione di cosa significa lottare per il black power”. Ma anche sotto questo aspetto non riusciamo a vedere una grande novità dal momento che il jazz come musica di protesta non è certo cosa di oggi. Smaltita la sbornia dell’“Afrofuturism” (così viene definita la musica di Sons of Kemet da chi se ne intende), ecco il 27 sempre alla Casa del Jazz, la giovane e brava sassofonista Nubya Garcia, reduce dallo straordinario successo ottenuto dal suo primo album “Source” su etichetta Concord. Bel concerto questo con una musica sì proiettata verso il futuro ma sempre memore di ciò che il jazz ha rappresentato fino ad oggi. Anche la Garcia viene fuori dalla tumultuosa scena londinese di questi ultimi anni affermandosi passo dopo passo come una delle strumentiste più preparate e fantasiose del pur vasto panorama. In effetti Nubya frequenta il sax da tanti anni riuscendo così a raggiungere una tecnica tutt’altro che banale, una tecnica comunque sempre messa al servizio dell’espressività e di una concezione musicale fortemente inclusiva dal momento che nelle sue performances sono ben riscontrabili echi di jazz spirituale, dub, reggae, ritmi latini e suoni africani. Così il concerto si è sviluppato lungo modalità contrassegnate da notevoli assolo non solo della leader ma anche del pianista-tastierista Alastair MacSween mentre la sezione ritmica (Daniel Casimir contrabbasso e Sam Jones batteria) forniva un supporto sempre preciso, puntuale, propositivo. E a proposito di ritmo, da sottolineare la sensualità dei ritmi colombiani rinverdita dalla Nubya nella riproposizione di uno dei brani più riusciti dell’intera serata, “La Cumbia Me Está Llamando”, scritta con il trio colombiano al femminile “La Perla”.
Smaltita la sbornia dell’“Afrofuturism” (così viene definita la musica di Sons of Kemet da chi se ne intende), ecco il 27 sempre alla Casa del Jazz, la giovane e brava sassofonista Nubya Garcia, reduce dallo straordinario successo ottenuto dal suo primo album “Source” su etichetta Concord. Bel concerto questo con una musica sì proiettata verso il futuro ma sempre memore di ciò che il jazz ha rappresentato fino ad oggi. Anche la Garcia viene fuori dalla tumultuosa scena londinese di questi ultimi anni affermandosi passo dopo passo come una delle strumentiste più preparate e fantasiose del pur vasto panorama. In effetti Nubya frequenta il sax da tanti anni riuscendo così a raggiungere una tecnica tutt’altro che banale, una tecnica comunque sempre messa al servizio dell’espressività e di una concezione musicale fortemente inclusiva dal momento che nelle sue performances sono ben riscontrabili echi di jazz spirituale, dub, reggae, ritmi latini e suoni africani. Così il concerto si è sviluppato lungo modalità contrassegnate da notevoli assolo non solo della leader ma anche del pianista-tastierista Alastair MacSween mentre la sezione ritmica (Daniel Casimir contrabbasso e Sam Jones batteria) forniva un supporto sempre preciso, puntuale, propositivo. E a proposito di ritmo, da sottolineare la sensualità dei ritmi colombiani rinverdita dalla Nubya nella riproposizione di uno dei brani più riusciti dell’intera serata, “La Cumbia Me Está Llamando”, scritta con il trio colombiano al femminile “La Perla”.



