da Amedeo Furfaro | 03/Ago/2022 | Editoriali, News, Primo piano
La televisione è stata spesso oggetto di critiche in quanto possibile veicolo di regresso culturale delle masse. Umberto Eco, a proposito dell’uomo circuìto dai mass media, scriveva che “poiché uno dei compensi narcotici a cui ha diritto è l’evasione nel sogno, gli vengono presentati di solito degli ideali tra lui e quelli con cui si possa stabilire una tensione” (Diario Minimo, 1961). La tematica dei rapporti fra musica e mass media investe anche un genere non definibile “narcotizzante” come il jazz nella sua relazione con la tv. In proposito, in Italia, si sono verificati dei momenti di avvicinamento fra i due termini del rapporto che consentono di abbozzare dei lineamenti di storia televisiva “vista” attraverso il fil rouge delle sigle jazz.
—
Donald Bogle ha osservato che “attorno al 1950 i sets tv arrivavano nelle case degli americani trasformandone gradualmente abitudini e prospettive” (Blacks in American Films and Television, New York, Fireside, 1989). E David Johnson di recente ha annotato che “come la tv si insinuava nell’entertainment dell’America di metà 900, musicisti e compositori, molti con esperienze jazz, venivano chiamati a scrivere temi ed “attacchi” per varietà e programmi” (Heard It On The Tv: Jazz Takes On Television Themes, indianapublicmedia.org, 12/5/2021). Osservazioni in parte trasferibili, con le dovute proporzioni, all’Italia che, dal 1954, dai primi vagiti della neonata tv, subiva il modificarsi di usi, linguaggio, immaginario collettivo in un contesto di rapida trasformazione economica, sociale e culturale, a causa anche alla spinta dei mass media. Su queste colonne, fra le sottotracce della nostra storia televisiva, abbiamo provato a “rintracciare” un argomento abbastanza sottaciuto, quello delle sigle (e intersigle) che sono poi l’antipasto e il post prandium del programma televisivo, nello specifico quelle dialoganti lato sensu in jazz o comunque prodotte od associabili a jazzisti. Come “la radio degli anni Cinquanta è a cavallo tra conservazione e trasformazione” (cfr. sub voce Cultura e educazione, l’Universale Radio, Milano, 2006) così il nuovo medium, già dai primi anni di vita, attenzionava sonorità che erano espressione di differenti musiche del mondo. Su un tale sfondo il jazz riusciva man mano a ritagliarsi spazi nei palinsesti e ad essere presente in filmati, notiziari, dossier, speciali, spot e jingle (cfr. Jazz e pubblicità, “A proposito di Jazz”, 9/4/2021), programmi a quiz, a premi e a cotillon, varietà, sceneggiati e “originali televisivi”, serie tv. Già nell’Italia della ricostruzione postbellica la dimensione locale non più autarchica si era confrontata sulla globale “importando” liberamente musica che durante il regime era proibita. Con l’avvento del medium tv le sigle di fatto fungevano da possibile cavallo di Troia per conquistare al jazz spazio in audio/video e lasciar trapelare le note di Woody Herman, Stan Kenton, Duke Ellington, Toots Thielemans … e vari artefici di una musica che in quegli anni non veniva più percepita solo come intrattenimento omologante bensì anche quale propaggine di quella cultura neroamericana propria di una comunità oppressa non dominante. Una comunità in fibrillante opposizione politica e spiccato antagonismo sociale i cui risvolti rimbalzavano nelle lettere, nelle arti, nella musica. Ma entriamo nel dettaglio. In Italia, nel 1957, coetanea di Carosello, vedeva la luce in tv Telematch. La trasmissione a premi era introdotta dalle note di “Marching Strings” dell’orchestra di Ray Martin, il bandleader di “The Swingin’ Marchin’ Band” (RCA, 1958). Light music, la sua, che rappresentava però un’apertura internazionale verso la musica easy listening d’oltrefrontiera sul Programma Nazionale e in prima serata. Parallelamente, alla radio, nel 1960, Adriano Mazzoletti, da un anno collaboratore della Rai, debuttava con la Coppa del Jazz promuovendo in tal modo una più stabile programmazione in senso jazzistico sul mezzo radiofonico i cui primordi risalgono all’antenato Eiar Jazz del 1929.
 A dire il vero, dopo il primo melodico Sanremo del ’51, una decisa aura jazz si era avvertita in Nati per la Musica, un programma con Jula De Palma, Quartetto Cetra, Teddy Reno che si avvaleva delle orchestre di ritmi moderni di Gorni Kramer e Lelio Luttazzi, la cui sigla è ascoltabile sul Portale della Canzone Italiana dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi (www.canzone italiana.it/1zlns). Sorella Radio avrebbe dato anche in seguito significativi contributi alla causa jazzistica – si pensi all’uso fatto da Radio1 dello stacco di “Country“ tratto dal cd “My Song” di Jarrett con Garbarek, Danielson e Christensen (ECM, 1977) – ma il copioso materiale di Mamma Rai, con il ricchissimo archivio sonoro ad oggi digitalizzato, meriterebbe di essere approfondito in altra sede. Torniamo allora al come eravamo tramite il cosa guardavamo. Dopo la vittoria di Modugno all’Ariston nel ’58, con una “Nel blu dipinto di blu” a ritmo swing, nell’anno di grazia televisivo 1961 passavano in video le immagini di Moderato Swing che era anche il titolo della sigla di Piero Umiliani. Un biennio ancora per poi sentire il canto e la tromba di Nini Rosso echeggiare in “I ragazzi del jazz”, sigla di Fuori I ’Orchestra, epica trasmissione, per la regia di Lino Procacci, che si avvaleva della direzione musicale dello stesso Umiliani. Si trattava di una rubrica che si occupava “di musica equidistante fra quella leggerissima e quella classica“ (www.umiliani.com) che rimane una pietra miliare della televisione italiana. Fra i numeri fissi c’erano quello dedicato al Jazz made in Italy ed l’altro spazio denominato Parole e musica che registrava partecipazioni lussuose tipo la cantante Helen Merrill. Da segnalare che Umiliani avrebbe poi collaborato con I Marc 4 (acronimo di Maurizio Majorana, Antonello Vannucchi, Roberto Podio, Carlo Pes), gruppo operante fra ’60 e ’76, a cui è da ascrivere la sigla di Prima Visione (su album Ricordi, 1974). Il 1963 resta un anno significativo per il jazz sul piccolo schermo anche perché decollava in Italia, con TV7, l’idea di utilizzare un brano jazz come intro di un programma d’inchiesta. Per l’occasione la scelta cadeva su “Intermission Riff” di Stan Kenton, poi sostituita con una storica versione dell’Equipe 84. A fine decennio toccava alla serie tv Nero Wolf diretta da Giuliana Berlinguer con Tino Buazzelli, vedere impressi i titoli di testa e di coda dalla tromba di Nunzio Rotondo sulla base elettronica di Romolo Grano, musica da noir con echi dal lungometraggio di Louis Malle Ascenseur pour l’échafaud, del ’58, sonorizzato da Miles Davis, trombettista a cui Rotondo è stato spesso accostato. Ed avrebbe “aperto” un thriller televisivo il compositore Berto Pisano con la sua “Blue Shadow”, sigla lounge dello sceneggiato Ho incontrato un’ombra del 1974, che figura nella classifica stilata da “Rolling Stone” il 26 agosto 2020 in Fantasmi e storie maledette. Le migliori sigle della tv italiana del mistero degli anni ’70. In tema di rotocalchi da menzionare che AZ un fatto come e perché (in onda dal ‘70 fino al luglio ’76) adottava un pezzo del repertorio jazz, esattamente “Hard to Keep My Mind of You”, di Woody Herman.
A dire il vero, dopo il primo melodico Sanremo del ’51, una decisa aura jazz si era avvertita in Nati per la Musica, un programma con Jula De Palma, Quartetto Cetra, Teddy Reno che si avvaleva delle orchestre di ritmi moderni di Gorni Kramer e Lelio Luttazzi, la cui sigla è ascoltabile sul Portale della Canzone Italiana dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi (www.canzone italiana.it/1zlns). Sorella Radio avrebbe dato anche in seguito significativi contributi alla causa jazzistica – si pensi all’uso fatto da Radio1 dello stacco di “Country“ tratto dal cd “My Song” di Jarrett con Garbarek, Danielson e Christensen (ECM, 1977) – ma il copioso materiale di Mamma Rai, con il ricchissimo archivio sonoro ad oggi digitalizzato, meriterebbe di essere approfondito in altra sede. Torniamo allora al come eravamo tramite il cosa guardavamo. Dopo la vittoria di Modugno all’Ariston nel ’58, con una “Nel blu dipinto di blu” a ritmo swing, nell’anno di grazia televisivo 1961 passavano in video le immagini di Moderato Swing che era anche il titolo della sigla di Piero Umiliani. Un biennio ancora per poi sentire il canto e la tromba di Nini Rosso echeggiare in “I ragazzi del jazz”, sigla di Fuori I ’Orchestra, epica trasmissione, per la regia di Lino Procacci, che si avvaleva della direzione musicale dello stesso Umiliani. Si trattava di una rubrica che si occupava “di musica equidistante fra quella leggerissima e quella classica“ (www.umiliani.com) che rimane una pietra miliare della televisione italiana. Fra i numeri fissi c’erano quello dedicato al Jazz made in Italy ed l’altro spazio denominato Parole e musica che registrava partecipazioni lussuose tipo la cantante Helen Merrill. Da segnalare che Umiliani avrebbe poi collaborato con I Marc 4 (acronimo di Maurizio Majorana, Antonello Vannucchi, Roberto Podio, Carlo Pes), gruppo operante fra ’60 e ’76, a cui è da ascrivere la sigla di Prima Visione (su album Ricordi, 1974). Il 1963 resta un anno significativo per il jazz sul piccolo schermo anche perché decollava in Italia, con TV7, l’idea di utilizzare un brano jazz come intro di un programma d’inchiesta. Per l’occasione la scelta cadeva su “Intermission Riff” di Stan Kenton, poi sostituita con una storica versione dell’Equipe 84. A fine decennio toccava alla serie tv Nero Wolf diretta da Giuliana Berlinguer con Tino Buazzelli, vedere impressi i titoli di testa e di coda dalla tromba di Nunzio Rotondo sulla base elettronica di Romolo Grano, musica da noir con echi dal lungometraggio di Louis Malle Ascenseur pour l’échafaud, del ’58, sonorizzato da Miles Davis, trombettista a cui Rotondo è stato spesso accostato. Ed avrebbe “aperto” un thriller televisivo il compositore Berto Pisano con la sua “Blue Shadow”, sigla lounge dello sceneggiato Ho incontrato un’ombra del 1974, che figura nella classifica stilata da “Rolling Stone” il 26 agosto 2020 in Fantasmi e storie maledette. Le migliori sigle della tv italiana del mistero degli anni ’70. In tema di rotocalchi da menzionare che AZ un fatto come e perché (in onda dal ‘70 fino al luglio ’76) adottava un pezzo del repertorio jazz, esattamente “Hard to Keep My Mind of You”, di Woody Herman.
 Dal giornalismo d’inchiesta a quello sportivo: nel ’78 era il turno di Jazz Band di Hengel Gualdi a far da “preludio” a Novantesimo minuto, storica rubrica di RaiSport, e come non citare, dal campionario di La Domenica Sportiva, “Dribbling” di Piero Umiliani (1967), “Winning The West” della Buddy Rich Big Band (1973), “Mexico” di Danilo Rea e Roberto Gatto (1985), “Breakout” di Spyro Gira (1991)? Spostandoci alla “pagina” spettacoli, fra il ’76 e il ‘78, Rete 2 dava spazio in Odeon al pianista Keith Emerson (senza Lake e Palmer) in “Odeon Rag” arrangiamento di “Maple Leaf Rag” di Scott Joplin, subentrato in luogo del precedente “Honky Tonk Train Blues”, autore il pianista Meade Lux Lewis. Il filone spettacolistico avrebbe registrato più in là significativi esempi con lo scat di Lucio Dalla con gli Stadio che annuncia Lunedifilm per un buon ventennio fino al 2002 e l’ellingtoniano “Take The A Train” di Strayhorn a fare da intro ai trailer cinematografici assemblati da AnicaFlash per la rassegna delle novità cinematografiche “di stagione”. Si diceva come luogo fertile per la semina tv di suoni jazz da filtrare nelle orecchie dei telespettatori fosse l’informazione. Gettonatissima rimane al riguardo la sigla di Mixer (1980-1996) ovvero “Jazz Carnival” dei brasiliani Azimuth, specialisti del samba doido, genere fusion-funky. Latin come nelle radiocronache di Tutto il calcio minuto per minuto, dove Herb Alpert e Tijuana Brass interpretano “A Taste of Honey”, brano di stampo pop, in repertorio a Beatles e Giganti (“In paese è festa”). Per la tv italiana va ricordato che, fuori dal reticolo giornalistico, si contano altre occasioni più dirette di esposizione per la musica jazz filtrata tramite il piccolo schermo. La Portobello Jazz Band di Lino Patruno “presentava” il programma di Enzo Tortora (cfr. La tana delle sigle in tds.sigletv.net) nel 1978, stesso anno dello sceneggiato in 3 puntate Jazz Band di Pupi Avati, colonna sonora di Amedeo Tommasi, con il clarino di Hengel Gualdi in evidenza nelle sigle di apertura e chiusura, “Jazz Band” e “Swing Time” ; poi ancora Di Jazz in Jazz, programma “dedicato” con relativa sigla a cura dell’Orchestra Big Band della Rai diretta da Giampiero Boneschi e Franco Cerri (www.teche.rai.it). “Schegge”, queste ultime, che costituivano una vetrina per il jazz di casa nostra in una situazione in cui il format varietà si teneva alquanto distante, a differenza di quanto avveniva negli U.S.A. . Dalle nostre parti vanno citati comunque Milleluci, show datato 1974, nella cui sigla finale “Non gioco più” Mina duetta con l’armonica di Toots Thielemans, Palcoscenico, in onda fra 1980 e 1981, con Milva accompagnata da Astor Piazzolla mentre scorrono i titoli di coda in “Fumo e odore di caffè” e Premiatissima del 1985 dove il crooner Johnny Dorelli canta “La cosa si fa“ su base swing “metropolitano. Lo sdoganamento delle sigle jazz nei varietà proseguiva con Renzo Arbore (e Gegè Telesforo) a cui si deve “Smorza e’ lights (Such a night)” incipit di Telepatria International, inizio trasmissioni il 6 dicembre 1981 (www.arboristeria.it – Renzo Arbore Channel). Per la cronaca il 18 marzo 1981, e fino al 1989, sarebbe andata in onda la prima edizione di Quark di Piero Angela, conduttore nonché apprezzato pianista jazz. La trasmissione di divulgazione scientifica sarebbe stata simbioticamente legata alla sigla, la “Air for G String” di Bach, eseguita da The Swingle Singers, pubblicata nell’album “Jazz Sèbastian Bach” (1963), peraltro incisa anche insieme al Modern Jazz Quartet in “Place Vendòme”, album del ’68 della Philips. Terminiamo questa breve carrellata, che non include per sintesi le emittenti private/commerciali pro-tempore, per ricordare la sigla swing di DOC Musica e altro a denominazione d’origine controllata (1987-1988) di Arbore, Telesforo e Monica Nannini, esempio di come coinvolgere il jazz in un contenitore di buona musica. Il breve excursus è stato uno squarcio fugace su una jazz age, grossomodo racchiusa fra ’54 e ’94, un fugace momento di (bel) spaesizzazione musicale segnato, al proprio interno, dal passaggio dall’analogico al digitale, fase che precedeva la successiva della tv satellite e quella attuale della connessione via internet con la diffusione dei social e di new media come le web-tv con piattaforme on demand. E’ stato osservato che nella tv generalista di oggi “il jazz non ha più la stessa presa pubblica di un tempo” (cfr. Il jazz e le sigle radiotelevisive, riccardofacchi.wordpress.com, 2/8/2016). E “CiakClub.it” ha pubblicato, a firma di Alberto Candiani, un elenco con Le 20 migliori sigle televisive di sempre: Da Friends a Il trono di spade la lista delle più affascinanti iconiche e meglio congeniate sigle delle serie tv senza che ne compaia qualcuna (simil)jazz. Vero! Ci sono molti set televisivi in cui il jazz fa comparse episodiche. C’è poi che, a causa dell’affinarsi delle tecnologie digitali, molte sigle vengono confezionate a tavolino e, perdendo in istantaneità, sono sempre meno frutto di incisioni live né tantomeno vengono selezionate fra materiali preesistenti. Ed è forse tutto ciò che ammanta quei “primi quarant’anni” di tv “eterea” di un irripetibile sapore amarcord.
Dal giornalismo d’inchiesta a quello sportivo: nel ’78 era il turno di Jazz Band di Hengel Gualdi a far da “preludio” a Novantesimo minuto, storica rubrica di RaiSport, e come non citare, dal campionario di La Domenica Sportiva, “Dribbling” di Piero Umiliani (1967), “Winning The West” della Buddy Rich Big Band (1973), “Mexico” di Danilo Rea e Roberto Gatto (1985), “Breakout” di Spyro Gira (1991)? Spostandoci alla “pagina” spettacoli, fra il ’76 e il ‘78, Rete 2 dava spazio in Odeon al pianista Keith Emerson (senza Lake e Palmer) in “Odeon Rag” arrangiamento di “Maple Leaf Rag” di Scott Joplin, subentrato in luogo del precedente “Honky Tonk Train Blues”, autore il pianista Meade Lux Lewis. Il filone spettacolistico avrebbe registrato più in là significativi esempi con lo scat di Lucio Dalla con gli Stadio che annuncia Lunedifilm per un buon ventennio fino al 2002 e l’ellingtoniano “Take The A Train” di Strayhorn a fare da intro ai trailer cinematografici assemblati da AnicaFlash per la rassegna delle novità cinematografiche “di stagione”. Si diceva come luogo fertile per la semina tv di suoni jazz da filtrare nelle orecchie dei telespettatori fosse l’informazione. Gettonatissima rimane al riguardo la sigla di Mixer (1980-1996) ovvero “Jazz Carnival” dei brasiliani Azimuth, specialisti del samba doido, genere fusion-funky. Latin come nelle radiocronache di Tutto il calcio minuto per minuto, dove Herb Alpert e Tijuana Brass interpretano “A Taste of Honey”, brano di stampo pop, in repertorio a Beatles e Giganti (“In paese è festa”). Per la tv italiana va ricordato che, fuori dal reticolo giornalistico, si contano altre occasioni più dirette di esposizione per la musica jazz filtrata tramite il piccolo schermo. La Portobello Jazz Band di Lino Patruno “presentava” il programma di Enzo Tortora (cfr. La tana delle sigle in tds.sigletv.net) nel 1978, stesso anno dello sceneggiato in 3 puntate Jazz Band di Pupi Avati, colonna sonora di Amedeo Tommasi, con il clarino di Hengel Gualdi in evidenza nelle sigle di apertura e chiusura, “Jazz Band” e “Swing Time” ; poi ancora Di Jazz in Jazz, programma “dedicato” con relativa sigla a cura dell’Orchestra Big Band della Rai diretta da Giampiero Boneschi e Franco Cerri (www.teche.rai.it). “Schegge”, queste ultime, che costituivano una vetrina per il jazz di casa nostra in una situazione in cui il format varietà si teneva alquanto distante, a differenza di quanto avveniva negli U.S.A. . Dalle nostre parti vanno citati comunque Milleluci, show datato 1974, nella cui sigla finale “Non gioco più” Mina duetta con l’armonica di Toots Thielemans, Palcoscenico, in onda fra 1980 e 1981, con Milva accompagnata da Astor Piazzolla mentre scorrono i titoli di coda in “Fumo e odore di caffè” e Premiatissima del 1985 dove il crooner Johnny Dorelli canta “La cosa si fa“ su base swing “metropolitano. Lo sdoganamento delle sigle jazz nei varietà proseguiva con Renzo Arbore (e Gegè Telesforo) a cui si deve “Smorza e’ lights (Such a night)” incipit di Telepatria International, inizio trasmissioni il 6 dicembre 1981 (www.arboristeria.it – Renzo Arbore Channel). Per la cronaca il 18 marzo 1981, e fino al 1989, sarebbe andata in onda la prima edizione di Quark di Piero Angela, conduttore nonché apprezzato pianista jazz. La trasmissione di divulgazione scientifica sarebbe stata simbioticamente legata alla sigla, la “Air for G String” di Bach, eseguita da The Swingle Singers, pubblicata nell’album “Jazz Sèbastian Bach” (1963), peraltro incisa anche insieme al Modern Jazz Quartet in “Place Vendòme”, album del ’68 della Philips. Terminiamo questa breve carrellata, che non include per sintesi le emittenti private/commerciali pro-tempore, per ricordare la sigla swing di DOC Musica e altro a denominazione d’origine controllata (1987-1988) di Arbore, Telesforo e Monica Nannini, esempio di come coinvolgere il jazz in un contenitore di buona musica. Il breve excursus è stato uno squarcio fugace su una jazz age, grossomodo racchiusa fra ’54 e ’94, un fugace momento di (bel) spaesizzazione musicale segnato, al proprio interno, dal passaggio dall’analogico al digitale, fase che precedeva la successiva della tv satellite e quella attuale della connessione via internet con la diffusione dei social e di new media come le web-tv con piattaforme on demand. E’ stato osservato che nella tv generalista di oggi “il jazz non ha più la stessa presa pubblica di un tempo” (cfr. Il jazz e le sigle radiotelevisive, riccardofacchi.wordpress.com, 2/8/2016). E “CiakClub.it” ha pubblicato, a firma di Alberto Candiani, un elenco con Le 20 migliori sigle televisive di sempre: Da Friends a Il trono di spade la lista delle più affascinanti iconiche e meglio congeniate sigle delle serie tv senza che ne compaia qualcuna (simil)jazz. Vero! Ci sono molti set televisivi in cui il jazz fa comparse episodiche. C’è poi che, a causa dell’affinarsi delle tecnologie digitali, molte sigle vengono confezionate a tavolino e, perdendo in istantaneità, sono sempre meno frutto di incisioni live né tantomeno vengono selezionate fra materiali preesistenti. Ed è forse tutto ciò che ammanta quei “primi quarant’anni” di tv “eterea” di un irripetibile sapore amarcord.
Amedeo Furfaro
da Redazione | 19/Ott/2021 | Editoriali, News, Primo piano
di Flaviano Bosco –
Pare perfino scontato salutare Franco Cerri ora che ha deciso di raggiungere suo figlio per continuare la sua infinita serie di concerti in un’altra dimensione. Dire che era il decano del jazz italiano è auto-evidente e per onorarlo degnamente bisogna di certo osare di più.
Se c’è qualcuno che ha dato al jazz italiano una fisionomia che gli è propria, un gusto tutto nostro, disincantato, leggero, popolare e al tempo stesso colto e raffinatissimo è stato di certo il chitarrista milanese per antonomasia. Cerri ha traghettato generazioni intere dalla musica d’imitazione americana, che nel nostro paese aveva avuto una gloriosa stagione già a partire dagli anni ‘30, verso un sound tutto nuovo, tra le nebbie e il sole della pianura padana “fino ai laghi bianchi del silenzio” come ricorda in una sua canzone Paolo Conte, altro grande testimone del nostro tempo, mentre parla di un chitarrista che si estenua alla ricerca della giusta intonazione.
Se proprio vogliamo andare in ordine cronologico, tutto era iniziato in Europa con l’inarrivabile Django Reinhardt e con il suo sodale Sthépane Grappelli. Cerri poteva dirsi loro allievo diretto, visto che giovanissimo lavorò con entrambi e condiviso un tour europeo con il secondo, durato due anni con centinaia di concerti.
Leggenda vuole che il jazz in origine sia stato per 2/4 afroamericano, 1/4 italiano e tutto il resto una fantasmagoria gitana. Sempre, come dice l’avvocato di Asti in altro contesto ma nella medesima canzone: “la sua origine d’Africa, la sua eleganza di zebra, il suo essere di frontiera, una verde frontiera tra il suonare e l’amare, verde spettacolo in corsa da inseguire. Da inseguire sempre, da inseguire ancora”.
Franco Cerri chitarrista ha vissuto tutta la propria lunga prodigiosa esistenza di musicista puro in questa luce d’orizzonte, continuando ad esplorare i misteri della musica con il suo sorriso da eterno ragazzo, meravigliandosi sempre dei miracoli delle sue dita, come raccontava spesso.
Chi scrive ricorda d’averlo visto in concerto la prima volta sul finire degli anni ‘80 e poi in moltissime altre occasioni tra le quali una memorabile esibizione con il quartetto di Gianni Coscia (11/06/1999 Gorizia) che celebrava gli anni pionieristici del Jazz italiano. I vecchi appunti di allora recitano:
“Quella musica irripetibile che sapeva di Novembre e di bachelite, quei suoni che erano la colonna sonora del ciclismo dei gregari, le salite e gli aeroplani, il vino rosso nei bicchieri di vetro spesso e delle domeniche pomeriggio… quella musica, a dispetto delle hit parade, esiste ancora. Gianni Coscia e Franco Cerri sono stati i sacerdoti officianti del gran rito della memoria, di qualcosa che non passa, migliora e si affina nei decenni. L’Italia, con i propri enormi difetti, con le proprie miserie, è inspiegabilmente custode di un patrimonio musicale inarrivabile che si esprime anche nelle canzoni popolari del secondo dopoguerra, giudicate spesso troppo superficialmente ma che in realtà sono scrigni all’interno dei quali si conserva molto spesso la nostra anima più pura, quella ingenua e sognante, perfino stupida e stupita in un’armonia di danza e di sberleffi.
Nel nostro cuore la “swing era” non è mai finita, le stelle del jazz appartengono anche a noi, scimmie della pianura padana o dei vicoli in festa tra lacrime e Vesuvio. Il lavoro di riscoperta continua delle nostre radici musicali da parte di questi musicisti è pregevolissimo. Cerri è un chitarrista dal suono e dalle abilità ipnotiche che, pur nella sua estrema sobrietà, sa toccare come pochi le corde dell’emozione. Coscia è un musicista più passionale e istrionico che si serve più del cuore che del virtuosismo”.
È sembrato giusto ricordarlo così, vivo e vibrante com’è stato fino allo scadere di questo suo transito terrestre. Imperturbabile e impermeabile alle mode passeggere, ha sempre continuato a riproporre i suoi accordi cristallini di una musica che apparteneva ad un altro tempo senza mai apparire anacronistica. Da perfetto autodidatta, il chitarrista milanese aveva trovato il proprio suono e continuò ad arrotarlo e affilarlo per decenni in infinite anche minime variazioni, modulazioni e riflessioni.
Ricevette la prima chitarra nel settembre del 1943 e trovò i primi accordi ascoltando i dischi di Benny Goodman, Louis Armstrong, Duke Ellington a casa di un amico più ricco, mentre per mantenersi faceva il muratore. Già durante la guerra cominciò subito a suonare a Radio Tevere, voce di Roma libera che era invece la voce della famigerata Repubblica sociale italiana che, in teoria, considerava il jazz “musica degenerata e negroide”, mentre il figlio di Mussolini era uno dei migliori pianisti jazz della sua epoca, nel nostro paese sempre in mezzo alle contraddizioni e ai miracoli della musica.
Cerri in seguito cominciò a suonare nell’orchestra di Gorni Kramer che scovò il suo talento una domenica pomeriggio mentre, a Milano, faceva ballare la gente in un cortile con la sua piccola band. Lo scritturò all’istante inserendolo nell’ambiente della musica del primo dopoguerra dove, giovanissimo, divenne uno dei musicisti e compositori più importanti e contesi tra Natalino Otto e il Quartetto Cetra, in sintesi i pionieri del jazz italiano più autentico. Il resto della sua lunghissima carriera è consegnato alla storia e alla leggenda con collaborazioni da far tremare le vene e i polsi, con le star più luminose del firmamento della musica di ispirazione afroamericana. Oltre ai nomi già citati ricordiamo almeno: Billie Holiday, Chet Baker – del quale fu contrabbassista per tre anni – Wes Montgomery, Mal Waldron, Dizzy Gillespie e centinaia di altri in una stagione di sogni in musica del tutto irripetibile.
È superfluo citare tutti i suoi successi e la sua discografia infinita. Per evocare tutta un’epoca basta ricordare ancora il suo sodalizio con Nicola Arigliano, grande crooner della canzone italiana, oggi quasi dimenticato dal grande pubblico ma che fu un talento inimitabile, che condivise con il chitarrista anche una vasta fama catodica dovuta, tra l’altro, a iconici spot pubblicitari della televisione d’antan.
Fantastica la loro interpretazione del classico Cherokee di Charlie Parker a Sanremo nel 1959, con Cerri alla chitarra Manouche-Maccaferri proprio come quella di Django Reinhardt. I due calcarono ancora un’ultima volta il palco di Sanremo in una memorabile serata del 2005.
Tra le sue incisioni più recenti vale la pena di ricordare anche quella con Antonio Onorato del 2016, recensita con grande favore su questa stessa rivista nel 2016 dall’ottima Marina Tuni. Un duo chitarristico spettacolare nel quale, sulla base di alcuni standard, Cerri, a 91 anni suonati, si metteva ancora una volta alla prova con musicisti molto più giovani di lui e di diversa formazione, come quelli che componevano la fantastica sezione ritmica di quel disco straordinario, giovani Maestri del Jazz italiano come Simone Serafini e Luca Colussi.
Vogliamo ricordarcelo così Franco Cerri con il sorriso sempre stampato sulla faccia e la chitarra imbracciata. Come diceva quella vecchia canzone di Vera Lynn: “ We’ll meet again, don’t know where, don’t know when, but I know we’ll meet again some sunny day…”
Flaviano Bosco
La foto di copertina è di Angelo Salvin
da Amedeo Furfaro | 25/Giu/2021 | News, Primo piano
Da semplici curiosi di filatelia ci siamo imbattuti nella bella emissione dedicata a Joe Zawinul dall’Austria, cioè da un grande paese di Eurolandia, agli onori della cronaca per la disfida calcistica fra le due nazionali agli europei, e non una lontana repubblica papuasica.
Una nazione in cui il jazz e i jazzisti godono di una considerazione elevata tant’è che il citato tastierista e compositore viennese viene celebrato con francobolli che ne veicolano ed associano l’immagine nel mondo con migliaia di esemplari spediti a tutte le latitudini.
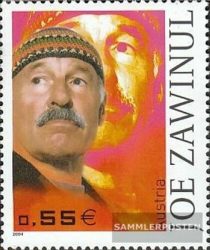 Il pensiero va allora alla proposta apparsa su queste colonne il 24 marzo 2017 di Affrancare il jazz con una serie di francobolli sul grande jazz italiano ribadita l’anno dopo con un ritorno giornalistico datato 18 maggio.
Il pensiero va allora alla proposta apparsa su queste colonne il 24 marzo 2017 di Affrancare il jazz con una serie di francobolli sul grande jazz italiano ribadita l’anno dopo con un ritorno giornalistico datato 18 maggio.
La nota era stata poi inviata al competente Ministero per la relativa valutazione e l’eventuale individuazione di eccellenze jazzistiche da effigiare.
Ad oggi non si hanno notizie di rilievo al riguardo. Vero è che l’uso del francobollo su lettera va gradualmente cadendo in desuetudine ma ci risulta che gli sportelli filatelici offrano periodicamente stamp di vario argomento.
Ne riparliamo ancora nella convinzione che l’Italia, oltre ad aver dato i natali a Verdi e Puccini, Vivaldi e Pavarotti, Modugno e Mino Reitano, Tenco e Nino Rota, sia anche la terra di Gaslini, Gorni Kramer, Arigliano, Basso, Dora Musumeci, Massimo Urbani, Luca Flores…
Stavolta comunque l’articolo non verrà tradotto in istanza burocratica.
Rimarrà a livello di semplice riflessione, ripensando al ricordo di una jazzistica notte di mezza estate a Saalfelden, rinverdito dalla visione di un semplice francobollo. Di Poste austriache, si precisa, mentre si resta in attesa di analoghe iniziative pro-jazz dai competenti organi bel paesani.
Amedeo Furfaro
da Amedeo Furfaro | 09/Apr/2021 | News, Primo piano
In genere, conversando di economia della musica, tendiamo a dividere i nostri interlocutori in due categorie: da una parte i puristi che, sulla scia di Adorno, sono contrari ad ogni tipo di mercificazione della musica, jazz compreso, che avvenga tramite mass media; dall’altra i realisti, o “responsabili”, i quali ritengono che il jazz non possa stare assiso su un piedistallo ad auto-contemplare narcisisticamente le proprie beltà e debba invece posare i piedi “per terra”.
Non è facile individuare quale sia la giusta scelta di campo specie quando il discorso sui media si sposta sulla pubblicità. E non quella che attiene al “prodotto” festival, concerto, disco, clinics etc. insomma l’involucro con cui si avvolge l’oggetto o l’evento.
Il nodo è sulla musica che viene “applicata” ad un prodotto industriale per rafforzarne la forza comunicativa, a volte però sfalsando la “finalità” originaria della musica stessa.
Caso di scuola il tormentone “La pancia non c’è più” nello spot tv di un famoso olio d’oliva associato a “Il mattino” di Grieg. Il compositore norvegese tutto si sarebbe aspettato nel comporre la suite del Peer Gynt tranne che il suo Morning Mood, nel 1966, avrebbe commentato incubi da grassi in eccesso dovuti a problemi di cattiva digestione serale di un uomo qualunque. Dura lex (pubblicitaria) sed lex, si dirà. Però le note di Grieg, grazie a quella trovata, sarebbero diventate familiari anche fuori dalla tavola degli italiani assurgendo indirettamente a chiara fama!
Ma allora la musica, se resa funzionale ad un’esigenza commerciale, può o meno ritenersi in qualche modo “svenduta”?
Il dilemma andrebbe aggiornato con più precisa sintesi adattata alla piega presa da un certo andamento massmediatico: essere o non essere… (nazional)popolare?
Il nodo è come fare a mantenere l’ “integrità” artistica pur prestando il fianco alle lusinghe del mercato che offre vantaggi in termini di ritorno economico e/o benefici a livello di visibilità. Domande, queste, a cui è difficile dare una risposta tramite monosillabi. Sulla carta, la scelta la detta anzitutto il consumatore ma sono gli “operatori comunicativi” che, imbeccati dalla clientela, nel decifrarne l’identikit in base ad indagini di mercato, tentano di orientarlo tramite persuasivi “consigli per gli acquisti”. Questi ultimi sono impartiti per trasmettere al massimo grado la spinta alla spesa. Saranno poi i committenti a giudicare i risultati ma più sul piano della quantità (lo share, i contatti, l’audience, gli incrementi di vendite etc… ) che di qualità.
Gli spazi costano un tot a secondo o a cm ed allora urge l’affondo che deve essere il più possibile attrattivo rispetto al target, considerato che il destinatario non è l’homo “auscultans” bensì l’utilizzatore “finale”, primo decisore della compera.
La pubblicità, connessa strettamente ad altre forme di comunicazione mediatica come stampa radio cinema tv affissione elettronica web, si alimenta di musica e con il jazz ha inanellato dei momenti di sinergia. Se ne rintracciano ad esempio sul piano discografico nella serie “Top of the Spot”. Nel cd Polygram del 1998 si ritrovano “pezzi indimenticabili di famose pubblicità” con standard interpretati da Quincy Jones, Dinah Washington, Billie Holliday, Nina Simone, Ella & Louis, Anita O’Day, Sarah Vaughan…
Tracce di jazz persistono anche negli altri album della serie ma la curva tende a scendere. La ABC Production nel 2018 lamentava “Quando c’era Top of the Spot” ed in effetti non si trovano in rete riferimenti recenti a compilation del genere.
Ma vediamo quali potrebbero essere le opzioni per un pubblicitario che volesse servirsi del jazz per promuovere un qualsiasi articolo: – mettere sotto contratto un jazzista con relativo uso dell’immagine in spot (tipo Franco Cerri che fronteggiava l’attore Paolo Ferrari nel suggerire il giusto detersivo alle casalinghe o un Armando Trovajoli che nel manifesto suggeriva di bere una nota sambuca per essere “fra la gente che conta”) o da sponsor – o meglio testimonial – tipo Nicola Arigliano che tesseva le lodi di un famoso digestivo anticipando il Woody Allen comparso nel 1967 sul manifesto di una premiata vodka russa; – prelevare un jingle da un brano o l’intero brano assolvendo gli obblighi verso i titolari del copyright; – uso-tappezzeria della musica, come sfondo più o meno lontano rispetto all’immagine principale su cui si fonda lo spot;
– inserire musica, jazz nello specifico, senza “cambi di rotta” e qui l’esempio più veritiero pare essere, nello storico Carosello Tv, il “reportage” con cui la Facis “confeziona” per il piccolo schermo nel 1973 profili di jazzisti come Enrico Intra, Dino Piana, Gianni Basso, Gil Cuppini, con lo slogan “a ciascuno il suo guardaroba” .
Il filmato Jazzisti n. 1 “, con il marchio dall’Archivio Nazionale Cinema d’Impresa”, è visibile su Youtube. Ancor prima, nel 1957, erano stati Lelio Luttazzi e Gorni Kramer ad eseguire una spassosa “Vecchia America” (www.mondocarosello.com), sponsor una nota marca di dadi per brodo. Il discorso sulla funzione “didattico-divulgativa” degli story-board di Carosello ci porterebbe lontano. Fatto è che quel modulo italiano di programma ante-prima serata tv resta inimitato. All’epoca peraltro non c’era l’assillo velocista di chi fa oggi comunicazione pubblicitaria ed il “tempo” veniva gestito senza affanno al punto da consentire sketches anche di ambientazione teatrale o cinematografica di ottima fattura e persino “concessioni” a jazz e jazzmen.
O tempora o mores! Se si pensa a come hanno furoreggiato nel 2020 spot con, fra gli altri, Lady Gaga e David Bowie, BTS e Mengoni, si vede come sia il pop d’autore ad avere il sopravvento in molte campagne pubblicitarie (www.sorrisicanzoni.com).
Il jazz, musica diffusa a livello planetario, non sempre ha quella immediatezza che altri generi possiedono. Perdere terreno in pubblicità però non è un bene specie in un momento storico di riduzione delle risorse pubbliche e di nuova “debolezza” strutturale del sistema di musica e spettacolo. Solo che, al tempo dei new media e del dominio dei banner, rimpiangere Carosello non è di per sé una soluzione.
Concludiamo invitando art buyer e art director delle agenzie pubblicitarie ad avvicinarsi di più al jazz senza preconcetti e con spirito innovativo, superando certi diffusi stereotipi, perché no, cominciando dall’adottare anche soluzioni miste come poteva essere l’accoppiata Bollani-Vergassola in uno spot di alcuni anni fa.
Jazz e pubblicità sono, in fondo, due mondi popolati da creativi.
E la pubblicità è un medium artistico, un hub in cui si insegue un’idea originale, la si materializza e la si offre alla possibile intercettazione del pubblico. Come nel jazz.
Amedeo Furfaro
da Gerlando Gatto | 12/Gen/2021 | News, Primo piano
C’è un paradosso che francamente non riesco ancora a spiegarmi: Dora Musumeci è stata una grandissima artista, la prima pianista e cantante jazz italiana che ha ottenuto incredibili successi anche al di fuori dei confini nazionali. Eppure le varie storie del jazz, scritte sia da stranieri sia da italiani, non ne fanno menzione. Anche le più moderne, le più pretenziose, magari scritte a quattordici mani, se la cavano con una semplice citazione, nulla di più. Come mai? Un mistero cui non so dare una logica spiegazione. E’ per questo motivo che ho deciso di riproporvi un bell’articolo pubblicato dal “Sicilian Post” a firma del collega Giuseppe Attardi. (G.G.)
 È siciliana non solo la prima cantautrice italiana, Rosa Balistreri, ma anche la prima pianista e cantante jazz italiana: Dora Musumeci. E la Sicilia è stata capace di dimenticare entrambe. Se dell’artista di Licata si è cominciato in ritardo a celebrarla con sparute e disarticolate iniziative, la musicista catanese sembra essere caduta nel dimenticatoio. Eppure, da molti fu considerata la “Regina dello swing”, tanto da essere corteggiata da Broadway.
È siciliana non solo la prima cantautrice italiana, Rosa Balistreri, ma anche la prima pianista e cantante jazz italiana: Dora Musumeci. E la Sicilia è stata capace di dimenticare entrambe. Se dell’artista di Licata si è cominciato in ritardo a celebrarla con sparute e disarticolate iniziative, la musicista catanese sembra essere caduta nel dimenticatoio. Eppure, da molti fu considerata la “Regina dello swing”, tanto da essere corteggiata da Broadway.
La musica la piccola Giulia Isidora Musumeci l’aveva respirata sin dai primi vagiti: il padre, Totò, era violino di fila al Teatro Bellini, il fratello Tito suonava il contrabbasso, la nonna era una eccellente pianista per diletto. Insomma, il ritmo Giulia Isidora lo aveva nel sangue. Enfant prodige, già a 6/7 anni si esibiva, suonando il piano in una orchestrina con la quale effettuerà nel Dopoguerra un tour in Tripolitania. La chiamavano perché lei era capace di leggere e suonare immediatamente tutti i pezzi che le proponevano. A 9 anni chiese al padre di mandarle a ritirare direttamente dagli States gli spartiti di George Gershwin, che da quel momento sarà il suo punto di riferimento. Attraverso l’autore di Porgy & Bess scoprirà il jazz e se ne innamorerà.
Ed è mentre accompagna ballerini, comici e soubrette, che si sparge la voce di questa favolosa pianista che suona la musica degli afroamericani.
Forse insegue e sogna Broadway quando, subito dopo aver conseguito a 18 anni il diploma di pianista al San Pietro a Majella di Napoli, sceglie il nome di Dora e presta il suo piano alla rivista. Ed è mentre accompagna ballerini, comici e soubrette, che si sparge la voce di questa favolosa pianista che suona la musica degli afroamericani. “Musica Jazz” le dedica un articolo monografico, lei comincia a girare per l’Italia esibendosi con i grandi della musica, soprattutto jazz, come Dizzy Gillespie e Lionel Hampton. In questo stesso periodo, forma la sua prima band e incide le sue prime opere, che la porteranno in tour in Spagna, Francia, Portogallo, Germania, Belgio e Svizzera.
«Dora è stata la prima grande pianista jazz, un talento straordinario: per lei la musica era un elemento naturale», ricorda Roby Matano, musicista cantante de I Campioni, che per due anni lavorò con la musicista etnea. «Fu suo padre a chiedermi di entrare nel complesso di Dora come cantante/bassista. Con lei si creò subito un’intesa artistica perfetta e una grande fraterna amicizia. Fu un periodo di tournée in tutta Italia: ricordo per esempio il locale L’Oleander a Ischia dove, tra i grandi personaggi che lo frequentavano (attori, giornalisti, ecc.), c’era anche Alfred Hitchcok, anche lui in vacanza a Ischia: a lui piaceva molto la canzone napoletana, in particolare ‘O Marenariello. Il mio rapporto con Dora si interruppe a Viareggio, mentre eravamo al Principe di Piemonte per il veglione di Carnevale, ospite d’onore Gina Lollobrigida… mi arrivò la notizia che dovevo partire per il servizio militare».
Negli anni Sessanta arriva a Roma e porta il jazz nel “tempio del beat”, al Piper club. Fu un successone, tanto che Arrigo Polillo scrisse: «Che l’avvenire del jazz sia nelle mani femminili?».
Nel 1956 Dora vince il Festival del jazz di Modena Dora e pubblica per la Cetra il suo primo album: La regina dello swing. Fu registrato a Torino, a casa di Gorni Kramer che suonava il contrabbasso, mentre Gil Cuppini stava alla batteria. Negli anni Sessanta arriva a Roma e porta il jazz nel “tempio del beat”, al Piper club, esibendosi con Romano Mussolini e Lionel Hampton. «Ed ora vi lascio con questa meravigliosa pianista», la presentò una sera Nunzio Rotondo, con il quale suonava, lasciandola sola con la ritmica. Fu un successone, tanto che Arrigo Polillo scrisse: «Che l’avvenire del jazz sia nelle mani femminili?».
 Seguirono tantissimi concerti, radio, televisione, Dora ebbe parte attiva nel mondo del cinema, registrando alcuni brani per colonne sonore assieme a importanti compositori, tra cui il maestro Ennio Morricone, Romano Mussolini e Giovanni Tommaso. Con il compianto autore di C’era una volta il West, incise il 45 giri Caffè e camomilla, sulla cui copertina era presentata con queste parole. «Ragazza dal viso aperto e dagli occhi luminosi nei quali si riflettono i colori della Sicilia. Pianista ben preparata e appassionata di jazz: qualcuno sentendola cantare e accompagnarsi con tanta carica di swing, l’ha definita la Nelly Lutcher italiana. Non c’è dubbio che Dora Musumeci sia su un livello artistico molto elevato, anche perché sa esprimere con particolare eleganza la sua natura di donna romantica e di ragazza moderna. Un contrasto messo in evidenza da Caffè e camomilla».
Seguirono tantissimi concerti, radio, televisione, Dora ebbe parte attiva nel mondo del cinema, registrando alcuni brani per colonne sonore assieme a importanti compositori, tra cui il maestro Ennio Morricone, Romano Mussolini e Giovanni Tommaso. Con il compianto autore di C’era una volta il West, incise il 45 giri Caffè e camomilla, sulla cui copertina era presentata con queste parole. «Ragazza dal viso aperto e dagli occhi luminosi nei quali si riflettono i colori della Sicilia. Pianista ben preparata e appassionata di jazz: qualcuno sentendola cantare e accompagnarsi con tanta carica di swing, l’ha definita la Nelly Lutcher italiana. Non c’è dubbio che Dora Musumeci sia su un livello artistico molto elevato, anche perché sa esprimere con particolare eleganza la sua natura di donna romantica e di ragazza moderna. Un contrasto messo in evidenza da Caffè e camomilla».
In quegli stessi anni prese parte al festival di Comblain-la-Tour, dove suona con Cannonball Adderley.
«Ai pianisti maschietti il mio successo non fece tanto piacere e cercarono di mettermi, in tutti i modi, i bastoni fra le ruote. Prima erano loro che chiamavano me, adesso ero stata io a chiamare loro e questo dava fastidio»
La piccola Dora diventa la “first lady” italiana del jazz che le donne le voleva al massimo cantanti, muse, ma non musiciste. Dora è una pioniera: pelle bruna, anelli d’oro alle orecchie, treccione nero sul prendisole a righe “alla marinara”, lei sta in mezzo a Intra, Gaslini, Cerri, che di nome fanno Enrico, Giorgio, Franco, mentre il suo termina per “a”, Dora come Donna. «Ai pianisti maschietti il mio successo non fece tanto piacere e cercarono di mettermi, in tutti i modi, i bastoni fra le ruote», accusò in una intervista a Gerlando Gatto, pubblicata nel libro L’altra metà del jazz, ricordando uno specifico episodio: «Fui invitata a un festival a Torino: ero una sorta di organizzatrice di regina del festival e feci venire Carlo Loffredo, Romano Mussolini, ma tutti questi erano distaccati, quasi incattiviti, probabilmente pensavano che mi stessi impadronendo della situazione: prima erano loro che chiamavano me, adesso ero stata io a chiamare loro e questo dava fastidio».

Delusa dal mondo misogino del jazz, Dora respinge le avances che le arrivano da Broadway e negli anni Settanta abdica al trono di “regina dello swing” per dedicarsi alla musica classica, suo primo amore, soprattutto a quella di Debussy, Bach, Rachmaninoff. Compose musiche per spettacoli radiofonici, tra cui nel 1972 La scuola dei buffoni di Michel de Ghelderode, per la regia di Romano Bernardi. Collabora con il Teatro Stabile di Catania (ben venti produzioni) ed è spesso protagonista di recital al Bellini, nel frattempo insegna pianoforte al Conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria. Nel 1994 venne nominata Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica, come eccellenza italiana nel mondo. Dieci anni dopo muore, uccisa da un pirata della strada nei pressi del Corso Italia, dopo un lungo periodo di coma. Dimenticata dal jazz e dalla sua città.
Giuseppe Attardi
da Amedeo Furfaro | 16/Mar/2019 | News, Primo piano

A tutela del mercato musicale italiano la Lega ha proposto di garantire almeno una canzone italiana su tre nelle trasmissioni radio. Fra i favorevoli Mogol, Baudo e Al Bano. Fra i contrari conduttori come Linus e musicisti /produttori discografici come Saturnino Celani. Abbiamo provato, tramite uno dei redattori di questa testata, ad evidenziare il nostro punto di vista, ovviamente jazzistico, nella seguente nota
——————————
Se una radio è libera, ma è libera veramente: con che spirito Finardi canterebbe oggi questo riff dopo la svolta “protettiva”, non protezionistica, preannunciata dalla proposta di legge (primo firmatario l’on. Alessandro Morelli) recante “Disposizioni in materia di programmazione radiofonica della produzione musicale italiana”.
L’intento è nobile: la difesa della italianità melodica e dei diritti autoriali, contro le incursioni barbariche, in senso musicale, ovviamente. Da attuare riservando almeno un terzo della “programmazione giornaliera alla produzione musicale italiana, ad opera di autori e artisti italiani e incisa e prodotta in Italia” e una quota del 10%, sempre a cura delle emittenti radiofoniche, nazionali e private “alle produzioni degli artisti
emergenti”. .
Un sistema di quote in uso già in Europa, in particolare in Francia dove, grazie alla legge Toubon del 1994, la percentuale è fissata al 40% della produzione radio giornaliera.
Una legge aspramente avversata, all’epoca, da linguisti come Tullio De Mauro, le cui origini risalgono alla politica linguistica di De Gaulle. Oggi, in Italia, non è che si inseguano propositi di grandeur. Il fatto è che, secondo dati Siae riferiti dal presidente Mogol, su dieci stazioni radiofoniche solo quattro avrebbero rispettato la soglia del 33%” fra il 2010 e il 2017.
 Ma il rimedio, così come proposto, è la soluzione giusta? Il pianista Simone Graziano, presidente Midj, Musicisti Italiani Di Jazz, osserva che “in assoluto il principio si potrebbe estendere per esempio ai festival, riservando un terzo dei concerti ai musicisti italiani”. Ed aggiunge che la misura sarebbe veramente positiva specie “se rivolta alla musica di qualità più che di quantità”. La considerazione tocca un punto nevralgico del provvedimento in itinere che appare di evidente significato politico, artistico ed economico. Fra i pareri più autorevoli di segno contrario da citare Francesco De Gregori: “non so cosa sarebbe stata la mia vita da musicista se non avessi potuto ascoltare fin da piccolo tutte le canzoni straniere che ho sentito”. E mugugni sono apparsi sul web dal mondo della musica afroamericana, che è quello fra i più esposti all’abbraccio “contagioso” di (im)migrazioni musicali. Visto che in materia, peraltro, viene sollecitato dagli stessi proponenti il dibattito… diciamo la nostra.
Ma il rimedio, così come proposto, è la soluzione giusta? Il pianista Simone Graziano, presidente Midj, Musicisti Italiani Di Jazz, osserva che “in assoluto il principio si potrebbe estendere per esempio ai festival, riservando un terzo dei concerti ai musicisti italiani”. Ed aggiunge che la misura sarebbe veramente positiva specie “se rivolta alla musica di qualità più che di quantità”. La considerazione tocca un punto nevralgico del provvedimento in itinere che appare di evidente significato politico, artistico ed economico. Fra i pareri più autorevoli di segno contrario da citare Francesco De Gregori: “non so cosa sarebbe stata la mia vita da musicista se non avessi potuto ascoltare fin da piccolo tutte le canzoni straniere che ho sentito”. E mugugni sono apparsi sul web dal mondo della musica afroamericana, che è quello fra i più esposti all’abbraccio “contagioso” di (im)migrazioni musicali. Visto che in materia, peraltro, viene sollecitato dagli stessi proponenti il dibattito… diciamo la nostra.
Ciò che la normativa (adottanda?) potrebbe meglio individuare è la “cifra” artistica, visti i rapporti di forza in campo.
In parole povere se la tutela fosse generica finirebbe nel rafforzare (oltre giustamente al belcanto) anzitutto quel genere “nazionalpop” che già fruisce di spazi cospicui sui network radiofonici e non solo tali. Perché allora non agevolare, in modo non costrittivo, settori (non chiamiamoli minori, né deboli perché la loro caratura artistica ė il più delle volte, notevole) che stentano ad avere il risalto che meriterebbero? Insomma se proprio si vuol meglio promuovere la musica ‘patriota’, perché non offrire corsie preferenziali a quella meno gettonata dalle radio, tipo sinfonica, classica, etnica, ed anche, se permettete, il jazz “fatto in casa”? Non siamo più ai tempi di Pietro Bembo, della polemica puristi-antipuristi, dell’opposizione agli internazionalismi. E la musica neroamericana fa parte ormai, dai tempi di Sesto Carlini e Gorni Kramer, della nostra cultura. Ciò posto, insistiamo sull’ opportunità che, se si va verso la citata delimitazione di controlli ideali alle frontiere, sarebbe il caso di premiare le cenerentole prima delle principesse.
È vero, c’è Rai Radio3, ci sono le radio web specialistiche e via elencando.
Eppure quanto proposto potrebbe delineare una traccia giuridica anche per quanto si sta per legiferare in tutto l’ambito musicale (legge sullo spettacolo, Alta Formazione…) fornendo segnali di un’attenzione miratamente selettiva. Oltretutto, dando voce a generi diversi dal seminato, si ridurrebbero i rischi di ripetitività nell’ascolto (accade spesso che, pur cambiando frequenza, si senta trasmettere lo stesso brano). Etere o non etere, questo è il problema: che le emittenti diventino un campo aperto, ma differenziato, e la musica italiana tutta, anche quella strumentale, sia vista come un fiume in piena che attende solo di debordare dagli argini.
Al di là della linea più o meno “nazionalistica” che si riterrà di adottare, resta positivo il fatto che in Parlamento si lavori per delineare indirizzi che disciplinino il fascinoso caos anarcoide/neoliberistico del mercato musicale italico, con uno sguardo a giovani artisti e piccole etichette. Resta la speranza che, se pure si vuol regolare il laissez faire laissez passer di musiche “straniere” che contaminano la purezza indigena, si possano aprire nuovi varchi legislativi nella direzione sopracitata: affinché sempre più la musica, per citare ancora “La radio” di Finardi, liberi la mente.
Amedeo Furfaro
 A dire il vero, dopo il primo melodico Sanremo del ’51, una decisa aura jazz si era avvertita in Nati per la Musica, un programma con Jula De Palma, Quartetto Cetra, Teddy Reno che si avvaleva delle orchestre di ritmi moderni di Gorni Kramer e Lelio Luttazzi, la cui sigla è ascoltabile sul Portale della Canzone Italiana dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi (www.canzone italiana.it/1zlns). Sorella Radio avrebbe dato anche in seguito significativi contributi alla causa jazzistica – si pensi all’uso fatto da Radio1 dello stacco di “Country“ tratto dal cd “My Song” di Jarrett con Garbarek, Danielson e Christensen (ECM, 1977) – ma il copioso materiale di Mamma Rai, con il ricchissimo archivio sonoro ad oggi digitalizzato, meriterebbe di essere approfondito in altra sede. Torniamo allora al come eravamo tramite il cosa guardavamo. Dopo la vittoria di Modugno all’Ariston nel ’58, con una “Nel blu dipinto di blu” a ritmo swing, nell’anno di grazia televisivo 1961 passavano in video le immagini di Moderato Swing che era anche il titolo della sigla di Piero Umiliani. Un biennio ancora per poi sentire il canto e la tromba di Nini Rosso echeggiare in “I ragazzi del jazz”, sigla di Fuori I ’Orchestra, epica trasmissione, per la regia di Lino Procacci, che si avvaleva della direzione musicale dello stesso Umiliani. Si trattava di una rubrica che si occupava “di musica equidistante fra quella leggerissima e quella classica“ (www.umiliani.com) che rimane una pietra miliare della televisione italiana. Fra i numeri fissi c’erano quello dedicato al Jazz made in Italy ed l’altro spazio denominato Parole e musica che registrava partecipazioni lussuose tipo la cantante Helen Merrill. Da segnalare che Umiliani avrebbe poi collaborato con I Marc 4 (acronimo di Maurizio Majorana, Antonello Vannucchi, Roberto Podio, Carlo Pes), gruppo operante fra ’60 e ’76, a cui è da ascrivere la sigla di Prima Visione (su album Ricordi, 1974). Il 1963 resta un anno significativo per il jazz sul piccolo schermo anche perché decollava in Italia, con TV7, l’idea di utilizzare un brano jazz come intro di un programma d’inchiesta. Per l’occasione la scelta cadeva su “Intermission Riff” di Stan Kenton, poi sostituita con una storica versione dell’Equipe 84. A fine decennio toccava alla serie tv Nero Wolf diretta da Giuliana Berlinguer con Tino Buazzelli, vedere impressi i titoli di testa e di coda dalla tromba di Nunzio Rotondo sulla base elettronica di Romolo Grano, musica da noir con echi dal lungometraggio di Louis Malle Ascenseur pour l’échafaud, del ’58, sonorizzato da Miles Davis, trombettista a cui Rotondo è stato spesso accostato. Ed avrebbe “aperto” un thriller televisivo il compositore Berto Pisano con la sua “Blue Shadow”, sigla lounge dello sceneggiato Ho incontrato un’ombra del 1974, che figura nella classifica stilata da “Rolling Stone” il 26 agosto 2020 in Fantasmi e storie maledette. Le migliori sigle della tv italiana del mistero degli anni ’70. In tema di rotocalchi da menzionare che AZ un fatto come e perché (in onda dal ‘70 fino al luglio ’76) adottava un pezzo del repertorio jazz, esattamente “Hard to Keep My Mind of You”, di Woody Herman.
A dire il vero, dopo il primo melodico Sanremo del ’51, una decisa aura jazz si era avvertita in Nati per la Musica, un programma con Jula De Palma, Quartetto Cetra, Teddy Reno che si avvaleva delle orchestre di ritmi moderni di Gorni Kramer e Lelio Luttazzi, la cui sigla è ascoltabile sul Portale della Canzone Italiana dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi (www.canzone italiana.it/1zlns). Sorella Radio avrebbe dato anche in seguito significativi contributi alla causa jazzistica – si pensi all’uso fatto da Radio1 dello stacco di “Country“ tratto dal cd “My Song” di Jarrett con Garbarek, Danielson e Christensen (ECM, 1977) – ma il copioso materiale di Mamma Rai, con il ricchissimo archivio sonoro ad oggi digitalizzato, meriterebbe di essere approfondito in altra sede. Torniamo allora al come eravamo tramite il cosa guardavamo. Dopo la vittoria di Modugno all’Ariston nel ’58, con una “Nel blu dipinto di blu” a ritmo swing, nell’anno di grazia televisivo 1961 passavano in video le immagini di Moderato Swing che era anche il titolo della sigla di Piero Umiliani. Un biennio ancora per poi sentire il canto e la tromba di Nini Rosso echeggiare in “I ragazzi del jazz”, sigla di Fuori I ’Orchestra, epica trasmissione, per la regia di Lino Procacci, che si avvaleva della direzione musicale dello stesso Umiliani. Si trattava di una rubrica che si occupava “di musica equidistante fra quella leggerissima e quella classica“ (www.umiliani.com) che rimane una pietra miliare della televisione italiana. Fra i numeri fissi c’erano quello dedicato al Jazz made in Italy ed l’altro spazio denominato Parole e musica che registrava partecipazioni lussuose tipo la cantante Helen Merrill. Da segnalare che Umiliani avrebbe poi collaborato con I Marc 4 (acronimo di Maurizio Majorana, Antonello Vannucchi, Roberto Podio, Carlo Pes), gruppo operante fra ’60 e ’76, a cui è da ascrivere la sigla di Prima Visione (su album Ricordi, 1974). Il 1963 resta un anno significativo per il jazz sul piccolo schermo anche perché decollava in Italia, con TV7, l’idea di utilizzare un brano jazz come intro di un programma d’inchiesta. Per l’occasione la scelta cadeva su “Intermission Riff” di Stan Kenton, poi sostituita con una storica versione dell’Equipe 84. A fine decennio toccava alla serie tv Nero Wolf diretta da Giuliana Berlinguer con Tino Buazzelli, vedere impressi i titoli di testa e di coda dalla tromba di Nunzio Rotondo sulla base elettronica di Romolo Grano, musica da noir con echi dal lungometraggio di Louis Malle Ascenseur pour l’échafaud, del ’58, sonorizzato da Miles Davis, trombettista a cui Rotondo è stato spesso accostato. Ed avrebbe “aperto” un thriller televisivo il compositore Berto Pisano con la sua “Blue Shadow”, sigla lounge dello sceneggiato Ho incontrato un’ombra del 1974, che figura nella classifica stilata da “Rolling Stone” il 26 agosto 2020 in Fantasmi e storie maledette. Le migliori sigle della tv italiana del mistero degli anni ’70. In tema di rotocalchi da menzionare che AZ un fatto come e perché (in onda dal ‘70 fino al luglio ’76) adottava un pezzo del repertorio jazz, esattamente “Hard to Keep My Mind of You”, di Woody Herman. Dal giornalismo d’inchiesta a quello sportivo: nel ’78 era il turno di Jazz Band di Hengel Gualdi a far da “preludio” a Novantesimo minuto, storica rubrica di RaiSport, e come non citare, dal campionario di La Domenica Sportiva, “Dribbling” di Piero Umiliani (1967), “Winning The West” della Buddy Rich Big Band (1973), “Mexico” di Danilo Rea e Roberto Gatto (1985), “Breakout” di Spyro Gira (1991)? Spostandoci alla “pagina” spettacoli, fra il ’76 e il ‘78, Rete 2 dava spazio in Odeon al pianista Keith Emerson (senza Lake e Palmer) in “Odeon Rag” arrangiamento di “Maple Leaf Rag” di Scott Joplin, subentrato in luogo del precedente “Honky Tonk Train Blues”, autore il pianista Meade Lux Lewis. Il filone spettacolistico avrebbe registrato più in là significativi esempi con lo scat di Lucio Dalla con gli Stadio che annuncia Lunedifilm per un buon ventennio fino al 2002 e l’ellingtoniano “Take The A Train” di Strayhorn a fare da intro ai trailer cinematografici assemblati da AnicaFlash per la rassegna delle novità cinematografiche “di stagione”. Si diceva come luogo fertile per la semina tv di suoni jazz da filtrare nelle orecchie dei telespettatori fosse l’informazione. Gettonatissima rimane al riguardo la sigla di Mixer (1980-1996) ovvero “Jazz Carnival” dei brasiliani Azimuth, specialisti del samba doido, genere fusion-funky. Latin come nelle radiocronache di Tutto il calcio minuto per minuto, dove Herb Alpert e Tijuana Brass interpretano “A Taste of Honey”, brano di stampo pop, in repertorio a Beatles e Giganti (“In paese è festa”). Per la tv italiana va ricordato che, fuori dal reticolo giornalistico, si contano altre occasioni più dirette di esposizione per la musica jazz filtrata tramite il piccolo schermo. La Portobello Jazz Band di Lino Patruno “presentava” il programma di Enzo Tortora (cfr. La tana delle sigle in tds.sigletv.net) nel 1978, stesso anno dello sceneggiato in 3 puntate Jazz Band di Pupi Avati, colonna sonora di Amedeo Tommasi, con il clarino di Hengel Gualdi in evidenza nelle sigle di apertura e chiusura, “Jazz Band” e “Swing Time” ; poi ancora Di Jazz in Jazz, programma “dedicato” con relativa sigla a cura dell’Orchestra Big Band della Rai diretta da Giampiero Boneschi e Franco Cerri (www.teche.rai.it). “Schegge”, queste ultime, che costituivano una vetrina per il jazz di casa nostra in una situazione in cui il format varietà si teneva alquanto distante, a differenza di quanto avveniva negli U.S.A. . Dalle nostre parti vanno citati comunque Milleluci, show datato 1974, nella cui sigla finale “Non gioco più” Mina duetta con l’armonica di Toots Thielemans, Palcoscenico, in onda fra 1980 e 1981, con Milva accompagnata da Astor Piazzolla mentre scorrono i titoli di coda in “Fumo e odore di caffè” e Premiatissima del 1985 dove il crooner Johnny Dorelli canta “La cosa si fa“ su base swing “metropolitano. Lo sdoganamento delle sigle jazz nei varietà proseguiva con Renzo Arbore (e Gegè Telesforo) a cui si deve “Smorza e’ lights (Such a night)” incipit di Telepatria International, inizio trasmissioni il 6 dicembre 1981 (www.arboristeria.it – Renzo Arbore Channel). Per la cronaca il 18 marzo 1981, e fino al 1989, sarebbe andata in onda la prima edizione di Quark di Piero Angela, conduttore nonché apprezzato pianista jazz. La trasmissione di divulgazione scientifica sarebbe stata simbioticamente legata alla sigla, la “Air for G String” di Bach, eseguita da The Swingle Singers, pubblicata nell’album “Jazz Sèbastian Bach” (1963), peraltro incisa anche insieme al Modern Jazz Quartet in “Place Vendòme”, album del ’68 della Philips. Terminiamo questa breve carrellata, che non include per sintesi le emittenti private/commerciali pro-tempore, per ricordare la sigla swing di DOC Musica e altro a denominazione d’origine controllata (1987-1988) di Arbore, Telesforo e Monica Nannini, esempio di come coinvolgere il jazz in un contenitore di buona musica. Il breve excursus è stato uno squarcio fugace su una jazz age, grossomodo racchiusa fra ’54 e ’94, un fugace momento di (bel) spaesizzazione musicale segnato, al proprio interno, dal passaggio dall’analogico al digitale, fase che precedeva la successiva della tv satellite e quella attuale della connessione via internet con la diffusione dei social e di new media come le web-tv con piattaforme on demand. E’ stato osservato che nella tv generalista di oggi “il jazz non ha più la stessa presa pubblica di un tempo” (cfr. Il jazz e le sigle radiotelevisive, riccardofacchi.wordpress.com, 2/8/2016). E “CiakClub.it” ha pubblicato, a firma di Alberto Candiani, un elenco con Le 20 migliori sigle televisive di sempre: Da Friends a Il trono di spade la lista delle più affascinanti iconiche e meglio congeniate sigle delle serie tv senza che ne compaia qualcuna (simil)jazz. Vero! Ci sono molti set televisivi in cui il jazz fa comparse episodiche. C’è poi che, a causa dell’affinarsi delle tecnologie digitali, molte sigle vengono confezionate a tavolino e, perdendo in istantaneità, sono sempre meno frutto di incisioni live né tantomeno vengono selezionate fra materiali preesistenti. Ed è forse tutto ciò che ammanta quei “primi quarant’anni” di tv “eterea” di un irripetibile sapore amarcord.
Dal giornalismo d’inchiesta a quello sportivo: nel ’78 era il turno di Jazz Band di Hengel Gualdi a far da “preludio” a Novantesimo minuto, storica rubrica di RaiSport, e come non citare, dal campionario di La Domenica Sportiva, “Dribbling” di Piero Umiliani (1967), “Winning The West” della Buddy Rich Big Band (1973), “Mexico” di Danilo Rea e Roberto Gatto (1985), “Breakout” di Spyro Gira (1991)? Spostandoci alla “pagina” spettacoli, fra il ’76 e il ‘78, Rete 2 dava spazio in Odeon al pianista Keith Emerson (senza Lake e Palmer) in “Odeon Rag” arrangiamento di “Maple Leaf Rag” di Scott Joplin, subentrato in luogo del precedente “Honky Tonk Train Blues”, autore il pianista Meade Lux Lewis. Il filone spettacolistico avrebbe registrato più in là significativi esempi con lo scat di Lucio Dalla con gli Stadio che annuncia Lunedifilm per un buon ventennio fino al 2002 e l’ellingtoniano “Take The A Train” di Strayhorn a fare da intro ai trailer cinematografici assemblati da AnicaFlash per la rassegna delle novità cinematografiche “di stagione”. Si diceva come luogo fertile per la semina tv di suoni jazz da filtrare nelle orecchie dei telespettatori fosse l’informazione. Gettonatissima rimane al riguardo la sigla di Mixer (1980-1996) ovvero “Jazz Carnival” dei brasiliani Azimuth, specialisti del samba doido, genere fusion-funky. Latin come nelle radiocronache di Tutto il calcio minuto per minuto, dove Herb Alpert e Tijuana Brass interpretano “A Taste of Honey”, brano di stampo pop, in repertorio a Beatles e Giganti (“In paese è festa”). Per la tv italiana va ricordato che, fuori dal reticolo giornalistico, si contano altre occasioni più dirette di esposizione per la musica jazz filtrata tramite il piccolo schermo. La Portobello Jazz Band di Lino Patruno “presentava” il programma di Enzo Tortora (cfr. La tana delle sigle in tds.sigletv.net) nel 1978, stesso anno dello sceneggiato in 3 puntate Jazz Band di Pupi Avati, colonna sonora di Amedeo Tommasi, con il clarino di Hengel Gualdi in evidenza nelle sigle di apertura e chiusura, “Jazz Band” e “Swing Time” ; poi ancora Di Jazz in Jazz, programma “dedicato” con relativa sigla a cura dell’Orchestra Big Band della Rai diretta da Giampiero Boneschi e Franco Cerri (www.teche.rai.it). “Schegge”, queste ultime, che costituivano una vetrina per il jazz di casa nostra in una situazione in cui il format varietà si teneva alquanto distante, a differenza di quanto avveniva negli U.S.A. . Dalle nostre parti vanno citati comunque Milleluci, show datato 1974, nella cui sigla finale “Non gioco più” Mina duetta con l’armonica di Toots Thielemans, Palcoscenico, in onda fra 1980 e 1981, con Milva accompagnata da Astor Piazzolla mentre scorrono i titoli di coda in “Fumo e odore di caffè” e Premiatissima del 1985 dove il crooner Johnny Dorelli canta “La cosa si fa“ su base swing “metropolitano. Lo sdoganamento delle sigle jazz nei varietà proseguiva con Renzo Arbore (e Gegè Telesforo) a cui si deve “Smorza e’ lights (Such a night)” incipit di Telepatria International, inizio trasmissioni il 6 dicembre 1981 (www.arboristeria.it – Renzo Arbore Channel). Per la cronaca il 18 marzo 1981, e fino al 1989, sarebbe andata in onda la prima edizione di Quark di Piero Angela, conduttore nonché apprezzato pianista jazz. La trasmissione di divulgazione scientifica sarebbe stata simbioticamente legata alla sigla, la “Air for G String” di Bach, eseguita da The Swingle Singers, pubblicata nell’album “Jazz Sèbastian Bach” (1963), peraltro incisa anche insieme al Modern Jazz Quartet in “Place Vendòme”, album del ’68 della Philips. Terminiamo questa breve carrellata, che non include per sintesi le emittenti private/commerciali pro-tempore, per ricordare la sigla swing di DOC Musica e altro a denominazione d’origine controllata (1987-1988) di Arbore, Telesforo e Monica Nannini, esempio di come coinvolgere il jazz in un contenitore di buona musica. Il breve excursus è stato uno squarcio fugace su una jazz age, grossomodo racchiusa fra ’54 e ’94, un fugace momento di (bel) spaesizzazione musicale segnato, al proprio interno, dal passaggio dall’analogico al digitale, fase che precedeva la successiva della tv satellite e quella attuale della connessione via internet con la diffusione dei social e di new media come le web-tv con piattaforme on demand. E’ stato osservato che nella tv generalista di oggi “il jazz non ha più la stessa presa pubblica di un tempo” (cfr. Il jazz e le sigle radiotelevisive, riccardofacchi.wordpress.com, 2/8/2016). E “CiakClub.it” ha pubblicato, a firma di Alberto Candiani, un elenco con Le 20 migliori sigle televisive di sempre: Da Friends a Il trono di spade la lista delle più affascinanti iconiche e meglio congeniate sigle delle serie tv senza che ne compaia qualcuna (simil)jazz. Vero! Ci sono molti set televisivi in cui il jazz fa comparse episodiche. C’è poi che, a causa dell’affinarsi delle tecnologie digitali, molte sigle vengono confezionate a tavolino e, perdendo in istantaneità, sono sempre meno frutto di incisioni live né tantomeno vengono selezionate fra materiali preesistenti. Ed è forse tutto ciò che ammanta quei “primi quarant’anni” di tv “eterea” di un irripetibile sapore amarcord.



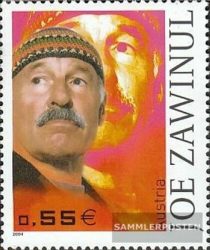 Il pensiero va allora alla proposta apparsa su queste colonne il 24 marzo 2017 di Affrancare il jazz con una serie di francobolli sul grande jazz italiano ribadita l’anno dopo con un ritorno giornalistico datato 18 maggio.
Il pensiero va allora alla proposta apparsa su queste colonne il 24 marzo 2017 di Affrancare il jazz con una serie di francobolli sul grande jazz italiano ribadita l’anno dopo con un ritorno giornalistico datato 18 maggio.



 È siciliana non solo la prima cantautrice italiana, Rosa Balistreri, ma anche la prima pianista e cantante jazz italiana: Dora Musumeci. E la Sicilia è stata capace di dimenticare entrambe. Se dell’artista di Licata si è cominciato in ritardo a celebrarla con sparute e disarticolate iniziative, la musicista catanese sembra essere caduta nel dimenticatoio. Eppure, da molti fu considerata la “Regina dello swing”, tanto da essere corteggiata da Broadway.
È siciliana non solo la prima cantautrice italiana, Rosa Balistreri, ma anche la prima pianista e cantante jazz italiana: Dora Musumeci. E la Sicilia è stata capace di dimenticare entrambe. Se dell’artista di Licata si è cominciato in ritardo a celebrarla con sparute e disarticolate iniziative, la musicista catanese sembra essere caduta nel dimenticatoio. Eppure, da molti fu considerata la “Regina dello swing”, tanto da essere corteggiata da Broadway. Seguirono tantissimi concerti, radio, televisione, Dora ebbe parte attiva nel mondo del cinema, registrando alcuni brani per colonne sonore assieme a importanti compositori, tra cui il maestro Ennio Morricone, Romano Mussolini e Giovanni Tommaso. Con il compianto autore di C’era una volta il West, incise il 45 giri Caffè e camomilla, sulla cui copertina era presentata con queste parole. «Ragazza dal viso aperto e dagli occhi luminosi nei quali si riflettono i colori della Sicilia. Pianista ben preparata e appassionata di jazz: qualcuno sentendola cantare e accompagnarsi con tanta carica di swing, l’ha definita la Nelly Lutcher italiana. Non c’è dubbio che Dora Musumeci sia su un livello artistico molto elevato, anche perché sa esprimere con particolare eleganza la sua natura di donna romantica e di ragazza moderna. Un contrasto messo in evidenza da Caffè e camomilla».
Seguirono tantissimi concerti, radio, televisione, Dora ebbe parte attiva nel mondo del cinema, registrando alcuni brani per colonne sonore assieme a importanti compositori, tra cui il maestro Ennio Morricone, Romano Mussolini e Giovanni Tommaso. Con il compianto autore di C’era una volta il West, incise il 45 giri Caffè e camomilla, sulla cui copertina era presentata con queste parole. «Ragazza dal viso aperto e dagli occhi luminosi nei quali si riflettono i colori della Sicilia. Pianista ben preparata e appassionata di jazz: qualcuno sentendola cantare e accompagnarsi con tanta carica di swing, l’ha definita la Nelly Lutcher italiana. Non c’è dubbio che Dora Musumeci sia su un livello artistico molto elevato, anche perché sa esprimere con particolare eleganza la sua natura di donna romantica e di ragazza moderna. Un contrasto messo in evidenza da Caffè e camomilla».

 Ma il rimedio, così come proposto, è la soluzione giusta? Il pianista Simone Graziano, presidente Midj, Musicisti Italiani Di Jazz, osserva che “in assoluto il principio si potrebbe estendere per esempio ai festival, riservando un terzo dei concerti ai musicisti italiani”. Ed aggiunge che la misura sarebbe veramente positiva specie “se rivolta alla musica di qualità più che di quantità”. La considerazione tocca un punto nevralgico del provvedimento in itinere che appare di evidente significato politico, artistico ed economico. Fra i pareri più autorevoli di segno contrario da citare Francesco De Gregori: “non so cosa sarebbe stata la mia vita da musicista se non avessi potuto ascoltare fin da piccolo tutte le canzoni straniere che ho sentito”. E mugugni sono apparsi sul web dal mondo della musica afroamericana, che è quello fra i più esposti all’abbraccio “contagioso” di (im)migrazioni musicali. Visto che in materia, peraltro, viene sollecitato dagli stessi proponenti il dibattito… diciamo la nostra.
Ma il rimedio, così come proposto, è la soluzione giusta? Il pianista Simone Graziano, presidente Midj, Musicisti Italiani Di Jazz, osserva che “in assoluto il principio si potrebbe estendere per esempio ai festival, riservando un terzo dei concerti ai musicisti italiani”. Ed aggiunge che la misura sarebbe veramente positiva specie “se rivolta alla musica di qualità più che di quantità”. La considerazione tocca un punto nevralgico del provvedimento in itinere che appare di evidente significato politico, artistico ed economico. Fra i pareri più autorevoli di segno contrario da citare Francesco De Gregori: “non so cosa sarebbe stata la mia vita da musicista se non avessi potuto ascoltare fin da piccolo tutte le canzoni straniere che ho sentito”. E mugugni sono apparsi sul web dal mondo della musica afroamericana, che è quello fra i più esposti all’abbraccio “contagioso” di (im)migrazioni musicali. Visto che in materia, peraltro, viene sollecitato dagli stessi proponenti il dibattito… diciamo la nostra.



