da Gerlando Gatto | 26/Ott/2022 | News, Primo piano
 La mattina, appena sveglio – maledetta abitudine – per prima cosa do uno sguardo alla rassegna stampa che mi arriva sul telefonino. E così ho fatto anche stamane; ad un certo punto, ancora non del tutto sveglio, noto la foto di un bell’uomo, giovane. Tra me e me penso: ma questo lo conosco. A poco a poco i neuroni si mettono in moto e lo riconosco, è lui, è Franco e capisco immediatamente: Franco Fayenz se ne è andato in un luogo, per chi ci crede, sicuramente migliore di questa terra.
La mattina, appena sveglio – maledetta abitudine – per prima cosa do uno sguardo alla rassegna stampa che mi arriva sul telefonino. E così ho fatto anche stamane; ad un certo punto, ancora non del tutto sveglio, noto la foto di un bell’uomo, giovane. Tra me e me penso: ma questo lo conosco. A poco a poco i neuroni si mettono in moto e lo riconosco, è lui, è Franco e capisco immediatamente: Franco Fayenz se ne è andato in un luogo, per chi ci crede, sicuramente migliore di questa terra.
La notizia è di quelle che si fatica a digerire anche se l’età di Franco (92 anni) ci aveva messo tutti in preallarme. Ma, come al solito, una cosa è immaginare altra cosa è vivere una determinata realtà.
Cercherò in questo breve ricordo di non lasciarmi andare a quell’ondata di tristezza che mi ha avvolto questa mattina anche se lo confesso non è facile. Conoscevo Franco non so bene se da 40 o 50 anni. Il nostro era un bel rapporto sempre improntato al sorriso, allo scherzo, al comune amore per il jazz.
Quando ci incontravamo o ci sentivamo per telefono lui amava prendersi gioco di me, inventando giochi di parole sui miei nome e cognome, ma lo faceva in modo così amorevole, col sorriso sulle labbra che sembrava voler dire “non badare alle mie parole, ti voglio bene” che era impossibile arrabbiarsi.
-
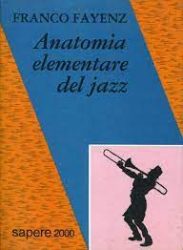
-

Ovviamente c’erano anche momenti più seri, quelli in cui si parlava di musica ed era un piacere ascoltarlo anche perché lui ti raccontava eventi, episodi vissuti in prima persona. Eventi che lo hanno visto protagonista della scena jazzistica almeno per trent’anni di fila in cui Franco si è segnalato come un grande divulgatore grazie ai suoi articoli, ai suoi libri e alle sue apparizioni in TV. Non dimentichiamo che negli anni Settanta Fayenz, assieme a Franco Cerri, collabora a “Jazz in Italia”, un programma di Carlo Bonazzi declinato attraverso una serie di interviste ai jazzisti le cui performances in giro per i jazz club della Penisola venivano mandati in onda. La sua brillante carriera è stata costellata da molti riconoscimenti che riteniamo superfluo ricordare in questa sede. Basti solo considerare il fatto che la stima da parte dei musicisti mai è venuta meno nei suoi confronti anche quando, per lunghi anni, ha lavorato per un quotidiano che mai è stato in cima alle preferenze dell’ambiente jazzistico globalmente considerato.
L’ultima volta che ci siam visti è stato nel 2015 durante il Festival Udine Jazz e non è stato un bel vedere dal momento che si vedeva come Franco, purtroppo, accusasse il peso dell’età anche se l’arguzia e la voglia di scherzare erano quelle di sempre.
-

-
Courtesy Udin&Jazz 25, 2015
ph Luca A. d’Agostino Phocus Agency
Adesso non scherza più… almeno su questa terra. Ciao Franco, vai ad ascoltare altre melodie!
Gerlando Gatto
da Gerlando Gatto | 19/Ott/2022 | Interviste, News, Primo piano
Pianista e compositore raffinato ma anche uomo di rara disponibilità e gentilezza, Phil Markowitz – classe 1952 – è a mio avviso uno dei tanti musicisti ancora sottovalutato. E dire che nella sua vita di cose ne ha fatte tante. Basti al riguardo scorrere la sua ricca discografia e lo troviamo sia alla testa di proprie indimenticabili formazioni, sia come sideman accanto ad altri veri e propri giganti del jazz quali Chet Baker, Dave Liebman e Bob Mintzer.
Di recente abbiamo ascoltato il doppio album inciso in solitaria durante un concerto all’Auditorium Parco della Musica di Roma il 9 maggio del 2006. Ne siamo rimasti particolarmente colpiti e abbiamo avuto il desiderio di intervistarlo. Ci siamo rivolti all’amico Giorgio Enea, dell’ufficio stampa dell’Auditorium, il quale ci ha fornito un contatto mail. Così ci siamo scritti e Phil ci ha risposto immediatamente. Di qui l’intervista che pubblichiamo di seguito.
-Partiamo da un doppio album registrato live a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, il 9 maggio del 2006 ma pubblicato solo poche settimane fa. Ricorda qual era il suo stato d’animo quando suonò questa splendida musica?
“Ero davvero felice di suonare in concerto da solo e ovviamente anche un po’ nervoso prima di salire sul palco, cosa assolutamente normale. Ricordo di essermi molto concentrato per questa performance, considerato che si trattava di una scaletta parecchio impegnativa, e di essere stato infine molto soddisfatto grazie alla magnifica risposta del pubblico, cosa molto incoraggiante. I tre bis, poi, sono stati semplicemente meravigliosi”.
-Nel frattempo, sono trascorsi ben 16 anni; come è cambiato Phil Markowitz in questo lasso di tempo?
“Penso che quando uno arriva ai 50 anni più o meno sa chi è, ergo ci sono stati degli sviluppi da quel giorno ma essenzialmente il mio cammino musicale ha seguito la stessa strada eclettica che ho sempre intrapreso”.
– Qual è attualmente il suo approccio verso la musica?
“Da un punto di vista compositivo il mio approccio è quello di creare strutture in ambienti molto ben definiti e di suonare creativamente e inventivamente all’interno di esse. Per quanto riguarda le performance in gruppo è ed è sempre stato lo stesso: supportare la band, essere preparati e saper giocare di squadra”.
– Adesso riandiamo indietro nel tempo: un po’ come tutti i musicisti di jazz, anche lei prima di guidare propri gruppi ha militato come sideman in formazioni guidate da altri. Quanto ciò è importante nella formazione di un musicista?
“Se sei un musicista che si occupa del ritmo, che sia il pianoforte, il basso, la batteria o altri strumenti a corda, è cruciale per il tuo sviluppo musicale. Si deve saper valutare ogni situazione musicale e ogni musicista che si accompagna; ciò affina le tue abilità musicali e devi essere un artista maturo per avere successo. Io dico sempre ai miei studenti che le abilità di accompagnatore sono la parte più importante della disciplina di ognuno: una cosa è essere un gran solista, altra cosa è saper accompagnare. È la capacità di accompagnare che ti permette di far suonare bene la musica e di farti conservare il lavoro dato che così facendo metti il tuo leader nelle condizioni migliori!”.
– C’è stato un momento nella sua vita, nel suo percorso artistico che le ha fatto capire di essere in grado di affrontare una sua personalissima carriera?
“Non sono sicuro di aver capito la domanda ma in sintesi è stato il mio amore per la musica improvvisata che suoniamo e ovviamente i numerosi e incredibili maestri che ho avuto durante il mio percorso a spingermi verso una carriera fatta di musica. Inoltre, ho capito molto presto che è assolutamente importante essere un compositore con una propria, ben specifica unicità che ti consente di creare quegli ambienti nei quali s’innesta il panorama sonoro che ti rende immediatamente riconoscibile”.
– Lei ha ottenuto, per l’appunto, una straordinaria visibilità anche come compositore quando ha suonato con Toots Thielemans a NYC. Come ricorda quel periodo?
“New York negli anni Ottanta era magnifica, c’era un sacco di lavoro. Suonavo con Chet Baker, Toots, la Mel Lewis Big Band e, poco prima, con Joe Chambers; mi guadagnavo da vivere suonando nella downtown, in concerti con diversi gruppi. In sintesi, è stato un periodo molto fertile. Ovviamente sono molto grato a Toots, con il quale ho lavorato per quattro anni e che fu anche uno dei miei primi mentori quando studiavo al College nella Eastman School of Music. C’era questa meravigliosa confluenza di circostanze: ad esempio Bill Evans veniva al nostro concerto a N.Y. e noi suonavamo “Sno’ Peas”, un pezzo che Toots eseguiva ogni sera”.
– Tra gli artisti con i quali ha suonato a lungo figurano Chet Baker e Dave Liebman, musicisti differenti quasi da ogni punto di vista. Qual è stato il suo rapporto con i due?
“Con Chet avevo un bellissimo rapporto anche se era più anziano di noi. In quel tempo – quando ero più vicino ai trenta che ai vent’anni – suonavo con la band. Lui era molto paziente con noi e dava il buon esempio a tutti. Ho certamente imparato l’arte dell’accompagnamento durante questo periodo; se qualcuno suonava un accordo sbagliato dietro a Chet rovinava le sue meravigliose e incontaminate sortite solistiche degne di Mozart. Quando mi sono trasferito a New York negli ultimi anni Settanta, conoscevo già Dave Liebman dalle sue registrazioni con Miles ed Elvin Jones e la band “Quest”, che aveva con Richie Beirach. Quando ero in città andavo quasi ad ogni concerto in cui c’erano loro; era sempre stato il sogno della mia vita suonare con Dave e nei primi anni Novanta il mio desiderio venne esaudito. Lui è sempre stato per me un assiduo e sincero maestro, mi ha sempre appoggiato ed ha avuto una grande e meravigliosamente positiva influenza nella mia vita. Penso che l’aver avuto, sin da giovanissimo, un interesse molto forte per la musica del XX secolo e per l’armonia cromatica mi abbia reso più pronto per i suoi concerti. La “Saxophone Summit” è stata senza dubbio la miglior band con cui abbia suonato e quell’esperienza ventennale rimane la più entusiasmante che abbia vissuto nel mondo del jazz. Ci sono moltissime registrazioni meravigliose con quel gruppo e aver suonato con Joe Lovano, Michael Brecker, Ravi Coltrane, Greg Osby e naturalmente Dave Liebman è stata un’esperienza formativa dal valore incommensurabile. Per non parlare di Billy Hart che è senza ombra di dubbio il miglior batterista con cui abbia avuto il piacere di suonare”.
– Lei suona da solo, in combo e in big band. In quale situazione preferisce esprimersi?
“Adoro il piano trio perché come leader ti dà la maggior flessibilità mentre plasmi la musica. Anche il duo è estremamente gratificante, sebbene sia più difficile: devi accompagnare, essere tutta la band e suonare da solo. È un ambiente meraviglioso. D’altro canto, suonare con la sezione fiati è stato molto bello; in effetti per la big band è una lunga storia ma basti sapere che se si è pianisti in quel contesto è necessario sapere tutto ciò che l’arrangiatore ha messo in ogni spartito. La mia band con il violinista Zach Brock (jazzista statunitense, classe 1974, membro degli Snarky Puppy dal 2007 n.d.a.) è stata molto gratificante; ho sempre voluto lavorare con un violinista e ho sempre creduto che piano e violino siano un perfetto abbinamento sonoro”.
– Oggi il jazz è diventato materia di insegnamento e Lei se ne occupa appieno. A suo avviso, quanto è importante per il futuro della ‘nostra’ musica questo tipo di formazione?
“L’educazione jazz è una sorta di spada a doppio taglio. Ritengo che in questo momento sia importante perché la scena è molto più ristretta adesso rispetto a quanto lo fosse negli anni ’70 e ’80. Sono grato per la mia esperienza universitaria alla Eastman School of Music, dove ho incontrato Gordon Johnson (contrabbassista e chitarrista statunitense classe 1952 n.d.a) e il batterista Ted Moore con i quali ho fondato una band chiamata “Petrus” che vinse un concorso nazionale per il miglior gruppo jazz giovane con in palio una performance al Newport Jazz Festival del 1973. Nei prossimi mesi rilasceremo finalmente le nostre registrazioni in studio, che avevo conservato nel mio armadio… suonano come se fossero di oggi. Tutto ciò non sarebbe mai successo se non ci fossimo incontrati in Conservatorio. Le connessioni che si creano in ambito musicale con le persone che incontri, gli insegnamenti che puoi ricevere da grandi musicisti che normalmente non avresti opportunità di incontrare e la musica che crei, durano per la vita. E sono cose che non si dimenticano. È chiaro che per avere una preparazione più approfondita si deve studiare in Conservatorio, e ciò prevede dei costi; certo, si possono trovare insegnanti anche tra i musicisti di strada, ma non è la stessa cosa; tuttavia, nella scena attuale ognuno deve avere la consapevolezza di ciò cui va incontro: non tutti diventano star o super star, spesso i migliori musicisti non sono i più famosi, e spesso i più famosi non sono i migliori. Io ritengo che la pedagogia, come io l’ho sviluppata nei numerosi anni in cui sono stato educatore, specie negli ultimi 20 anni nel programma di laurea e dottorato nella “Manhattan School of Music”, mi abbia aiutato a definire il mio stile. Imparare ad insegnare può agevolare notevolmente il proprio sviluppo”.
– C’è qualche musicista che ritiene particolarmente importante per la Sua di formazione?
“Tutta la gente che ho menzionato in precedenza è molto importante: Chet Baker, Dave Liebman e posso aggiungere Bob Mintzer e Maurizio Giammarco in Italia. Queste sono le persone principali con cui ho avuto lunghe collaborazioni. Ma ovviamente ce ne sono state tante altre lungo il cammino dalle quali, ogni qualvolta si suoni assieme, si impara qualcosa”.
– Quando pensa di tornare in Italia?
“Si spera il prima possibile: È il mio posto preferito dove suonare”.
E noi ce lo auguriamo di tutto cuore; a presto Phil…
Gerlando Gatto
da Marina Tuni | 21/Feb/2021 | News, Primo piano, Recensioni
Hyperion, «colui che precede il Sole», era un Titano della mitologia greca, padre di Elio (Dio del Sole), di Eos (l’Aurora) e di Selene (la Luna). Collegare questa mitologica figura ad Armando Anthony Corea, detto Chick, scomparso a 79 anni a Tampa Bay il 9 febbraio, è stato istintivo: lui è un titano della musica jazz, un audace precursore che come pochi altri ha saputo sviluppare l’arte del pianoforte portandola a livelli altissimi o, come mi ha scritto un amico pianista, un illuminato, «tra i più grandi creatori di archetipi della storia».
Qualche giorno prima che Chick se ne andasse, così… all’improvviso, stavo ascoltando un album, non certo epidittico della sua enorme, cinquantennale produzione. Si tratta di un LP del 1976 (Atlantic Records) «Chick Corea, Herbie Hancock, Keith Jarrett, McCoy Tyner». È un’operazione suggestiva, una sorta di silloge dell’arte pianistica che racchiude due brani per ciascuno dei quattro più importanti pianisti dell’era post-bop, nella formazione in trio.
Chick sceglie un brano di sua composizione “Tones for Joan’s Bone’s” (che è anche il titolo del suo album di debutto, nel 1968) nel nel quale è accompagnato da Joe Chambers alla batteria e Steve Swallow al basso, mentre il secondo, “This is New”, porta la firma “nientepopodimeno che” di Kurt Weill e Ira Gershwin; qui lo accompagnano il trombettista Woody Shaw e il sassofonista Joe Farrell. C’è un assolo di Corea che mi fa impazzire… è bizzoso e puntuto…
 Il Chick che ho ascoltato di più, tuttavia, è quello dei Return To Forever, nelle sue varie formazioni (dal 1971 ai giorni nostri) nelle quali sono transitati musicisti molto noti, tra cui alcuni top guitarist come Al Di Meola ed Earl Klugh. L’album di debutto della band, “Return to Forever”, uscito nel 1972 per l’etichetta ECM, con Chick al Fender Rhodes, Stanley Clarke al basso, Joe Farrell al flauto e sax, Airto Moreira, alle percussioni e la grande voce di Flora Purim, è per me uno dei dieci album di jazz-fusion più belli in assoluto…
Il Chick che ho ascoltato di più, tuttavia, è quello dei Return To Forever, nelle sue varie formazioni (dal 1971 ai giorni nostri) nelle quali sono transitati musicisti molto noti, tra cui alcuni top guitarist come Al Di Meola ed Earl Klugh. L’album di debutto della band, “Return to Forever”, uscito nel 1972 per l’etichetta ECM, con Chick al Fender Rhodes, Stanley Clarke al basso, Joe Farrell al flauto e sax, Airto Moreira, alle percussioni e la grande voce di Flora Purim, è per me uno dei dieci album di jazz-fusion più belli in assoluto…
Già… il Fender Rhodes… c’è un famoso aneddotto legato a questo strumento, che Corea raccontò così in un’intervista:
 «Nel gruppo di Miles (Davis) facevo ciò che mi veniva chiesto. Per i primi sei mesi suonai il piano acustico, poi Miles disse che voleva un sound diverso; una notte si presentò con un piano elettrico e mi disse: “suona questo”. All’inizio ho odiato il Fender Rhodes, perché lo suonavo come un pianoforte, cosa che non è. Ma mi sono applicato, ho fatto di tutto per accontentare Miles. Poi quando ho fondato il mio primo gruppo Return to Forever ho suonato soprattutto il Fender».
«Nel gruppo di Miles (Davis) facevo ciò che mi veniva chiesto. Per i primi sei mesi suonai il piano acustico, poi Miles disse che voleva un sound diverso; una notte si presentò con un piano elettrico e mi disse: “suona questo”. All’inizio ho odiato il Fender Rhodes, perché lo suonavo come un pianoforte, cosa che non è. Ma mi sono applicato, ho fatto di tutto per accontentare Miles. Poi quando ho fondato il mio primo gruppo Return to Forever ho suonato soprattutto il Fender».
Chick Corea l’ho incontrato nel 2015 a Udin&Jazz (a Udine venne anche nel 1997 in duo con il vibrafonista Gary Burton) e, al di là dello splendido concerto per piano solo a cui ho avuto la fortuna di assistere, nel quale presentò un repertorio composto non solo dalle sue composizioni originali ma che viaggiava anche sulle note di Gershwin, Scarlatti, Chopin, conservo gelosamente nel mio cuore il ricordo di una persona estremamente aperta e disponibile, sia con il numeroso pubblico presente, sia con noi dietro le quinte.
-

-
Chick Corea Udin&Jazz 31/07/2015 – ph Luca d’Agostino
-

-
Chick Corea Udin&Jazz 31/07/2015 – ph Luca d’Agostino
-

-
Chick Corea Udin&Jazz 31/07/2015 – ph Luca d’Agostino
-

-
Chick Corea Udin&Jazz 31/07/2015 – ph Luca d’Agostino
Sempre generoso e aperto allo scambio, Chick invitò sul palco alcuni pianisti presenti che ebbero l’incredibile opportunità di suonare con una leggenda del jazz, vincitore di ben 23 Grammy Awards! Nel 1993, ricevette anche una Targa Tenco per “Sicily”, interpretata con il nostro Pino Daniele. Corea suonò il pezzo a Napoli, durante il suo concerto all’Arena Flegrea nel 2016, dedicandolo all’amico Pino, scomparso un anno prima, definendolo uno dei più grandi musicisti italiani e del mondo…
Se penso che quest’estate avrei finalmente rivisto questo straordinario pianista in Friuli Venezia Giulia, dov’era atteso a luglio per una data di Grado Jazz…
Nel periodo del primo lockdown, in aprile, lui postava sulla sua pagina Facebook un sacco di video: «Hello everybody, it’s Chick! Day 2» e via così… Ne ho seguiti diversi, rimanendo una volta di più stupefatta dal suo grande cuore e dal suo sempre impellente desiderio di condividere con gli altri la sua visione della musica.
Tra i suoi innumerevoli progetti, tengo particolarmente a menzionare la Chick Corea Elektric (in trio anche Akoustic) Band, con Patitucci, Gambale e Weckl, a testimonianza dell’eclettismo di questo artista e di quanto egli amasse addentrarsi nelle infinite pieghe della sperimentazione, con ibridazioni musicali cross-over.
Herbie Hancock, suo grande amico, racconta su Rolling Stone di quando una sera, nel 1980, al Montreux Jazz Festival… «sono finito sotto il pianoforte, suonavo la parte in legno. Chick era sopra il piano e faceva qualcosa con le corde. Il pubblico era fuori di testa. […] Non facevamo i pagliacci. Volevamo fare musica e allo stesso tempo divertirci. Che c’è di male?
Sapete cosa abbiamo fatto per il quinto bis? Eravamo dietro le quinte e Chick mi ha detto: “Dobbiamo tornare indietro, stanno ancora gridando”. Ho risposto: “Ok Chick, perché non mettiamo due sedie di fronte al pubblico e facciamo dei giochi con loro?”. È andata proprio così. Non abbiamo più toccato il pianoforte. Ci siamo seduti e abbiamo fatto tutto quello che ci veniva in mente: usavamo le parti del nostro corpo per suonare le percussioni, ci toccavamo la gola per fare dei suoni oscillanti. […] Non lo dimenticherò mai. È un ricordo monumentale».

Herbie Hancock& Chick Corea – Ph: Torben Christensen ©
Monumentale, un aggettivo che si attaglia perfettamente all’immenso lascito artistico di Chick Corea, un patrimonio prezioso, una fonte inesauribile di ispirazione per intere generazioni di musicisti, come nel suo ultimo messaggio, scritto quando aveva già la consapevolezza di doverci lasciare: « Voglio ringraziare tutti coloro che nel corso del mio viaggio hanno contribuito a mantenere vivo il fuoco della musica. Spero che chi di voi abbia l’attitudine per suonare, scrivere, esibirsi o altro lo faccia. Se non per voi stessi, fatelo per noi. Non solo perché il mondo ha bisogno di più artisti ma anche perché è molto divertente esserlo!»
Per te, Chick, una dedica speciale con una poesia di Srečko Kosovel, poeta sloveno poco “mainstream”, che quell’attitudine per scrivere di cui parli ce l’aveva eccome!
Purtroppo non ha potuto esprimerla appieno essendo morto a soli 22 anni…
«Oh, ma non c’è morte, morte! Solo il silenzio è troppo profondo. Come in una foresta verde in espansione! Solo ti ritiri, solo diventi silenzioso, solo cresci… solo… solo, solo, solo, invisibile.
Oh, ma non c’è morte, morte! Solo tu cadi, solo cadi… cadi, cadi in un abisso di blu infinito».
I bid you farewell, Chick, I bid you farewell. Ti ritroverò nell’imponderabilità tonale di una nota blu…
Marina Tuni ©
da Gerlando Gatto | 25/Mar/2020 | News, Primo piano
Continuano i lutti anche nel mondo del jazz, a ulteriore conferma di un inizio d’anno che definire traumatico è semplicemente eufemistico. Mentre il Coronavirus colpisce duramente in tutto il pianeta, ovviamente si continua a morire anche per altre cause; ed ecco quindi che dalla Francia e dagli States ci arrivano le ferali notizie della scomparsa di tre grandi musicisti: il sassofonista Manu Dibango, il clarinettista e compositore Bill Smith e il percussionista Ray Mantilla.

Manu Dibango con Enzo Avitabile
Contrariamente a molte altre occasioni si tratta di tre jazzisti che ho avuto l’opportunità di ascoltare dal vivo ma con i quali non avevo intessuto alcun rapporto personale neanche di “buon giorno e buona sera”. Ve ne parlo, quindi, da semplice cronista e appassionato. Ma procediamo con ordine.
La notizia della scomparsa di Manu Dibango, sassofonista, compositore, vibrafonista e cantante, mi è giunta pochi minuti prima di pubblicare il ricordo di Bill Smith e Ray Mantilla, rendendo, se possibile, la mia giornata più pesante.
Manu Dibango è uno di quegli artisti la cui fama aveva superato i confini del jazz, grazie al successo internazionale dell’album “Soul Makossa” del 1972, e detiene il non invidiabile primato di essere stato il primo jazzista di fama internazionale ad essersene andato a causa di questa sconvolgente pandemia: era stato ricoverato la scorsa settimana in un ospedale parigino dopo essere stato trovato positivo al test per il coronavirus.

Manu Dibango, affettuosamente soprannominato “Papy Groove”, nasce in Camerun, a Douala il 12 dicembre 1933 per spegnersi a Parigi questa mattina (24 marzo 2020). Evidenzia una grande predisposizione per la musica sin da bambino cosicché, all’età di 15 anni, i suoi lo mandano a studiare musica a Parigi. Qui viene affascinato soprattutto dal jazz e dalla musica della sua terra che mai ha dimenticato. Studia quindi con interesse questi due linguaggi e negli anni sessanta, mentre si sviluppa il movimento africano per l’indipendenza, entra a far parte degli “African Jazz”. In quest’ambito nasce quello stile che lo renderà famoso in tutto il mondo, uno stile che mescola jazz, soul, musica del Congo e dello Zaire, e che trova la sua più esemplare declinazione in quel brano “Makossa” accennato in precedenza. E’ l’inizio di una strepitosa carriera che lo porta a collaborare con moltissimi musicisti e a incidere innumerevoli album. Tra queste collaborazioni ricordiamo quella con il sassofonista napoletano Enzo Avitabile per l’album “Black Tarantella”, e all’annuncio della dipartita dell’amico camerunense, addolorato è stato il suo commento «Purtroppo il mio grande amico Manu Dibango si é spento stamane a causa di questo maledetto virus. Quanti concerti insieme, quanti ricordi. Sono addolorato!». Cordoglio che in queste ore viene manifestato da tanti musicisti e appassionati che hanno avuto modo di apprezzare la carica innovativa insita nella sua musica, quella straordinaria intuizione di capire, ben prima della world music, che la musica africana potesse ben essere esportata negli altri continenti senza alcunché perdere della sia originaria valenza. A conferma di tutto ciò le molteplici nomination al Grammy, le nomine di Ambasciatore dell’Unesco e di Cavaliere delle Arti in Francia, nonché la pubblicazione della sua autobiografia “Tre chili di caffè – vita del padre dell’afro music” per i tipi in Italia della Edt.
*****

Bill Smith
William Overton Smith, detto “Bill”, nasce il 22 settembre del 1926 a Sacramento ma cresce a Oakland, California. Scompare nella sua casa di Seattle, all’età di 93 anni, per le complicazioni di un tumore alla prostata, dopo una lunga e straordinaria carriera che l’ha visto tra i protagonisti assoluti del jazz contemporaneo.
Comincia a studiare il clarinetto all’età di 10 anni, a 13 costituisce un gruppo di musica da ballo, a 15 fa parte della Oakland Symphony. A seguito di approfonditi studi, diversifica i suoi interessi occupandosi sia di jazz sia di musica colta. Così negli anni ’50 si afferma sulle scene del West Coast Jazz accanto al pianista Dave Brubeck del cui gruppo è una colonna importante. Contemporaneamente il suo ‘Five Pieces for Clarinet Alone’ diviene nel 1959 la prima composizione, mai registrata, con uso di suoni multipli per clarinetto. Nello stesso anno realizza presso i Columbia-Princeton Electronic Music Studios di New York il primo lavoro che integra una esecuzione del clarinetto dal vivo con un nastro registrato composto da suoni dello stesso clarinetto trasformati. Alcuni anni dopo partecipa, con Paul Ketoff a Roma, allo sviluppo del primo sintetizzatore elettronico portatile e del primo microfono per clarinetto. Nel 1960 completa il suo catalogo di oltre 200 suoni multifonici per clarinetto. All’attività di musicista affianca quella di didatta: dal 1966 dirige presso l’Università di Washington il Contemporary Music Ensemble.
Oltre cinquanta i dischi incisi con le etichette Columbia, Rca, New World, Contemporary Crystal e Edipan. A conferma della sua straordinaria statura di musicista da segnalare che Luigi Nono gli ha dedicato il suo concerto per clarinetto.
*****

Ray Mantilla – ph Arturo Di Vita
Completamente diverso il percorso artistico di Ray Mantilla, batterista e percussionista di origine cubana molto conosciuto in Italia per aver inciso a lungo con la Red Record di Sergio Veschi e aver lavorato sia con il M’Boom Re Percussion fondato da Max Roach, sia con altri grandissimi jazzisti quali, tanto per fare qualche nome, Tito Puente, Art Blakey, Max Roach, Gato Barbieri, Charles Mingus, Herbie Mann, Bobby Watson, Cedar Walton, Muhal Richard Abrams, Ray Barretto…Negli anni ’80 costituisce la sua Ray Mantilla Space Station, con cui raggiunge risultati di assoluto livello. Insomma un vero e proprio gigante delle percussioni amato e apprezzato in tutto il mondo.
Ray Mantilla nasce nel 1934, nel South Bronx, e già all’età di vent’anni, si esibisce a New York, con uno stile del tutto personale che riesce a fondere le sue radici afro-cubane con il linguaggio jazz contemporaneo dell’epoca. Il successo come side-man arriva quando comincia a collaborare con Art Blakey ed i Jazz Messengers, con cui rimane per diverso tempo negli anni ’70. Debutta come solista nel 1978 con ‘Mantilla’ per la Inner City (con Eddie Gomez al basso, Joe Chambers alla batteria, Car Ratzer alle chitarre e Jeremy Steig nella duplice veste di flautista e produttore) ma bisognerà attendere il 1984, quando viene pubblicato “Hands of Fire” (Red Records), perché la carriera da solista acquisti definitivo slancio. Da questo momento Mantilla si dedica quasi esclusivamente a gruppi da lui guidati tra cui la “European Space Station” formata da musicisti italiani
Nel 2017 il suo ultimo album, “High Voltage” per Savant Records con Jorge Castro al sax baritono e flauto, Cucho Martinez al basso, Diego Lopez alla batteria, Edy Martinez al piano, Ivan Renta al sax tenore e soprano e Guido Gonzalez alla tromba e flicorno.
*****

Jimmy Heath
E consentitemi in questa sede di ricordare un altro grande scomparso il 19 gennaio scorso a 93 anni, per cause naturali: il sassofonista Jimmy Heath, vera e propria leggenda del jazz americano. Conosciuto nell’ambiente come ‘Little Bird’ per l’influenza che Charlie ‘Bird’ Parker ebbe sul suo passaggio al sassofono tenore, Jimmy nasce il 25 ottobre 1926 a Filadelfia, Pennsylvania, in una famiglia evidentemente baciata dalla dea dell’arte dal momento che la sorella diventa pianista e i due fratelli Percy e Albert rispettivamente bassista e batterista.
Jimmy si interessa alla musica sin da giovanissimo e a 13 anni ha in dono il suo primo sassofono da cui mai si separerà. Negli anni ‘50 anch’egli ha problemi con la droga e viene condannato a quattro anni e mezzo di prigione per spaccio. Fortunatamente si libera dalla dipendenza e impara a suonare il flauto, approfondendo gli studi di composizione e arrangiamento. Il suo primo album, «The Thumper», risale al 1959 e accanto al sassofonista ci sono il fratello Albert, Paul Chambers al basso, Nat Adderley alla cornetta, Wynton Kelly al piano, Curtis Fuller al trombone. A partire dai primissimi anni ’60, Jimmy Heatyh rimane sulla cresta dell’onda lavorando con nomi come Miles Davis, John Coltrane e Dizzy Gillespie. In particolare nel 1975, forma con i fratelli il gruppo “Heath Brothers”, comprendente anche il pianista Stanley Cowell.
Nel corso della sua lunga carriera Heath partecipa sia come side-man sia come leader ad oltre 100 album, ottenendo tre Grammy Nomination e un dottorato onorario in Lettere Umanistiche presso il “Queens College, City University of New York”.
Gerlando Gatto
da synpress44 | 24/Ago/2017 | Comunicati stampa
TRENTINOINJAZZ 2017
e
Panorama Music
presentano:
Domenica 27 agosto 2017
ore 13.00
Alpe Lusia
Località I Ronc 4
Moena (TN)
FRANCESCO MACCIANTI TRIO
feat.
ARES TAVOLAZZI
e
ROBERTO GATTO
(ingresso gratuito)
Ultimo appuntamento con Panorama Music, la sezione del TrentinoInJazz della Val di Fassa, dedicata ai concerti in alta quota. Il concerto finale, alle 13.00 di domenica 27 agosto, chiude in grande stile la rassegna con un trio eccezionale: Francesco Maccianti insieme a due giganti del jazz italiano – due figure di rilevanza anche internazionale – come Ares Tavolazzi e Roberto Gatto.
Il pianista fiorentino presenta questo trio di recente formazione che completa un lungo e entusiasmante percorso artistico. Formatosi con Franco D’Andrea a Siena e qui protagonista come fondatore del Centro Attività Musicali (C.A.M.) dove insegna pianoforte e musica d’insieme, Maccianti ha avuto modo di avviare una straordinaria attività concertistica insieme a colossi italiani (Pietro Tonolo, Maurizio Giammarco, Larry Nocella, Paolo Fresu, Luca Flores, Sandro Gibellini, Giovanni Tommaso, Flavio Boltro) e stranieri (Eddie Lockjaw Davis, Harry Sweets Edison, Sal Nistico, Joe Chambers etc.). Ha fatto stabilmente parte del Quartetto di Massimo Urbani (con Enzo Pietropaoli e Giampaolo Ascolese), dell’Orchestra del C.A.M. sotto la direzione di Bruno Tommaso e di Enrico Rava, il trio di cui è ideatore e titolare lo vede accanto a due maestri del rispettivo strumento come Tavolazzi (contrabasso) e Gatto (batteria), protagonisti indiscussi della musica italiana.
Il concerto è gratuito, il costo del biglietto della Cabinovia Lusia a carico dei partecipanti. In caso di maltempo il concerto si terrà all’interno dello Chalet Valbona. Prossimo appuntamento TIJ 2017: Artchipel Orchestra, Andalo, sabato 2 settembre.
Trentino Jazz:
http://www.trentinojazz.com/
da Eleonora Sole Travagli | 08/Ott/2016 | Comunicati stampa
Quest’anno Ferrara in Jazz conquista la maggiore età, e il pluripremiato jazz club estense si appresta a festeggiare il diciottesimo anno nella storica sede del Torrione San Giovanni (bastione rinascimentale iscritto nella lunga lista dei beni UNESCO, e location per il cinema di Emilia-Romagna Film Commission) con un’edizione speciale che prenderà il via venerdì 07 ottobre 2016, per concludersi a fine aprile 2017, con oltre 30 concerti animati da protagonisti assoluti del panorama internazionale, altrettante serate dedicate a talenti emergenti e novità discografiche, nuovi itinerari musicali, il live mensile della Tower Jazz Composers Orchestra (l’orchestra residente del Jazz Club Ferrara), didattica, incontri con l’autore e ben tre mostre tra illustrazione e fotografia, per un totale di circa 70 appuntamenti (la metà circa ad ingresso a offerta libera riservato ai soci Endas) che abbracciano il linguaggio jazzistico a 360° gradi, valicando confini geografico-culturali, in una continua alternanza di avanguardia e tradizione.
Il taglio del nastro della rassegna concertistica, organizzata da Jazz Club Ferrara con il contributo di Regione Emilia-Romagna, Comune di Ferrara, Endas Emilia-Romagna ed il prezioso sostegno di numerosi partner privati, è affidato al trio del pianista statunitense Harold Mabern, figura fondamentale nell’evoluzione del linguaggio jazzistico moderno.
Nelle tre serate di apertura settimanale – il venerdì, il sabato e il lunedì – si alterneranno a molti talenti del panorama italiano ed europeo icone internazionali della musica afroamericana quali Barry Harris, Randy Brecker, Horacio “El Negro” Hernandez, Buster Williams, Kurt Rosenwinkel, Franco D’Andrea, Michel Portal, Dado Moroni, Samuel Blaser, Theo Bleckmann, Fabrizio Bosso, The Bad Plus, Myra Melford, Julian Lage, The New Zion Trio, Ben Monder, Regina Carter, Fred Frith, Jaques Morelembaum, Tim Berne, David Torn, Eric Friedlander, Joe Chambers, Bill Carrothers e Dave King. I lunedì del Jazz Club firmati Monday Night Raw saranno volti alla scoperta di giovani leoni del jazz e alla presentazione di nuovi progetti discografici, seguiti da imprevedibili jam session. Alle altre serate del week-end, sotto la sigla Somethin’Else, spetta invece l’esplorazione di nuovi sentieri musicali che quest’anno toccheranno in particolar modo i territori della canzone d’autore, della world e black music, deviando lungo spericolati “fuoripista” contemporanei.
Continua, altresì, l’appassionante avventura della Tower Jazz Composers Orchestra: i 20 elementi che compongono l’apprezzata resident band del Torrione, diretti da Alfonso Santimone e Piero Bittolo Bon, arricchiranno il palinsesto con un’esibizione mensile e saranno preceduti da interessanti incontri con l’autore, mentre, sotto la sigla Jazz Goes To College, si rinnova il sodalizio con il Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara. Restando in ambito didattico, nel corso del 2017, riprenderà The Unreal Book, serie di clinics ideata da Jazz Club Ferrara tenuta da docenti di prima fascia.
Consueto è infine l’appuntamento del Torrione con l’arte contemporanea. Ospiti di questa edizione speciale di Ferrara in Jazz saranno le tavole dell’artista e illustratore Gianluigi Toccafondo, che costituiranno la preziosa anteprima del Festival internazionale di fumetto BilBOlbul (in collaborazione con Bologna Jazz Festival); “Note in bianco e nero”, la personale del giovane fotografo Michele Bordoni realizzata in collaborazione con Endas Emilia-Romagna e, last but not least, “Le strade del jazz”, mostra fotografica dell’eclettico Roberto Cifarelli.
Ferrara in Jazz 2016/2017 si fregia di una preziosa rete di co-produzioni che ne amplifica il prestigio e la visibilità. Quest’anno, oltre al Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara, Ferrara Musica, Bologna Jazz Festival e Crossroads Jazz e altro in Emilia-Romagna, il Jazz Club accoglie il nuovo ingresso di Teatro Off e Only Good Music. (altro…)
 La mattina, appena sveglio – maledetta abitudine – per prima cosa do uno sguardo alla rassegna stampa che mi arriva sul telefonino. E così ho fatto anche stamane; ad un certo punto, ancora non del tutto sveglio, noto la foto di un bell’uomo, giovane. Tra me e me penso: ma questo lo conosco. A poco a poco i neuroni si mettono in moto e lo riconosco, è lui, è Franco e capisco immediatamente: Franco Fayenz se ne è andato in un luogo, per chi ci crede, sicuramente migliore di questa terra.
La mattina, appena sveglio – maledetta abitudine – per prima cosa do uno sguardo alla rassegna stampa che mi arriva sul telefonino. E così ho fatto anche stamane; ad un certo punto, ancora non del tutto sveglio, noto la foto di un bell’uomo, giovane. Tra me e me penso: ma questo lo conosco. A poco a poco i neuroni si mettono in moto e lo riconosco, è lui, è Franco e capisco immediatamente: Franco Fayenz se ne è andato in un luogo, per chi ci crede, sicuramente migliore di questa terra.
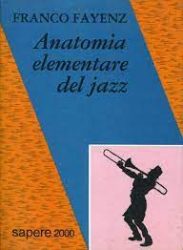





 Il Chick che ho ascoltato di più, tuttavia, è quello dei Return To Forever, nelle sue varie formazioni (dal 1971 ai giorni nostri) nelle quali sono transitati musicisti molto noti, tra cui alcuni top guitarist come Al Di Meola ed Earl Klugh. L’album di debutto della band, “Return to Forever”, uscito nel 1972 per l’etichetta ECM, con Chick al Fender Rhodes, Stanley Clarke al basso, Joe Farrell al flauto e sax, Airto Moreira, alle percussioni e la grande voce di Flora Purim, è per me uno dei dieci album di jazz-fusion più belli in assoluto…
Il Chick che ho ascoltato di più, tuttavia, è quello dei Return To Forever, nelle sue varie formazioni (dal 1971 ai giorni nostri) nelle quali sono transitati musicisti molto noti, tra cui alcuni top guitarist come Al Di Meola ed Earl Klugh. L’album di debutto della band, “Return to Forever”, uscito nel 1972 per l’etichetta ECM, con Chick al Fender Rhodes, Stanley Clarke al basso, Joe Farrell al flauto e sax, Airto Moreira, alle percussioni e la grande voce di Flora Purim, è per me uno dei dieci album di jazz-fusion più belli in assoluto… «Nel gruppo di Miles (Davis) facevo ciò che mi veniva chiesto. Per i primi sei mesi suonai il piano acustico, poi Miles disse che voleva un sound diverso; una notte si presentò con un piano elettrico e mi disse: “suona questo”. All’inizio ho odiato il Fender Rhodes, perché lo suonavo come un pianoforte, cosa che non è. Ma mi sono applicato, ho fatto di tutto per accontentare Miles. Poi quando ho fondato il mio primo gruppo Return to Forever ho suonato soprattutto il Fender».
«Nel gruppo di Miles (Davis) facevo ciò che mi veniva chiesto. Per i primi sei mesi suonai il piano acustico, poi Miles disse che voleva un sound diverso; una notte si presentò con un piano elettrico e mi disse: “suona questo”. All’inizio ho odiato il Fender Rhodes, perché lo suonavo come un pianoforte, cosa che non è. Ma mi sono applicato, ho fatto di tutto per accontentare Miles. Poi quando ho fondato il mio primo gruppo Return to Forever ho suonato soprattutto il Fender».













