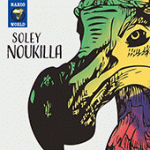da Beniamino Gatto | 25/Feb/2024 | Eventi, News, Primo piano, Recensioni
Serata “scoppiettante” quella di martedì scorso che alla Casa del Jazz, nell’ambito del ciclo “L’altra metà del Jazz” curato da Gerlando Gatto, ha visto protagoniste Susanna Stivali, accompagnata da Alessandro Gwis al piano, e Chiara Viola con Danilo Blaiotta al piano.
Come si accennava, ospite del primo tempo Susanna Stivali, che ha esordito rispondendo alla domanda di Gatto riguardo ad eventuali problemi legati al sessismo nel mondo del jazz; l’artista ha invitato tutti ad una riflessione, non su episodi specifici ma su un atteggiamento generale abbastanza arretrato nei confronti delle musiciste jazz in Italia sebbene oggi, grazie ad iniziative di musicisti, organizzatori e manager si stia avviando un lento ma inesorabile cambiamento, con una conseguente apertura maggiore alle musiciste jazz. Tra gli eventi più significativi, la creazione dell’associazione Musicisti Italiani di Jazz (MIDJ) del cui direttivo Susanna fa parte, l’istituzione del Premio Gender Equality destinato al festival più impegnato dal punto di vista della parità di genere e un report annuale che descrive la situazione relativa a questa problematica con riferimento al panorama nazionale.
-

-

Conclusa la parte relativa alle questioni di genere Susanna, guidata dalle domande di Gatto, parla della sua carriera partendo dalla sua preparazione: nel raccontare dei suoi studi di pianoforte, canto classico e canto jazz ricorda come la sua formazione classica sia stata indispensabile per avere solide fondamenta su cui costruire anche il canto jazz – disciplina che aveva intrapreso di nascosto, contro il volere della sua insegnante di canto. Una particolarità che riguarda la sua formazione è che anche lei, come altre musiciste di questa serie di incontri, ha studiato presso il Berklee College of Music di Boston per un anno e mezzo, grazie al conseguimento di una borsa di studio; proprio a Boston Susanna decide di dedicarsi in toto allo studio della musica. Relativamente a quell’esperienza, ma anche ai suoi numerosi viaggi in vari paesi tra cui Sudafrica, Brasile, Thailandia, Lettonia e Mozambico, Susanna descrive una sensazione molto particolare, che si prova studiando a lungo all’estero: paradossalmente quando si è più lontani da casa, a suo dire, ci si avvicina di più alle proprie radici e alla propria terra e ci si trasforma; a questo proposito condivide un bel ricordo di una sua partecipazione ad un festival locale di musica internazionale. Tra gli insegnanti avuti in questo periodo ricorda Bob Stoloff, Mark Murphy, ma soprattutto Hal Crook, trombonista di vaglia nonché autore del libro How To Improvise, uno dei più conosciuti manuali di improvvisazione jazz in circolazione.
In seguito parla delle sue collaborazioni una volta tornata in Italia: oltre ai sodalizi con artisti del calibro di Lee Collins, Miriam Makeba e Rita Marcotulli (già ospite di questa serie) Susanna dà particolare spazio al suo rapporto di amicizia con Giorgia, conosciuta in un campus in Inghilterra e con cui ha sviluppato fin da subito un legame grazie alla passione comune per Whitney Houston; legame che si è esteso anche in ambito artistico, dal momento che Susanna ha scritto il brano Chiaraluce per l’amica, contenuto nell’album Stonata del 2007. Un’altra collaborazione di cui la cantante parla con affetto è quella con il Trio Corrente composto da Paulo Paulelli al contrabbasso, Fabio Torres al pianoforte e Edu Ribeiro alla batteria, trio brasiliano tra i più conosciuti nell’ambito jazz in patria per uno stile musicale che adotta una pulsazione ritmica diversa da quella tipica brasiliana per fare spazio ad atmosfere più soavi e morbide (vincitori peraltro di un Grammy Award al miglior album di musica latina nel 2014 con Song For Maura, registrato con Paquito D’Rivera). Ed è collegandosi proprio a quest’argomento che si va a toccare l’ultimo punto della chiacchierata, ovvero l’importanza della scrittura, fondamentale a detta della vocalist che ha anche raccontato la sua evoluzione dal punto di vista della lingua usata: ha infatti iniziato a scrivere in inglese, cambiando poi registro quando è passata alla scrittura in italiano. Conclude quindi esprimendo la sua opinione riguardo alla correlazione tra sensibilità femminile e scrittura musicale, sostenendo l’effettiva inesistenza di questa dicotomia.
I brani cantati da Susanna, insieme al pianista Alessandro Gwiss, sono stati Valsinha, tratto dall’album Caro Chico; Fee-Fi-Fo-Fum dello scomparso Wayne Shorter e Decostruzione della stessa cantante, un’anteprima del suo prossimo album, in uscita a giugno in Brasile.
La seconda cantante della serata, Chiara Viola, entrata sul palco accompagnata dal pianista Danilo Blaiotta, inizia raccontando del suo rapporto con la musica, di cui si è innamorata soprattutto per quanto riguarda il canto, grazie al film Sister Act, la cui visione era una tradizione annuale nella scuola di suore che frequentava durante l’infanzia. In seguito, racconta dei suoi studi di chitarra classica e di come la sua passione per la musica degli 883 l’abbia da una parte spinta ad imparare a suonare lo strumento, e dall’altra l’abbia messa un po’ in contrasto con il suo insegnante. In seguito si iscrive alla Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia per studiare canto, e a seguito di un concerto di Joey Garrison si innamora del jazz e decide che quella sarà la sua strada (una divertita Chiara racconta, a questo proposito, dell’indifferente reazione di Garrison all’entusiasmo della cantante). Prosegue raccontando dei tanti lavori da lei svolti al di fuori della musica: dal fare l’hostess di terra per Alitalia a lavorare in un albergo di Parigi, dove si è trasferita in seguito e dove adesso risiede.
Tornando alla musica, continua parlando del suo periodo di studio al Conservatorio Santa Cecilia, con insegnanti del calibro di Maria Pia de Vito (già anche lei ospite del ciclo) e Danilo Rea, e della tesi con cui si è laureata con 110 e lode, dedicata al silenzio. Dietro sollecitazione di Gatto, la Viola esprime una particolare ammirazione per il “silenzio” che lei ama come una tela bianca che permette di apprezzarne i colori – in questo caso i suoni. Un dato curioso è che un’altra musicista ospite del ciclo, Miriam Fornari, aveva dedicato la sua tesi di laurea allo stesso argomento esprimendo più o meno le stesse opinioni di Chiara.
Il racconto prosegue con una artista assolutamente padrona del palco che denota una sorta di umorismo davvero apprezzabile con cui tiene desta l’attenzione del folto pubblico, chiaramente divertito e interessato. Ecco quindi l’esperienza in un gruppo di jazz tradizionale in contemporanea ad un suo tour con un complesso di free jazz – tour nato per puro caso, in cui lei era entrata in sostituzione della cantante titolare a causa di un malore di quest’ultima.
L’ultima parte della chiacchierata è dedicata ad un intenso dibattito, in cui è stato coinvolto anche Danilo, riguardo alle differenze tra l’Italia e Parigi per quanto riguarda il ruolo dei musicisti nella società: la nostra cantante racconta di un pubblico parigino educato fin da piccolo alla musica, grazie anche all’istituzione dei conservatoires, rinomate scuole di musica statali presenti in abbondanza nella Città delle Luci, una per ogni banlieue – ma più in generale grazie ad uno stato che investe di più sulla cultura rispetto a quello italiano, tanto che lì è in vigore una legge che consente ai musicisti di ricevere un sussidio statale (legge che, come fa notare Danilo, è passata in maniera molto più restrittiva anche qui in Italia); da qui è emersa un profondo disappunto da parte di Chiara nei confronti dello Stato italiano e degli organizzatori che non pagano abbastanza i musicisti, trascurando anche l’aspetto culturale.
I pezzi eseguiti da Chiara e Danilo sono stati Didsbury, tratta dall’album Until Down pubblicato da Chiara nel 2019, Lullaby for Francesco, anch’essa una toccante composizione della cantante, e una originale rielaborazione di Harvest Moon di Neil Young.
Degno di una nota a parte è stato il finale della serata: in virtù di un rapporto di amicizia che lega Chiara e Susanna, le due cantanti, accompagnate da Danilo Blaiotta al piano, si sono esibite insieme in una frizzante esecuzione di Bye Bye Blackbird.
Beniamino Gatto
da Beniamino Gatto | 16/Feb/2024 | Eventi, News, Primo piano, Recensioni
Dopo un’attesa di circa due mesi e mezzo, la fortunata serie L’Altra Metà del Jazz, a cura di Gerlando Gatto, è ricominciata alla Casa del Jazz con due valide artiste: la pianista Cinzia Gizzi e l’arpista e vocalist Noemi Nuti.
La prima parte della serata è dedicata appunto a Cinzia Gizzi, la cui intervista inizia con una riflessione sull’assenza del canto jazz nel Festival della Canzone Italiana di Sanremo, conclusosi pochi giorni prima dell’evento: riflessione da cui scaturisce l’amara considerazione di un confinamento del jazz in certe nicchie e ambienti definiti, nonostante l’attuale tendenza alla contaminazione tra generi.
-

- Cinzia Gizzi, Gerlando Gatto
-

- Cinzia Gizzi, Gerlando Gatto
Parla poi della sua carriera: partendo dal primo incontro con la musica che avvenne per caso durante i suoi studi universitari in una facoltà impostale dalla famiglia . Ma ben presto la musica ebbe la meglio e nell’arco di poco tempo si andò delineando la personalità di una grande artista che proseguì con il suo rapporto con il piano classico, che lei definisce fondamentale per una buona formazione jazzistica ma non indispensabile. Sulla musica classica tornerà in seguito, esprimendo la sua preferenza, tra i compositori, per Bach, genio capace di donare equilibrio a chi lo ascolta. Enumera quindi alcune delle sue collaborazioni più significative e di alto profilo come Harry “Sweets” Edison, Joe Newman, Sammy Davis e Tony Scott, dei quali ricorda con grande affetto l’aspetto umano oltre a quello artistico. E si arriva così al 1988, anno della svolta per la sua carriera: sarà infatti quello l’anno in cui vincerà una borsa di studio, grazie ad una sua amica che la convinse a presentare la domanda, che la porterà negli USA, a Berkeley; Cinzia ricorda questi tempi negli Stati Uniti come duri ma molto soddisfacenti. Altri incontri e collaborazioni l’hanno segnata: nello specifico con Chet Baker, Dizzy Gillespie e in particolare Jaki Byard, con cui ha studiato metodologia a seguito di un incontro presso il Mississippi Jazz Club, allora gestito dai fratelli Toth.
Racconta poi del suo ritorno in Italia e della pubblicazione del suo primo disco Trio and Sextet, nel 1991, con la collaborazione di musicisti come Flavio Boltro alla tromba, Piero Odorici al sassofono, Giovanni Tommaso al basso, Gianni Cazzola alla batteria e Mario Migliardi al trombone, e della sua carriera didattica di cui ricorda luci e ombre: tra le prime ricorda la soddisfazione dell’insegnamento, sottolineandone tuttavia la complessità; tra le seconde illustra le difficoltà affrontate a causa di un sistema che imponeva al detentore della cattedra unica l’insegnamento di sette materie in tutto il semestre ed anche del fatto che, in quanto donna, ha dovuto dimostrare più degli altri colleghi maschi. Da questo complessivo bagaglio di esperienze le deriva la forza e la capacità di scrivere due libri dedicati agli “Arrangiatori Jazz”.
Toccando infine gli aspetti più recenti della sua carriera, ricorda il premio alla carriera vinto nel 2017 nell’ambito del Premio Internazionale Profilo Donna, grazie alla segnalazione di Patricia Adkins Chiti, e conclude con una piccola riflessione sulla quasi totale assenza di jazz nella Rai, collegandosi alla prima domanda fatta durante l’incontro da cui si evince, secondo Cinzia, che i giovani d’oggi vengono bombardati da un determinato tipo di musica, mentre dovrebbero avere la possibilità di scegliere la musica che amano e la Rai – servizio pubblico, non dimentichiamolo – dovrebbe dare modo ai suoi ascoltatori, che pagano un canone, di seguire ogni genere musicale.
Come al solito non sono mancati interventi musicali: in questo caso Cinzia è stata accompagnata dal contrabbassista Pietro Ciancaglini e dal batterista Marco Valeri, e insieme hanno suonato I Keep Love in You di Bud Powell, Subconsciously di Lee Collins e Te Vojo Bene Assaje.
-

- Noemi Nuti, Gerlando Gatto
-

- Noemi Nuti, Andrew McCormack, Gerlando Gatto
-

- Noemi Nuti
Dopo il consueto intervallo di cinque minuti, la serata è ripresa con l’arpista e vocalist Noemi Nuti che purtroppo, a causa di un problema tecnico con l’arpa, si è presentata solo nelle vesti di cantante, accompagnata dall’eccellente pianista Andrew McCormack, compagno non solo sulla scena ma anche nella vita.
La vita di Noemi è caratterizzata da numerosi viaggi e contatti con diverse culture: nasce infatti a New York da famiglia italiana e ci rimane fino agli otto anni; da quel momento si trasferisce in Italia dove passerà la tarda infanzia e l’adolescenza, per poi trasferirsi a Londra, dove tuttora risiede. Già fin dall’età di otto anni Noemi inizia a studiare l’arpa, di cui si è innamorata grazie alla copertina di una rivista che la raffigurava in tutto il suo splendore; comincia quindi con lo studio dell’arpa classica e folk (soprattutto celtica) fino all’ottavo grado, ma grazie al contatto con la musica di Kurt Rosenwinkel ed Ella Fitzgerald decide di passare alla musica jazz: ed è in questo ambito che nel 2012 si diplomerà al Trinity College di Londra, studiando con insegnanti del calibro di Anita Waddell, John Hendrix e Sammie Purcell.
Nella sua musica risulta evidente un vivo interesse per la musica brasiliana, soprattutto per l’unione, da lei illustrata, tra ricchi ritmi e melodie leggere, semplici solo all’apparenza ma che in realtà nascondono una complessità disarmante: questa passione la porterà a formare una band di samba che arriverà fino al celeberrimo Carnevale di Rio de Janeiro. A proposito del Brasile, Noemi lo descrive come un posto molto particolare: un luogo isolato e un porto allo stesso tempo, contemporaneamente un melting pot e un luogo legato alla propria cultura.
Un altro luogo di cui parla con molto affetto è la sua residenza attuale, ovvero Londra: facendo un paragone tra la scena musicale londinese e quella italiana Noemi nota un attaccamento al passato e alle tradizioni molto più presente in Italia che nel Regno Unito dove, al contrario, osserva una maggiore apertura all’innovazione e attenzione da parte del governo nei confronti delle arti. Sempre a proposito del jazz inglese, descrive l’influenza subita dalla musica sudafricana e le differenze dei ritmi afro-jazz presenti nelle varie regioni del mondo: da una chiacchierata con il pianista panamense Danilo Pérez nasce una maggiore attenzione alle casse e ai bassi nelle regioni del Sud America, mentre, al contrario, una predilezione nei confronti dei piatti e delle frequenze alte nel Regno Unito; a questo proposito ha citato la cantante britannica Norma Winstone e come un suo brano, Azimuth, sia tornato alla ribalta grazie ai celebri rapper Drake e Yeat e ai produttori Bnyx e Sebastian Shah, che l’hanno campionata nel loro IDGAF, uscito nello scorso ottobre. Conclude infine il suo intervento con un ulteriore elogio nei confronti di Londra, ovvero di come la scena inglese permetta un’ottima formazione a livello professionale e di affrontare a ogni sorta di pubblico e ambiente.
I brani proposti con il pianista Andrew McCormack sono stati “For What I See,” composizione originale di Noemi contenuta nel suo disco ‘Venus Eye’ uscito nel 2020 e ispirata da “Treme Terra” di Flora Purim e Airto Moreira con Joe Farrell (il disco si chiama “Three-Way Mirror”). A questa prima, trascinante esibizione hanno fatto seguito “Disfarça e Chora” di Cartola e “I Can’t Believe You’re In Love With Me” di Jimmy McHugh, interpretato anche da Billie Holiday.
In quanto a pubblico la serata è stata un successo, facendo registrare non solo un numero di spettatori tale da riempire quasi l’intera sala ma anche un entusiasmo e un gradimento che chi vi scrive non può che condividere.
Il prossimo appuntamento è in programma martedì 20 Febbraio alle 21 con Susanna Stivali e Chiara Viola. Clicca qui per info&tickets
Beniamino Gatto
da Danilo Blaiotta | 30/Apr/2023 | News, Primo piano, Recensioni
“Ahmadiyya” era chiamata la comunità islamica a cui, nel 1951, il giovane Frederick Russell Jones affida la sua vita spirituale. Mirza Ghulam Ahmad, suo fondatore nell’India di fine ‘800, venne allontanato dall’Islam ufficiale e divenne quindi un eretico. Fino ad oggi, Ahmadiyya non appartiene alla stragrande percentuale dell’Islam sunnita. Jones si affida al profeta Ahmad e dalla sua conversione diviene Ahmad Jamal.
Parto da qui, per delineare i tratti più evidenti del profilo di uno dei più grandi pianisti della storia del jazz, scomparso il 16 aprile scorso ad Ashley Falls, Massachusetts.
La storia con la quale ho principiato vi racconta subito di un anticonformista per vocazione, una mina vagante in un periodo nel quale la musica jazz seguiva percorsi quasi obbligati: gli anni del bop, quelli del cool, l’hard-bop. Ahmad Jamal era però tutto e niente. Era un’altra storia.
-

- Udin&Jazz 1998 – ph: Luca A. d’Agostino
-

-

-

Il pianista solista di jazz si accompagnava, nell’era post-bop, con la classica ritmica contrabbasso/batteria. La prima formazione di un Jamal poco più che ventenne si avvale invece di contrabbasso e chitarra – Ray Crawford e Eddie Calhoun – come i trio di Nat King Cole e Art Tatum. I pianisti di allora inseguivano le funambolerie bop di Bud Powell e Wynton Kelly. Jamal crea spazi, usa l’armonia come fraseggio, cambia le carte in tavola.
Miles Davis lo ascoltò a Chicago nei primi ’50, ne rimase estasiato e ne divenne amico e supporter, tanto da affermare che Jamal fosse un vero e proprio riferimento per la sua musica. Viene naturale chiedersi allora come mai preferisce nelle sue formazioni pianisti come Horace Silver prima, Red Garland e Bill Evans poi.
Nel 1958 la carriera di Jamal esplose letteralmente, dopo la registrazione per la Argo dell’album live “At the Pershing / But not for me” in trio con Israel Crosby e Vernel Fournier. Il disco vendette quasi 50 mila copie in pochi mesi, rimase in classifica Billboard per 107 settimane e, negli anni ’90, venne calcolato che l’album arrivò a superare il milione di copie vendute. Si ricorda in particolare la sua celebre versione dello standard “Poinciana” di Nat Simon; tanto divenne nota, che molti ancora oggi pensano che sia una composizione dello stesso Jamal.
Curioso, aperto alle contaminazioni ma sempre a servizio dell’arte (la sua e specialmente il suo pianismo sono riconoscibilissimi sin dalle prime note); nei successivi decenni Jamal si avvicina anche al funky, alla musica latina e incide anche alcune perle in piano solo. Il mood però è sempre quello: devozione all’ascolto dell’intero gruppo, grandi dinamiche, gusto infinito per le scelte armoniche, timbriche e ritmiche.
Pensando agli anni ’80 e soprattutto ai gloriosi anni ’90 (decennio in cui la musica di Jamal subì una nuova ondata di successo), voglio consigliarvi due album che hanno stregato la mia adolescenza: “Live at Midem 1981” con il vibrafonista Gary Burton e lo stupendo “I remember Duke, Hoagy and Strayhorn” del 1994 con Ephriam Wolfolk al contrabbasso e Arti Dixson alla batteria.
Danilo Blaiotta
Con questo articolo, “A proposito di Jazz” saluta l’ingresso tra i suoi collaboratori di un grande pianista: Danilo Blaiotta. Di lui ci eravamo già occupati recensendo i suoi due album “Departures” e “The White Nights Suite”; da poco è uscito il terzo eccellente CD, “Platenariat”, su ci soffermeremo quanto prima con una approfondita intervista allo stesso Blaiotta. Per il momento siamo lietissimi di salutarlo come collaboratore con questo interessante ricordo di Ahmad Jamal, accompagnato anche da un raro spezzone video, girato nel 1998 durante il concerto che l’artista tenne a Udin&Jazz, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, con una speciale testimonianza…
________________________
“Jamal venne a Udin&Jazz nel 1998, in un nuovissimo Teatro Nuovo, e ci regalò eleganza, carisma, interculturalità nella sua massima espressione. Pochi come lui hanno saputo legare armonie e suoni delle origini africane con le più contemporanee letture occidentali. Non era certo un personaggio semplice con cui interloquire; il suo linguaggio espressivo era quasi esclusivamente la sua straordinaria musica”. (Giancarlo Velliscig, direttore artistico Udin&Jazz)
Ahmad Jamal, piano / Othello Molineaux, steel drums / James Cammack, double bass / Idris Muhammad, drums
Udin&Jazz– VIII edizione
Udine, 2 giugno 1998 / Teatro Nuovo Giovanni da Udine (Riprese d’archivio/Archive footage)
da Gerlando Gatto | 09/Mag/2022 | I nostri CD, Primo piano, Recensioni
I NOSTRI CD

 Jon Balke Siwan – “Hafla” – ECM
Jon Balke Siwan – “Hafla” – ECM
A distanza di tanti secoli ancora sopravvive il mito di Al-Andalus ovvero di quella Spagna medievale musulmana, in cui sotto la guida di colti principi arabi, musulmani, ebrei e cristiani vivevano tutti insieme senza distinzione alcuna di razza e/o di religione. Ecco, questo mito viene ora riattualizzato dalla musica di Siwan, il collettivo musicale transculturale e trans-idiomatico guidato dal tastierista e compositore norvegese Jon Balke, giunto al suo terzo album dedicato alla materia in oggetto. Questa volta uno accanto all’altro troviamo un musicista kemençe turco (Derya Turkan), un maestro iraniano del tombak (Pedram Khavar Zamini), un batterista norvegese di aperte vedute (Helge Norbakken), una nutrita sezione di archi specialisti del barocco guidata da Bjarte Ejke e una cantante algerina, Mona Boutchebak, che interpreta testi e di Wallada bint al-Mustakfi, la principessa omayyade di Cordoba dell’XI secolo e di altri poeti a lei contemporanei quali Ibn Zaydun (1003-1071, suo appassionato amante) e Ibn Sara As-Santarini (1043-1123). L’album non si presta ad un semplice ascolto né tanto meno ad una facile lettura. Si tratta di musica complessa, caratterizzata da un contesto in cui le parole hanno un peso spesso importante, e da un inusuale impasto sonoro determinato dalla coesistenza di strumenti che appartengono a mondi culturali diversi. Il leader tenta di assemblare il tutto con l’ impegno e la passione che gli sono propri, anche se il risultato non sempre è dei migliori.
 Flavio Boltro, Fabio Giachino – “Things to Say” – Cam Jazz
Flavio Boltro, Fabio Giachino – “Things to Say” – Cam Jazz
Suonare in duo è sempre molto impegnativo, forse più della prova in solitario. Il fatto è che quando ci si esibisce in due occorre che i musicisti si conoscano molto bene e riescano così a precedere le intenzioni l’uno dell’altro sì da assicurare alla musica una fluidità che non conosce intoppi. Ecco, tutto ciò lo si ritrova in questo album interpretato da due grandi jazzisti italiani. Flavio Boltro (classe 1961) è artista oramai maturo che ha raggiunto una perfetta padronanza dello strumento il che gli consente di evidenziare un bel suono, pieno, ricco supportato da un fraseggio mai fine a se stesso e da una indubbia capacità di intonare suadenti linee melodiche. Giachino (classe 1986) è un pianista che ha conquistato pubblico e critica grazie ad uno stile raffinato in cui sottile ironia e padronanza della dinamica si coniugano mirabilmente, il tutto declinato con una personale dimensione dello spazio (lo si ascolti in “Prelude to Salina”). In programma un repertorio tutto composto da original a firma soprattutto di Fabio Giachino il che conferma vieppiù la maturità di questo pianista. Di qui una musica che scorre fluida caratterizzata spesso da notevole intensità emotiva e soprattutto da una perfetta intesa tra i due musicisti che, pur proveniendo da ambienti diversi, riescono a fondere le loro esperienze in un unicum raffinato. Ed è una sensazione che si percepisce immediatamente sin dall’ascolto del primo brano in programma, “Piccola Nina” di Flavio Boltro, sino a quel “Spicy Blues” ancora di Boltro che chiude l’album.
 Avishai Cohen – “Naked Truth” – ECM
Avishai Cohen – “Naked Truth” – ECM
Tra le stelle di primaria grandezza che rifulgono nel panorama jazzistico internazionale, un suo posto di rilievo ce l’ha sicuramente il trombettista israeliano Avishai Cohen. Registrato negli Studios La Buissonne a Pernes-les-Fontaines nel Sud della Francia, nel settembre del 2021, sotto la produzione ECM, l’album ci consegna un Cohen sotto certi aspetti inediti. Abbandonate le atmosfere “elettriche” del precedente album, il trombettista si consegna al suo pubblico in estrema sincerità, con una musica tutta giocata sul coté dell’intimismo e declinata attraverso otto parti di una lunga suite intitolata “Naked Truth” e da un brano conclusivo, “Departure”. Avishai suona con la perizia che ben conosciamo ma è l’atmosfera generale dell’album che, come si diceva, lo proietta in una luce diversa. Perfettamente coadiuvato da Yonathan Avishai al piano, dal bassista Barak Mori e dal batterista Ziv Ravitz, il leader disegna una sorta di percorso che si snoda coerentemente quasi illustrando vari stati d’animo. Così si passa da pezzi di chiara impronta crepuscolare a frammenti in cui la tromba pare schiarirsi e aprirsi ad orizzonti più rosei fino a sfiorare il clima tipico delle ballad.
Da sottolineare come, accanto al leader, suona uno splendido Yonathan Avishai il cui pianoforte si pone come autentico alter-ego del leader prendendo egli stesso in mano il pallino del discorso (si ascolti al riguardo la convincente Part.V).
Come si accennava, il disco si chiude con la poesia “Departure”, dell’autrice israeliana Zelda Schneurson Mishkovsky (1914.1984), recitata dallo stesso Cohen sul tappeto strumentale degli altri musicisti.
 Claudio Cojaniz – “Orfani” – Caligola
Claudio Cojaniz – “Orfani” – Caligola
Poeta della tastiera. Così mi sento di definire Claudio Cojaniz dopo l’ascolto di questo bell’album registrato nell’aprile del 2021 a Treviso dall’oramai rodato quartetto del pianista completato da un sempre straordinario Alessandro Turchet al contrabbasso (a mio avviso uno dei migliori bassisti italiani), Luca Colussi alla batteria e Luca Grizzo percussioni. In repertorio sette composizioni dello stesso Cojaniz. Conosco Claudio oramai da tanti anni ma francamente non so dire con precisione a quali “orfani” si riferisce. Orfani di cosa? Di chi? Personalmente ho avvertito, comunque, nella musica di Cojaniz una sorta di dolore di fondo, di grande malinconia come se l’artista volesse farci riflettere sui tanti guai che in questo momento affliggono l’umanità. Certo, non ci si riferisce alla guerra ché l’album è stato inciso prima, ma resta egualmente la sensazione di un disagio, di un modo di vedere una realtà che non ci piace più di tanto. Ecco, penso che in questo caso il riferimento al blues, non tanto come struttura, ma come musica che rispecchia uno stato d’animo, sia assolutamente presente. E la cosa non stupisce più di tanto ove si tenga presente da un canto la lunga militanza di Cojaniz nell’ambito del jazz (il suo pianismo è ancora una volta coerente, del tutto idoneo alle sue volontà espressive), dall’altro i frequenti richiami africaneggianti che il musicista ha già fatto nei precedenti lavori. Insomma un artista che dimostra, ancora una volta, una profonda conoscenza del linguaggio jazzistico non solo dal punto di vista musicale ma anche da ciò che questo linguaggio ha rappresentato – e ancora oggi rappresenta – per le popolazioni di colore negli States…e non solo.
 Lorenzo De Finti Quartet – “Mysterium Lunae” – Losen
Lorenzo De Finti Quartet – “Mysterium Lunae” – Losen
Strano ma vero, un quartetto italiano che incide per una etichetta norvegese e non è la prima volta dato che il pianista Lorenzo De Finti ha già inciso per la Losen altri due album. Ma veniamo a quest’ultimo “Mysterium Lunae” registrato a Torino nei primi tre giorni del luglio 2021. Per quest’ultima fatica discografica, il gruppo si è arricchito di un prestigioso elemento, il trombettista e flicornista Alberto Mandarini unanimemente considerato musicista a 360 gradi. A completare il gruppo Stefano Dall’Ora al basso e Marco Castiglioni alla batteria. In programma sei brani firmati congiuntamente da De Fanti e Dall’Ora. De Finti è musicista di larga esperienza avendo suonato in orchestre sinfoniche, nella celebrata Instabile Orchestra e accanto a Paolo Conte in molte tournées. Ciò gli ha permesso di elaborare un proprio stile caratterizzato da un sound originale e dalla capacità di scavare a fondo in ogni composizione per trarne ogni possibile implicazione. E tutto ciò si evince dall’ascolto dell’album in oggetto che si apre con la composizione forse più interessante, “Mysterium Lunae”, che si richiama espressamente all’antica metafora per cui un oggetto freddo può diventare fonte di bellezza riflettendo, però, una luce più grande proveniente da qualcos’altro. Ecco quindi questo vero e proprio richiamo alla speranza, sentimento che nel corso della pandemia (periodo in cui è stato registrato il CD) purtroppo è andato quasi perso. Ma i quattro non si limitano a focalizzare uno stato d’animo ché l’album prosegue con una serie di atmosfere cangianti grazie all’attento uso dei colori e delle dinamiche che appaiono già patrimonio consolidato del quartetto.
 Joey DeFrancesco – “More Music” – Mack Avenue
Joey DeFrancesco – “More Music” – Mack Avenue
Non c’è dubbio alcuno che tra quanti suonano ancora oggi l’organo Hammond Joey DeFrancesco sia tra i più bravi. Ma il nostro non si limita a maneggiare con maestria l’organo dal momento che suona bene anche la tromba, il sax tenore, le tastiere e il piano. E ce ne dà prova in questo album in cui presenta undici composizioni (ben dieci a sua firma) in cui, accompagnato da una ritmica composta da Michael Ode alla batteria e Lucas Brown chitarra, organo e tastiere, si diverte ad evidenziare il suo multistrumentismo. E lo fa già in apertura interpretando alla tromba il brano “Free” che, a scanso di equivoci, nulla a che vedere ha con il free jazz. Eccolo ancora alla tromba nel blues “Where to Go”, mentre nelle due ballads, “Lady G” ed “Angel Calling”, si misura con il sax tenore… ma tutto ciò non sarebbe stato sufficiente senza un brano cantato… e voila “And If You Please”, cosicché in alcuni brani l’Hammond B3 viene suonato da Lucas Brown, anch’egli polistrumentista di assoluto livello. Da quanto sin qui detto risulta abbastanza evidente come tutto l’album sia all’insegna della gioia di suonare, di poter eseguire senza tema di essere criticati la musica che piace. Certo, se ci si dovesse poi chiedere in quale veste preferiamo Joey, la risposta non può che essere una ed una sola: all’organo Hammond di cui DeFrancesco rimane uno straordinario interprete, capace di trarre dallo strumento tutta una serie di nuances, di sfumature che pochi altri sanno imitare.
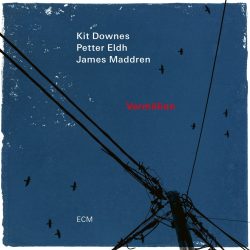 Kit Downes – “Vermillion” – ECM
Kit Downes – “Vermillion” – ECM
Dopo i suoi due precedenti album per ECM, “Dreamlife of Debris” del 2019 e “Obsidian” del 2017 in cui suonava un organo da chiesa a canne, il musicista inglese Kit Downes si ripresenta alla testa di un classico piano-trio coadiuvato dallo svedese Petter Edh già ammirato nel trio di Django Bates al contrabbasso e il britannico James Maddren alla batteria. In realtà al momento della registrazione di questo album, i tre si conoscevano già bene avendo suonato assieme sotto l’insegna di Trio Enemy. Questo “Vermillion” risente molto della formazione musicale del leader: abituato a frequentare quasi indistintamente territori classici, moderni e jazzistici, il pianista infonde alla sua musica uno spirito affatto particolare che la pone piuttosto lontana da ciò che normalmente si immagina debba essere un trio di jazz. In effetti qui non troviamo una continua pulsazione ritmica, né linee melodiche facilmente identificabili ma un flusso costante di musica tutta giocata su toni meditativi. Ovviamente – Evans insegna – non c’è alcuna gerarchia fra i tre strumenti che dialogano su un piano di assoluta parità alla ricerca di un’espressività interiore che mai viene meno. Di qui la sensazione, non si sa bene quanto veritiera, che la scrittura la faccia da padrona sull’improvvisazione. Insomma una sorta di viaggio introspettivo declinato attraverso dieci composizioni di pianista e contrabbassista e la cover di Jimi Hendrix, “Castles Made of Sand” tratto da “Axis: bold as Love” del 1967che chiude meravigliosamente l’album.
 Mathias Eick – “When We Leave” – ECM
Mathias Eick – “When We Leave” – ECM
Il trombettista Mathias Eick è uno di quei musicisti che mai ti delude. Ogni suo album è una summa di quel che oggi dovrebbe rappresentare, a nostro avviso, la figura del jazzista, vale a dire un musicista che pur conoscendo perfettamente la tradizione, volge lo sguardo al futuro. E lo fa con la piena consapevolezza dei propri mezzi espressivi. Ingredienti, questi, che si ritrovano appieno in “When We Leave” registrato a Oslo nell’agosto 2020 da un organico piuttosto ampio guidato da Mathias Eick (nell’occasione anche alle tastiere) e completato da Andreas Ulvo al piano, dal bassista Audun Erlien, da Hakon Aase violino e percussioni, dai due batteristi e percussionisti Torstein Lofthus e Helge Andreas Norbakken e dal chitarrista Stian Carstensen il cui apporto risulta tutt’altro che secondario. Come abbiamo già avuto modo di apprezzare nei suoi precedenti lavori, la musica di Eick si mantiene su atmosfere intimiste, malinconiche, declinata attraverso il fitto colloquio dei musicisti che sembrano aderire perfettamente a quelle che sono le linee guida dettate dal leader. Di qui una insieme di linee melodiche sempre riconoscibili, un perfetto controllo del ritmo ben supportato da una sezione quanto mai precisa ed efficiente, ed un gioco sulle dinamiche che spesso si fa apprezzare per la sua originalità. Tra i vari strumentisti precedentemente citati, da sottolineare ancora una volta la prova del violinista Hakon Aase che oltre ad eseguire spesso il tema all’unisono con la tromba del leader, si produce in pregevoli assolo. Ma il fulcro di tutto è sempre lui, Mathias Eick il cui strumento si staglia sempre preciso, puntuale, così come le sue capacità compositive dato che tutti i brani dell’album sono dovuti alla sua penna.
 Antonio Flinta – “Secrets of a Kiri Tree” – Autoprod.
Antonio Flinta – “Secrets of a Kiri Tree” – Autoprod.
Sono passati circa due anni da quando, discutendo con Antonio Flinta, gli chiesi come mai non si fosse ancora cimentato al piano-solo dopo una intensa carriera. Antonio mi rispose che l’avrebbe fatto solo se si fosse sentito pronto. Il momento è arrivato ed ecco questo “Secrets of a Kiri Tree” in cui il pianista cileno ci spinge a guardarci nel profondo, a riscoprire quel che abbiamo dentro, anche se per farlo probabilmente abbiamo bisogno di qualcuno che si spinga in tal senso. E per ottenere tale scopo Flinta sceglie un repertorio tanto vasto quanto difficile. Ecco quindi Paco de Lucia con “Cancion de amor”, accanto a George Fragos (“I Hear a Rhapsody”), la straordinaria Violeta Parra (“Gracias a la vida”) assieme al gigante del jazz Thelonious Monk (”’Round Midnight”) il tutto completato da tre originals di Antonio. A nostro avviso il meglio dell’album lo si ritrova nelle composizioni dello stesso pianista. Scevro da qualsivoglia preoccupazione se non quella di lasciarsi andare al proprio istinto, Flinta inanella una serie di improvvisazioni davvero notevoli in cui mai si perde il filo del discorso tanto è solida la base su cui l’artista costruisce i suoi edifici musicali. Così risulta quanto mai arduo distinguere le parti improvvisate da quelle scritte, ammesso poi che la cosa abbia un minimo di importanza. Così il pianismo di Flinta scorre fluido sicuro, lucido, essenziale, mai sovracaricato di orpelli inutili e pur tuttavia sempre in grado di incuriosire l’ascoltatore. Quanto agli altri brani, abbiamo particolarmente apprezzato la versione di “Gracias a la vida” che conserva intatta la sua dolce e malinconica linea melodica.
 Tord Gustavsen – “Opening” – ECM
Tord Gustavsen – “Opening” – ECM
Ancora un piano-trio questa volta di marca norvegese. A costituirlo sono infatti il pianista Tord Gustavsen, il contrabbassista Steinar Raknes (responsabile anche di un sapiente e sobrio uso dell’elettronica) e il batterista Jarle Vespestad ovvero tre dei migliori musicisti che il panorama jazz norvegese possa oggi offrire. E il risultato è in effetti di grande rilevanza. Certo non scopriamo in questa sede lo straordinario talento del pianista, ma fa immenso piacere constatare come uno dopo l’altro tutti i lavori di Tord si mantengano su un livello di assoluta eccellenza. In programma, questa volta, dodici brani di cui nove a firma del leader cui si aggiungono un brano traditional e due pezzi firmati rispettivamente da Geir Tveitt – figura centrale del movimento culturale norvegese negli anni ’30 – e da Egil Hovland, compositore classico che si formò studiando tra gli altri con Aaron Copland e a Firenze con Luigi Dallapiccola. E da queste poche note si può già comprendere quanto ampio sia l’universo musicale di riferimento di Gustavsen e quindi dell’intero trio. Di qui una musica saldamente ancorata al patrimonio norvegese, e nordico più in generale. Ecco quindi la rivisitazione, già al secondo pezzo, di un brano abbastanza celebrato in Svezia, “Visa från Rättvik” (Vista dalla città di Rättvik), già inserito da Jan Johansson – uno tra i più grandi pianisti svedesi di cui Gustavsen ha dichiarato di sentire l’influenza – nell’album del 1964, “Jazz pa Svenska”, album che all’epoca vendette la stratosferica cifra di 250.000 copie. Gustavsen stravolge il pezzo rendendolo praticamente suo e lo stesso fa per tutta la durata dell’album mai offrendo musica banale o scontata. Si ascolti, ad esempio, il suo modo di intendere il tango in “Helensburgh Tango”, lontano che più non si potrebbe dalle atmosfere tipiche tanguere. Splendida la versione di “Var Sterk, Min Sjel” assolutamente rispettosa dell’originale del già citato Egil Hovland.
 Roberto Laneri – “Musica finta / Blue Prints” – Da Vinci Classics
Roberto Laneri – “Musica finta / Blue Prints” – Da Vinci Classics
Roberto Laneri – “South of No Border” – Black Sweat Records
Il polistrumentista Roberto Laneri si ripresenta con due album registrati rispettivamente nel 1998 e in un arco temporale che va dal 2014 al 2018. Ma procediamo con ordine. “Musica finta / Blue Prints”, registrato come si diceva nel 1998 ma pubblicato solo nei primi mesi del 2020, va inquadrato correttamente grazie al sottotitolo “A Study in Metamusicology”. Si tratta, cioè, di un album assai complesso, di lettura difficile, in cui Laneri – come egli stesso afferma, suonando al sax soprano alcuni rags di Scott Joplin ha provato ad introdurre dei cambiamenti nel testo, dapprima minimi, poi sempre più articolati, fino ad arrivare alla composizione di pezzi autonomi e paralleli, da suonarsi assieme ai pezzi originali. “L’effetto di questa estremizzazione – aggiunge Laneri – è paragonabile alle prospettive impossibili di Escher, oppure ai disegni tridimensionali generati al computer, dai quali possono emergere immagini complementari eppur assai diverse da quelle immediatamente apparenti”. Fin qui le premesse metodologiche. Ma il risultato musicale? Laneri presenta composizioni originali, unite a quelle di Schumann, Schubert ma anche Joplin e Jelly Roll Morton. Quindi linguaggi differenti ricondotti ad unità per una sorta di opera di ampio respiro divisa in cinque capitoli. Per questa impresa Laneri (sax soprano, sampling e sound treatment) ha chiamato accanto a sé la pianista Maria Jolanda Masciovecchio e Alan Ferry come spoken voice.
 “South of No Border” (come si diceva registrato tra il 2014 e il 2018 ma anch’esso pubblicato poche settimane fa) vede Roberto Laneri (clarinetto, clarinetto basso, sax sopranino, sax soprano e alto, didjeridoo, shruti box, voce e percussioni) alla testa di un gruppo comprendente Giuppi Paone voce, Raffaela Siniscalchi voce, Eleonora Vulpiani chitarra, Luigi Polsini contrabbasso e Laugi Marino zarb. Contrariamente al primo album, in questo caso il repertorio è come una sorta di finestra affacciata sulle musiche del mondo. Ecco, quindi, dopo l’apertura affidata alle melodie orientaleggianti di “Malia” (scritta da Laneri), il choro brasiliano “Tico-Tico no fubá” (scritto da Zequinha de Abreu nel 1917, accanto al bolero cubano “Contigo En La Distancia” scritto dal cantautore César Portillo de la Luz quando aveva 24 anni nel 1946, il tutto impreziosito da 4 original del leader. A confronto con un tale repertorio, Laneri dà ancora una volta prova non solo della sua indiscussa preparazione tecnica ma anche della profonda conoscenza del panorama musicale internazionale. Le sue interpretazioni risultano, quindi, assolutamente pertinenti: traendo feconda ispirazione da svariate tradizioni, riesce a produrre una sintesi che non conosce confini geografici grazie ad una concezione visionaria della musica senza barriere. Insomma un disco originale nella concezione e nell’esecuzione.
“South of No Border” (come si diceva registrato tra il 2014 e il 2018 ma anch’esso pubblicato poche settimane fa) vede Roberto Laneri (clarinetto, clarinetto basso, sax sopranino, sax soprano e alto, didjeridoo, shruti box, voce e percussioni) alla testa di un gruppo comprendente Giuppi Paone voce, Raffaela Siniscalchi voce, Eleonora Vulpiani chitarra, Luigi Polsini contrabbasso e Laugi Marino zarb. Contrariamente al primo album, in questo caso il repertorio è come una sorta di finestra affacciata sulle musiche del mondo. Ecco, quindi, dopo l’apertura affidata alle melodie orientaleggianti di “Malia” (scritta da Laneri), il choro brasiliano “Tico-Tico no fubá” (scritto da Zequinha de Abreu nel 1917, accanto al bolero cubano “Contigo En La Distancia” scritto dal cantautore César Portillo de la Luz quando aveva 24 anni nel 1946, il tutto impreziosito da 4 original del leader. A confronto con un tale repertorio, Laneri dà ancora una volta prova non solo della sua indiscussa preparazione tecnica ma anche della profonda conoscenza del panorama musicale internazionale. Le sue interpretazioni risultano, quindi, assolutamente pertinenti: traendo feconda ispirazione da svariate tradizioni, riesce a produrre una sintesi che non conosce confini geografici grazie ad una concezione visionaria della musica senza barriere. Insomma un disco originale nella concezione e nell’esecuzione.
 Roberto Magris – “Match Point” – JMood / Roberto Magris – “Duo & Trio” – JMood
Roberto Magris – “Match Point” – JMood / Roberto Magris – “Duo & Trio” – JMood
Tra i musicisti che riescono a conservare un alto livello delle proprie produzioni, lavorando in ambedue le sponte dell’Atlantico, c’è sicuramente il pianista Roberto Magris di cui segnaliamo due nuove uscite. Il primo – “Match Point” – registrato a Miami l’8 dicembre del 2018, è stato a ben ragione considerato da critici statunitensi come uno degli album più interessanti pubblicati negli ultimi mesi. “Match Point” vede il pianista triestino alla testa di un quartetto dai mille colori completato dal cubano Alfredo Chacon al vibrafono e percussioni, dal batterista Rodolfo Zunica proveniente dal Costa Rica e dallo statunitense Dion Kerr al basso. In repertorio otto brani equamente divisi tra composizioni dello stesso Magris e brani di giganti della tastiera quali Richard Kermode tastierista americano, noto soprattutto per essersi esibito con Janis Joplin, Malo e Santana, McCoy Tyner, Thelonious Monk, Randy Weston. Da quanto sin qui detto è già possibile avere un’idea della musica che Magris ci propone, una musica che, saldamente ancorata alla produzione, presenta quel tocco di “latino” che impreziosisce il tutto. Al riguardo basti ascoltare “Caban Bamboo Highlife” di Randy Weston, uno dei jazzisti preferiti da Magris, con Chacon e Zuniga in grande evidenza.
In “Duo & Trio” Magris adotta una formula diversa esibendosi in sei brani in duo con il sassofonista Mark Colby e in cinque pezzi in gruppo con Elisa Pruett al basso, Brian Steever alla batteria mentre Pablo Sanhueza alle congas è presente solo in “Melody for C” di Sonny Clark e “Samba Rasta” di Andrew Hill. Per il resto i compositori visitati da Magris fanno parte dell’Olimpo della musica quali Elmo Hope, Bernstein, Ray Noble, Shuman, Kurt Weill; il tutto completato, come al solito, da alcune composizioni dello stesso Magris. L’ascolto dell’album lascia pienamente soddisfatti per almeno due ordini di motivi: innanzitutto la straordinaria maestria di Roberto Magris che, dall’alto della sua immensa preparazione pianistica, affronta con estrema disinvoltura partiture assai diversificate tra di loro (eccolo intimista e toccante in “Old Folks”, classico nell’accezione più completa del termine in “Cherokee”, trascinante improvvisatore in “Melody for C”); in secondo luogo per la scelta di collaboratori sempre di livello. Da segnalare, in questa occasione il lavoro del sassofonista Mark Colby che sia al tenore sia al soprano evidenzia una forte personalità scevra da qualsivoglia intento di stupire chi ti ascolta.
 Dino & Franco Piana Ensemble – “Reflections” –Alfa Music
Dino & Franco Piana Ensemble – “Reflections” –Alfa Music
Attualmente l’ensemble diretto dalla premiata ditta “Dino & Franco Piana” è una delle migliori formazioni del jazz attuale. Ciò anche perché nel suo ambito, oltre ai citati leader, figurano artisti di grande spessore quali la pianista Stefania Tallini, il bassista Dario Deidda e il batterista Roberto Gatto. In quest’ultima fatica discografica il gruppo è affiancato dalla B.i.m. Orchestra mentre il repertorio comprende dieci brani di cui ben sei composti da Franco Piana (altresì flicornista e arrangiatore del gruppo), altri due original dovuti rispettivamente a Lorenzo Corsi e Stefania Tallini e due standard, “Skylark” di Hoagy Carmichael e “Embraceable You” di George Gershwin. Il progetto nasce durante il lockdown dalle riflessioni dei due leader che hanno focalizzato l’attenzione sulle molteplici possibilità d’espressione che i vari organici possono offrire. Di qui il far ricorso, per ogni brano, ad un organico diverso. Si inizia così da “Skylark”, suonato dal trombone di Dino Piana in solo, passando poi a brani in duo – trio – quartetto – quintetto – sestetto, fino ad arrivare ad arrangiamenti per quartetto d’archi (B.i.m. Orchestra), 4 flauti, piano e flicorno. Come le precedenti prove dei Piana, anche questo album entra di diritto tra i migliori album di jazz italiano pubblicati negli ultimi mesi in quanto la bellezza dei temi è supportata e valorizzata da arrangiamenti ben strutturati e altrettanto ben eseguiti da una formazione che presenta anche individualità di tutto rispetto. Senza dimenticare i due leader – di cui comunque spesse volte abbiamo tessuto le lodi – bisogna sottolineare l’apporto di Stefania Tallini che si conferma jazzista a tutto tondo capace sia di sviluppare suadenti linee melodiche sia di imporre un ritmo preciso e coinvolgente (la si ascolti in “D and F”). Ma la citazione di questo brano è solo un esempio ché tutto l’album merita di essere ascoltato.
 Valentina Ranalli, Enrico Pieranunzi – “Cantare Pieranunzi” – Alfa Music
Valentina Ranalli, Enrico Pieranunzi – “Cantare Pieranunzi” – Alfa Music
Enrico Pieranunzi Quintet – “The Extra Something” – Cam Jazz
Quasi contemporaneamente sono usciti due pregevoli album che vedono impegnato Enrico Pieranunzi. Nel primo – “Cantare Pieranunzi” – il pianista romano si presenta nella triplice veste di leader dello Youth Project (con Giuseppe Romagnoli al basso, Cesare Mangiocavallo alla batteria e Giacomo Serino alla tromba), compositore e arrangiatore. Il tutto al servizio della vocalist Valentina Ranalli. La genesi dell’album è assai particolare e ce la illustra lo stesso Pieranunzi nelle note che accompagnano il CD: in buona sostanza “Cantare Pieranunzi” è il frutto della tesi di laurea in canto jazz presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma di Valentina Ranalli che ha presentato un lavoro incentrato su pezzi del pianista, cui ha aggiunto le parole in italiano, inglese, francese e napoletano. Incuriosito dall’iniziativa e dopo aver ascoltato la vocalist, Pieranunzi decide di mettere il tutto su disco e bene ha fatto dal momento che l’album è di assoluto livello. Le undici tracce contenute nell’album sono interpretati dalla Ranalli con sincera partecipazione dialogando intensamente con il pianoforte di Enrico: si ascolti, ad esempio, “You Know”. Ma è tutta la performance della cantante che convince e che fa ottimamente sperare per il suo futuro; fra i pezzi da segnalare “Suspension points” fatto di poche note ma di tanta emozione, e “Persona” in cui la Ranalli si trova particolarmente a suo agio esprimendosi nella lingua della sua terra, il partenopeo.
 Completamente diverso il secondo album – “The Extra Something” – registrato live il 13 e 14 gennaio 2016 al Village Vanguard da un quintetto che vedeva il pianista romano in compagnia di Diego Urcola tromba e trombone (semplicemente straordinario nella title tracke), Seamus Blake sax tenore (particolarmente convincente in “Atoms”), Ben Street basso e Adam Cruz batteria. E per quanti seguono il jazz non c’è bisogno di altre parole per sottolineare il valore assoluto della band. Valore assoluto che si evidenzia in tutto il repertorio, sette brani tutti composti dal pianista. Pieranunzi, come spesso gli capita, è in uno stato di grazie e conduce il gruppo con mano sicura, del tutto consapevole dell’intesa che ha raggiunto con i compagni di viaggio. Dal punto di vista compositivo non scopriamo certo oggi il suo senso della struttura che mai l’abbandona, per cui se consideriamo tutti questi elementi si capisce bene perché il ben noto Brian Morton abbia incluso Enrico tra “i più significativi musicisti contemporanei”. Nelle note di copertina Pieranunzi dedica espressamente questo terzo CD Live at The Village Vanguard a Lorraine Gordon in memoriam, senza la quale né questo né i precedenti due si sarebbero potuti realizzare. Ricordiamo per inciso che il pianista romano è forse l’unico musicista italiano nella veste di leader ed uno dei pochissimi europei ad aver suonato nel leggendario jazz club a forma di diamante aperto da Max Gordon nel 1935 al 178 Seventh Avenue South di Manhattan.
Completamente diverso il secondo album – “The Extra Something” – registrato live il 13 e 14 gennaio 2016 al Village Vanguard da un quintetto che vedeva il pianista romano in compagnia di Diego Urcola tromba e trombone (semplicemente straordinario nella title tracke), Seamus Blake sax tenore (particolarmente convincente in “Atoms”), Ben Street basso e Adam Cruz batteria. E per quanti seguono il jazz non c’è bisogno di altre parole per sottolineare il valore assoluto della band. Valore assoluto che si evidenzia in tutto il repertorio, sette brani tutti composti dal pianista. Pieranunzi, come spesso gli capita, è in uno stato di grazie e conduce il gruppo con mano sicura, del tutto consapevole dell’intesa che ha raggiunto con i compagni di viaggio. Dal punto di vista compositivo non scopriamo certo oggi il suo senso della struttura che mai l’abbandona, per cui se consideriamo tutti questi elementi si capisce bene perché il ben noto Brian Morton abbia incluso Enrico tra “i più significativi musicisti contemporanei”. Nelle note di copertina Pieranunzi dedica espressamente questo terzo CD Live at The Village Vanguard a Lorraine Gordon in memoriam, senza la quale né questo né i precedenti due si sarebbero potuti realizzare. Ricordiamo per inciso che il pianista romano è forse l’unico musicista italiano nella veste di leader ed uno dei pochissimi europei ad aver suonato nel leggendario jazz club a forma di diamante aperto da Max Gordon nel 1935 al 178 Seventh Avenue South di Manhattan.
 Serena Spedicato – “Io che amo solo te” – Dodicilune
Serena Spedicato – “Io che amo solo te” – Dodicilune
Non sempre la bellezza della confezione corrisponde alla bontà del contenuto. In questo caso, la Dodicilune ha realizzato qualcosa di eccellente affidando alla vocalist Serena Spedicato (utilizzata anche come splendida voce narrante) un repertorio per noi italiani impossibile da dimenticare, all’interno di una confezione sobriamente elegante. In realtà Serena Spedicato e lo scrittore Osvaldo Piliego avevano dato vita a questo loro progetto originale come concerto/spettacolo con la regia di Riccardo Lanzarone, che solo successivamente è approdato alla forma libro/cd. Così la Dodicilune ci presenta un prezioso libretto, con la grafica di Marina Damato, autrice delle foto con Maurizio Bizzochetti, e i testi inediti di Osvaldo Piliego che accompagnano dodici brani tra i più belli e rappresentativi del cantautorato italiano, rielaborati in una forma nuova grazie agli arrangiamenti del fisarmonicista Vince Abbracciante coadiuvato da Nando Di Modugno (chitarra classica) e Giorgio Vendola (contrabbasso). Le canzoni proposte appartengono tutte alla cd. “scuola genovese” vale a dire Luigi Tenco, Fabrizio De André, Gino Paoli, Sergio Endrigo, Umberto Bindi, Bruno Lauzi. In buona sostanza tutto il lavoro ruota attorno ai cantautori che sono cresciuti e si sono formati in quel di Genova, ove sul finire degli anni Cinquanta si sviluppò un movimento culturale e artistico che rivoluzionò il mondo della canzone italiana. Ed è proprio questo clima che si respira ascoltando l’album. Molte le positività del lavoro: le centrate interpretazioni della vocalist che evidenzia una musicalità ed una sensibilità non comuni, i testi intelligenti che aiutano (soprattutto i più giovani) a capire ciò che si ascolta, ma soprattutto gli arrangiamenti di Vince Abbracciante che oramai non ne sbaglia una. Misurarsi con dei veri e proprio mostri sacri della musica non è certo impresa facile: ebbene il fisarmonicista ha affrontato l’impresa con passione e professionalità regalandoci degli arrangiamenti che, senza alcunché togliere al fascino originario, hanno rivestito i brani di una patina jazzistica pertinente ed affascinante. Ovviamente più che positiva anche l’apporto di Nando Di Modugno e Giorgio Vendola per un album di sicuro rilievo.
 Andrés Thor – Hereby – Losen
Andrés Thor – Hereby – Losen
Siamo veramente grati alla norvegese Losen Records per la possibilità che ci offre di far conoscere al pubblico italiano dei veri e propri talenti che, non avendo ancora raggiunto fama internazionale, difficilmente raggiungono le nostre platee. E’ il caso del chitarrista islandese Andrés Thor che, giunto al suo settimo album da leader, si presenta al pubblico alla testa di un trio completato dall’altro islandese Magnús Trygvason Eliassen batteria e dal francese Nicolas Moreaux contrabbasso. Quello di Thor è un fraseggio molto personale, pulito, chiaro, senza alcuna pretesa di sperimentalismo o di sensazionalismo. La sua idea di guidare il trio si avvicina molto alla lezione impartita da Bill Evans con Scott LaFaro. Quindi una formazione che si muove su basi paritetiche in cui ognuno può improvvisare ed esprimere la propria personalità all’interno di una cornice ben delineata dalle nove composizioni tutte a firma dello stesso Thor. Da un punto di vista prettamente chitarristico, Thor è chiaramente ispirato da tre grandi esponenti della chitarra jazz – Jim Hall, John Scofield e Pat Metheny – mentre sotto un profilo più generale tra i suoi maggiori interessi figurano rock band come i Led Zeppelin e i Doors nonché Jimi Hendrix e John Coltrane. Come si nota un universo di riferimento assai ampio che Thor dimostra di aver assorbito molto bene soprattutto nel modo in cui costruisce le sue composizioni, dotate tutte di un eccellente senso architettonico e ben arrangiate. Da sottolineare che mentre nei primi sette brani Andrés utilizza la chitarra elettrica, negli ultimi due imbraccia lo strumento acustico senza che ciò influenzi minimamente l’omogeneità dell’album.
 Mark Turner – “Return From The Stars” – ECM
Mark Turner – “Return From The Stars” – ECM
Registrato a New York nel novembre del 2019, questo album vede impegnato un quartetto piano-less guidato dal sassofonista Mark Turner e completato da Jason Palmer alla tromba, Joe Martin al contrabbasso e Jonathan Pinson alla batteria. L’album si inserisce in quella nuova corrente musicale che si allontana molto dal jazz mainstream per inserirsi in ciò che si può definire “musica moderna” tout court. Ma, a questo punto, qualcuno potrebbe chiedersi: si tratta ancora di jazz? Lasciamo ad altri la risposta a questo inutile quesito per soffermarci su un altro interrogativo molto più pregnante: si tratta di musica di qualità o no? La risposta non può che essere positiva: si, si tratta di musica di qualità dal momento che risponde ad alcuni requisiti facilmente individuabili. Intendiamo riferirci, innanzitutto, alla natura delle composizioni: Turner scrive benissimo, con perfetto senso delle proporzioni, lasciando ad ognuno dei suoi collaboratori il giusto spazio pur essendo comunque in condizione di ricondurre il discorso ad unità; il tutto corroborato dalla capacità di creare una omogeneità di fondo. Ma ciò sarebbe stato inutile se ad interpretare queste complesse partiture non ci fossero stati dei musicisti completi, preparati. Si ascolti, ad esempio, con quanta pertinenza il trombettista segua il leader nelle sue escursioni o di come il batterista riesca ad inserire il suo drumming nelle complesse trame disegnate dal leader mentre il basso non perde un colpo nel supportare il ritmo del gruppo. Insomma un disco tutto da gustare, per palati raffinati.
 Cristina Zavalloni – “Parlami di me” – Egea
Cristina Zavalloni – “Parlami di me” – Egea
“Parlami di me” è il suggestivo titolo di questo nuovo album dedicato alle musiche di Nino Rota, all’anagrafe Giovanni Rota Rinaldi, scomparso nel 1979 e a ben ragione considerato, a livello mondiale, uno dei massimi esponenti dei compositori che hanno dedicato la loro vita al cinema. Basti ricordare le colonne sonore di quasi tutti i film di Fellini nonché le colonne sonore del Padrino e Il padrino – Parte II vincendo, per quest’ultimo, il Premio Oscar alla migliore colonna sonora. Evidentemente il connubio tra jazz e musiche da film non è certo una novità eppure ogni nuovo album del genere va ascoltato con la massima attenzione data la delicatezza della materia. In effetti estrapolare tale musiche dal contesto per cui sono nate e farne un qualcosa a sé stante è impresa tutt’altro che banale. A cimentarsi con questo difficile compito è ora una delle nostre migliori vocalist, Cristina Zavalloni, accompagnata da quattro musicisti di assoluto livello quali Gabriele Mirabassi al clarinetto, Cristiano Arcelli al sax soprano (nonché responsabile degli ottimi arrangiamenti), Massimo Morganti al trombone e Manuel Magrini al pianoforte, cui si aggiunge il ClaraEnsemble, sestetto costituito da flauto, contrabbasso, due violini, viola e violoncello. Un organico, quindi, piuttosto ampio che si attaglia perfettamente sia alla voce della Zavalloni sia agli arrangiamento di Arcelli. La vocalist entra quasi in punta di piedi nell’universo di Nino Rota, ma subito dopo se ne appropria, lo fa suo e lo reinterpreta con chiavi sempre originali pur nulla perdendo dell’originario fascino. Così riascoltiamo alcune perle del Maestro che hanno stupendamente accompagnato le immagini volute dai più grandi registi italiani da Fellini a Visconti, da Wertmuller a Zeffirelli…Il repertorio dell’album si completa con l’unica canzone scritta integralmente, dalla Zavalloni, “Prova tu”, che si integra perfettamente nel discorso generale portato avanti da “Parlami di me”.
Gerlando Gatto
da Gerlando Gatto | 19/Set/2020 | Interviste, News, Primo piano
Ho appena finito di ascoltare per la quarta volta “Nascente”, un bell’album firmato dal vocalist Flavio Spampinato per l’Alfa Music. Dicevo un bell’album e questo giudizio è del tutto condiviso da Maria Pia De Vito e da David Linx, che di canto jazz capiscono qualcosina. Non a caso scrive la De Vito, riporto testualmente: “In ‘Nascente’, questo primo lavoro di Flavio Spampinato, ritrovo grazia e profondità, ricerca, tensione desiderante, gioia, nella grana della voce. C’è amore. C’è tutto quello che occorre per un viaggio lungo con la musica. Ad maiora!”.

Flavio Spampinato è seduto proprio di fronte a me in un’afosa giornata d’estate e ci apprestiamo a concretizzare un’intervista a lungo progettata. Da siciliano doc sono molto incuriosito dal cognome del mio interlocutore dal momento che Spampinato sembra venire proprio dalla mia città, Catania.
“Spampinato è un cognome cento per cento siciliano, area catanese – mi conferma il musicista – comunque sono nato a Roma e dopo ventidue anni nella Capitale mi sono trasferito a Bruxelles, con un intermezzo a Berlino”.
-Come si è avvicinato alla musica, al jazz?
“Mi sono avvicinato alla musica un po’ per caso, in casa, ma il jazz l’ho scoperto in un secondo momento, da solo. Intorno ai sedici anni ho cominciato a conoscere meglio tutto ciò che prima avveniva spontaneamente, ho osservato la mia voce prendendo lezioni di canto, dopo il liceo è stato il Conservatorio e tutto ciò che ne consegue”.
-Come mai ha scelto il canto, disciplina di solito poco frequentata specie dagli uomini?
“Una scelta totalmente corporea. Il primo strumento che abbiamo a disposizione per esprimere noi stessi è proprio la nostra voce, il canto, e l’ho sentito da subito mio”.
-C’è stato sin dall’inizio un qualche modello di riferimento?
“Vari, troppi da mettere in lista, tanti e diversi tra loro. Comunque uno dei primi che mi ha fatto innamorare della musica è stato Stevie Wonder”.
-Scelta che personalmente considero ben fatta. Quindi l’inizio è da collegare strettamente alla musica nera globalmente intesa…
“Assolutamente. Il jazz è giunto dopo, quasi come una sorta di naturale evoluzione. Così, insieme alle voci del Soul e del Blues, mi sono ritrovato ad ascoltare gli improvvisatori di jazz e le cantanti, ma non ce n’è solo uno che posso dire d’avermi particolarmente influenzato. Mi ritrovo nel canto jazz, cerco ogni giorno di ampliare un vocabolario che viaggia tra storia e contemporaneità”.
-In Conservatorio con chi ha studiato?
“A Roma ho avuto la fortuna di incrociare sin dal primo anno Maria Pia De Vito e con lei ho studiato per tre anni. Gli ultimi due, dietro suo suggerimento, ho studiato con David Linx a Bruxelles e poi mi piace citare anche Elisabetta Antonini che è stata un’altra ‘mamma musicale’ che mi ha seguito fuori dal Conservatorio”.
-Quindi, se ho capito bene, lei è andato a Bruxelles sulla scia di David Linx. Ma come le è venuto in mente?
“Mi sono innamorato di lui attraverso la sua musica e ho pensato ‘devo incontrare questa persona’. Il suo stile, la sua musica erano molto vicini a ciò che alimentava il fuoco nello studio, la frenesia di carpire i segreti dell’improvvisazione”.
-Per cui è andato a Bruxelles e qui cosa è accaduto?
“L’ho incontrato ed è stato un percorso piuttosto accidentato, pieno di alti e bassi; David è una persona ricca di ‘artisticità’ se mi passa il termine, ma anche di carattere, di esplosività, e queste non sono caratteristiche che si trovano ogni giorno. Certo, stargli dietro non è stato facilissimo ma alla fine ne sono uscito enormemente migliorato: mi ha dato tanto, tantissimo. Gli devo davvero molto”.
-Scusi la mia curiosità, ma come fa un ragazzo nato e cresciuto a Roma, artisticamente alle prime armi, ad andare in un Paese straniero e riuscire ad ambientarsi sì da farne una seconda casa? Come funziona?
“Finché si sta in una struttura, in un’accademia – e mi riferisco al Koninklijk Conservatorium di Bruxelles, dove ho studiato altri quattro anni – si ha il confort delle mura. La sfida ovviamente viene dopo, quando si esce da lì, la sfida sta nel rimanere, creare nuove basi e contorni all’interno dei quali dare un senso a ciò che si fa. Superato il primo anno, quindi anche il secondo, la strada si è fatta meno impervia. Molto mi ha aiutato il supporto della famiglia, seppur a distanza, e il Belgio stesso, che mi ha dato fiducia”.
-Quindi lei ha studiato anche al Conservatorio di Bruxelles?
“Sì, nel dipartimento fiammingo ho conseguito il mio Master, mentre in quello francofono la mia formazione all’insegnamento”.
-E la parentesi berlinese?
“È stata un’esperienza Erasmus; quello è stato forse il mio primo salto “nel vuoto”, da solo in una capitale europea, ricca di stimoli. Lì ho incontrato molti musicisti preparatissimi, tra cui la cantante Judy Niemack”.
-Torniamo a Bruxelles. Uscito dal Conservatorio come si è procurato da vivere?
“Ho cominciato ad insegnare nelle scuole di musica, a dare lezioni individuali e poi finalmente nelle Accademie di Marchienne-au-Pont, Evere, e Watermael a Bruxelles. Un concetto che noi in Italia non abbiamo, quello dell’Accademia; si tratta di una struttura statale che non è né Conservatorio né scuola di musica: è una vera e propria Accademia delle Arti dove persone di ogni età possono apprendere l’arte della scena, della danza, della musica, ogni quartiere ne ha una, ed è un gran bel modo di vivere quello di insegnare canto jazz, che è la mia specialità”.
-E le attività più propriamente artistiche?
“Mi rendo perfettamente conto che specie in questo momento sono davvero pochi quanti possono contare sui concerti per introiti sicuri. Fino a oggi ho fatto in Belgio delle esperienze che forse in Italia non avrei potuto fare e mi riferisco alla fiducia che mi hanno accordato tanti promoter, club, anche alcuni festival dove mi sono esibito. Insomma ho fatto dei bei passi avanti, come migrante”.

-Adesso parliamo di questo bel disco che ha come titolo “Nascente”. Che vuol dire?
“Questo termine ha significati diversi a seconda delle due lingue che ho scelto per l’album. Così in italiano, lo sappiamo bene, indica qualcosa che viene alla luce, che nasce, quindi l’atto delle origini, mentre in brasiliano (portoghese), indica la fonte, la sorgente della luce, di un corso d’acqua. E come primo album ho pensato potesse essere un bel titolo”.
-Come mai pur vivendo a Bruxelles lo ha registrato con una etichetta italiana, l’’Alfa Music” nello specifico?
“Perché è un disco molto legato alla cultura mediterranea e italiana, quindi casa, e anche perché, utilizzando la lingua italiana, ho pensato che un’etichetta italiana potesse essere più indicata. Ma forse era anche un’esigenza più personale: volevo ‘nascere’, discograficamente parlando, con un disco edito nel mio Paese. E devo dire che i responsabili dell’Alfa Music si sono mostrati immediatamente interessati ed io mi sono affidato a loro. Da non trascurare poi il fatto che ci sono due musicisti che vivono in Italia, parlo di Alessandro Gwis al piano e del sassofonista Javier Girotto, ai quali si aggiungono la clarinettista francese Hélène Duret e il contrabbassista brasiliano Fil Caporali. I brani sono al sessanta per cento mie composizioni e al quaranta per cento di autori brasiliani: Guinga, Milton Nascimento, Egberto Gismonti”.
-Quindi non strade particolarmente battute…
“No, non è la bossa nova, non è il samba più conosciuto, si tratta di un Brasile che non si ha molto spesso l’occasione di apprezzare. L’album è uscito nel gennaio di quest’anno e finora ha avuto un’accoglienza positiva da parte di quanti lo hanno ascoltato, in special modo critici musicali. Poi il Covid ha messo tutto in standby”.
-In Italia che tipo di progetti ha?
“Mi lasci un attimo tornare in Belgio dove, per l’inizio del 2021, ci sarà un tour che si prospetta molto interessante. In Italia sto aspettando delle conferme per una presentazione del disco nella mia amata Roma. Mi piacerebbe presentarlo alla Casa del Jazz, che per me ha segnato una svolta importante”.
Gerlando Gatto
da Gerlando Gatto | 07/Set/2020 | I nostri CD, Primo piano, Recensioni

Cari amici, come promesso, eccomi dopo le vacanze estive, quest’anno piuttosto particolari, con la solita nutrita rubrica dedicata alle novità discografiche. Come vedrete ce n’è davvero per tutti i gusti: dal jazz canonico a quello più sperimentale, dal jazz per big band a quello per combo, dal jazz strumentale a quello vocale. Non mi resta, quindi, altro che augurarvi buon ascolto.
Aldo Bagnoni – The Connection – Alfa Music
 “The Connection” è il nuovo album di Aldo Bagnoni. Il batterista e compositore barese si ripresenta al suo pubblico alla testa di un quartetto completato da altri tre musicisti pugliesi, il polistrumentista Emanuele Coluccia, il contrabbassista Giampaolo Laurentaci e il tastierista Mauro Tre. In repertorio dieci brani di cui nove originali e l’arrangiamento di un pezzo popolare lucano. Particolare tutt’altro che trascurabile, una tantum il titolo rispecchia abbastanza fedelmente la musica che vi si ascolta; in effetti Bagnoni e compagni propongono un jazz che entra in specifica connessione con altri linguaggi: ecco quindi affacciarsi un’atmosfera tanguera nella linea melodica di “Clarabella”, un qualche riferimento a melopee seppur vagamente orientaleggianti in “Eternal Returns” con in bella evidenza il pianismo di Mauro Tre mentre Giampaolo Laurentaci si fa apprezzare in “The Dolmen and The See” brano che si può ascrivere alle correnti più attuali del jazz, una puntata nell’atonale, un’incursione nel folk con “Lipompo’s Just Arrived”… fino al conclusivo “Clarabella – Epilogo” e “The Connection” è servita nel migliore dei modi. Volendo esprimere un giudizio complessivo sull’album, direi che si tratta di un volume innanzitutto ben congegnato e altrettanto ben eseguito da tutti i musicisti, ma soprattutto coraggioso, una realizzazione che non ha alcun timore a distaccarsi dalle mode oggi prevalenti per proporre esclusivamente quella musica che si ritiene corrispondente ai propri principi non solo estetici. D’altro canto conoscendo Bagnoni non v’è alcun dubbio sul fatto che questi principi abbiano sempre indirizzato la sua esistenza e non solo di musicista.
“The Connection” è il nuovo album di Aldo Bagnoni. Il batterista e compositore barese si ripresenta al suo pubblico alla testa di un quartetto completato da altri tre musicisti pugliesi, il polistrumentista Emanuele Coluccia, il contrabbassista Giampaolo Laurentaci e il tastierista Mauro Tre. In repertorio dieci brani di cui nove originali e l’arrangiamento di un pezzo popolare lucano. Particolare tutt’altro che trascurabile, una tantum il titolo rispecchia abbastanza fedelmente la musica che vi si ascolta; in effetti Bagnoni e compagni propongono un jazz che entra in specifica connessione con altri linguaggi: ecco quindi affacciarsi un’atmosfera tanguera nella linea melodica di “Clarabella”, un qualche riferimento a melopee seppur vagamente orientaleggianti in “Eternal Returns” con in bella evidenza il pianismo di Mauro Tre mentre Giampaolo Laurentaci si fa apprezzare in “The Dolmen and The See” brano che si può ascrivere alle correnti più attuali del jazz, una puntata nell’atonale, un’incursione nel folk con “Lipompo’s Just Arrived”… fino al conclusivo “Clarabella – Epilogo” e “The Connection” è servita nel migliore dei modi. Volendo esprimere un giudizio complessivo sull’album, direi che si tratta di un volume innanzitutto ben congegnato e altrettanto ben eseguito da tutti i musicisti, ma soprattutto coraggioso, una realizzazione che non ha alcun timore a distaccarsi dalle mode oggi prevalenti per proporre esclusivamente quella musica che si ritiene corrispondente ai propri principi non solo estetici. D’altro canto conoscendo Bagnoni non v’è alcun dubbio sul fatto che questi principi abbiano sempre indirizzato la sua esistenza e non solo di musicista.
Danilo Blaiotta Trio – “Departures” – Filibusta Records
 Il pianista Danilo Blaiotta, il contrabbassista Jacopo Ferrazza e il batterista Valerio Vantaggio sono i protagonisti di questo album uscito il 15 maggio per l’etichetta Filibusta. Il trio, formato nel 1917, è composto da musicisti dell’area romana accomunati da un profondo interesse per la musica classica testimoniato dal fatto che sia il leader, sia il contrabbassista possono vantare approfonditi studi di pianoforte classico. In particolare Blaiotta ha studiato, tra l’altro, diversi anni con il maestro Aldo Ciccolini e negli anni dal 2010 al 2012 si è esibito in recital monografici dedicati a Chopin, Liszt e Debussy per la celebrazione della nascita dei tre compositori. Ed è proprio questa l’impronta che caratterizza tutto l’album, un profondo amore per la musica classica declinato attraverso un linguaggio jazzistico non particolarmente originale ma comunque ben lontano dalla banalità. In repertorio sei brani originali composti da Blaiotta che denota una buona capacità di scrittura anche per il giusto equilibrio tra parti scritte e parti improvvisate; accanto a questi original figurano “Gioco d’azzardo” di Paolo Conte, “There Will Never Be Another You” di Warren e Gordon e “Solar” di Miles Davis. In quest’ambito i pezzi più interessanti sono “The Devil’s Kitchen” con le sue due sezioni ben distinte, “Into The Blue” caratterizzato da una suadente linea melodica ben espressa anche dal contrabbasso di Ferrazza mentre “Solar”, impreziosito da una convincente intro, è porto con sincera partecipazione senza alcuna voglia di strafare nel mantenere l’originaria bellezza del brano davisiano.
Il pianista Danilo Blaiotta, il contrabbassista Jacopo Ferrazza e il batterista Valerio Vantaggio sono i protagonisti di questo album uscito il 15 maggio per l’etichetta Filibusta. Il trio, formato nel 1917, è composto da musicisti dell’area romana accomunati da un profondo interesse per la musica classica testimoniato dal fatto che sia il leader, sia il contrabbassista possono vantare approfonditi studi di pianoforte classico. In particolare Blaiotta ha studiato, tra l’altro, diversi anni con il maestro Aldo Ciccolini e negli anni dal 2010 al 2012 si è esibito in recital monografici dedicati a Chopin, Liszt e Debussy per la celebrazione della nascita dei tre compositori. Ed è proprio questa l’impronta che caratterizza tutto l’album, un profondo amore per la musica classica declinato attraverso un linguaggio jazzistico non particolarmente originale ma comunque ben lontano dalla banalità. In repertorio sei brani originali composti da Blaiotta che denota una buona capacità di scrittura anche per il giusto equilibrio tra parti scritte e parti improvvisate; accanto a questi original figurano “Gioco d’azzardo” di Paolo Conte, “There Will Never Be Another You” di Warren e Gordon e “Solar” di Miles Davis. In quest’ambito i pezzi più interessanti sono “The Devil’s Kitchen” con le sue due sezioni ben distinte, “Into The Blue” caratterizzato da una suadente linea melodica ben espressa anche dal contrabbasso di Ferrazza mentre “Solar”, impreziosito da una convincente intro, è porto con sincera partecipazione senza alcuna voglia di strafare nel mantenere l’originaria bellezza del brano davisiano.
Maurizio Brunod – “Ensemble” – Caligola
 Una premessa di carattere personale: conosco Brunod da parecchi anni e ho avuto il piacere di averlo mio ospite durante una delle mie “Guide all’ascolto”. E’ quindi con grande piacere che vi presento questo album dal sapore del tutto particolare. In effetti per festeggiare il suo cinquantesimo compleanno e i trent’anni di carriera il chitarrista ha realizzato un progetto speciale reinterpretando alcune delle sue composizioni, dagli esordi fino ad oggi. Per far ciò ha chiamato accanto a sé due giovani talenti del jazz piemontese, il pianista Emanuele Sartoris ed il contrabbassista Marco Bellafiore, cui sono stati affiancati come special guest in alcuni brani Daniele Di Bonaventura al bandoneon e Gianluigi Trovesi al sax alto e clarinetto. Il risultato è eccellente, senza se e senza ma. La musica scorre fluida, sempre piacevole, a tratti venata da una certa malinconia seppur mai inutilmente sdolcinata. E il trio, senza batteria, si muove perfettamente a suo agio nel contesto disegnato e voluto dal leader. Quanto al ruolo dei due ospiti, risulta anch’esso di grande spessore. Basti ascoltare, ad esempio, “Stinko Tango” in cui il bandoneon gioca un ruolo di primissimo piano e “Urban Squad” con un Trovesi che, con accorte pennellate, dimostra di non aver perso un’oncia della sua inimitabile statura artistica. Dal canto suo il leader dimostra di aver raggiunto una completa maturità sia come chitarrista sia come compositore quale ciliegina su una torta che lo ha visto collaborare con alcuni dei massimi esponenti del jazz nazionale e internazionale quali Enrico Rava, Miroslav Vitous, John Surman, Tim Berne.
Una premessa di carattere personale: conosco Brunod da parecchi anni e ho avuto il piacere di averlo mio ospite durante una delle mie “Guide all’ascolto”. E’ quindi con grande piacere che vi presento questo album dal sapore del tutto particolare. In effetti per festeggiare il suo cinquantesimo compleanno e i trent’anni di carriera il chitarrista ha realizzato un progetto speciale reinterpretando alcune delle sue composizioni, dagli esordi fino ad oggi. Per far ciò ha chiamato accanto a sé due giovani talenti del jazz piemontese, il pianista Emanuele Sartoris ed il contrabbassista Marco Bellafiore, cui sono stati affiancati come special guest in alcuni brani Daniele Di Bonaventura al bandoneon e Gianluigi Trovesi al sax alto e clarinetto. Il risultato è eccellente, senza se e senza ma. La musica scorre fluida, sempre piacevole, a tratti venata da una certa malinconia seppur mai inutilmente sdolcinata. E il trio, senza batteria, si muove perfettamente a suo agio nel contesto disegnato e voluto dal leader. Quanto al ruolo dei due ospiti, risulta anch’esso di grande spessore. Basti ascoltare, ad esempio, “Stinko Tango” in cui il bandoneon gioca un ruolo di primissimo piano e “Urban Squad” con un Trovesi che, con accorte pennellate, dimostra di non aver perso un’oncia della sua inimitabile statura artistica. Dal canto suo il leader dimostra di aver raggiunto una completa maturità sia come chitarrista sia come compositore quale ciliegina su una torta che lo ha visto collaborare con alcuni dei massimi esponenti del jazz nazionale e internazionale quali Enrico Rava, Miroslav Vitous, John Surman, Tim Berne.
Marcella Carboni Trio – “This Is Not A Harp” – barnum
 Conosco e seguo Marcella Carboni sin dagli inizi della sua strepitosa carriera e l’ho sempre considerata una fuoriclasse, fuoriclasse perché è riuscita ad inserire in territorio jazzistico uno strumento certo non usuale coma l’arpa che tecnicamente padroneggia con estrema sicurezza, una fuoriclasse perché ha elaborato un fraseggio assolutamente personale, una fuoriclasse perché sta evidenziando una verve compositiva non comune. E questo album, registrato in trio con altri due giganti del jazz italiano quali Paolino Dalla Porta al contrabbasso e Stefano Bagnoli alla batteria conferma appieno quanto sin qui detto. I tre si muovono con grande empatia lungo un repertorio costituito da 12 brani composti dai tre artisti, in massima parte dalla stessa Carboni. Particolarmente significativo il titolo dell’album: come spiega la stessa Marcella tutti si attendono un’arpa angelica, magica e rilassante mentre questa “non è un’arpa: è la mia voce, il mio suono. È uno strumento che sa graffiare, sa avere ritmo, groove”. E come darle torto. Il sound che la Carboni riesce a trarre dal suo strumento è davvero ben lontano da quello cui siamo abituati, come se ci si trovasse dinnanzi ad un classico trio piano-batteria-contrabbasso in cui tutti e tre gli strumenti hanno un’eguale importanza. All’interno del CD si trova una password che dà la possibilità di scaricare una vera e propria estensione del disco con contenuti extra tra cui tre pillole di improvvisazione inedite: “Time Transfixed” (M.Carboni /S.Bagnoli), “The False Mirror” (M.Carboni /P.Dalla Porta) e “The Empire of Lights”
Conosco e seguo Marcella Carboni sin dagli inizi della sua strepitosa carriera e l’ho sempre considerata una fuoriclasse, fuoriclasse perché è riuscita ad inserire in territorio jazzistico uno strumento certo non usuale coma l’arpa che tecnicamente padroneggia con estrema sicurezza, una fuoriclasse perché ha elaborato un fraseggio assolutamente personale, una fuoriclasse perché sta evidenziando una verve compositiva non comune. E questo album, registrato in trio con altri due giganti del jazz italiano quali Paolino Dalla Porta al contrabbasso e Stefano Bagnoli alla batteria conferma appieno quanto sin qui detto. I tre si muovono con grande empatia lungo un repertorio costituito da 12 brani composti dai tre artisti, in massima parte dalla stessa Carboni. Particolarmente significativo il titolo dell’album: come spiega la stessa Marcella tutti si attendono un’arpa angelica, magica e rilassante mentre questa “non è un’arpa: è la mia voce, il mio suono. È uno strumento che sa graffiare, sa avere ritmo, groove”. E come darle torto. Il sound che la Carboni riesce a trarre dal suo strumento è davvero ben lontano da quello cui siamo abituati, come se ci si trovasse dinnanzi ad un classico trio piano-batteria-contrabbasso in cui tutti e tre gli strumenti hanno un’eguale importanza. All’interno del CD si trova una password che dà la possibilità di scaricare una vera e propria estensione del disco con contenuti extra tra cui tre pillole di improvvisazione inedite: “Time Transfixed” (M.Carboni /S.Bagnoli), “The False Mirror” (M.Carboni /P.Dalla Porta) e “The Empire of Lights”
Avishai Cohen – “Big Vicious” – ECM
 Ritroviamo il carismatico trombettista Avishai Cohen alla testa del suo gruppo “Big Vicious” costituito circa sei anni addietro quando fece ritorno in Israele suo Paese natale dopo aver a lungo soggiornato negli States. A completare la formazione ci sono Uzi Ramirez chitarra, Aviv Cohen batteria, Yonatan Albalak chitarra e basso, Ziv Ravitz percussioni e live sampling. Questi musicisti, come spiega lo stesso Cohen, non provengono tutti dal jazz ma hanno alle spalle esperienze le più diversificate, dall’elettronica all’ ambient music, dalla musica psichedelica al rock, al pop…fino al trip-hop. Insomma un miscuglio di stili, di linguaggi che sapientemente mescolati dal leader, danno vita ad una miscela di sicuro interesse. Insomma qui non siamo nel campo del jazz propriamente detto, del jazz classico, ma ascoltiamo qualcosa se volete di più complesso, difficile da definire. Ad esempio un brano come “King Kutner” caratterizzato da un’orecchiabile linea melodica e da un andamento armonico-ritmico assai marcato non scandalizzerebbe i seguaci del pop di qualità. Ma subito dopo troviamo sia un omaggio a Beethoven con “Moonlight Sonata”, sia un brano dei Massive Attack “Teardrop” (particolarmente indovinato l’arrangiamento) sino a giungere al pezzo di chiusura, “Intent” che ci riporta su terreni più prettamente jazzistici. Il tutto illuminato dagli interventi del leader (lo si ascolti ad esempio in “Fractals”) che si stagliano come lacerti illuminanti in un ambiente musicale dai mille colori, dalle mille sfumature con un repertorio ben scritto, ottimamente arrangiato e altrettanto ben eseguito, con tutti i musicisti messi nelle migliori condizioni per esprimere appieno il proprio potenziale.
Ritroviamo il carismatico trombettista Avishai Cohen alla testa del suo gruppo “Big Vicious” costituito circa sei anni addietro quando fece ritorno in Israele suo Paese natale dopo aver a lungo soggiornato negli States. A completare la formazione ci sono Uzi Ramirez chitarra, Aviv Cohen batteria, Yonatan Albalak chitarra e basso, Ziv Ravitz percussioni e live sampling. Questi musicisti, come spiega lo stesso Cohen, non provengono tutti dal jazz ma hanno alle spalle esperienze le più diversificate, dall’elettronica all’ ambient music, dalla musica psichedelica al rock, al pop…fino al trip-hop. Insomma un miscuglio di stili, di linguaggi che sapientemente mescolati dal leader, danno vita ad una miscela di sicuro interesse. Insomma qui non siamo nel campo del jazz propriamente detto, del jazz classico, ma ascoltiamo qualcosa se volete di più complesso, difficile da definire. Ad esempio un brano come “King Kutner” caratterizzato da un’orecchiabile linea melodica e da un andamento armonico-ritmico assai marcato non scandalizzerebbe i seguaci del pop di qualità. Ma subito dopo troviamo sia un omaggio a Beethoven con “Moonlight Sonata”, sia un brano dei Massive Attack “Teardrop” (particolarmente indovinato l’arrangiamento) sino a giungere al pezzo di chiusura, “Intent” che ci riporta su terreni più prettamente jazzistici. Il tutto illuminato dagli interventi del leader (lo si ascolti ad esempio in “Fractals”) che si stagliano come lacerti illuminanti in un ambiente musicale dai mille colori, dalle mille sfumature con un repertorio ben scritto, ottimamente arrangiato e altrettanto ben eseguito, con tutti i musicisti messi nelle migliori condizioni per esprimere appieno il proprio potenziale.
Maria Pia De Vito – “Dreamers” – Via Veneto Jazz, Jando Music
 Credo che nessuno avrà da obiettare se dico che attualmente Maria Pia De Vito è una delle più interessanti vocalist che il mondo del jazz internazionale possa annoverare. Napoletana di carattere, anno dopo anno mai si è fermata continuando a studiare, a sperimentare con passione e quella curiosità che fanno di un musicista un vero artista. E quest’ultima fatica discografica non fa che confermare quanto detto. Maria Pia è coadiuvata da Julian Oliver Mazzariello al piano, Enzo Pietropaoli al contrabbasso, Alessandro Paternesi alla batteria cui si aggiunge in “The Lee Shore” Roberto Cecchetto alla chitarra. Il titolo “Dreamers” (“Sognatori”) si riferisce a quanti con le loro melodie hanno saputo raccontare e fors’anche prevedere le vicende della società statunitense…e non solo. E così in cartellone ritroviamo nove brani che rappresentano una sorta di breve catalogo di canzoni icone del songwriting d’oltreoceano, firmate da Paul Simon, David Crosby, Bob Dylan, Tom Waits e soprattutto Joni Mitchell di cui la De Vito ripropone ben tre pezzi; e la cosa non stupisce dato che Maria Pia aveva già affrontato il repertorio della Mitchell nel precedente «So Right» (Cam Jazz). Io credo che la cifra stilistica dell’album consista nella grande personalità dell’artista che riesce ad esplorare ogni brano sin nelle più intime pieghe così da farlo proprio e riprodurlo in modo personale con assoluta padronanza. E la cosa è ancora più rilevante ove si tenga conto che non si tratta certo di brani facili e che moltissimi li conoscono nelle loro versioni originali per cui non è difficile effettuare paragoni. Alla perfetta riuscita dell’album contribuiscono in maniera forte gli arrangiamenti scarni, essenziali, con una particolare attenzione alle dinamiche, il tutto nel pieno rispetto dell’originario spirito dei brani. E a proposito di quest’ultimi, fermo restando che vanno tutti ascoltati con la massima attenzione, mi piace sottolineare le interpretazioni di “Chinese Cafè” e “Carey” ambedue di Joni Mitchell; il primo brano presenta uno straordinario cambio di atmosfere e il mirabile inserimento di un inserto tratto da “Unchained Melody” mentre in “Carey” si possono apprezzare, tra l’altro, i vocalizzi scat della De Vito. Ultima considerazione, di certo non secondaria, la perfetta pronuncia inglese della vocalist.
Credo che nessuno avrà da obiettare se dico che attualmente Maria Pia De Vito è una delle più interessanti vocalist che il mondo del jazz internazionale possa annoverare. Napoletana di carattere, anno dopo anno mai si è fermata continuando a studiare, a sperimentare con passione e quella curiosità che fanno di un musicista un vero artista. E quest’ultima fatica discografica non fa che confermare quanto detto. Maria Pia è coadiuvata da Julian Oliver Mazzariello al piano, Enzo Pietropaoli al contrabbasso, Alessandro Paternesi alla batteria cui si aggiunge in “The Lee Shore” Roberto Cecchetto alla chitarra. Il titolo “Dreamers” (“Sognatori”) si riferisce a quanti con le loro melodie hanno saputo raccontare e fors’anche prevedere le vicende della società statunitense…e non solo. E così in cartellone ritroviamo nove brani che rappresentano una sorta di breve catalogo di canzoni icone del songwriting d’oltreoceano, firmate da Paul Simon, David Crosby, Bob Dylan, Tom Waits e soprattutto Joni Mitchell di cui la De Vito ripropone ben tre pezzi; e la cosa non stupisce dato che Maria Pia aveva già affrontato il repertorio della Mitchell nel precedente «So Right» (Cam Jazz). Io credo che la cifra stilistica dell’album consista nella grande personalità dell’artista che riesce ad esplorare ogni brano sin nelle più intime pieghe così da farlo proprio e riprodurlo in modo personale con assoluta padronanza. E la cosa è ancora più rilevante ove si tenga conto che non si tratta certo di brani facili e che moltissimi li conoscono nelle loro versioni originali per cui non è difficile effettuare paragoni. Alla perfetta riuscita dell’album contribuiscono in maniera forte gli arrangiamenti scarni, essenziali, con una particolare attenzione alle dinamiche, il tutto nel pieno rispetto dell’originario spirito dei brani. E a proposito di quest’ultimi, fermo restando che vanno tutti ascoltati con la massima attenzione, mi piace sottolineare le interpretazioni di “Chinese Cafè” e “Carey” ambedue di Joni Mitchell; il primo brano presenta uno straordinario cambio di atmosfere e il mirabile inserimento di un inserto tratto da “Unchained Melody” mentre in “Carey” si possono apprezzare, tra l’altro, i vocalizzi scat della De Vito. Ultima considerazione, di certo non secondaria, la perfetta pronuncia inglese della vocalist.
Alessandro Fabbri – «Five Winds» – Caligola
 Prima di entrare nel merito di questo interessante lavoro, consentitemi ancora una volta una riflessione del tutto personale: è da molto tempo che non incontro Alessandro Fabbri e così, quando ho visto la fotografia del settetto contenuta nella copertina dell’album, ho stentato a riconoscere il batterista fiorentino. Segno evidente che la mia memoria, almeno per quanto riguarda il riconoscimento facciale, denota qualche problema. Viceversa l’udito è rimasto perfetto e così ho avuto modo di percepire appeno tutte le qualità di questo “Five Winds”. Si tratta del quarto disco da leader di Fabbri per Caligola, sette anni dopo «StrayHorn». Il gruppo presenta un organico tutt’altro che usuale dal momento che accanto al leader figurano Guido Zorn al contrabbasso, e poi una straordinaria batteria di fiati: Davide Maia al bassoon, Elia Venturini al corno francese, Simone Santini sax alto, sopranino, oboe e EWI, Sebastiano Bon flauto, flauto alto e basso, e il sempre grandioso Pietro Tonolo ai sax tenore e soprano. Il repertorio si incentra su sei composizioni di Fabbri con l’aggiunta di “Four Winds” di Dava Holland, “No Baby” di Steve Lacy e “Silent Brother” di Luca Flores, queste ultime rivisitate alla luce della personalissima visione del leader. Dalla composizione del gruppo si evince facilmente come una delle caratteristiche principali dell’album sia l’ampia tavolozza cromatica che, unitamente all’assenza di uno strumento armonico, rende possibile l’articolazione della musica su una struttura contrappuntistica con evidenti e inevitabili richiami ai grandi del cool-jazz. Insomma, come si accennava in apertura, un lavoro di gande spessore e artisticamente molto interessante.
Prima di entrare nel merito di questo interessante lavoro, consentitemi ancora una volta una riflessione del tutto personale: è da molto tempo che non incontro Alessandro Fabbri e così, quando ho visto la fotografia del settetto contenuta nella copertina dell’album, ho stentato a riconoscere il batterista fiorentino. Segno evidente che la mia memoria, almeno per quanto riguarda il riconoscimento facciale, denota qualche problema. Viceversa l’udito è rimasto perfetto e così ho avuto modo di percepire appeno tutte le qualità di questo “Five Winds”. Si tratta del quarto disco da leader di Fabbri per Caligola, sette anni dopo «StrayHorn». Il gruppo presenta un organico tutt’altro che usuale dal momento che accanto al leader figurano Guido Zorn al contrabbasso, e poi una straordinaria batteria di fiati: Davide Maia al bassoon, Elia Venturini al corno francese, Simone Santini sax alto, sopranino, oboe e EWI, Sebastiano Bon flauto, flauto alto e basso, e il sempre grandioso Pietro Tonolo ai sax tenore e soprano. Il repertorio si incentra su sei composizioni di Fabbri con l’aggiunta di “Four Winds” di Dava Holland, “No Baby” di Steve Lacy e “Silent Brother” di Luca Flores, queste ultime rivisitate alla luce della personalissima visione del leader. Dalla composizione del gruppo si evince facilmente come una delle caratteristiche principali dell’album sia l’ampia tavolozza cromatica che, unitamente all’assenza di uno strumento armonico, rende possibile l’articolazione della musica su una struttura contrappuntistica con evidenti e inevitabili richiami ai grandi del cool-jazz. Insomma, come si accennava in apertura, un lavoro di gande spessore e artisticamente molto interessante.
Jimmy Greene – “While Looking Up” – Mack Avenue
 Era il 14 dicembre 2012 quando Adam Lanza, di 20 anni, dopo essersi introdotta presso la Sandy Hook Elementary School, di Sandy Hook, borgo della città di Newtown in Connecticut (USA), aprì il fuoco causando la morte di 27 persone, 20 delle quali bambini di età compresa tra i 6 e i 7 anni, suicidandosi prima dell’arrivo della polizia. Tra le vittime c’era anche Ana Márquez-Greene figlia del sassofonista Jimmy Greene il quale, entrato in studio nel marzo del 2019, registrò “While Looking Up” ispirato a questa tragedia ma anche al caos del mondo contemporaneo. Greene è accompagnato da Aaron Goldberg al pianoforte e Rhodes, Stefon Harris a marimba e vibrafono, Lage Lund alla chitarra, Reuben Rogers al contrabbasso e Kendrick Scott alla batteria. In repertorio dieci composizioni molte originali dello stesso Greene, declinate attraverso un linguaggio prettamente jazzistico in cui si avvertono, evidenti, influssi gospel. Particolarmente interessante “No Words” in cui, su un tappeto ritmico che sembra riprodurre i battiti di un cuore, Greene si esprime con note quasi dolenti che ben si attagliano a quanto in precedenza detto. E il ricordo della tragedia è ancora richiamato in “April 4th”, data di nascita della figlia, una sorta di inno in cui all’assolo del leader fa seguito un magistrale intervento di Stefon Harris al vibrafono. Interessante e convincente anche la riproposizione di “I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)” portato al successo da Whitney Houston; Greene la interpreta a tempo lento ben sostenuto dal pianismo sempre essenziale di Aaron Goldberg
Era il 14 dicembre 2012 quando Adam Lanza, di 20 anni, dopo essersi introdotta presso la Sandy Hook Elementary School, di Sandy Hook, borgo della città di Newtown in Connecticut (USA), aprì il fuoco causando la morte di 27 persone, 20 delle quali bambini di età compresa tra i 6 e i 7 anni, suicidandosi prima dell’arrivo della polizia. Tra le vittime c’era anche Ana Márquez-Greene figlia del sassofonista Jimmy Greene il quale, entrato in studio nel marzo del 2019, registrò “While Looking Up” ispirato a questa tragedia ma anche al caos del mondo contemporaneo. Greene è accompagnato da Aaron Goldberg al pianoforte e Rhodes, Stefon Harris a marimba e vibrafono, Lage Lund alla chitarra, Reuben Rogers al contrabbasso e Kendrick Scott alla batteria. In repertorio dieci composizioni molte originali dello stesso Greene, declinate attraverso un linguaggio prettamente jazzistico in cui si avvertono, evidenti, influssi gospel. Particolarmente interessante “No Words” in cui, su un tappeto ritmico che sembra riprodurre i battiti di un cuore, Greene si esprime con note quasi dolenti che ben si attagliano a quanto in precedenza detto. E il ricordo della tragedia è ancora richiamato in “April 4th”, data di nascita della figlia, una sorta di inno in cui all’assolo del leader fa seguito un magistrale intervento di Stefon Harris al vibrafono. Interessante e convincente anche la riproposizione di “I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)” portato al successo da Whitney Houston; Greene la interpreta a tempo lento ben sostenuto dal pianismo sempre essenziale di Aaron Goldberg
Connie Han – Iron Starlet – mack avenue
 E’ uscito il 12 giugno per la Mack Avenue “Iron Starlet”, il secondo album della pianista americana di origine cinese, Connie Han, alla testa del suo trio completato da Ivan Taylor al contrabbasso e Bill Wysaske nella triplice veste di batterista, produttore e direttore musicale. Ai tre si aggiungono, in alcuni brani, Walter Smith III al sax e Jeremy Pelt alla tromba a costituire un sestetto di sicuro impatto. In repertorio dieci brani tra cui “For th O.G.”, in memoria di McCoy Tyner. Ciò premesso occorre sottolineare come dal punto di vista tecnico la Han sia fortissima così come aveva dimostrato nel precedente album del 2018 “Crime Zone”: la pianista e compositrice ha ben introitato la lezione dei grandi del jazz, da McCoy Tyner a Hank Jones senza dimenticare artisti più moderni quali Kenny Kirkland e Jeff “Tain” Watts. Di qui un pianismo ricco, spumeggiante, con una diteggiatura velocissima e una buona indipendenza tra le due mani che ben si ancora alla costante pulsazione di una sezione ritmica eccellente. Il tutto impreziosito dai due fiati che innervano la musica di una certa raffinatezza e di un’ulteriore forza d’impatto. Si ascolti come il trombettista Jeremy Pelt conduce le danze nella title tracke prima che la pianista prenda in mano le redini della situazione o come tromba e sax tenore duettino all’inizio del successivo “Nova” in cui la leader suona il Fender Rhodes. Tra gli altri brani da segnalare ancora il già citato “For th O.G.” con la pianista in grande spolvero e particolarmente efficace anche sul piano espressivo e il delicato valzer “The Forsaken” della stessa Han eseguito ancora in trio con Bill Wysaske in bella evidenza.
E’ uscito il 12 giugno per la Mack Avenue “Iron Starlet”, il secondo album della pianista americana di origine cinese, Connie Han, alla testa del suo trio completato da Ivan Taylor al contrabbasso e Bill Wysaske nella triplice veste di batterista, produttore e direttore musicale. Ai tre si aggiungono, in alcuni brani, Walter Smith III al sax e Jeremy Pelt alla tromba a costituire un sestetto di sicuro impatto. In repertorio dieci brani tra cui “For th O.G.”, in memoria di McCoy Tyner. Ciò premesso occorre sottolineare come dal punto di vista tecnico la Han sia fortissima così come aveva dimostrato nel precedente album del 2018 “Crime Zone”: la pianista e compositrice ha ben introitato la lezione dei grandi del jazz, da McCoy Tyner a Hank Jones senza dimenticare artisti più moderni quali Kenny Kirkland e Jeff “Tain” Watts. Di qui un pianismo ricco, spumeggiante, con una diteggiatura velocissima e una buona indipendenza tra le due mani che ben si ancora alla costante pulsazione di una sezione ritmica eccellente. Il tutto impreziosito dai due fiati che innervano la musica di una certa raffinatezza e di un’ulteriore forza d’impatto. Si ascolti come il trombettista Jeremy Pelt conduce le danze nella title tracke prima che la pianista prenda in mano le redini della situazione o come tromba e sax tenore duettino all’inizio del successivo “Nova” in cui la leader suona il Fender Rhodes. Tra gli altri brani da segnalare ancora il già citato “For th O.G.” con la pianista in grande spolvero e particolarmente efficace anche sul piano espressivo e il delicato valzer “The Forsaken” della stessa Han eseguito ancora in trio con Bill Wysaske in bella evidenza.
Frank Martino – “Ego Boost” – Auand
 Il sound è sicuramente l’elemento distintivo di questo album del chitarrista, compositore e produttore, Frank Martino che evidenzia ancora una volta come le sue fonti di ispirazione non vadano ricercate solo nel jazz ma anche (se non forse soprattutto) nel rock e nell’elettronica. In effetti questo terzo album del suo progetto Disorgan, attivo dal 2015, si muove lungo coordinate caratterizzate da un forte impianto ritmico e come si accennava in apertura dalla ricerca di un sound particolare, piuttosto duro, ricercato attraverso le diverse soluzioni che l’organico può offrire. E questo risultato non sarebbe stato possibile se non vi avessero contribuito in maniera determinante tutti i musicisti scelti da Martino, vale a dire il sassofonista Massimiliano Milesi, Claudio Vignali (tastiere) e Niccolò Romanin (batteria) mentre in alcuni brani Martino abbandona la sua fida chitarra a 8 corde per passare al basso. In repertorio 7 brani, tutti a firma di Martino, eccetto ‘Trees of Silence and Fire’ (Milesi/Vignali), che denotano un’intima coerenza data l’assoluta aderenza al progetto da parte dell’intero gruppo che, importante ripeterlo, ha svolto un incredibile e apprezzabile lavoro a livello di suono rendendo inutile il lavoro di post-produzione. Particolarmente rilevante il ruolo svolto da Martino che questa volta piuttosto che porsi in primo piano ha preferito mettersi a servizio del gruppo, pur non disdegnando interessanti sortite solistiche come in “Fring”.
Il sound è sicuramente l’elemento distintivo di questo album del chitarrista, compositore e produttore, Frank Martino che evidenzia ancora una volta come le sue fonti di ispirazione non vadano ricercate solo nel jazz ma anche (se non forse soprattutto) nel rock e nell’elettronica. In effetti questo terzo album del suo progetto Disorgan, attivo dal 2015, si muove lungo coordinate caratterizzate da un forte impianto ritmico e come si accennava in apertura dalla ricerca di un sound particolare, piuttosto duro, ricercato attraverso le diverse soluzioni che l’organico può offrire. E questo risultato non sarebbe stato possibile se non vi avessero contribuito in maniera determinante tutti i musicisti scelti da Martino, vale a dire il sassofonista Massimiliano Milesi, Claudio Vignali (tastiere) e Niccolò Romanin (batteria) mentre in alcuni brani Martino abbandona la sua fida chitarra a 8 corde per passare al basso. In repertorio 7 brani, tutti a firma di Martino, eccetto ‘Trees of Silence and Fire’ (Milesi/Vignali), che denotano un’intima coerenza data l’assoluta aderenza al progetto da parte dell’intero gruppo che, importante ripeterlo, ha svolto un incredibile e apprezzabile lavoro a livello di suono rendendo inutile il lavoro di post-produzione. Particolarmente rilevante il ruolo svolto da Martino che questa volta piuttosto che porsi in primo piano ha preferito mettersi a servizio del gruppo, pur non disdegnando interessanti sortite solistiche come in “Fring”.
Lorenzo Miatto – “Civico 19” – Caligola
 Album d’esordio come leader per il veneto Lorenzo Miatto, specialista del basso elettrico, coadiuvato da altri due musicisti dell’area veneta, il chitarrista Nicola Privato e il batterista Niccolò Romanin. Miatto si presenta al pubblico del jazz nella triplice veste di leader, strumentista e compositore (nove brani su dodici sono suoi), e in tutte e tre le vesti Miatto se la cava più che egregiamente. Come bassista Miatto ha completato i suoi studi al Conservatorio di Adria sotto la guida di Paolo Ghetti ed è anche membro dell’orchestra nazionale di jazz diretta da Pino Jodice e Riccardo Luppi; come leader dimostra di saper guidare il trio con mano ferma e competente; infine come compositore evidenzia un notevole gusto per linee melodiche suadenti e originali. E questo della ricerca della melodia è una costante di tutto l’album; non a caso il brano che si stacca più nettamente dal resto, con un andamento più ruvido, spigoloso è “The Pretender” un brano dei Foo Fighters rivisitato in forma originale. Per il resto il trio si muove su coordinate ben precise, sempre dettate dal leader che si riserva quattro brevi interventi in completa solitudine (“Con calma # 1,2,3,4), lasciando per il resto ampio spazio ai compagni di strada per esprimere appieno le proprie potenzialità. Si ascolti al riguardo “Whirlwinds” e “Shapes” due composizioni del chitarrista caratterizzate da una bella accentuazione ritmica-armonica mentre in “Storie di sempre” ritorna in auge la linea melodica privilegiata dal leader.
Album d’esordio come leader per il veneto Lorenzo Miatto, specialista del basso elettrico, coadiuvato da altri due musicisti dell’area veneta, il chitarrista Nicola Privato e il batterista Niccolò Romanin. Miatto si presenta al pubblico del jazz nella triplice veste di leader, strumentista e compositore (nove brani su dodici sono suoi), e in tutte e tre le vesti Miatto se la cava più che egregiamente. Come bassista Miatto ha completato i suoi studi al Conservatorio di Adria sotto la guida di Paolo Ghetti ed è anche membro dell’orchestra nazionale di jazz diretta da Pino Jodice e Riccardo Luppi; come leader dimostra di saper guidare il trio con mano ferma e competente; infine come compositore evidenzia un notevole gusto per linee melodiche suadenti e originali. E questo della ricerca della melodia è una costante di tutto l’album; non a caso il brano che si stacca più nettamente dal resto, con un andamento più ruvido, spigoloso è “The Pretender” un brano dei Foo Fighters rivisitato in forma originale. Per il resto il trio si muove su coordinate ben precise, sempre dettate dal leader che si riserva quattro brevi interventi in completa solitudine (“Con calma # 1,2,3,4), lasciando per il resto ampio spazio ai compagni di strada per esprimere appieno le proprie potenzialità. Si ascolti al riguardo “Whirlwinds” e “Shapes” due composizioni del chitarrista caratterizzate da una bella accentuazione ritmica-armonica mentre in “Storie di sempre” ritorna in auge la linea melodica privilegiata dal leader.
Jean-Louis Matinier, Kevin Seddiki – « Rivages » – ECM
 Grande musica quella contenuta in questo album realizzato in duo dai musicisti francesi Jean-Louis Matinier all’accordion e Kevin Seddiki alla chitarra. Lo riconosco: questo giudizio potrebbe essere falsato dalla mia predilezione per la fisarmonica tuttavia non credo di essere molto lontano dal vero nell’affermazione di cui in apertura. In effetti non possono sussistere dubbi sulla statura artistica di Matinier testimoniata, ampiamente, dalle precedenti prove per la stessa ECM. Si ascoltino le precedenti registrazioni con i gruppi di Anouar Brahem, Louis Sclavis e François Couturier e in duo con Marco Ambrosini. Adesso si ripresenta protagonista di una nuova impresa, un altro duo con il chitarrista Kevin Seddiki che nell’occasione debutta in casa ECM. Seddiki può vantare una robusta preparazione tecnica avendo studiato chitarra classica con Pablo Marquez dopo di che ha lavorato con molti improvvisatori non solo nel campo del jazz. Questa trasversalità culturale viene qui assai ben declinata attraverso un repertorio che accanto a traditional quali “Greensleeves” comprende brani classici come “Les Berceaux” di Gabriel Fauré fino a giungere a composizioni e improvvisazioni di grande suggestione. Comunque a prescindere dai singoli brani è tutto l’album che si lascia ascoltare con interesse dal primo all’ultimo istante. La musica fluisce in maniera naturale, senza forzature, respirando al ritmo dei mantici di Matinier che ben si accordano con il sound così caratteristico della chitarra di Seddiki. Quest’ultimo evidenzia una spiccata predilezione per la tecnica percussiva derivante anche dal fatto che il chitarrista ha studiato e collaborato con il percussionista francese di origine persiana Bijan Cherimani, specialista dello zarb (tamburo di calici proveniente dalla Persia).
Grande musica quella contenuta in questo album realizzato in duo dai musicisti francesi Jean-Louis Matinier all’accordion e Kevin Seddiki alla chitarra. Lo riconosco: questo giudizio potrebbe essere falsato dalla mia predilezione per la fisarmonica tuttavia non credo di essere molto lontano dal vero nell’affermazione di cui in apertura. In effetti non possono sussistere dubbi sulla statura artistica di Matinier testimoniata, ampiamente, dalle precedenti prove per la stessa ECM. Si ascoltino le precedenti registrazioni con i gruppi di Anouar Brahem, Louis Sclavis e François Couturier e in duo con Marco Ambrosini. Adesso si ripresenta protagonista di una nuova impresa, un altro duo con il chitarrista Kevin Seddiki che nell’occasione debutta in casa ECM. Seddiki può vantare una robusta preparazione tecnica avendo studiato chitarra classica con Pablo Marquez dopo di che ha lavorato con molti improvvisatori non solo nel campo del jazz. Questa trasversalità culturale viene qui assai ben declinata attraverso un repertorio che accanto a traditional quali “Greensleeves” comprende brani classici come “Les Berceaux” di Gabriel Fauré fino a giungere a composizioni e improvvisazioni di grande suggestione. Comunque a prescindere dai singoli brani è tutto l’album che si lascia ascoltare con interesse dal primo all’ultimo istante. La musica fluisce in maniera naturale, senza forzature, respirando al ritmo dei mantici di Matinier che ben si accordano con il sound così caratteristico della chitarra di Seddiki. Quest’ultimo evidenzia una spiccata predilezione per la tecnica percussiva derivante anche dal fatto che il chitarrista ha studiato e collaborato con il percussionista francese di origine persiana Bijan Cherimani, specialista dello zarb (tamburo di calici proveniente dalla Persia).
Wolfgang Muthspiel – “Angular Blues” – ECM
 Il chitarrista austriaco Wolfgang Muthspiel si ripresenta all’attenzione del pubblico e della critica del jazz alla testa del suo trio completato da Scott Colley contrabbasso, che ha preso il posto di Larry Grenadier presente in precedenti album di Muthspiel e Brian Blade alla batteria. In programma due standard (“Everything I Love” di Cole Porter, “I’ll remember april” di Gene de Paul, Don Ray e Patricia Johnston), e sette original del leader tra cui “Solo Kanon in 5/4”, eseguito da Muthspiel in solitudine. Si tratta del quarto album registrato dal chitarrista per ECM e ancora una volta ci restituisce un artista maturo, perfettamente consapevole dei propri mezzi espressivi, che sa transitare con estrema disinvoltura dalla chitarra acustica a quella elettrica, tanto che senza un ascolto più che attento non è possibile stabilire quando venga utilizzato l’uno o l’altro strumento. Ciò detto occorre però aggiungere che l’album soffre di una certa staticità frutto da un canto di un repertorio non particolarmente originale e dall’altro di una eccessiva omogeneità di sound. Evidentemente ciò non disturberà più di tanto gli amanti della chitarra, ma il vostro recensore da un artista quale Muthspiel si attende qualcosa di più specie dal punto di vista del coinvolgimento.
Il chitarrista austriaco Wolfgang Muthspiel si ripresenta all’attenzione del pubblico e della critica del jazz alla testa del suo trio completato da Scott Colley contrabbasso, che ha preso il posto di Larry Grenadier presente in precedenti album di Muthspiel e Brian Blade alla batteria. In programma due standard (“Everything I Love” di Cole Porter, “I’ll remember april” di Gene de Paul, Don Ray e Patricia Johnston), e sette original del leader tra cui “Solo Kanon in 5/4”, eseguito da Muthspiel in solitudine. Si tratta del quarto album registrato dal chitarrista per ECM e ancora una volta ci restituisce un artista maturo, perfettamente consapevole dei propri mezzi espressivi, che sa transitare con estrema disinvoltura dalla chitarra acustica a quella elettrica, tanto che senza un ascolto più che attento non è possibile stabilire quando venga utilizzato l’uno o l’altro strumento. Ciò detto occorre però aggiungere che l’album soffre di una certa staticità frutto da un canto di un repertorio non particolarmente originale e dall’altro di una eccessiva omogeneità di sound. Evidentemente ciò non disturberà più di tanto gli amanti della chitarra, ma il vostro recensore da un artista quale Muthspiel si attende qualcosa di più specie dal punto di vista del coinvolgimento.
Noukilla – “Soley” – Naxos
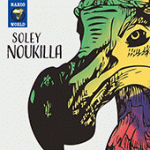 Con questo album usciamo decisamente fuori dal seminato in quanto di jazz c’è solo qualche lieve sentore: si tratta, in effetti, di musica tradizionale, popolare ma densa di significato. E’ un sentito tributo che il gruppo Noukilla rivolge al proprio Paese, l’Isola Mauritius. Com’è facile immaginare, il ritmo la fa da padrone così come la gioia di suonare e l’allegria mentre, almeno per quanto mi riguarda, le linee tematiche riportano alla mente quello ‘zouk’ che negli anni ’90 furoreggiava in Martinica tra la popolazione autoctona. In questo caso è una sorta di mélange tra sega e seggae. E per trovare le origini della musica sega bisogna andare molto indietro nel tempo in quanto la stessa venne creata dagli schiavi creoli; proprio per questo in Mauritius venne pubblicamente disprezzata fino agli anni ‘60 quando finalmente fu adottata come musica nazionale. Negli anni ‘90, un rastafari mauritiano, conosciuto come Kaya, dal celebre album di Bob Marley, innervò la sega con elementi di reggae, creando così il seggae. Nonostante sia morto nel 1999 in circostanze rimaste misteriose, molti artisti mauritiani continuano a rendergli omaggio e a creare una musica – come evidenzia anche questo “Soley” – che risente della sua influenza. Un’ultima notizia di cronaca: la copertina dell’album ritrae un ex residente dell’isola, sicuramente il più celebre, l’uccello Dodo; endemico dell’isola non poteva volare, si nutriva di frutti e nidificava a terra. Si estinse rapidamente nella seconda metà del XVII secolo in seguito all’arrivo sull’isola dei portoghesi e degli olandesi.
Con questo album usciamo decisamente fuori dal seminato in quanto di jazz c’è solo qualche lieve sentore: si tratta, in effetti, di musica tradizionale, popolare ma densa di significato. E’ un sentito tributo che il gruppo Noukilla rivolge al proprio Paese, l’Isola Mauritius. Com’è facile immaginare, il ritmo la fa da padrone così come la gioia di suonare e l’allegria mentre, almeno per quanto mi riguarda, le linee tematiche riportano alla mente quello ‘zouk’ che negli anni ’90 furoreggiava in Martinica tra la popolazione autoctona. In questo caso è una sorta di mélange tra sega e seggae. E per trovare le origini della musica sega bisogna andare molto indietro nel tempo in quanto la stessa venne creata dagli schiavi creoli; proprio per questo in Mauritius venne pubblicamente disprezzata fino agli anni ‘60 quando finalmente fu adottata come musica nazionale. Negli anni ‘90, un rastafari mauritiano, conosciuto come Kaya, dal celebre album di Bob Marley, innervò la sega con elementi di reggae, creando così il seggae. Nonostante sia morto nel 1999 in circostanze rimaste misteriose, molti artisti mauritiani continuano a rendergli omaggio e a creare una musica – come evidenzia anche questo “Soley” – che risente della sua influenza. Un’ultima notizia di cronaca: la copertina dell’album ritrae un ex residente dell’isola, sicuramente il più celebre, l’uccello Dodo; endemico dell’isola non poteva volare, si nutriva di frutti e nidificava a terra. Si estinse rapidamente nella seconda metà del XVII secolo in seguito all’arrivo sull’isola dei portoghesi e degli olandesi.
Francesco Polito – “Trip” – Alfa Music
 Qui siamo in ambiente dichiaratamente ‘smoothjazz’, quindi niente ardite sperimentazioni, né linguaggi particolarmente astrusi ma la voglia, grande, di suonare ciò che piace, al meglio delle proprie possibilità. In effetti, se dal punto di vista compositivo l’album potrebbe far storcere il naso a quanti pretendono sempre qualcosa di nuovo, dal punto di vista esecutivo nulla si può rimproverare al gruppo guidato da Francesco Polito, al suo esordio discografico da leader ma musicista già ampiamente rodato anche perché nasce in una famiglia di musicisti ben nota in quel di Sala Consilina. Il sassofonista guida un gruppo ad organico variabile in cui figurano Enzo Polito alle tastiere-sint e accordion, Roberto Polito batteria e percussioni, Frank Marino basso, Silvio De Filippo chitarra, Gianfranco Cloralio chitarra, Massimo Romano Chitarra. In programma nove brani tutti composti da Francesco Polito da solo o in cooperazione con gli altri due Polito, cui si aggiunge, in chiusura, “A testa in giù di Pino Daniele”. Il leader suona sax tenore, sax alto e sax soprano evidenziando un’ottima preparazione strumentale che gli consente di passare con disinvoltura da uno strumento all’altro, dimostrando così di aver ben interiorizzato la lezione dei maggiori esponenti del genere quali Jenni K. I compagni d’avventura non sono da meno cosicché il gruppo, come accennato, risulta ben assortito. I brani sono tutti contrassegnati da una felice linea melodica anche se personalmente preferiamo i pezzi in cui è presente la fisarmonica, vale a dire “In Your Eyes”, “Martina” e il già citato “A testa in giù” in cui Enzo Polito sfoggia una sonorità moderna e un fraseggio non banale.
Qui siamo in ambiente dichiaratamente ‘smoothjazz’, quindi niente ardite sperimentazioni, né linguaggi particolarmente astrusi ma la voglia, grande, di suonare ciò che piace, al meglio delle proprie possibilità. In effetti, se dal punto di vista compositivo l’album potrebbe far storcere il naso a quanti pretendono sempre qualcosa di nuovo, dal punto di vista esecutivo nulla si può rimproverare al gruppo guidato da Francesco Polito, al suo esordio discografico da leader ma musicista già ampiamente rodato anche perché nasce in una famiglia di musicisti ben nota in quel di Sala Consilina. Il sassofonista guida un gruppo ad organico variabile in cui figurano Enzo Polito alle tastiere-sint e accordion, Roberto Polito batteria e percussioni, Frank Marino basso, Silvio De Filippo chitarra, Gianfranco Cloralio chitarra, Massimo Romano Chitarra. In programma nove brani tutti composti da Francesco Polito da solo o in cooperazione con gli altri due Polito, cui si aggiunge, in chiusura, “A testa in giù di Pino Daniele”. Il leader suona sax tenore, sax alto e sax soprano evidenziando un’ottima preparazione strumentale che gli consente di passare con disinvoltura da uno strumento all’altro, dimostrando così di aver ben interiorizzato la lezione dei maggiori esponenti del genere quali Jenni K. I compagni d’avventura non sono da meno cosicché il gruppo, come accennato, risulta ben assortito. I brani sono tutti contrassegnati da una felice linea melodica anche se personalmente preferiamo i pezzi in cui è presente la fisarmonica, vale a dire “In Your Eyes”, “Martina” e il già citato “A testa in giù” in cui Enzo Polito sfoggia una sonorità moderna e un fraseggio non banale.
Marco Ponchiroli – “Solo Live” – Caligola
 Pianista evidentemente convinto dei propri mezzi tecnici ed espressivi, Marco Ponchiroli affronta per la seconda volta le insidie del piano-solo. Ci aveva provato nel 2012 con “Solo” album registrato in studio e comprendente solo brani originali dello stesso artista. Questa volta il discorso è completamente diverso: il CD è stato registrato il 25 luglio del 2018 durante un concerto all’Arena del Parco Azzurro di Passons in provincia di Udine e il repertorio è costituito da quattro original del leader cui si affiancano tre brani molto conosciuti, “Senza fine” di Gino Paoli, “Body And Soul” di Green, Heyman, Sour, Eyton e “Retrato em branco e preto” di Jobim e Buarque. Quindi tre brani tra di loro assai diversi che si esplicano in tre differenti linguaggi ad evidenziare le buone capacità interpretative di Ponchiroli. Il pianista veneziano riesce a connettersi assai bene con il pubblico che l’ascolta e mostra eccellenti capacità improvvisative che prendono il via dal rispetto delle linee melodiche caratterizzanti tutti i brani dell’album. E devo dire che a mio avviso le capacità di Ponchiroli risaltano più evidenti nell’interpretazione dei tre brani non suoi che pur essendo (in special modo i primi due) ascoltati e riascoltati centinaia di volte vengono riproposti in versione assolutamente originale. Per il resto “Misty Morning” e “Hercules” provengono dal precedente “Solo” mentre la sola composizione non registrata in precedenza è “Inverno”.
Pianista evidentemente convinto dei propri mezzi tecnici ed espressivi, Marco Ponchiroli affronta per la seconda volta le insidie del piano-solo. Ci aveva provato nel 2012 con “Solo” album registrato in studio e comprendente solo brani originali dello stesso artista. Questa volta il discorso è completamente diverso: il CD è stato registrato il 25 luglio del 2018 durante un concerto all’Arena del Parco Azzurro di Passons in provincia di Udine e il repertorio è costituito da quattro original del leader cui si affiancano tre brani molto conosciuti, “Senza fine” di Gino Paoli, “Body And Soul” di Green, Heyman, Sour, Eyton e “Retrato em branco e preto” di Jobim e Buarque. Quindi tre brani tra di loro assai diversi che si esplicano in tre differenti linguaggi ad evidenziare le buone capacità interpretative di Ponchiroli. Il pianista veneziano riesce a connettersi assai bene con il pubblico che l’ascolta e mostra eccellenti capacità improvvisative che prendono il via dal rispetto delle linee melodiche caratterizzanti tutti i brani dell’album. E devo dire che a mio avviso le capacità di Ponchiroli risaltano più evidenti nell’interpretazione dei tre brani non suoi che pur essendo (in special modo i primi due) ascoltati e riascoltati centinaia di volte vengono riproposti in versione assolutamente originale. Per il resto “Misty Morning” e “Hercules” provengono dal precedente “Solo” mentre la sola composizione non registrata in precedenza è “Inverno”.
Reunion Big Band – “My Life Is Now, a tribute to Marco Tamburini” – Caligola
 Ottimo album d’esordio per questa orchestra sulla cui storia vale la pena spendere qualche parola. La “Reunion Big Band” venne fondata da Marco Tamburini, insieme a Roberto Rossi e Piero Odorici per debuttare nell’autunno del 1999 al Chet Baker, famoso club bolognese. Dopo un’intensa attività costellata di partecipazioni in molti festival, teatri e club dell’area tosco–emiliana, la band si sciolse e si ricostituì nell’estate del 2012 per accompagnare Dee Dee Bridgewater al Narni Black Festival. È stata questa la ripresa dell’attività, prima sotto la direzione di Tamburini e poi, dopo la sua scomparsa, dell’amico e trombonista Roberto Rossi. Ed eccoci, quindi, come si accennava in apertura, a questo esordio discografico dedicato al trombettista immaturamente scomparso nel 2015. I dieci brani sono tutti di Tamburini e si avvalgono di sapidi arrangiamenti firmati oltre che dallo stesso Tamburini, da Stefano Paolini, Roberto Rossi, Fabio Petretti e Ivan Elefante e impreziositi da centrati assolo presi sia dai musicisti della band, sia dagli ospiti quali Pietro Tonolo, Fabrizio Bosso (li si ascolti nel brano d’apertura “Bossa to Criss”) e Marcello Tonolo (semplicemente superlativo in “Eduard”). Comunque, a mio avviso, il brano più riuscito è quello che dà il titolo all’intero album che evidenzia un ensemble davvero omogeneo, ben rodato che si muove all’unisono con bella compattezza.
Ottimo album d’esordio per questa orchestra sulla cui storia vale la pena spendere qualche parola. La “Reunion Big Band” venne fondata da Marco Tamburini, insieme a Roberto Rossi e Piero Odorici per debuttare nell’autunno del 1999 al Chet Baker, famoso club bolognese. Dopo un’intensa attività costellata di partecipazioni in molti festival, teatri e club dell’area tosco–emiliana, la band si sciolse e si ricostituì nell’estate del 2012 per accompagnare Dee Dee Bridgewater al Narni Black Festival. È stata questa la ripresa dell’attività, prima sotto la direzione di Tamburini e poi, dopo la sua scomparsa, dell’amico e trombonista Roberto Rossi. Ed eccoci, quindi, come si accennava in apertura, a questo esordio discografico dedicato al trombettista immaturamente scomparso nel 2015. I dieci brani sono tutti di Tamburini e si avvalgono di sapidi arrangiamenti firmati oltre che dallo stesso Tamburini, da Stefano Paolini, Roberto Rossi, Fabio Petretti e Ivan Elefante e impreziositi da centrati assolo presi sia dai musicisti della band, sia dagli ospiti quali Pietro Tonolo, Fabrizio Bosso (li si ascolti nel brano d’apertura “Bossa to Criss”) e Marcello Tonolo (semplicemente superlativo in “Eduard”). Comunque, a mio avviso, il brano più riuscito è quello che dà il titolo all’intero album che evidenzia un ensemble davvero omogeneo, ben rodato che si muove all’unisono con bella compattezza.
Christian Sands – “Be Water” – Mack Avenue
 Nel suo nuovo album, “Be Water”, il pianista Christian Sands trae ispirazione dall’acqua attraverso le varie declinazioni attraverso cui la stessa si presenta. Così dopo aver fatto ricorso, per il titolo dell’album, alla filosofia del maestro di arti marziali e star del cinema Bruce Lee, Christian nei titoli dei dieci pezzi da lui stesso composti, cerca di rivestire in musica i concetti in precedenza espressi. Ci riesce? Francamente non tanto anche perché, come più volte sottolineato, la musica non è semantica. Ma è altresì vero che tutto ciò poco o nulla influisce sulla valenza della musica che rimane su livelli alti. Anche perché, nonostante l’ancor giovane età (31 anni), Sands ha alle spalle notevoli esperienze avendo collaborato con gli Inside Straight, il Trio di Christian McBride, Gregory Porter e Ulysses Owens. In questo quarto album per la Mack Avenu, Sands si presenta con il suo trio abituale, composto dal bassista Yasushi Nakamura e dal batterista Clarence Penn, cui si aggiungono il chitarrista Marvin Sewell, il sassofonista Marcus Strickland, il trombettista Sean Jones e il trombonista Steve Davis. In un pezzo l’ensemble è completato da un quartetto d’archi con Sara Caswell, Tomoko Akaboshi, Benni von Gutzeit ed Eleanor Norton. C’è da evidenziare come, indipendentemente dal brano, indipendentemente dallo stile e dal terreno scelti (il pianista passa con estrema disinvoltura dallo swing, al bebop, dal progressive jazz, alla fusion fino alle sonorità brasiliane e afro-cubane) Sands mai perde un’oncia di quell’eleganza e compostezza che accompagna ogni sua performance sia su disco sia live.
Nel suo nuovo album, “Be Water”, il pianista Christian Sands trae ispirazione dall’acqua attraverso le varie declinazioni attraverso cui la stessa si presenta. Così dopo aver fatto ricorso, per il titolo dell’album, alla filosofia del maestro di arti marziali e star del cinema Bruce Lee, Christian nei titoli dei dieci pezzi da lui stesso composti, cerca di rivestire in musica i concetti in precedenza espressi. Ci riesce? Francamente non tanto anche perché, come più volte sottolineato, la musica non è semantica. Ma è altresì vero che tutto ciò poco o nulla influisce sulla valenza della musica che rimane su livelli alti. Anche perché, nonostante l’ancor giovane età (31 anni), Sands ha alle spalle notevoli esperienze avendo collaborato con gli Inside Straight, il Trio di Christian McBride, Gregory Porter e Ulysses Owens. In questo quarto album per la Mack Avenu, Sands si presenta con il suo trio abituale, composto dal bassista Yasushi Nakamura e dal batterista Clarence Penn, cui si aggiungono il chitarrista Marvin Sewell, il sassofonista Marcus Strickland, il trombettista Sean Jones e il trombonista Steve Davis. In un pezzo l’ensemble è completato da un quartetto d’archi con Sara Caswell, Tomoko Akaboshi, Benni von Gutzeit ed Eleanor Norton. C’è da evidenziare come, indipendentemente dal brano, indipendentemente dallo stile e dal terreno scelti (il pianista passa con estrema disinvoltura dallo swing, al bebop, dal progressive jazz, alla fusion fino alle sonorità brasiliane e afro-cubane) Sands mai perde un’oncia di quell’eleganza e compostezza che accompagna ogni sua performance sia su disco sia live.
Cinzia Tedesco – “Mister Puccini in Jazz” – Sony Classica
 Giacomo Puccini è una vera e propria icona della musica italiana…e non solo… che tutti noi rispettiamo e ammiriamo. Tentare, quindi, di ripresentare le sue immortali melodie in una veste diversa dall’originale è impresa al limite dell’impossibile, comunque molto ma molto difficile. Ma quando entra in gioco Cinzia Tedesco l’impossibile non esiste e così, dopo l’album dedicato a Verdi (“Verdi’s Mood by Cinzia Tedesco”), l’artista pugliese è riuscita a bissare il miracolo dando vita ad un CD a momenti davvero toccante. Per ottenere un risultato così brillante c’è voluto uno sforzo produttivo notevole: ecco quindi, accanto alla vocalist, un trio di grandi jazzisti quali Stefano Sabatini piano e arrangiamenti, Luca Pirozzi contrabbasso e Pietro Iodice alla batteria con in più la Puccini Fetival Orchestra diretta dal maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli, composta da ben ventinove elementi ai quali si sono affiancati come special guest Flavio Boltro alla tromba, Stefano Di Battista e Javier Girotto al sax soprano, Antonello Salis accordion e Roberto Guarino chitarra; superlativa anche la prova di Pino Jodice che oltre ad esibirsi al piano in “Un bel dì vedremo” ha scritto e arrangiato gli archi della Puccini Festival Orchestra. Ma risolti i problemi prettamente strumentali, restava lo scoglio dei testi dei libretti originali difficilmente adattabili al linguaggio jazz. Ebbene in questa particolare sfida la Tedesco è stata superlativa riuscendo a superare lo scoglio grazie alla sua grande sensibilità e alla duttilità della voce che le hanno consentito di esprimere con assoluta padronanza e coerenza quelle frasi che oramai fanno parre integrante del patrimonio dei melomani di mezzo mondo. Gli undici brani sono uno più bello dell’altro: basta qualche titolo per rendersene conto, da “Che gelida manina” da “La Bohème” a “E lucevan le stelle” dalla “Tosca” sino alla ripresa di “E lucevan le stelle” che chiude l’album. Insomma un album che coniuga una estrema godibilità con un ragguardevole spessore artistico.
Giacomo Puccini è una vera e propria icona della musica italiana…e non solo… che tutti noi rispettiamo e ammiriamo. Tentare, quindi, di ripresentare le sue immortali melodie in una veste diversa dall’originale è impresa al limite dell’impossibile, comunque molto ma molto difficile. Ma quando entra in gioco Cinzia Tedesco l’impossibile non esiste e così, dopo l’album dedicato a Verdi (“Verdi’s Mood by Cinzia Tedesco”), l’artista pugliese è riuscita a bissare il miracolo dando vita ad un CD a momenti davvero toccante. Per ottenere un risultato così brillante c’è voluto uno sforzo produttivo notevole: ecco quindi, accanto alla vocalist, un trio di grandi jazzisti quali Stefano Sabatini piano e arrangiamenti, Luca Pirozzi contrabbasso e Pietro Iodice alla batteria con in più la Puccini Fetival Orchestra diretta dal maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli, composta da ben ventinove elementi ai quali si sono affiancati come special guest Flavio Boltro alla tromba, Stefano Di Battista e Javier Girotto al sax soprano, Antonello Salis accordion e Roberto Guarino chitarra; superlativa anche la prova di Pino Jodice che oltre ad esibirsi al piano in “Un bel dì vedremo” ha scritto e arrangiato gli archi della Puccini Festival Orchestra. Ma risolti i problemi prettamente strumentali, restava lo scoglio dei testi dei libretti originali difficilmente adattabili al linguaggio jazz. Ebbene in questa particolare sfida la Tedesco è stata superlativa riuscendo a superare lo scoglio grazie alla sua grande sensibilità e alla duttilità della voce che le hanno consentito di esprimere con assoluta padronanza e coerenza quelle frasi che oramai fanno parre integrante del patrimonio dei melomani di mezzo mondo. Gli undici brani sono uno più bello dell’altro: basta qualche titolo per rendersene conto, da “Che gelida manina” da “La Bohème” a “E lucevan le stelle” dalla “Tosca” sino alla ripresa di “E lucevan le stelle” che chiude l’album. Insomma un album che coniuga una estrema godibilità con un ragguardevole spessore artistico.
Luca Zennaro – “When Nobody Is Listening” – Caligola
 Nonostante sia molto giovane (23 anni) e tuttora studente del Conservatorio di Rovigo, il chitarrista di Chioggia è già al suo secondo album da leader dopo “Javaskara” del 2018. In effetti questo “When Nobody Is Listening” ci consegna un musicista già in grado di affrontare prove impegnative come quella di un’uscita discografica. In repertorio nove composizioni originali, tutte di Zennaro, eseguite da un quintetto di base completato da Jacopo Fagioli alla tromba, Nicola Caminiti al sax alto, Michelangelo Scandroglio al contrabbasso e Mattia Galeotti alla batteria cui si aggiungono in alcuni brani Alessandro Lanzoni e Nico Tangherlini, ambedue al pianoforte. Il linguaggio è sicuramente jazzistico a tutto tondo, con una front line ben sostenuta dalla sezione ritmica; l’atmosfera è in linea di massima intimista con il gruppo alla ricerca della migliore intesa per esplorare, nelle pieghe più intime, le linee melodiche disegnate dal leader. Questi, piuttosto che porsi continuamene in primo piano, preferisce mantenersi quasi in disparte dando così l’opportunità ai compagni di viaggio di estrinsecare le proprio possibilità. Ciò ovviamente non toglie che Zennaro ci dia mostra del suo talento chitarristico come in “Heritage”. Tra gli altri brani particolarmente interessante “Recitativo” a chiudere l’album, con Tangherlini e Fagioli che dialogano con disinvoltura e pertinenza.
Nonostante sia molto giovane (23 anni) e tuttora studente del Conservatorio di Rovigo, il chitarrista di Chioggia è già al suo secondo album da leader dopo “Javaskara” del 2018. In effetti questo “When Nobody Is Listening” ci consegna un musicista già in grado di affrontare prove impegnative come quella di un’uscita discografica. In repertorio nove composizioni originali, tutte di Zennaro, eseguite da un quintetto di base completato da Jacopo Fagioli alla tromba, Nicola Caminiti al sax alto, Michelangelo Scandroglio al contrabbasso e Mattia Galeotti alla batteria cui si aggiungono in alcuni brani Alessandro Lanzoni e Nico Tangherlini, ambedue al pianoforte. Il linguaggio è sicuramente jazzistico a tutto tondo, con una front line ben sostenuta dalla sezione ritmica; l’atmosfera è in linea di massima intimista con il gruppo alla ricerca della migliore intesa per esplorare, nelle pieghe più intime, le linee melodiche disegnate dal leader. Questi, piuttosto che porsi continuamene in primo piano, preferisce mantenersi quasi in disparte dando così l’opportunità ai compagni di viaggio di estrinsecare le proprio possibilità. Ciò ovviamente non toglie che Zennaro ci dia mostra del suo talento chitarristico come in “Heritage”. Tra gli altri brani particolarmente interessante “Recitativo” a chiudere l’album, con Tangherlini e Fagioli che dialogano con disinvoltura e pertinenza.
















 Jon Balke Siwan – “Hafla” – ECM
Jon Balke Siwan – “Hafla” – ECM Flavio Boltro, Fabio Giachino – “Things to Say” – Cam Jazz
Flavio Boltro, Fabio Giachino – “Things to Say” – Cam Jazz Avishai Cohen – “Naked Truth” – ECM
Avishai Cohen – “Naked Truth” – ECM Claudio Cojaniz – “Orfani” – Caligola
Claudio Cojaniz – “Orfani” – Caligola Lorenzo De Finti Quartet – “Mysterium Lunae” – Losen
Lorenzo De Finti Quartet – “Mysterium Lunae” – Losen Joey DeFrancesco – “More Music” – Mack Avenue
Joey DeFrancesco – “More Music” – Mack Avenue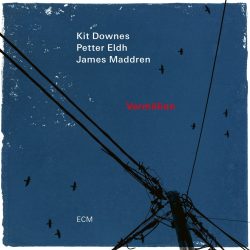 Kit Downes – “Vermillion” – ECM
Kit Downes – “Vermillion” – ECM Mathias Eick – “When We Leave” – ECM
Mathias Eick – “When We Leave” – ECM Antonio Flinta – “Secrets of a Kiri Tree” – Autoprod.
Antonio Flinta – “Secrets of a Kiri Tree” – Autoprod. Tord Gustavsen – “Opening” – ECM
Tord Gustavsen – “Opening” – ECM Roberto Laneri – “Musica finta / Blue Prints” – Da Vinci Classics
Roberto Laneri – “Musica finta / Blue Prints” – Da Vinci Classics “South of No Border” (come si diceva registrato tra il 2014 e il 2018 ma anch’esso pubblicato poche settimane fa) vede Roberto Laneri (clarinetto, clarinetto basso, sax sopranino, sax soprano e alto, didjeridoo, shruti box, voce e percussioni) alla testa di un gruppo comprendente Giuppi Paone voce, Raffaela Siniscalchi voce, Eleonora Vulpiani chitarra, Luigi Polsini contrabbasso e Laugi Marino zarb. Contrariamente al primo album, in questo caso il repertorio è come una sorta di finestra affacciata sulle musiche del mondo. Ecco, quindi, dopo l’apertura affidata alle melodie orientaleggianti di “Malia” (scritta da Laneri), il choro brasiliano “Tico-Tico no fubá” (scritto da Zequinha de Abreu nel 1917, accanto al bolero cubano “Contigo En La Distancia” scritto dal cantautore César Portillo de la Luz quando aveva 24 anni nel 1946, il tutto impreziosito da 4 original del leader. A confronto con un tale repertorio, Laneri dà ancora una volta prova non solo della sua indiscussa preparazione tecnica ma anche della profonda conoscenza del panorama musicale internazionale. Le sue interpretazioni risultano, quindi, assolutamente pertinenti: traendo feconda ispirazione da svariate tradizioni, riesce a produrre una sintesi che non conosce confini geografici grazie ad una concezione visionaria della musica senza barriere. Insomma un disco originale nella concezione e nell’esecuzione.
“South of No Border” (come si diceva registrato tra il 2014 e il 2018 ma anch’esso pubblicato poche settimane fa) vede Roberto Laneri (clarinetto, clarinetto basso, sax sopranino, sax soprano e alto, didjeridoo, shruti box, voce e percussioni) alla testa di un gruppo comprendente Giuppi Paone voce, Raffaela Siniscalchi voce, Eleonora Vulpiani chitarra, Luigi Polsini contrabbasso e Laugi Marino zarb. Contrariamente al primo album, in questo caso il repertorio è come una sorta di finestra affacciata sulle musiche del mondo. Ecco, quindi, dopo l’apertura affidata alle melodie orientaleggianti di “Malia” (scritta da Laneri), il choro brasiliano “Tico-Tico no fubá” (scritto da Zequinha de Abreu nel 1917, accanto al bolero cubano “Contigo En La Distancia” scritto dal cantautore César Portillo de la Luz quando aveva 24 anni nel 1946, il tutto impreziosito da 4 original del leader. A confronto con un tale repertorio, Laneri dà ancora una volta prova non solo della sua indiscussa preparazione tecnica ma anche della profonda conoscenza del panorama musicale internazionale. Le sue interpretazioni risultano, quindi, assolutamente pertinenti: traendo feconda ispirazione da svariate tradizioni, riesce a produrre una sintesi che non conosce confini geografici grazie ad una concezione visionaria della musica senza barriere. Insomma un disco originale nella concezione e nell’esecuzione. Roberto Magris – “Match Point” – JMood / Roberto Magris – “Duo & Trio” – JMood
Roberto Magris – “Match Point” – JMood / Roberto Magris – “Duo & Trio” – JMood Dino & Franco Piana Ensemble – “Reflections” –Alfa Music
Dino & Franco Piana Ensemble – “Reflections” –Alfa Music Valentina Ranalli, Enrico Pieranunzi – “Cantare Pieranunzi” – Alfa Music
Valentina Ranalli, Enrico Pieranunzi – “Cantare Pieranunzi” – Alfa Music Completamente diverso il secondo album – “The Extra Something” – registrato live il 13 e 14 gennaio 2016 al Village Vanguard da un quintetto che vedeva il pianista romano in compagnia di Diego Urcola tromba e trombone (semplicemente straordinario nella title tracke), Seamus Blake sax tenore (particolarmente convincente in “Atoms”), Ben Street basso e Adam Cruz batteria. E per quanti seguono il jazz non c’è bisogno di altre parole per sottolineare il valore assoluto della band. Valore assoluto che si evidenzia in tutto il repertorio, sette brani tutti composti dal pianista. Pieranunzi, come spesso gli capita, è in uno stato di grazie e conduce il gruppo con mano sicura, del tutto consapevole dell’intesa che ha raggiunto con i compagni di viaggio. Dal punto di vista compositivo non scopriamo certo oggi il suo senso della struttura che mai l’abbandona, per cui se consideriamo tutti questi elementi si capisce bene perché il ben noto Brian Morton abbia incluso Enrico tra “i più significativi musicisti contemporanei”. Nelle note di copertina Pieranunzi dedica espressamente questo terzo CD Live at The Village Vanguard a Lorraine Gordon in memoriam, senza la quale né questo né i precedenti due si sarebbero potuti realizzare. Ricordiamo per inciso che il pianista romano è forse l’unico musicista italiano nella veste di leader ed uno dei pochissimi europei ad aver suonato nel leggendario jazz club a forma di diamante aperto da Max Gordon nel 1935 al 178 Seventh Avenue South di Manhattan.
Completamente diverso il secondo album – “The Extra Something” – registrato live il 13 e 14 gennaio 2016 al Village Vanguard da un quintetto che vedeva il pianista romano in compagnia di Diego Urcola tromba e trombone (semplicemente straordinario nella title tracke), Seamus Blake sax tenore (particolarmente convincente in “Atoms”), Ben Street basso e Adam Cruz batteria. E per quanti seguono il jazz non c’è bisogno di altre parole per sottolineare il valore assoluto della band. Valore assoluto che si evidenzia in tutto il repertorio, sette brani tutti composti dal pianista. Pieranunzi, come spesso gli capita, è in uno stato di grazie e conduce il gruppo con mano sicura, del tutto consapevole dell’intesa che ha raggiunto con i compagni di viaggio. Dal punto di vista compositivo non scopriamo certo oggi il suo senso della struttura che mai l’abbandona, per cui se consideriamo tutti questi elementi si capisce bene perché il ben noto Brian Morton abbia incluso Enrico tra “i più significativi musicisti contemporanei”. Nelle note di copertina Pieranunzi dedica espressamente questo terzo CD Live at The Village Vanguard a Lorraine Gordon in memoriam, senza la quale né questo né i precedenti due si sarebbero potuti realizzare. Ricordiamo per inciso che il pianista romano è forse l’unico musicista italiano nella veste di leader ed uno dei pochissimi europei ad aver suonato nel leggendario jazz club a forma di diamante aperto da Max Gordon nel 1935 al 178 Seventh Avenue South di Manhattan. Serena Spedicato – “Io che amo solo te” – Dodicilune
Serena Spedicato – “Io che amo solo te” – Dodicilune Andrés Thor – Hereby – Losen
Andrés Thor – Hereby – Losen Mark Turner – “Return From The Stars” – ECM
Mark Turner – “Return From The Stars” – ECM Cristina Zavalloni – “Parlami di me” – Egea
Cristina Zavalloni – “Parlami di me” – Egea