da Amedeo Furfaro | 03/Ago/2022 | Editoriali, News, Primo piano
La televisione è stata spesso oggetto di critiche in quanto possibile veicolo di regresso culturale delle masse. Umberto Eco, a proposito dell’uomo circuìto dai mass media, scriveva che “poiché uno dei compensi narcotici a cui ha diritto è l’evasione nel sogno, gli vengono presentati di solito degli ideali tra lui e quelli con cui si possa stabilire una tensione” (Diario Minimo, 1961). La tematica dei rapporti fra musica e mass media investe anche un genere non definibile “narcotizzante” come il jazz nella sua relazione con la tv. In proposito, in Italia, si sono verificati dei momenti di avvicinamento fra i due termini del rapporto che consentono di abbozzare dei lineamenti di storia televisiva “vista” attraverso il fil rouge delle sigle jazz.
—
Donald Bogle ha osservato che “attorno al 1950 i sets tv arrivavano nelle case degli americani trasformandone gradualmente abitudini e prospettive” (Blacks in American Films and Television, New York, Fireside, 1989). E David Johnson di recente ha annotato che “come la tv si insinuava nell’entertainment dell’America di metà 900, musicisti e compositori, molti con esperienze jazz, venivano chiamati a scrivere temi ed “attacchi” per varietà e programmi” (Heard It On The Tv: Jazz Takes On Television Themes, indianapublicmedia.org, 12/5/2021). Osservazioni in parte trasferibili, con le dovute proporzioni, all’Italia che, dal 1954, dai primi vagiti della neonata tv, subiva il modificarsi di usi, linguaggio, immaginario collettivo in un contesto di rapida trasformazione economica, sociale e culturale, a causa anche alla spinta dei mass media. Su queste colonne, fra le sottotracce della nostra storia televisiva, abbiamo provato a “rintracciare” un argomento abbastanza sottaciuto, quello delle sigle (e intersigle) che sono poi l’antipasto e il post prandium del programma televisivo, nello specifico quelle dialoganti lato sensu in jazz o comunque prodotte od associabili a jazzisti. Come “la radio degli anni Cinquanta è a cavallo tra conservazione e trasformazione” (cfr. sub voce Cultura e educazione, l’Universale Radio, Milano, 2006) così il nuovo medium, già dai primi anni di vita, attenzionava sonorità che erano espressione di differenti musiche del mondo. Su un tale sfondo il jazz riusciva man mano a ritagliarsi spazi nei palinsesti e ad essere presente in filmati, notiziari, dossier, speciali, spot e jingle (cfr. Jazz e pubblicità, “A proposito di Jazz”, 9/4/2021), programmi a quiz, a premi e a cotillon, varietà, sceneggiati e “originali televisivi”, serie tv. Già nell’Italia della ricostruzione postbellica la dimensione locale non più autarchica si era confrontata sulla globale “importando” liberamente musica che durante il regime era proibita. Con l’avvento del medium tv le sigle di fatto fungevano da possibile cavallo di Troia per conquistare al jazz spazio in audio/video e lasciar trapelare le note di Woody Herman, Stan Kenton, Duke Ellington, Toots Thielemans … e vari artefici di una musica che in quegli anni non veniva più percepita solo come intrattenimento omologante bensì anche quale propaggine di quella cultura neroamericana propria di una comunità oppressa non dominante. Una comunità in fibrillante opposizione politica e spiccato antagonismo sociale i cui risvolti rimbalzavano nelle lettere, nelle arti, nella musica. Ma entriamo nel dettaglio. In Italia, nel 1957, coetanea di Carosello, vedeva la luce in tv Telematch. La trasmissione a premi era introdotta dalle note di “Marching Strings” dell’orchestra di Ray Martin, il bandleader di “The Swingin’ Marchin’ Band” (RCA, 1958). Light music, la sua, che rappresentava però un’apertura internazionale verso la musica easy listening d’oltrefrontiera sul Programma Nazionale e in prima serata. Parallelamente, alla radio, nel 1960, Adriano Mazzoletti, da un anno collaboratore della Rai, debuttava con la Coppa del Jazz promuovendo in tal modo una più stabile programmazione in senso jazzistico sul mezzo radiofonico i cui primordi risalgono all’antenato Eiar Jazz del 1929.
 A dire il vero, dopo il primo melodico Sanremo del ’51, una decisa aura jazz si era avvertita in Nati per la Musica, un programma con Jula De Palma, Quartetto Cetra, Teddy Reno che si avvaleva delle orchestre di ritmi moderni di Gorni Kramer e Lelio Luttazzi, la cui sigla è ascoltabile sul Portale della Canzone Italiana dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi (www.canzone italiana.it/1zlns). Sorella Radio avrebbe dato anche in seguito significativi contributi alla causa jazzistica – si pensi all’uso fatto da Radio1 dello stacco di “Country“ tratto dal cd “My Song” di Jarrett con Garbarek, Danielson e Christensen (ECM, 1977) – ma il copioso materiale di Mamma Rai, con il ricchissimo archivio sonoro ad oggi digitalizzato, meriterebbe di essere approfondito in altra sede. Torniamo allora al come eravamo tramite il cosa guardavamo. Dopo la vittoria di Modugno all’Ariston nel ’58, con una “Nel blu dipinto di blu” a ritmo swing, nell’anno di grazia televisivo 1961 passavano in video le immagini di Moderato Swing che era anche il titolo della sigla di Piero Umiliani. Un biennio ancora per poi sentire il canto e la tromba di Nini Rosso echeggiare in “I ragazzi del jazz”, sigla di Fuori I ’Orchestra, epica trasmissione, per la regia di Lino Procacci, che si avvaleva della direzione musicale dello stesso Umiliani. Si trattava di una rubrica che si occupava “di musica equidistante fra quella leggerissima e quella classica“ (www.umiliani.com) che rimane una pietra miliare della televisione italiana. Fra i numeri fissi c’erano quello dedicato al Jazz made in Italy ed l’altro spazio denominato Parole e musica che registrava partecipazioni lussuose tipo la cantante Helen Merrill. Da segnalare che Umiliani avrebbe poi collaborato con I Marc 4 (acronimo di Maurizio Majorana, Antonello Vannucchi, Roberto Podio, Carlo Pes), gruppo operante fra ’60 e ’76, a cui è da ascrivere la sigla di Prima Visione (su album Ricordi, 1974). Il 1963 resta un anno significativo per il jazz sul piccolo schermo anche perché decollava in Italia, con TV7, l’idea di utilizzare un brano jazz come intro di un programma d’inchiesta. Per l’occasione la scelta cadeva su “Intermission Riff” di Stan Kenton, poi sostituita con una storica versione dell’Equipe 84. A fine decennio toccava alla serie tv Nero Wolf diretta da Giuliana Berlinguer con Tino Buazzelli, vedere impressi i titoli di testa e di coda dalla tromba di Nunzio Rotondo sulla base elettronica di Romolo Grano, musica da noir con echi dal lungometraggio di Louis Malle Ascenseur pour l’échafaud, del ’58, sonorizzato da Miles Davis, trombettista a cui Rotondo è stato spesso accostato. Ed avrebbe “aperto” un thriller televisivo il compositore Berto Pisano con la sua “Blue Shadow”, sigla lounge dello sceneggiato Ho incontrato un’ombra del 1974, che figura nella classifica stilata da “Rolling Stone” il 26 agosto 2020 in Fantasmi e storie maledette. Le migliori sigle della tv italiana del mistero degli anni ’70. In tema di rotocalchi da menzionare che AZ un fatto come e perché (in onda dal ‘70 fino al luglio ’76) adottava un pezzo del repertorio jazz, esattamente “Hard to Keep My Mind of You”, di Woody Herman.
A dire il vero, dopo il primo melodico Sanremo del ’51, una decisa aura jazz si era avvertita in Nati per la Musica, un programma con Jula De Palma, Quartetto Cetra, Teddy Reno che si avvaleva delle orchestre di ritmi moderni di Gorni Kramer e Lelio Luttazzi, la cui sigla è ascoltabile sul Portale della Canzone Italiana dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi (www.canzone italiana.it/1zlns). Sorella Radio avrebbe dato anche in seguito significativi contributi alla causa jazzistica – si pensi all’uso fatto da Radio1 dello stacco di “Country“ tratto dal cd “My Song” di Jarrett con Garbarek, Danielson e Christensen (ECM, 1977) – ma il copioso materiale di Mamma Rai, con il ricchissimo archivio sonoro ad oggi digitalizzato, meriterebbe di essere approfondito in altra sede. Torniamo allora al come eravamo tramite il cosa guardavamo. Dopo la vittoria di Modugno all’Ariston nel ’58, con una “Nel blu dipinto di blu” a ritmo swing, nell’anno di grazia televisivo 1961 passavano in video le immagini di Moderato Swing che era anche il titolo della sigla di Piero Umiliani. Un biennio ancora per poi sentire il canto e la tromba di Nini Rosso echeggiare in “I ragazzi del jazz”, sigla di Fuori I ’Orchestra, epica trasmissione, per la regia di Lino Procacci, che si avvaleva della direzione musicale dello stesso Umiliani. Si trattava di una rubrica che si occupava “di musica equidistante fra quella leggerissima e quella classica“ (www.umiliani.com) che rimane una pietra miliare della televisione italiana. Fra i numeri fissi c’erano quello dedicato al Jazz made in Italy ed l’altro spazio denominato Parole e musica che registrava partecipazioni lussuose tipo la cantante Helen Merrill. Da segnalare che Umiliani avrebbe poi collaborato con I Marc 4 (acronimo di Maurizio Majorana, Antonello Vannucchi, Roberto Podio, Carlo Pes), gruppo operante fra ’60 e ’76, a cui è da ascrivere la sigla di Prima Visione (su album Ricordi, 1974). Il 1963 resta un anno significativo per il jazz sul piccolo schermo anche perché decollava in Italia, con TV7, l’idea di utilizzare un brano jazz come intro di un programma d’inchiesta. Per l’occasione la scelta cadeva su “Intermission Riff” di Stan Kenton, poi sostituita con una storica versione dell’Equipe 84. A fine decennio toccava alla serie tv Nero Wolf diretta da Giuliana Berlinguer con Tino Buazzelli, vedere impressi i titoli di testa e di coda dalla tromba di Nunzio Rotondo sulla base elettronica di Romolo Grano, musica da noir con echi dal lungometraggio di Louis Malle Ascenseur pour l’échafaud, del ’58, sonorizzato da Miles Davis, trombettista a cui Rotondo è stato spesso accostato. Ed avrebbe “aperto” un thriller televisivo il compositore Berto Pisano con la sua “Blue Shadow”, sigla lounge dello sceneggiato Ho incontrato un’ombra del 1974, che figura nella classifica stilata da “Rolling Stone” il 26 agosto 2020 in Fantasmi e storie maledette. Le migliori sigle della tv italiana del mistero degli anni ’70. In tema di rotocalchi da menzionare che AZ un fatto come e perché (in onda dal ‘70 fino al luglio ’76) adottava un pezzo del repertorio jazz, esattamente “Hard to Keep My Mind of You”, di Woody Herman.
 Dal giornalismo d’inchiesta a quello sportivo: nel ’78 era il turno di Jazz Band di Hengel Gualdi a far da “preludio” a Novantesimo minuto, storica rubrica di RaiSport, e come non citare, dal campionario di La Domenica Sportiva, “Dribbling” di Piero Umiliani (1967), “Winning The West” della Buddy Rich Big Band (1973), “Mexico” di Danilo Rea e Roberto Gatto (1985), “Breakout” di Spyro Gira (1991)? Spostandoci alla “pagina” spettacoli, fra il ’76 e il ‘78, Rete 2 dava spazio in Odeon al pianista Keith Emerson (senza Lake e Palmer) in “Odeon Rag” arrangiamento di “Maple Leaf Rag” di Scott Joplin, subentrato in luogo del precedente “Honky Tonk Train Blues”, autore il pianista Meade Lux Lewis. Il filone spettacolistico avrebbe registrato più in là significativi esempi con lo scat di Lucio Dalla con gli Stadio che annuncia Lunedifilm per un buon ventennio fino al 2002 e l’ellingtoniano “Take The A Train” di Strayhorn a fare da intro ai trailer cinematografici assemblati da AnicaFlash per la rassegna delle novità cinematografiche “di stagione”. Si diceva come luogo fertile per la semina tv di suoni jazz da filtrare nelle orecchie dei telespettatori fosse l’informazione. Gettonatissima rimane al riguardo la sigla di Mixer (1980-1996) ovvero “Jazz Carnival” dei brasiliani Azimuth, specialisti del samba doido, genere fusion-funky. Latin come nelle radiocronache di Tutto il calcio minuto per minuto, dove Herb Alpert e Tijuana Brass interpretano “A Taste of Honey”, brano di stampo pop, in repertorio a Beatles e Giganti (“In paese è festa”). Per la tv italiana va ricordato che, fuori dal reticolo giornalistico, si contano altre occasioni più dirette di esposizione per la musica jazz filtrata tramite il piccolo schermo. La Portobello Jazz Band di Lino Patruno “presentava” il programma di Enzo Tortora (cfr. La tana delle sigle in tds.sigletv.net) nel 1978, stesso anno dello sceneggiato in 3 puntate Jazz Band di Pupi Avati, colonna sonora di Amedeo Tommasi, con il clarino di Hengel Gualdi in evidenza nelle sigle di apertura e chiusura, “Jazz Band” e “Swing Time” ; poi ancora Di Jazz in Jazz, programma “dedicato” con relativa sigla a cura dell’Orchestra Big Band della Rai diretta da Giampiero Boneschi e Franco Cerri (www.teche.rai.it). “Schegge”, queste ultime, che costituivano una vetrina per il jazz di casa nostra in una situazione in cui il format varietà si teneva alquanto distante, a differenza di quanto avveniva negli U.S.A. . Dalle nostre parti vanno citati comunque Milleluci, show datato 1974, nella cui sigla finale “Non gioco più” Mina duetta con l’armonica di Toots Thielemans, Palcoscenico, in onda fra 1980 e 1981, con Milva accompagnata da Astor Piazzolla mentre scorrono i titoli di coda in “Fumo e odore di caffè” e Premiatissima del 1985 dove il crooner Johnny Dorelli canta “La cosa si fa“ su base swing “metropolitano. Lo sdoganamento delle sigle jazz nei varietà proseguiva con Renzo Arbore (e Gegè Telesforo) a cui si deve “Smorza e’ lights (Such a night)” incipit di Telepatria International, inizio trasmissioni il 6 dicembre 1981 (www.arboristeria.it – Renzo Arbore Channel). Per la cronaca il 18 marzo 1981, e fino al 1989, sarebbe andata in onda la prima edizione di Quark di Piero Angela, conduttore nonché apprezzato pianista jazz. La trasmissione di divulgazione scientifica sarebbe stata simbioticamente legata alla sigla, la “Air for G String” di Bach, eseguita da The Swingle Singers, pubblicata nell’album “Jazz Sèbastian Bach” (1963), peraltro incisa anche insieme al Modern Jazz Quartet in “Place Vendòme”, album del ’68 della Philips. Terminiamo questa breve carrellata, che non include per sintesi le emittenti private/commerciali pro-tempore, per ricordare la sigla swing di DOC Musica e altro a denominazione d’origine controllata (1987-1988) di Arbore, Telesforo e Monica Nannini, esempio di come coinvolgere il jazz in un contenitore di buona musica. Il breve excursus è stato uno squarcio fugace su una jazz age, grossomodo racchiusa fra ’54 e ’94, un fugace momento di (bel) spaesizzazione musicale segnato, al proprio interno, dal passaggio dall’analogico al digitale, fase che precedeva la successiva della tv satellite e quella attuale della connessione via internet con la diffusione dei social e di new media come le web-tv con piattaforme on demand. E’ stato osservato che nella tv generalista di oggi “il jazz non ha più la stessa presa pubblica di un tempo” (cfr. Il jazz e le sigle radiotelevisive, riccardofacchi.wordpress.com, 2/8/2016). E “CiakClub.it” ha pubblicato, a firma di Alberto Candiani, un elenco con Le 20 migliori sigle televisive di sempre: Da Friends a Il trono di spade la lista delle più affascinanti iconiche e meglio congeniate sigle delle serie tv senza che ne compaia qualcuna (simil)jazz. Vero! Ci sono molti set televisivi in cui il jazz fa comparse episodiche. C’è poi che, a causa dell’affinarsi delle tecnologie digitali, molte sigle vengono confezionate a tavolino e, perdendo in istantaneità, sono sempre meno frutto di incisioni live né tantomeno vengono selezionate fra materiali preesistenti. Ed è forse tutto ciò che ammanta quei “primi quarant’anni” di tv “eterea” di un irripetibile sapore amarcord.
Dal giornalismo d’inchiesta a quello sportivo: nel ’78 era il turno di Jazz Band di Hengel Gualdi a far da “preludio” a Novantesimo minuto, storica rubrica di RaiSport, e come non citare, dal campionario di La Domenica Sportiva, “Dribbling” di Piero Umiliani (1967), “Winning The West” della Buddy Rich Big Band (1973), “Mexico” di Danilo Rea e Roberto Gatto (1985), “Breakout” di Spyro Gira (1991)? Spostandoci alla “pagina” spettacoli, fra il ’76 e il ‘78, Rete 2 dava spazio in Odeon al pianista Keith Emerson (senza Lake e Palmer) in “Odeon Rag” arrangiamento di “Maple Leaf Rag” di Scott Joplin, subentrato in luogo del precedente “Honky Tonk Train Blues”, autore il pianista Meade Lux Lewis. Il filone spettacolistico avrebbe registrato più in là significativi esempi con lo scat di Lucio Dalla con gli Stadio che annuncia Lunedifilm per un buon ventennio fino al 2002 e l’ellingtoniano “Take The A Train” di Strayhorn a fare da intro ai trailer cinematografici assemblati da AnicaFlash per la rassegna delle novità cinematografiche “di stagione”. Si diceva come luogo fertile per la semina tv di suoni jazz da filtrare nelle orecchie dei telespettatori fosse l’informazione. Gettonatissima rimane al riguardo la sigla di Mixer (1980-1996) ovvero “Jazz Carnival” dei brasiliani Azimuth, specialisti del samba doido, genere fusion-funky. Latin come nelle radiocronache di Tutto il calcio minuto per minuto, dove Herb Alpert e Tijuana Brass interpretano “A Taste of Honey”, brano di stampo pop, in repertorio a Beatles e Giganti (“In paese è festa”). Per la tv italiana va ricordato che, fuori dal reticolo giornalistico, si contano altre occasioni più dirette di esposizione per la musica jazz filtrata tramite il piccolo schermo. La Portobello Jazz Band di Lino Patruno “presentava” il programma di Enzo Tortora (cfr. La tana delle sigle in tds.sigletv.net) nel 1978, stesso anno dello sceneggiato in 3 puntate Jazz Band di Pupi Avati, colonna sonora di Amedeo Tommasi, con il clarino di Hengel Gualdi in evidenza nelle sigle di apertura e chiusura, “Jazz Band” e “Swing Time” ; poi ancora Di Jazz in Jazz, programma “dedicato” con relativa sigla a cura dell’Orchestra Big Band della Rai diretta da Giampiero Boneschi e Franco Cerri (www.teche.rai.it). “Schegge”, queste ultime, che costituivano una vetrina per il jazz di casa nostra in una situazione in cui il format varietà si teneva alquanto distante, a differenza di quanto avveniva negli U.S.A. . Dalle nostre parti vanno citati comunque Milleluci, show datato 1974, nella cui sigla finale “Non gioco più” Mina duetta con l’armonica di Toots Thielemans, Palcoscenico, in onda fra 1980 e 1981, con Milva accompagnata da Astor Piazzolla mentre scorrono i titoli di coda in “Fumo e odore di caffè” e Premiatissima del 1985 dove il crooner Johnny Dorelli canta “La cosa si fa“ su base swing “metropolitano. Lo sdoganamento delle sigle jazz nei varietà proseguiva con Renzo Arbore (e Gegè Telesforo) a cui si deve “Smorza e’ lights (Such a night)” incipit di Telepatria International, inizio trasmissioni il 6 dicembre 1981 (www.arboristeria.it – Renzo Arbore Channel). Per la cronaca il 18 marzo 1981, e fino al 1989, sarebbe andata in onda la prima edizione di Quark di Piero Angela, conduttore nonché apprezzato pianista jazz. La trasmissione di divulgazione scientifica sarebbe stata simbioticamente legata alla sigla, la “Air for G String” di Bach, eseguita da The Swingle Singers, pubblicata nell’album “Jazz Sèbastian Bach” (1963), peraltro incisa anche insieme al Modern Jazz Quartet in “Place Vendòme”, album del ’68 della Philips. Terminiamo questa breve carrellata, che non include per sintesi le emittenti private/commerciali pro-tempore, per ricordare la sigla swing di DOC Musica e altro a denominazione d’origine controllata (1987-1988) di Arbore, Telesforo e Monica Nannini, esempio di come coinvolgere il jazz in un contenitore di buona musica. Il breve excursus è stato uno squarcio fugace su una jazz age, grossomodo racchiusa fra ’54 e ’94, un fugace momento di (bel) spaesizzazione musicale segnato, al proprio interno, dal passaggio dall’analogico al digitale, fase che precedeva la successiva della tv satellite e quella attuale della connessione via internet con la diffusione dei social e di new media come le web-tv con piattaforme on demand. E’ stato osservato che nella tv generalista di oggi “il jazz non ha più la stessa presa pubblica di un tempo” (cfr. Il jazz e le sigle radiotelevisive, riccardofacchi.wordpress.com, 2/8/2016). E “CiakClub.it” ha pubblicato, a firma di Alberto Candiani, un elenco con Le 20 migliori sigle televisive di sempre: Da Friends a Il trono di spade la lista delle più affascinanti iconiche e meglio congeniate sigle delle serie tv senza che ne compaia qualcuna (simil)jazz. Vero! Ci sono molti set televisivi in cui il jazz fa comparse episodiche. C’è poi che, a causa dell’affinarsi delle tecnologie digitali, molte sigle vengono confezionate a tavolino e, perdendo in istantaneità, sono sempre meno frutto di incisioni live né tantomeno vengono selezionate fra materiali preesistenti. Ed è forse tutto ciò che ammanta quei “primi quarant’anni” di tv “eterea” di un irripetibile sapore amarcord.
Amedeo Furfaro
da Amedeo Furfaro | 02/Ago/2022 | I nostri CD, Primo piano, Recensioni

EVA E IL JAZZ. DISCHI AL FEMMINILE
Non è una novità che il jazz italiano si arricchisca sempre più di apporti al femminile generalmente in ruoli di leader o coleader e non sempre solo canori. Ciò avviene in rassegne come, ad esempio, la recente Women for Freedom in Jazz (con Zoe Pia e Valeria Sturba in apertura di un cartellone molto nutrito) o quella storica di Lucca Jazz Donna. La constatazione si può estendere anche al mercato discografico sul quale forniamo, a seguire, un succinto aggiornamento su alcune produzioni recenti redatto all’insegna della varietà di album sicuramente degni di segnalazione.
Chiara Pelloni, “Eve”, Caligola Records
 Debutto discografico per Chiara Pelloni, con Eve, album a marchio Caligola Records, che “racconta” di una donna in un viaggio verso la Spagna le cui tappe sono costituite da otto canzoni: un’interprete di sé stessa, essendo anche “liricista” oltre che autrice musicale di brani eseguiti con Matteo Pontegavelli (tr.), Alvaro Zarzuela (tr.ne), Francesco Salmaso (sax ten.), Lorenzo Mazzochetti (p), Francesco Zaccanti (cb) e Riccardo Cocetti (dr.), formazione ben assortita che “pedina” il canto con discrezione. Ed una voce, quella della Pelloni, che lascia insinuare venature pop sul sostrato armonico costruitole attorno con un gusto che è tutto jazzistico. Ne vengon fuori pezzi eterei come “Eve” e “Rebirth”, intimi come “First Peace”, ballad intense come “Blue Colored Streets” e “Please Love Me Too”, latin moderati come “Vega” e poi “Memories of You” omonimo della song di Benny Goodman, infine l’accorata “Quello che conta”. Dunque il suo approdo biennale nei Paesi Baschi, dove si è perfezionata con Deborah Carter, non ci ha restituito souvenir di cante hondo o similia. Chiara è ripartita da lì portandosi appresso un bagaglio di “canzoni di viaggio” in cui ha saputo descrivere stati d’animo ed emozioni prima ancora che paesaggi e skilines. Just like the jazz.
Debutto discografico per Chiara Pelloni, con Eve, album a marchio Caligola Records, che “racconta” di una donna in un viaggio verso la Spagna le cui tappe sono costituite da otto canzoni: un’interprete di sé stessa, essendo anche “liricista” oltre che autrice musicale di brani eseguiti con Matteo Pontegavelli (tr.), Alvaro Zarzuela (tr.ne), Francesco Salmaso (sax ten.), Lorenzo Mazzochetti (p), Francesco Zaccanti (cb) e Riccardo Cocetti (dr.), formazione ben assortita che “pedina” il canto con discrezione. Ed una voce, quella della Pelloni, che lascia insinuare venature pop sul sostrato armonico costruitole attorno con un gusto che è tutto jazzistico. Ne vengon fuori pezzi eterei come “Eve” e “Rebirth”, intimi come “First Peace”, ballad intense come “Blue Colored Streets” e “Please Love Me Too”, latin moderati come “Vega” e poi “Memories of You” omonimo della song di Benny Goodman, infine l’accorata “Quello che conta”. Dunque il suo approdo biennale nei Paesi Baschi, dove si è perfezionata con Deborah Carter, non ci ha restituito souvenir di cante hondo o similia. Chiara è ripartita da lì portandosi appresso un bagaglio di “canzoni di viaggio” in cui ha saputo descrivere stati d’animo ed emozioni prima ancora che paesaggi e skilines. Just like the jazz.
Marta Giuliani, “Up on A Tightrope”, Encore Music
 Sarebbe forse più opportuno tradurre “Up on A Tightrope”, titolo del primo album da leader di Marta Giuliani, come La corda tesa e non Sul filo del rasoio. La vocalist marchigiana presenta infatti nove propri brani in cui, più che la tensione, è la ricerca di equilibrio ad esser protagonista. Un po’ come Il funambolo che lei canta, su testo di Giovanni Paladini che firma anche “Il cielo dei Rojava” : “non è magia, non è pazzia / questo sogno che / sopra un filo va / alto sulle ali”. L’idea espressa è quella di un percorso graduale che compie con degli amici con cui condivide lo spirito creativo e il senso del procedere con un’incertezza che, alla prova dei fatti musicali, si fa sicurezza. Ed è quella da cui traspare l’impronta di fertile autrice di partiture, di testi poeticamente validi – a partire dall’iniziale “Fleeting Beauty” – e di arrangiamenti dalle soluzioni armoniche spesso inedite, di interprete avvezza all’improvvisazione “senza fili”, di bussola del combo formato da Nico Tangherlini al piano, Gabriele Pesaresi al contrabbasso e Andrea Elisei alla batteria, rete protettiva per Marta, trapezista della voce. Da sentire, in proposito, le elucubrazioni virtuosistiche di “Colibri’ e, in “So What if I Fall?”, i raddoppi voce-tastiera. Ma piacciono anche la sospensione aerea di “Clouds”, il solo nervoso del piano. Pregevole la traduzione in musica di “Beneath The Mask” del poeta afroamericano Paul Laurence Dunbar.
Sarebbe forse più opportuno tradurre “Up on A Tightrope”, titolo del primo album da leader di Marta Giuliani, come La corda tesa e non Sul filo del rasoio. La vocalist marchigiana presenta infatti nove propri brani in cui, più che la tensione, è la ricerca di equilibrio ad esser protagonista. Un po’ come Il funambolo che lei canta, su testo di Giovanni Paladini che firma anche “Il cielo dei Rojava” : “non è magia, non è pazzia / questo sogno che / sopra un filo va / alto sulle ali”. L’idea espressa è quella di un percorso graduale che compie con degli amici con cui condivide lo spirito creativo e il senso del procedere con un’incertezza che, alla prova dei fatti musicali, si fa sicurezza. Ed è quella da cui traspare l’impronta di fertile autrice di partiture, di testi poeticamente validi – a partire dall’iniziale “Fleeting Beauty” – e di arrangiamenti dalle soluzioni armoniche spesso inedite, di interprete avvezza all’improvvisazione “senza fili”, di bussola del combo formato da Nico Tangherlini al piano, Gabriele Pesaresi al contrabbasso e Andrea Elisei alla batteria, rete protettiva per Marta, trapezista della voce. Da sentire, in proposito, le elucubrazioni virtuosistiche di “Colibri’ e, in “So What if I Fall?”, i raddoppi voce-tastiera. Ma piacciono anche la sospensione aerea di “Clouds”, il solo nervoso del piano. Pregevole la traduzione in musica di “Beneath The Mask” del poeta afroamericano Paul Laurence Dunbar.
Battaglia – Arrigoni – Caputo – Di Battista, “Questo Tempo”, Da Vinci Jazz
 Nei festival di poesia in genere la forma di dialogo fra musica e poesia più praticata è il reading, pronipote del settecentesco “recitativo accompagnato” laddove si declama mentre scorrono note musicali a commento della declamazione. Per contro in molte performances musicali accade che sia la musica a prevalere lasciando l’intermezzo poetico a far da corollario. L’unione paritetica fra le due arti, sperimentata ab initio dagli antichi greci, trova ancora oggi delle occasioni di sperimentazione. Ed è quanto fatto da Stefano Battaglia in seno al Laboratorio Permanente di Ricerca Musicale a Siena Jazz. Un risultato, incentrato nello specifico sul gemellaggio fra Improvvisazione e poesia, è l’album Questo Tempo, della Da Vinci Jazz, in cui quattro musicisti si cimentano davanti a una breve antologia poetica novecentesca e contemporanea di matrice femminile con l’intento di “sonorizzarla” e “vocalizzarla”. Protagonisti del lavoro, oltre al ricordato pianista, la cantante Beatrice Arrigoni, il vibrafonista Nazareno Caputo e il batterista Luca Di Battista. Un’operazione avventurosa, quella di congiungere parametri musicali e metriche versicolari ma soprattutto due tipi di ispirazione, appunto poetica e musicale, che nell’ordinarietà seguono iter autonomi. Il quadrivio improvvisativo incrocia disinvoltamente il proprio comporre istantaneo a liriche di Chandra Livia Candiani, Amelia Rosselli, Margherita Guidacci, Paola Loreto, Laura Pugno, Anna Maria Ortese dando così luogo ad una galleria di “poete” in cui, saltato il passaggio del testo scritto, le liriche si adagiano su un letto naturale di suono e canto, gioia e pathos, antico e moderno, disteso loro dalla musicista bergamasca che ha eletto e riletto Questo Tempo: che è, scrive Laura Pugno, “lana bianca che cade dalle mani / non si chiude il vestito / la sabbia nella mente ha formato la perla / e non ha luce”.
Nei festival di poesia in genere la forma di dialogo fra musica e poesia più praticata è il reading, pronipote del settecentesco “recitativo accompagnato” laddove si declama mentre scorrono note musicali a commento della declamazione. Per contro in molte performances musicali accade che sia la musica a prevalere lasciando l’intermezzo poetico a far da corollario. L’unione paritetica fra le due arti, sperimentata ab initio dagli antichi greci, trova ancora oggi delle occasioni di sperimentazione. Ed è quanto fatto da Stefano Battaglia in seno al Laboratorio Permanente di Ricerca Musicale a Siena Jazz. Un risultato, incentrato nello specifico sul gemellaggio fra Improvvisazione e poesia, è l’album Questo Tempo, della Da Vinci Jazz, in cui quattro musicisti si cimentano davanti a una breve antologia poetica novecentesca e contemporanea di matrice femminile con l’intento di “sonorizzarla” e “vocalizzarla”. Protagonisti del lavoro, oltre al ricordato pianista, la cantante Beatrice Arrigoni, il vibrafonista Nazareno Caputo e il batterista Luca Di Battista. Un’operazione avventurosa, quella di congiungere parametri musicali e metriche versicolari ma soprattutto due tipi di ispirazione, appunto poetica e musicale, che nell’ordinarietà seguono iter autonomi. Il quadrivio improvvisativo incrocia disinvoltamente il proprio comporre istantaneo a liriche di Chandra Livia Candiani, Amelia Rosselli, Margherita Guidacci, Paola Loreto, Laura Pugno, Anna Maria Ortese dando così luogo ad una galleria di “poete” in cui, saltato il passaggio del testo scritto, le liriche si adagiano su un letto naturale di suono e canto, gioia e pathos, antico e moderno, disteso loro dalla musicista bergamasca che ha eletto e riletto Questo Tempo: che è, scrive Laura Pugno, “lana bianca che cade dalle mani / non si chiude il vestito / la sabbia nella mente ha formato la perla / e non ha luce”.
Paola Arnesano – Vince Abbracciante, “Opera!”, Dodicilune Records
 L’opera lirica in formato cameristico, priva cioè di apparato scenico, sfavillio dei costumi, movenze attoriali dei cantanti, tessitura corale presuppone, da parte di interpreti e pubblico, una concentrazione mirata sulla musica “sola”, spoglia della cornice di “spettacolo totale” propria di quel tipo di messinscena. Il che, con i limiti del caso, alla fine può anche rivelarsi un’esaltante estrapolazione del momento compositivo. Dal canto loro i jazzisti che vi si confrontino senza voler sconfinare nella provocazione o ancor più nella dissacrazione, si trovano di fronte alla necessità di effettuare una scelta sul limite entro cui contenere la novità dell’arrangiamento, la libertà interpretativa e la creatività dell’improvvisazione senza incorrere nel peccato di lesa … Melodia. La vocalist Paola Arnesano e il fisarmonicista Vince Abbracciante, nell’album Opera! edito da Dodicilune Records, contemperano il rispetto dello spirito originario della partitura con il loro specifico approccio jazz. Dal corposo “songbook” operistico il duo ha prelevato musiche di Rossini Donizetti Bellini Verdi Leoncavallo Cilea Puccini, divinità dell’Olimpo melodrammatico, e seguendo le stecche di un ventaglio che va dal (pre)romanticismo al verismo alle suggestioni espressive del primo novecento, le ha riproposte con gusto personale ed accorto dosaggio delle componenti in campo. La Arnesano – musicista ferrata in latin e ben vocata per gli standards – ed Abbracciante – nomen omen se si pensa all’abbraccio multistyle della sua fisarmonica – hanno avvolto un involucro canoro/sonoro pertinente sia pure con alcune “zone franche” a mò di antiossidanti pietre filosofali che rimodellano arie immortali. Si va da un balcaneggiante “Io Son Docile” tratto dal “Barbiere”, alla rarefatta “Ecco Respiro Appena” ripresa dalla “Adriana Lecouvreur”, da “O Mio Babbino Caro”, fonte “Gianni Schicchi”, reso a swing, al pathos di “Vesti la Giubba”, maschera tragica di “Pagliacci”. E’ un altalenare fra i colori tenui di “Ieri Son Salita Tutta Sola” dalla “Butterfly” ed il volteggiare vocale su base sincopata di “Sempre Libera Degg’io” da “La Traviata” che è anche un inno alla varietà del Repertorio Lirico Nazionale e nel contempo alla sua unicità. C’è spazio per il walzer a tinte folk di “Mercè, Dilette Amiche” da “I Vespri Siciliani” ed il “Quando Men Vo” da “La Bohème” trasformato in chanson. Fra le chicche l’aria “Di Tal Amor Che Dirsi” da “Il Trovatore” in cui le volute belcantistiche si rivelano legittime antenate del vocalese e, dalla “Tosca”, le due perle “Vissi D’arte” ed “E Lucean le Stelle”. Non potevano mancare la “Norma” con “Casta Diva” e “Lucrezia Borgia” con “Il Segreto Per esser Felici” a completare quest’omaggio ad una nostra tradizione tuttora pulsante.
L’opera lirica in formato cameristico, priva cioè di apparato scenico, sfavillio dei costumi, movenze attoriali dei cantanti, tessitura corale presuppone, da parte di interpreti e pubblico, una concentrazione mirata sulla musica “sola”, spoglia della cornice di “spettacolo totale” propria di quel tipo di messinscena. Il che, con i limiti del caso, alla fine può anche rivelarsi un’esaltante estrapolazione del momento compositivo. Dal canto loro i jazzisti che vi si confrontino senza voler sconfinare nella provocazione o ancor più nella dissacrazione, si trovano di fronte alla necessità di effettuare una scelta sul limite entro cui contenere la novità dell’arrangiamento, la libertà interpretativa e la creatività dell’improvvisazione senza incorrere nel peccato di lesa … Melodia. La vocalist Paola Arnesano e il fisarmonicista Vince Abbracciante, nell’album Opera! edito da Dodicilune Records, contemperano il rispetto dello spirito originario della partitura con il loro specifico approccio jazz. Dal corposo “songbook” operistico il duo ha prelevato musiche di Rossini Donizetti Bellini Verdi Leoncavallo Cilea Puccini, divinità dell’Olimpo melodrammatico, e seguendo le stecche di un ventaglio che va dal (pre)romanticismo al verismo alle suggestioni espressive del primo novecento, le ha riproposte con gusto personale ed accorto dosaggio delle componenti in campo. La Arnesano – musicista ferrata in latin e ben vocata per gli standards – ed Abbracciante – nomen omen se si pensa all’abbraccio multistyle della sua fisarmonica – hanno avvolto un involucro canoro/sonoro pertinente sia pure con alcune “zone franche” a mò di antiossidanti pietre filosofali che rimodellano arie immortali. Si va da un balcaneggiante “Io Son Docile” tratto dal “Barbiere”, alla rarefatta “Ecco Respiro Appena” ripresa dalla “Adriana Lecouvreur”, da “O Mio Babbino Caro”, fonte “Gianni Schicchi”, reso a swing, al pathos di “Vesti la Giubba”, maschera tragica di “Pagliacci”. E’ un altalenare fra i colori tenui di “Ieri Son Salita Tutta Sola” dalla “Butterfly” ed il volteggiare vocale su base sincopata di “Sempre Libera Degg’io” da “La Traviata” che è anche un inno alla varietà del Repertorio Lirico Nazionale e nel contempo alla sua unicità. C’è spazio per il walzer a tinte folk di “Mercè, Dilette Amiche” da “I Vespri Siciliani” ed il “Quando Men Vo” da “La Bohème” trasformato in chanson. Fra le chicche l’aria “Di Tal Amor Che Dirsi” da “Il Trovatore” in cui le volute belcantistiche si rivelano legittime antenate del vocalese e, dalla “Tosca”, le due perle “Vissi D’arte” ed “E Lucean le Stelle”. Non potevano mancare la “Norma” con “Casta Diva” e “Lucrezia Borgia” con “Il Segreto Per esser Felici” a completare quest’omaggio ad una nostra tradizione tuttora pulsante.
Vanessa Tagliabue Yorke, “The Princess Theatre”, Azzurra Music
 The Princess Theatre di Vanessa Tagliabue Yorke (Azzurra Music) è album che vanta un legame ideale con il piccolo (meno di 300 posti) Teatro della Principessa della 39ma strada a New York, una struttura che, un paio d’anni dopo l’apertura nel 1913 e per un buon quadriennio, ospitò shows in formato “medium” a confronto dei reboanti musical di Broadway. Fu allora che, a causa della ristrettezza degli spazi, Jerome Kern fu obbligato a formulare melodie con le orchestrazioni di Frank Sadler scritte per ensembles non numerosi, forgiando così quell’innovativo e snello teatro musicale “americano” dell’epoca che si associa al team autoriale Kern, Guy Bolton, P.G. Wodehouse. Quello che la vocalist rievoca, a distanza di un secolo e passa e dopo due anni di pandemia, è il senso della spazialità ridotta, che non è angustia, e che “costringe” a pensare la musica in modo più raccolto e introspettivo. Ed è con questi occhiali che va interpretata la tracklist in cui accanto a brani di Strayhorn (“A flower is a Lovesome Thing”), Carmichael (“Stardust”), Green (“I Cover The Waterfront”), Kern (“The Way To Look Tonight”), Kitchings-Herzog jr (“Some Other Springs”), la Tagliabue “liricizza” Strayhorn (“Ballad for Very Tired and Very Sad Lotus Eaters”) o “musicalizza” Yeats (“Aedh Wishes for the Cloths of Heaven”). Va da sé che il disco non è costruito in laboratorio ma è il live del concerto tenutosi a Malcesine (VR) lo scorso 19 dicembre 2021 in cui figura al piano l’esperto Paolo Birro, peraltro coautore di “Leon”, con gli interventi della tromba di Fabrizio Bosso in “I’ve Stolen” e “Dream” e nel citato pezzo ripreso da Yeats dove il trombettista figura come coautore. Non c’è di che scegliere fra la Tagliabue autrice di “Ever” o “Don’t Leave Me” con la jazzista che completa il quadro armonico, elegante e forbito, di un pianista del livello di Birro. Tutto è al suo posto, quello ottimale per la dimensione del Princess Theatre in quel 1915-18, al riparo dai lontani venti di guerra che ancora oggi come allora soffiano e che la buona musica riesce a placare.
The Princess Theatre di Vanessa Tagliabue Yorke (Azzurra Music) è album che vanta un legame ideale con il piccolo (meno di 300 posti) Teatro della Principessa della 39ma strada a New York, una struttura che, un paio d’anni dopo l’apertura nel 1913 e per un buon quadriennio, ospitò shows in formato “medium” a confronto dei reboanti musical di Broadway. Fu allora che, a causa della ristrettezza degli spazi, Jerome Kern fu obbligato a formulare melodie con le orchestrazioni di Frank Sadler scritte per ensembles non numerosi, forgiando così quell’innovativo e snello teatro musicale “americano” dell’epoca che si associa al team autoriale Kern, Guy Bolton, P.G. Wodehouse. Quello che la vocalist rievoca, a distanza di un secolo e passa e dopo due anni di pandemia, è il senso della spazialità ridotta, che non è angustia, e che “costringe” a pensare la musica in modo più raccolto e introspettivo. Ed è con questi occhiali che va interpretata la tracklist in cui accanto a brani di Strayhorn (“A flower is a Lovesome Thing”), Carmichael (“Stardust”), Green (“I Cover The Waterfront”), Kern (“The Way To Look Tonight”), Kitchings-Herzog jr (“Some Other Springs”), la Tagliabue “liricizza” Strayhorn (“Ballad for Very Tired and Very Sad Lotus Eaters”) o “musicalizza” Yeats (“Aedh Wishes for the Cloths of Heaven”). Va da sé che il disco non è costruito in laboratorio ma è il live del concerto tenutosi a Malcesine (VR) lo scorso 19 dicembre 2021 in cui figura al piano l’esperto Paolo Birro, peraltro coautore di “Leon”, con gli interventi della tromba di Fabrizio Bosso in “I’ve Stolen” e “Dream” e nel citato pezzo ripreso da Yeats dove il trombettista figura come coautore. Non c’è di che scegliere fra la Tagliabue autrice di “Ever” o “Don’t Leave Me” con la jazzista che completa il quadro armonico, elegante e forbito, di un pianista del livello di Birro. Tutto è al suo posto, quello ottimale per la dimensione del Princess Theatre in quel 1915-18, al riparo dai lontani venti di guerra che ancora oggi come allora soffiano e che la buona musica riesce a placare.
Sonia Spinello – Roberto Olzer, “Silence”, Abeat
 L’assenza di suono, come dimostrato da John Cage, non esiste. E neanche la pausa musicale, di per sé, è sinonimo di vuoto totale. Per questo un album che si denomini Silence, come quello della vocalist Sonia Spinello e del pianista Roberto Olzer editato da Abeat, prefigura comunque delle note o comunque delle vibrazioni che giungono al “pianoforte segreto” del nostro orecchio. E non è luogo di afasie nientificazioni o rumori ma vi fluiscono semmai consonanze sussurrate, accennate, sviluppate, interagite con il violino di Eloisa Manera e il violoncello di Daniela Savoldi oltre al soprano di Massimo Valentini in “Consequences” ed al bansuri di Andrea Zaninetti in “Tell Me”. Questo lavoro, che nasce sulla scia dei cd Abeat “Steppin’ Out” e “Wonderland”, premiato in Giappone nel 2017 come miglior album vocale dalla rivista “Critique Magazine”, nel collocarsi fra le fenditure di world music, ambient jazz e classico-moderna, regala delle occasioni di “copertura” armonica del silenzio mantenendone l’aura sullo sfondo. A voler sceverare fra la dozzina di brani del compact non si può non sottolineare la bellezza di “Softly”, i colori intimi di “Silence”, la poeticità di “Attimi”, ma è tutto il mondo sonoro evocato dai musicisti a far da contrappunto al silenzio per il sound unico di questo disco candidato, ancora una volta, a proiettarsi sul proscenio internazionale.
L’assenza di suono, come dimostrato da John Cage, non esiste. E neanche la pausa musicale, di per sé, è sinonimo di vuoto totale. Per questo un album che si denomini Silence, come quello della vocalist Sonia Spinello e del pianista Roberto Olzer editato da Abeat, prefigura comunque delle note o comunque delle vibrazioni che giungono al “pianoforte segreto” del nostro orecchio. E non è luogo di afasie nientificazioni o rumori ma vi fluiscono semmai consonanze sussurrate, accennate, sviluppate, interagite con il violino di Eloisa Manera e il violoncello di Daniela Savoldi oltre al soprano di Massimo Valentini in “Consequences” ed al bansuri di Andrea Zaninetti in “Tell Me”. Questo lavoro, che nasce sulla scia dei cd Abeat “Steppin’ Out” e “Wonderland”, premiato in Giappone nel 2017 come miglior album vocale dalla rivista “Critique Magazine”, nel collocarsi fra le fenditure di world music, ambient jazz e classico-moderna, regala delle occasioni di “copertura” armonica del silenzio mantenendone l’aura sullo sfondo. A voler sceverare fra la dozzina di brani del compact non si può non sottolineare la bellezza di “Softly”, i colori intimi di “Silence”, la poeticità di “Attimi”, ma è tutto il mondo sonoro evocato dai musicisti a far da contrappunto al silenzio per il sound unico di questo disco candidato, ancora una volta, a proiettarsi sul proscenio internazionale.
Barbara Casini, “Hermanos”, Encore Music
 Gli Hermanos della cantante Barbara Casini, nell’album edito da Encore, sono il sassofonista Javier Girotto, il chitarrista Roberto Taufic e il pianista Seby Burgio. Fior di musicisti che partecipano all’esecuzione, oltre che con il proprio strumento, con interventi mirati come la quena di Girotto in “Hurry” dell’uruguagio Fattoruso e in “Tonada de Luna Llena” del venezuelano Simòn Diaz, la voce di Taufic in “Pasarero” di Carlos Aguirre, di Rosario, e in “Maria Landò” di Granda e Calvo in cui si sentono le claps di Burgio. Ma gli Hermanos di una Casini in gran spolvero di latin imbevuto da sempre nelle corde vocali li vediamo anche nella figura stratosferica del brasiliano Milton Nascimento che ha scritto “Milagre dos Peixes” con Fernando Brant e che il 4et interpreta mirabilmente in chiusura al disco. Una “squadra” di fuoriclasse con Taufic, nato in Honduras ma cresciuto in Brasile, l’italo-argentino Girotto e il siciliano Burgio che si affianca alla musicista fiorentina con in spalla il background di retaggi conoscenze e abilità, con intatto il proprio schietto versante jazz, ed un repertorio ricercato, vedansi “La Puerta” del messicano Luis Demetrio, “Candombe de la Azotea” e “La Maza” del grande Silvio Rodriguez. Non manca il “suo” Toninho Horta con “Viver de Amor” (cofirmata Bastos) e “Zamba de Carnaval” dell’argentino Cuchi Leguizamòn. Autori che configurano un orizzonte su cui la Casini impregna linee melodiche che tratteggiano il continente centrosudamericano senza cesura fra mpb e spanish tinge.
Gli Hermanos della cantante Barbara Casini, nell’album edito da Encore, sono il sassofonista Javier Girotto, il chitarrista Roberto Taufic e il pianista Seby Burgio. Fior di musicisti che partecipano all’esecuzione, oltre che con il proprio strumento, con interventi mirati come la quena di Girotto in “Hurry” dell’uruguagio Fattoruso e in “Tonada de Luna Llena” del venezuelano Simòn Diaz, la voce di Taufic in “Pasarero” di Carlos Aguirre, di Rosario, e in “Maria Landò” di Granda e Calvo in cui si sentono le claps di Burgio. Ma gli Hermanos di una Casini in gran spolvero di latin imbevuto da sempre nelle corde vocali li vediamo anche nella figura stratosferica del brasiliano Milton Nascimento che ha scritto “Milagre dos Peixes” con Fernando Brant e che il 4et interpreta mirabilmente in chiusura al disco. Una “squadra” di fuoriclasse con Taufic, nato in Honduras ma cresciuto in Brasile, l’italo-argentino Girotto e il siciliano Burgio che si affianca alla musicista fiorentina con in spalla il background di retaggi conoscenze e abilità, con intatto il proprio schietto versante jazz, ed un repertorio ricercato, vedansi “La Puerta” del messicano Luis Demetrio, “Candombe de la Azotea” e “La Maza” del grande Silvio Rodriguez. Non manca il “suo” Toninho Horta con “Viver de Amor” (cofirmata Bastos) e “Zamba de Carnaval” dell’argentino Cuchi Leguizamòn. Autori che configurano un orizzonte su cui la Casini impregna linee melodiche che tratteggiano il continente centrosudamericano senza cesura fra mpb e spanish tinge.
Juan Esteban Cuacci – Mariel Martinez y La Maquina del Tango, “Aca Lejos”, Caligola Records
 Che tango ci sarà dopo il … tango? La domanda è abbastanza scontata quando è riferita a generi musicali circoscritti che potrebbero avere espresso il meglio di sé e toccato il “picco” artistico con maestri come Piazzolla per il tango. Eppure, parlando sempre di tango, se lo si slega dal contesto storico in cui si è sviluppato e lo si vede come una sorta di archetipo, allora ci si renderà conto che sono tuttora possibili operazioni che non siano di mera facciata ma che abbiano un carattere rigenerante. Dalla rivoluzione del nuevo tango alla evoluzione del tango contemporaneo: prendiamo Aca Lejos, album del pianista Juan Esteban Cuacci e della vocalist Mariel Martinez y La Maquina del Tango prodotto in Italia da Caligola Records. Intanto il repertorio registra classici tangueri di Gardel, V. Esposito, Troilo, S. Piana etc. accanto a composizioni dello stesso Cuacci, motore della “macchina” che procede su binari (i tempi, ovviamente). A riprova della possibile convivenza e coesistenza del nuovo e delle rispettive radici. C’è poi la formazione con prevalenza femminile figurandovi la violista Silvina Alvarez e la contrabbassista Laura Asènsio Lopez unitamente al batterista Lauren Stradmann. Ancora, il climax. Pare molto più attenuato e dolce quel nostalgico “pensiero triste che si balla” grazie al canto della Martinez, virtualmente proiettato in avanti verso spazi sonori dischiusi, come un gaucho che scopre praterie prima sconosciute. Difficile, fra i tredici brani, stabilire un ordine di preferenze. E c’è dell’altro, sentiamo il lavoro vicino, “nostro” non solo per la radice di nomi che ricorrono – R. Calvo, L. Nebbia, A. Le Pera, J.M. Contursi – ma soprattutto per le forti tracce di melos sia pure corroborato da dna (poli)ritmico africano e da una persistente componente autoctona.
Che tango ci sarà dopo il … tango? La domanda è abbastanza scontata quando è riferita a generi musicali circoscritti che potrebbero avere espresso il meglio di sé e toccato il “picco” artistico con maestri come Piazzolla per il tango. Eppure, parlando sempre di tango, se lo si slega dal contesto storico in cui si è sviluppato e lo si vede come una sorta di archetipo, allora ci si renderà conto che sono tuttora possibili operazioni che non siano di mera facciata ma che abbiano un carattere rigenerante. Dalla rivoluzione del nuevo tango alla evoluzione del tango contemporaneo: prendiamo Aca Lejos, album del pianista Juan Esteban Cuacci e della vocalist Mariel Martinez y La Maquina del Tango prodotto in Italia da Caligola Records. Intanto il repertorio registra classici tangueri di Gardel, V. Esposito, Troilo, S. Piana etc. accanto a composizioni dello stesso Cuacci, motore della “macchina” che procede su binari (i tempi, ovviamente). A riprova della possibile convivenza e coesistenza del nuovo e delle rispettive radici. C’è poi la formazione con prevalenza femminile figurandovi la violista Silvina Alvarez e la contrabbassista Laura Asènsio Lopez unitamente al batterista Lauren Stradmann. Ancora, il climax. Pare molto più attenuato e dolce quel nostalgico “pensiero triste che si balla” grazie al canto della Martinez, virtualmente proiettato in avanti verso spazi sonori dischiusi, come un gaucho che scopre praterie prima sconosciute. Difficile, fra i tredici brani, stabilire un ordine di preferenze. E c’è dell’altro, sentiamo il lavoro vicino, “nostro” non solo per la radice di nomi che ricorrono – R. Calvo, L. Nebbia, A. Le Pera, J.M. Contursi – ma soprattutto per le forti tracce di melos sia pure corroborato da dna (poli)ritmico africano e da una persistente componente autoctona.
Amedeo Furfaro
da Gerlando Gatto | 02/Ago/2022 | Eventi, News, Primo piano
Dopo un periodo di relativa stasi per motivi facilmente individuabili, Roma è tornata ad essere attrattiva per gli passionati di jazz. Così da un canto l’Auditorium (con pochi ma eccellenti appuntamenti) dall’altro la Casa del Jazz con la sua consueta rassegna estiva, stanno fornendo ai cultori del jazz parecchi appuntamenti degni di rilievo, su alcuni dei quali mi soffermerò qui di seguito.
Il 10 luglio, alla Cavea dell’Auditorium, appuntamento con Gregory Porter. Sono oramai parecchi anni che conosco ad apprezzo questo vocalist e ancora una volta la sua performance ha corrisposto in pieno alle mie aspettative. La sua musicalità, il feeling che riesce a trasmettere agli ascoltatori, il suo senso del ritmo, il modo in cui riesce ad interpretare qualsiasi testo sono davvero straordinari. E non è certo un caso che la sua carriera artistica sia costellata da grandi successi e riconoscimenti tra cui due Grammy Awards per Miglior Album Vocale.

Per celebrare un decennio di successi, Gregory Porter ha pubblicato “Still Rising”, un doppio album contenente 34 tracce tra brani inediti, covers, duetti e una selezione speciale delle sue canzoni più amate. Ed è proprio sul repertorio di quest’ultimo doppio album che si è incentrata la performance romana. Ben coadiuvato da Hip Crawford al piano, Tivon Pennicott al sax tenore, Emanuel Harrold alla batteria, Jahmal Nichols al basso elettrico e Ondrej Pivec all’organo (gli stessi che l’hanno accompagnato nella già citata ultima fatica discografica) Porter ha dato ancora una volta un saggio di bravura proponendo una musica in cui era facile scorgere echi di soul, di gospel, di blues, financo di pop, mescolati in un unicum tanto originale quanto suggestivo. Ed è stato a tratti entusiasmante sentirlo duettare con alcuni dei suoi compagni di viaggio in un concerto tutto sommato breve ma di grande intensità.
Ascoltando Porter viene naturale un parallelo con i nostri giovani rampanti: beh, penso che ai vari San Giovanni, Albe, LDA, Ultimo e via discorrendo non farebbe male ascoltare qualche disco di chi sa cantare veramente bene. Ma questo è un tema che mi sollecita oramai da tempo e su cui prima o poi vorrò intervenire.
 Il 13, sempre alla Cavea, appuntamento con una vera e propria leggenda del jazz: Herbie Hancock. Spesso si adopera la parola “leggenda” in modo esagerato ma nel caso in questione non v’è dubbio alcuno che il termine sia più che appropriato. Non è questa la sede adatta per sintetizzare un curriculum assolutamente straordinario; basti solo dire che l’artista di Chicago, oggi ottantunenne, ha attraversato, sempre da protagonista, generi e mode come performer, compositore, arrangiatore, produttore, scopritore di talenti, inventore di nuove tendenze, senza mai perdere una coerenza di fondo. A Roma si è presentato alla testa di una band eccezionale completata da Terence Blanchard alla tromba, Lionel Loueke (chitarra), James Genus (basso) e Justin Tyson (batteria). Ascoltare un concerto di Hancock è come rivivere, in sintesi, buona parte della storia del jazz dal momento che questo artista ha sviluppato un’estetica giocata sempre su una sorta di doppio binario: da un canto virtuoso pianista del jazz acustico, dall’altro estimatore se non fondatore del funky elettronico. E questi due aspetti della sua personalità sono apparsi evidenti anche nel concerto romano; così in una prima parte abbiamo ascoltato alcuni classici del jazz come il sempre verde “Footprints” di Wayne Shorter, un altro giovanotto di 89 anni, omaggiato da Hancock che si alternava al piano e alle tastiere non disdegnando un ricorso mai esagerato al vocoder (ma che comunque se non ci fosse stato nulla avrebbe tolto alla validità del concerto). Nella seconda parte Hancock si richiamava al suo coté più funky e chiudeva il concerto con “Chameleon” brano tratto dal celebre album “Head Hunters” del 1973, scatenando l’entusiasmo del pubblico che si è accalcato a ballare sotto il palco.
Il 13, sempre alla Cavea, appuntamento con una vera e propria leggenda del jazz: Herbie Hancock. Spesso si adopera la parola “leggenda” in modo esagerato ma nel caso in questione non v’è dubbio alcuno che il termine sia più che appropriato. Non è questa la sede adatta per sintetizzare un curriculum assolutamente straordinario; basti solo dire che l’artista di Chicago, oggi ottantunenne, ha attraversato, sempre da protagonista, generi e mode come performer, compositore, arrangiatore, produttore, scopritore di talenti, inventore di nuove tendenze, senza mai perdere una coerenza di fondo. A Roma si è presentato alla testa di una band eccezionale completata da Terence Blanchard alla tromba, Lionel Loueke (chitarra), James Genus (basso) e Justin Tyson (batteria). Ascoltare un concerto di Hancock è come rivivere, in sintesi, buona parte della storia del jazz dal momento che questo artista ha sviluppato un’estetica giocata sempre su una sorta di doppio binario: da un canto virtuoso pianista del jazz acustico, dall’altro estimatore se non fondatore del funky elettronico. E questi due aspetti della sua personalità sono apparsi evidenti anche nel concerto romano; così in una prima parte abbiamo ascoltato alcuni classici del jazz come il sempre verde “Footprints” di Wayne Shorter, un altro giovanotto di 89 anni, omaggiato da Hancock che si alternava al piano e alle tastiere non disdegnando un ricorso mai esagerato al vocoder (ma che comunque se non ci fosse stato nulla avrebbe tolto alla validità del concerto). Nella seconda parte Hancock si richiamava al suo coté più funky e chiudeva il concerto con “Chameleon” brano tratto dal celebre album “Head Hunters” del 1973, scatenando l’entusiasmo del pubblico che si è accalcato a ballare sotto il palco.
E veniamo adesso ai concerti alla Casa del Jazz.
 Il 12 luglio una vecchia e cara conoscenza del pubblico romano: John Scofield. Il chitarrista può a ben ragione essere considerato una delle massime espressioni della chitarra jazz degli ultimi decenni. Musicista eclettico, voglioso sempre di sperimentare strade nuove, questa volta si è presentato con un progetto del tutto nuovo, “Yankee Go Home”, con cui torna alle radici del rock americano, riscoprendo classici fra il folk e il rock’n’roll. Accanto a lui Jon Cowherd (pianoforte e tastiere), Vicente Archer (contrabbasso)e Josh Dion (batteria). E’ lo stesso Scofield a illustrare il senso di questo nuovo progetto, non senza elogiare i suoi compagni di viaggio: “L’idea –afferma Scofield – è di coprire successi americani/rock e canzoni folk jazz, più alcuni dei miei brani originali scritti in quel modo. Mi sto riconnettendo con molte delle mie radici Rock ‘n Roll da adolescente, naturalmente colorate dai miei 50 anni di pratica Jazz…. Questi ragazzi sono straordinariamente versatili, altrettanto bravi quando si tratta di suonare in modo interattivo e creativo. Stiamo esplorando rock, funk, country, jazz e musica libera e ci divertiamo moltissimo. Sono entusiasta di questa collaborazione”. Risultato raggiunto? Assolutamente sì; il repertorio, comprendente brani tra gli altri di Bob Dylan, Neil Young, Grateful Dead, B.B. King, Buddy Holly, viene declinato attraverso quella maestria strumentale che ben conosciamo oramai da tanti anni. Scofield è sempre lì a tessere le fila del discorso, con un solismo preciso, elegante, raffinato mai soverchiante cosicché tutti i suoi compagni di viaggio hanno la possibilità di mettersi in luce. I vari pezzi vengono riletti alla luce di quelle esperienze cui lo stesso Scofield faceva riferimento ridando loro una sorta di nuova linfa e il pubblico dimostra di apprezzare con lunghi appalusi a scena aperta. Immancabile il bis: un coinvolgente blues che evidenzia come Scofield rimanga solidamente ancorato anche alle radici della musica afro-americana.
Il 12 luglio una vecchia e cara conoscenza del pubblico romano: John Scofield. Il chitarrista può a ben ragione essere considerato una delle massime espressioni della chitarra jazz degli ultimi decenni. Musicista eclettico, voglioso sempre di sperimentare strade nuove, questa volta si è presentato con un progetto del tutto nuovo, “Yankee Go Home”, con cui torna alle radici del rock americano, riscoprendo classici fra il folk e il rock’n’roll. Accanto a lui Jon Cowherd (pianoforte e tastiere), Vicente Archer (contrabbasso)e Josh Dion (batteria). E’ lo stesso Scofield a illustrare il senso di questo nuovo progetto, non senza elogiare i suoi compagni di viaggio: “L’idea –afferma Scofield – è di coprire successi americani/rock e canzoni folk jazz, più alcuni dei miei brani originali scritti in quel modo. Mi sto riconnettendo con molte delle mie radici Rock ‘n Roll da adolescente, naturalmente colorate dai miei 50 anni di pratica Jazz…. Questi ragazzi sono straordinariamente versatili, altrettanto bravi quando si tratta di suonare in modo interattivo e creativo. Stiamo esplorando rock, funk, country, jazz e musica libera e ci divertiamo moltissimo. Sono entusiasta di questa collaborazione”. Risultato raggiunto? Assolutamente sì; il repertorio, comprendente brani tra gli altri di Bob Dylan, Neil Young, Grateful Dead, B.B. King, Buddy Holly, viene declinato attraverso quella maestria strumentale che ben conosciamo oramai da tanti anni. Scofield è sempre lì a tessere le fila del discorso, con un solismo preciso, elegante, raffinato mai soverchiante cosicché tutti i suoi compagni di viaggio hanno la possibilità di mettersi in luce. I vari pezzi vengono riletti alla luce di quelle esperienze cui lo stesso Scofield faceva riferimento ridando loro una sorta di nuova linfa e il pubblico dimostra di apprezzare con lunghi appalusi a scena aperta. Immancabile il bis: un coinvolgente blues che evidenzia come Scofield rimanga solidamente ancorato anche alle radici della musica afro-americana.
Il 21 uno dei concerti inseriti nell’ambito della rassegna, tutta dedicata alle nuove tendenze e, dunque, alle più interessanti proposte di jazz contemporaneo. Un mondo affascinante, in cui si incontrano jazz, soul, funk, hip-hop, elettronica e spoken word.
In particolare giovedì 21 di scena il batterista Makaya McCraven produttore e batterista emergente, definito da Down Beat come uno dei più influenti musicisti del prossimo decennio.
In effetti Makaya McCraven, figlio di Stephen McCraven, batterista di Archie Shepp tra gli altri, è tutto questo e molto di più: americano di Parigi classe ‘83, iniziato alla musica jazz dal padre, cresciuto tra gli altri con la formazione derivante dal già citato Shepp, inizia a collaborare con artisti del calibro di Kris Delmhorst e gli Apollo Sunshine, prima di stabilire un suo complesso con il bassista Junius Paul, il chitarrista Matt Gold e il trombettista già attivo autonomamente Marquis Hill, formazione con cui si è presentato alla Casa del Jazz, per un concerto che ha soddisfatto appieno le più rosee aspettative.
 La band inizia a suonare senza presentare alcunché; McCraven è uomo di poche parole, e non si concede quasi mai pause, tranne una ogni tre pezzi circa per presentare e ringraziare la sua band e per annunciare – qualche volta – il nome del prossimo pezzo. Per il resto è stata una serata di pura musica ed energia: non solo di McCraven, il cui vigore era pari alla sua abilità – mai sentito un batterista che suonasse per circa un’ora e mezza, senza mai smettere di percuotere pelli e piatti con tanta ininterrotta energia – ma anche di tutti gli altri musicisti, che durante il concerto si cimentavano con diversi tipi di percussioni. Altra nota di merito va alla varietà di brani suonati: si passa da pezzi ormai diventati standard del jazz, come “Autumn in New York”, Frank’s Tune” di Frank Strzier o “A Slice of the Top” a pezzi originali di McCraven, come “In These Times”, “The Bounce!” e un inedito tratto dal suo prossimo album in uscita a settembre.
La band inizia a suonare senza presentare alcunché; McCraven è uomo di poche parole, e non si concede quasi mai pause, tranne una ogni tre pezzi circa per presentare e ringraziare la sua band e per annunciare – qualche volta – il nome del prossimo pezzo. Per il resto è stata una serata di pura musica ed energia: non solo di McCraven, il cui vigore era pari alla sua abilità – mai sentito un batterista che suonasse per circa un’ora e mezza, senza mai smettere di percuotere pelli e piatti con tanta ininterrotta energia – ma anche di tutti gli altri musicisti, che durante il concerto si cimentavano con diversi tipi di percussioni. Altra nota di merito va alla varietà di brani suonati: si passa da pezzi ormai diventati standard del jazz, come “Autumn in New York”, Frank’s Tune” di Frank Strzier o “A Slice of the Top” a pezzi originali di McCraven, come “In These Times”, “The Bounce!” e un inedito tratto dal suo prossimo album in uscita a settembre.
Riguardo alla performance dell’”archeologo del beat”, (come si definisce lo stesso batterista), essa nel suo complesso si basava su due punti di forza: la leadership di McCraven, che con grande forza e precisione trascinava sia i suoi musicisti sia il pubblico durante le esibizioni, nonché l’approccio inedito da DJ dello stesso McCraven specie nelle sue composizioni: infatti in gran parte dei brani veniva ripetuto un leitmotif al basso, che diventava il vero centro motore della situazione, attorno a cui venivano aggiunte gradualmente la batteria, la chitarra, la tromba e varie percussioni; in seguito si passava ad una graduale elaborazione dei motiv aggiunti alla linea di basso che, rimanendo sempre costante, forniva all’ascoltatore un filo rosso che legava le varie elaborazioni e improvvisazioni e un senso di familiarità all’interno della composizione. Quest’operazione coniuga a mio parere il processo creativo di numerose canzoni house, dance ed EDM con l’improvvisazione tipica del jazz: inoltre l’enfasi posta sulle percussioni nel concerto è caratteristica anche dei beat dei brani hip hop, dove il ritmo della base è cruciale per orientare il rapper durante il brano in questione.
 Il 23 la Casa de Jazz proponeva un quesito intrigante: può la sofisticata poetica di un Pieranunzi coniugarsi con l’incredibile carica energetica di Antonello Salis? In altri termini possono coesistere due musicisti stilisticamente quasi all’opposto, uniti solo dalla grande passione e dedizione alla musica? Ciò perché il concerto in programma prevedeva per l’appunto un duo di piano composto da questi due artisti che mai avevano avuto modo di incontrarsi sul palco. Grande attesa, quindi, e non a caso grande affluenza di pubblico…ripagato da un concerto sicuramente interessante. Seduti l’uno di fronte all’altro i due hanno suonato per circa un’ora e mezza sciorinando un’intesa che non era facile prevedere. Spesso si partiva da un tema che veniva sviluppato, esaminato, sviscerato fin nelle sue più intime pieghe e quindi riproposto in una veste totalmente diversa che traeva nelle capacità improvvisative dei due nuova linfa vitale. E questa volta non si può dire che l’uno si sia piegato alle esigenze dell’altro in quanto ambedue hanno sviluppato appieno le proprie tematiche che finivano con l’incontrarsi su un terreno ben frequentato sia da Enrico sia da Antonello: l’improvvisazione pura o forse meglio la capacità di creare musica strada facendo. In effetti, oltre che partire da un dato tema, i due si sono spesso avventurati anche sul foglio bianco, vale a dire cominciando a suonare senza conoscere il punto di approdo, con una maestria che solo pochi posseggono.
Il 23 la Casa de Jazz proponeva un quesito intrigante: può la sofisticata poetica di un Pieranunzi coniugarsi con l’incredibile carica energetica di Antonello Salis? In altri termini possono coesistere due musicisti stilisticamente quasi all’opposto, uniti solo dalla grande passione e dedizione alla musica? Ciò perché il concerto in programma prevedeva per l’appunto un duo di piano composto da questi due artisti che mai avevano avuto modo di incontrarsi sul palco. Grande attesa, quindi, e non a caso grande affluenza di pubblico…ripagato da un concerto sicuramente interessante. Seduti l’uno di fronte all’altro i due hanno suonato per circa un’ora e mezza sciorinando un’intesa che non era facile prevedere. Spesso si partiva da un tema che veniva sviluppato, esaminato, sviscerato fin nelle sue più intime pieghe e quindi riproposto in una veste totalmente diversa che traeva nelle capacità improvvisative dei due nuova linfa vitale. E questa volta non si può dire che l’uno si sia piegato alle esigenze dell’altro in quanto ambedue hanno sviluppato appieno le proprie tematiche che finivano con l’incontrarsi su un terreno ben frequentato sia da Enrico sia da Antonello: l’improvvisazione pura o forse meglio la capacità di creare musica strada facendo. In effetti, oltre che partire da un dato tema, i due si sono spesso avventurati anche sul foglio bianco, vale a dire cominciando a suonare senza conoscere il punto di approdo, con una maestria che solo pochi posseggono.
Ed è stato lo stesso Pieranunzi a svelare come la musica eseguita sia stata tutta improvvisata. Tra i brani eseguiti, da ricordare una sempre suggestiva “Moon River” di Henry Mancini, una “Well, you needn’t” di Thelonious Monk che nulla ha perso dell’originario fascino, una memorabile versione di “Naima” di John Coltrane, nonché un sentito omaggio ad Ennio Morricone con “Il clan dei siciliani”.
E a conferma della splendida atmosfera che si respirava sul palco, Pieranunzi è apparso particolarmente in forma anche quando ha intrattenuto il pubblico con sagaci commenti sulla “strumentazione” di Antonello (tra cui una latta di tonno Callipo) e con un sentito ricordo della sua esperienza a fianco di Morricone.
Ed eccoci alla serata di lunedì 25. Mi reco alla Casa del Jazz al solito orario e noto immediatamente una sorta di novità: una fila interminabile di auto parcheggiate sul marciapiedi a indicare una straordinaria affluenza di pubblico. Cosa che verifico subito: i giardini della Casa del Jazz sono letteralmente invasi da una massa di giovani festanti in attesa dell’evento: il concerto di “Sons of Kemet”.
La band inglese è giunta a Roma preceduta da una formidabile campagna di stampa che la indicava come una delle massime espressioni del cosiddetto nu jazz; a richiamare il pubblico anche la considerazione che si trattava dell’ultima tournée del gruppo che nei prossimi mesi dovrebbe sciogliersi. Insomma tutto pronto per un grande successo di pubblico… che puntualmente è arrivato.
 Guidati dal funambolico sassofonista Shabaka Hutchings, il quartetto (completato dal basso tuba di Theon Cross e ben due batterie nelle mani di Eddie Hick e della giovanissima e bravissima Jas Keyser in sostituzione di Tom Skinner in tour con Thom Yorke) ha sciorinato una musica di grande intensità, basata sul fitto tappeto ritmico intessuto dalle due batterie su cui svolgevano i loro interventi i due fiati. In particolare il sax del leader, spesso effettato con delay o reverberi, non disegnava lunghe linee melodiche ma intonava frasi ritmiche e frammenti melodici ripetuti più volte mentre il basso tuba contribuiva in maniera determinante a completare il tessuto ritmico delle due batterie. Il tutto ‘condito’ da un volume molto, molto elevato a creare una musica che raggiungesse l’obiettivo di portare al massimo l’eccitazione dell’uditorio e di coinvolgerlo in una sorta di rito collettivo in cui i richiami all’Africa erano ben evidenti. Si tenga presente che il concerto si è sviluppato su una linea di continuità ininterrotta tranne due momenti in cui Shabaka Hutchings ha imbracciato un flauto di legno per intonare una splendida melodia di origine africana e il tubista si è espresso in solitudine. Obiettivo raggiunto? Quanto al coinvolgimento direi proprio di sì… anche se non al cento per cento. Nel senso che, ad esempio, il vostro cronista non si è sentito coinvolto dalla musica dei Sons of Kemet. Ed il perché non è difficile da spiegare: avendo avuto la fortuna di ascoltare anche dal vivo alcuni dei più grandi musicisti – per intenderci quelli che hanno scritto davvero la storia del jazz – non è facile lasciarsi impressionare da qualcuno che pur suonando bene non raggiunge quei vertici cui prima si faceva riferimento. Quanto ai messaggi che questa musica così aggressiva intende veicolare, ci viene in soccorso lo stesso Shabaka Hutchings affermando che “Black to the Future (ultimo album del gruppo) è un poema sonoro di invocazione del potere, del ricordo e della guarigione. Raffigura un movimento, quello della ridefinizione e riaffermazione di cosa significa lottare per il black power”. Ma anche sotto questo aspetto non riusciamo a vedere una grande novità dal momento che il jazz come musica di protesta non è certo cosa di oggi.
Guidati dal funambolico sassofonista Shabaka Hutchings, il quartetto (completato dal basso tuba di Theon Cross e ben due batterie nelle mani di Eddie Hick e della giovanissima e bravissima Jas Keyser in sostituzione di Tom Skinner in tour con Thom Yorke) ha sciorinato una musica di grande intensità, basata sul fitto tappeto ritmico intessuto dalle due batterie su cui svolgevano i loro interventi i due fiati. In particolare il sax del leader, spesso effettato con delay o reverberi, non disegnava lunghe linee melodiche ma intonava frasi ritmiche e frammenti melodici ripetuti più volte mentre il basso tuba contribuiva in maniera determinante a completare il tessuto ritmico delle due batterie. Il tutto ‘condito’ da un volume molto, molto elevato a creare una musica che raggiungesse l’obiettivo di portare al massimo l’eccitazione dell’uditorio e di coinvolgerlo in una sorta di rito collettivo in cui i richiami all’Africa erano ben evidenti. Si tenga presente che il concerto si è sviluppato su una linea di continuità ininterrotta tranne due momenti in cui Shabaka Hutchings ha imbracciato un flauto di legno per intonare una splendida melodia di origine africana e il tubista si è espresso in solitudine. Obiettivo raggiunto? Quanto al coinvolgimento direi proprio di sì… anche se non al cento per cento. Nel senso che, ad esempio, il vostro cronista non si è sentito coinvolto dalla musica dei Sons of Kemet. Ed il perché non è difficile da spiegare: avendo avuto la fortuna di ascoltare anche dal vivo alcuni dei più grandi musicisti – per intenderci quelli che hanno scritto davvero la storia del jazz – non è facile lasciarsi impressionare da qualcuno che pur suonando bene non raggiunge quei vertici cui prima si faceva riferimento. Quanto ai messaggi che questa musica così aggressiva intende veicolare, ci viene in soccorso lo stesso Shabaka Hutchings affermando che “Black to the Future (ultimo album del gruppo) è un poema sonoro di invocazione del potere, del ricordo e della guarigione. Raffigura un movimento, quello della ridefinizione e riaffermazione di cosa significa lottare per il black power”. Ma anche sotto questo aspetto non riusciamo a vedere una grande novità dal momento che il jazz come musica di protesta non è certo cosa di oggi.
Quindi ben vengano gruppi del genere ma se mi si dice che questa è la nuova strada che il jazz si avvia a percorrere devo confessare che il jazz dei prossimi anni non mi avrà tra i suoi massimi sostenitori. Ovviamente la cosa poco importerà ai più ma a mio avviso il ruolo di un cronista-critico non è quello di affermare sempre che tutto va bene, ma anche di esprimere qualche perplessità, sempre motivandole, è ovvio.
 Smaltita la sbornia dell’“Afrofuturism” (così viene definita la musica di Sons of Kemet da chi se ne intende), ecco il 27 sempre alla Casa del Jazz, la giovane e brava sassofonista Nubya Garcia, reduce dallo straordinario successo ottenuto dal suo primo album “Source” su etichetta Concord. Bel concerto questo con una musica sì proiettata verso il futuro ma sempre memore di ciò che il jazz ha rappresentato fino ad oggi. Anche la Garcia viene fuori dalla tumultuosa scena londinese di questi ultimi anni affermandosi passo dopo passo come una delle strumentiste più preparate e fantasiose del pur vasto panorama. In effetti Nubya frequenta il sax da tanti anni riuscendo così a raggiungere una tecnica tutt’altro che banale, una tecnica comunque sempre messa al servizio dell’espressività e di una concezione musicale fortemente inclusiva dal momento che nelle sue performances sono ben riscontrabili echi di jazz spirituale, dub, reggae, ritmi latini e suoni africani. Così il concerto si è sviluppato lungo modalità contrassegnate da notevoli assolo non solo della leader ma anche del pianista-tastierista Alastair MacSween mentre la sezione ritmica (Daniel Casimir contrabbasso e Sam Jones batteria) forniva un supporto sempre preciso, puntuale, propositivo. E a proposito di ritmo, da sottolineare la sensualità dei ritmi colombiani rinverdita dalla Nubya nella riproposizione di uno dei brani più riusciti dell’intera serata, “La Cumbia Me Está Llamando”, scritta con il trio colombiano al femminile “La Perla”.
Smaltita la sbornia dell’“Afrofuturism” (così viene definita la musica di Sons of Kemet da chi se ne intende), ecco il 27 sempre alla Casa del Jazz, la giovane e brava sassofonista Nubya Garcia, reduce dallo straordinario successo ottenuto dal suo primo album “Source” su etichetta Concord. Bel concerto questo con una musica sì proiettata verso il futuro ma sempre memore di ciò che il jazz ha rappresentato fino ad oggi. Anche la Garcia viene fuori dalla tumultuosa scena londinese di questi ultimi anni affermandosi passo dopo passo come una delle strumentiste più preparate e fantasiose del pur vasto panorama. In effetti Nubya frequenta il sax da tanti anni riuscendo così a raggiungere una tecnica tutt’altro che banale, una tecnica comunque sempre messa al servizio dell’espressività e di una concezione musicale fortemente inclusiva dal momento che nelle sue performances sono ben riscontrabili echi di jazz spirituale, dub, reggae, ritmi latini e suoni africani. Così il concerto si è sviluppato lungo modalità contrassegnate da notevoli assolo non solo della leader ma anche del pianista-tastierista Alastair MacSween mentre la sezione ritmica (Daniel Casimir contrabbasso e Sam Jones batteria) forniva un supporto sempre preciso, puntuale, propositivo. E a proposito di ritmo, da sottolineare la sensualità dei ritmi colombiani rinverdita dalla Nubya nella riproposizione di uno dei brani più riusciti dell’intera serata, “La Cumbia Me Está Llamando”, scritta con il trio colombiano al femminile “La Perla”.
Gerlando & Beny Gatto
da Valerio Marchi | 09/Lug/2022 | Interviste, News, Primo piano
Lo scorso 23 giugno, alla rassegna “Borghi Swing” by Udin&Jazz, organizzata da Euritmica e Comune di Marano Lagunare, in provincia di Udine, Enrico Rava avrebbe dovuto esibirsi con la sua tromba e il suo flicorno assieme a Francesco Diodati (chitarra), Gabriele Evangelista (contrabbasso) ed Enrico Morello (batteria). Purtroppo, per cause di forza maggiore (un’indisposizione dell’artista), il concerto è stato annullato. Crediamo comunque di far cosa gradita pubblicando l’intervista che Rava ci ha concesso qualche giorno prima, augurandoci di cuore di poterlo rivedere presto in Friuli Venezia Giulia. (Valerio Marchi)
-Maestro, che rapporto ha con il Friuli?
«Bellissimo! A parte il fatto che mia moglie ha origini di Sacile, sono amico di musicisti friulani straordinari: da U.T. Gandhi a Francesco Bearzatti, ma anche Mirko Cisilino – che reputo il trombettista italiano più interessante, e che fra l’altro non è solo trombettista – e poi Giovanni Maier… Non solo, ma in Friuli nacque uno dei gruppi che più ho amato e che è durato di più: gli Electric Five, di cui fecero parte anche Gandhi, che ne era la colonna portante, e Maier. Poi ho altri cari amici, ad esempio Checco Altan ad Aquileia, e mi piacciono infinitamente la natura e il cibo».
–Trova florido il panorama jazzistico del nostro territorio?
«Sì, ma sia per questa che per altre regioni italiane che hanno un’attività molto viva, avviene spesso che ciò che si sviluppa da una parte – mi riferisco sempre al jazz – rimane più o meno lì. Anche in Calabria, in Sardegna o in Sicilia, ad esempio, ci sono eventi notevoli e musicisti giovani e fantastici che meriterebbero una fama ben più larga. Si può avere un successo strepitoso a Udine o a Palermo, per capirci, ma poi…»
-

-
Enrico Rava/Udin&Jazz Winter ph Luca A. d’Agostino©
-

-
Enrico Rava/Udin&Jazz Winter ph Luca A. d’Agostino©
-

-
Enrico Rava/Udin&Jazz Winter ph Luca A. d’Agostino©
-

-
Enrico Rava/Udin&Jazz Winter ph Luca A. d’Agostino©
-E lei come si spiega questo fenomeno?
«Non so, forse abbiamo ancora un retaggio dell’Italia dei Comuni, molte cose fanno molta fatica a varcare i confini. Gli unici luoghi che fanno più notizia a livello nazionale sono Milano e Roma, ma ciononostante nel nostro Paese manca, di fatto, un vero e proprio centro: come, ad esempio, Parigi per la Francia, Londra per l’Inghilterra o New York per gli USA, dove tutto ciò che avviene in quegli Stati in qualche modo si convoglia lì: vai lì e prima o poi conosci tutti».
-La sua fortuna infatti fu proprio quella di vivere a New York da giovane.
«Assolutamente sì. I dieci anni trascorsi a New York, a partire dai miei 24 anni in poi, sono stati fondamentali».
-Il Seminario che lei tiene da tanti anni a Siena sopperisce in qualche misura all’inconveniente tutto italiano di cui abbiamo appena parlato?
«È almeno l’occasione per conoscere musicisti strepitosi che altrimenti, forse, non conoscerei mai, a meno di non fare un continuo “Grand Tour” per l’Italia… e infatti quasi tutti i miei gruppi sono nati dall’esperienza di Siena. Tornando ai musicisti friulani, lo stesso Giovanni Maier lo conobbi lì; fu lui a farmi conoscere U.T. Gandhi e poi nacquero gli Electric Five».
-Il Friuli, e più in generale il Friuli Venezia Giulia e l’Italia, potrebbero avere dunque un maggior numero di celebrità internazionali?
«Abbiamo qualche jazzista italiano “iconico”, fra cui il sottoscritto, ma per tanti altri musicisti, giovani e meno giovani, in Friuli come altrove, è difficilissimo agguantare quello spazio che meriterebbero; così, da un certo punto di vista, essi rimangono sempre “promesse per il futuro” pur essendo realtà ben concrete e di qualità. Per non parlare delle formidabili musiciste!».
-In effetti il largo pubblico, al di là di nomi di primissimo piano come quelli di Rita Marcotulli o Stefania Tallini, non conosce molto del versante femminile.
«Già, ma emergono ragazze – Anaïs Drago, Evita Polidoro, Francesca Remigi, Sophia Tomelleri, solo per citarne alcune – che suonano benissimo, sono davvero eccezionali e ottengono anche riconoscimenti importanti. Ma di loro finalmente si inizia a parlare, e con la novità che portano si smuovono le acque e i media, il che ci aiuta a non cadere nella routine».
-E per lei la routine, a quasi 83 anni, rimane la principale nemica: giusto?
«Certo! La mia fortuna è di non essermi mai adagiato. Ho sempre bisogno di sorprese, da parte chi suona con me e da me stesso: per questo occorre che i componenti del mio gruppo abbiano una visione della musica vicino alla mia e la capacità di ascoltare, di comunicare quasi telepaticamente con una visione comune, con piena fiducia reciproca: quando tutto funziona bene, ognuno dà e riceve ciò di cui c’è bisogno per la creazione musicale. Senza rinunciare al proprio ego, ma senza prevaricare.
-Molte cose impreviste possono accadere, dunque, durante un concerto?
«Sì, la mia musica è molto libera. Io do una cornice, un canovaccio all’interno del quale ognuno è veramente libero, e quando c’è quella piena fiducia reciproca di cui parlavo tutto può svilupparsi al meglio, prendendo anche strade impensate. Non faccio mai una scaletta. Decido un primo pezzo, decido da dove si parte, poi dove vada a finire il concerto non lo so, perché dipende da tanti fattori: il suono, l’amplificazione, l’acustica, il pubblico, come stiamo noi, e così via…».
-Sembra facile… anzi no.
«Infatti non è facile. Ma per me non c’è nulla di peggio che sentire suonare un gruppo, anche di altissimo livello, che si limiti però ad una esibizione in cui ciascuno fa vedere la propria abilità senza costruire veramente assieme, senza quel legame perfetto che nasce dal collegamento diretto fra il nostro universo spirituale e l’equilibrio universale, fra la nostra armonia interiore e quella dell’universo. È una cosa difficile da spiegare, forse può far ridere qualcuno, ma è così. La musica non è matematica, è magia: ed è per questo che, nonostante l’età, continuo a suonare invece che dar da mangiare agli uccellini al parco».
-Una magia che il Covid ha alquanto limitato… Lei come ha vissuto il lungo periodo di pandemia?
«Il primo periodo bene: ho letto tantissimo – amo molto leggere – e ho riposato, mi sono esercitato, ho studiato lo strumento… (chi volesse approfondire può cliccare qui per leggere l’intervista di Gerlando Gatto a Rava, contenuta nel libro “Il Jazz Italiano in Epoca Covid” n.d.r.). Poi durante l’estate ho suonato di nuovo parecchio dal vivo, sinché è cominciato il secondo periodo di pandemia che, anche a causa di alcuni acciacchi, ho vissuto molto peggio: come diceva Moravia, il problema dell’età non esiste, il vero problema sono le malattie dell’età… Anche di recente, per un serio problema di salute, ho dovuto rimanere tre mesi senza poter suonare; poi, dopo la convalescenza, mi sono esercitato un paio di settimane e la prima cosa che ho fatto è stata quella di registrare un CD – peraltro venuto benissimo – con il grande pianista americano Fred Hersch».
-E questo CD quando uscirà?
«A settembre».
-Diceva del suo amore per la lettura; ma lo stesso vale anche per l’ascolto della musica, di tutta la musica e non solo il jazz, giusto?
«Certo. Apprezzo moltissimo, ad esempio, i Rolling Stones, oppure i Queen, per non parlare dei Beatles… ma potrei continuare. Tutti geniali, incredibili. E questo vale anche per altri generi di musica e di interpreti».
Ci dispiace un po’ per gli uccellini al parco, ma speriamo proprio che debbano aspettare ancora a lungo…
Valerio Marchi
da Gerlando Gatto | 31/Mag/2022 | I nostri libri, Primo piano, Recensioni

Ted Gioia – “Storia del Jazz” – EDT – pgg. 614 – € 35,00
 Non molto tempo fa discutevo con un amico musicista (ma anche scrittore e più in generale attento osservatore della realtà) se nell’attuale situazione fosse o meno giustificata la pubblicazione di una nuova storia del jazz. Trovare un punto di intesa non è stato difficile: certo oramai molto si è scritto sulla storia della musica afro-americana ma molto resta ancora da scrivere, da scoprire, da chiarire. In buona sostanza una storia del jazz oggi si giustifica se risponde ad alcuni ben precisi requisiti: innanzitutto che sul passato ci dica qualcosa di nuovo rispetto a quanto finora scritto, sul presente che ci illumini su quanto sta accadendo sulla scena internazionale, sul futuro che vengano lumeggiate le nuove linee di tendenza. Il tutto accompagnato da una fluidità di racconto che eviti il più possibile incorniciati e box che finiscono con il distrarre e far perdere il filo del discorso.
Non molto tempo fa discutevo con un amico musicista (ma anche scrittore e più in generale attento osservatore della realtà) se nell’attuale situazione fosse o meno giustificata la pubblicazione di una nuova storia del jazz. Trovare un punto di intesa non è stato difficile: certo oramai molto si è scritto sulla storia della musica afro-americana ma molto resta ancora da scrivere, da scoprire, da chiarire. In buona sostanza una storia del jazz oggi si giustifica se risponde ad alcuni ben precisi requisiti: innanzitutto che sul passato ci dica qualcosa di nuovo rispetto a quanto finora scritto, sul presente che ci illumini su quanto sta accadendo sulla scena internazionale, sul futuro che vengano lumeggiate le nuove linee di tendenza. Il tutto accompagnato da una fluidità di racconto che eviti il più possibile incorniciati e box che finiscono con il distrarre e far perdere il filo del discorso.
Ebbene questi requisiti sono tutti presenti nella nuova edizione della “Storia del Jazz” di Ted Gioia pubblicata dalla EDT in collaborazione con Fondazione Siena Jazz – Accademia nazionale del jazz Centro di attività e formazione musicale, che si avvale della precisa traduzione di Francesco Martinelli il quale, com’è suo costume, scrive in maniera fluida, scattante, priva di qualsiasi autocompiacimento letterario sicché lo spirito dell’autore viene pienamente rispettato.
Il volume è diviso in undici capitoli (da “La preistoria del jazz” a “La resurrezione del jazz”) con l’aggiunta di quattro Note dedicate rispettivamente a “Letture consigliate”, “Ascolti consigliati”, “Ringraziamenti” e il sempre indispensabile “Indice analitico”. Da questa partizione si capisce come l’Autore parta dalle origini della musica afro-americana per giungere sino ai nostri giorni. Così, nella narrazione di Gioia, ritroviamo tutte le figure più importanti del jazz – da Jelly Roll Morton a Louis Armstrong, da Duke Ellington al Cotton Club, ai giganti del cool come Gerry Mulligan, Stan Getz, e Lester Young, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Ornette Coleman…fino ai postmodernisti della scena downtown – inseriti in una cornice politica e socio-economica che costituisce uno dei punti di forza delle opere di Gioia. In effetti la musica non nasce spontaneamente come una sorta di fungo ma è il portato di tutta una serie di esperienze: di qui fondamentale comprendere il contesto in cui un certo linguaggio nasce e si sviluppa. E Gioia è davvero un maestro nel descrivere tutto ciò, nel farci capire – ad esempio – che cosa significò per i musicisti di colore negli States rivolgersi al be-bop mentre la seconda guerra mondiale volgeva al termine.
Ma è nella seconda parte del libro che a nostro avviso troviamo le notazioni più interessanti. Sono le pagine in cui l’Autore esamina “La resurrezione del jazz” partendo dalla “Resurrezione del cantante di jazz”.
Convincente la tesi sostenuta da Gioia per cui, in questi ultimissimi decenni, il jazz ha riscoperto in qualche modo le sue radici di musica del popolo avviando un dialogo nuovo e non programmato con la cultura di massa. E il ponte che ha permesso tutto ciò è stato varato da artisti quali Kamasi Washington, Robert Glasper, Esperanza Spalding i quali – sono parole di Gioia – “hanno dimostrato che possono utilizzare tutta la gamma stilistica delle canzoni odierne senza perdere le proprie radici jazzistiche”. Una visione, come si nota, assolutamente rivoluzionaria che rende finalmente obsoleto il dibattito circa la presunta “morte del jazz”. In tale quadro anche i cantanti hanno svolto un ruolo di primissimo piano tenendo strettamente collegato il jazz alla musica commerciale. Quasi inutile sottolineare come accanto alle notazioni di carattere sociale, Gioia mai dimentica di indicare le registrazioni che meglio possono corroborare il suo discorso.
Di grande utilità pratica le letture consigliate e gli ascolti consigliati che possono costituire una guida sia per chi voglia approfondire la materia sia per chi ad essa si avvicini per la prima volta
Insomma un volume che non può mancare nella libreria di chi ama la musica.
Amedeo Furfaro, Lionello Pogliani – “Musiche in mente” – The Writer – pgg. 127 – € 12,00
 Scritto a due mani dal nostro collaboratore Amedeo Furfaro e da Lionello Pogliani, rispettivamente giornalista e critico musicale il primo, e collaboratore scientifico dell’Università di Valencia, il secondo, il volume affronta il problema del linguaggio musicale sotto il profilo sia delle cosiddette scienze sociali e umane sia delle scienze strettamente intese. Di qui una lettura interessante in quanto si intersecano due tipi di logica in un momento in cui, viceversa, si tende a parcellizzare ogni discorso e quindi a esaltare il ruolo della specializzazione sempre e comunque. In buona sostanza obiettivo del lavoro, perfettamente centrato, è mettere in campo una concezione organica della musica che viene ricondotta in un unico arco culturale combinando idee che in genere non sono messe in correlazione fra di loro. In particolare, nella prima parte Pogliani, avvalendosi anche della collaborazione di Michel Villaz e Laurent Vercueil, si muove tra fisica, chimica, astronomia, biologia, acustica, medicina, mentre nella seconda parte Furfaro, partendo dalla sua formazione storico-politologica e antroposociale oltre che musicale, illustra le sue idee traendo ispirazione dalle occasioni più disparate come una lettura, una serata al cinema, una foto, una ricorrenza, un’intervista tutte su filo del discorso musicale.
Scritto a due mani dal nostro collaboratore Amedeo Furfaro e da Lionello Pogliani, rispettivamente giornalista e critico musicale il primo, e collaboratore scientifico dell’Università di Valencia, il secondo, il volume affronta il problema del linguaggio musicale sotto il profilo sia delle cosiddette scienze sociali e umane sia delle scienze strettamente intese. Di qui una lettura interessante in quanto si intersecano due tipi di logica in un momento in cui, viceversa, si tende a parcellizzare ogni discorso e quindi a esaltare il ruolo della specializzazione sempre e comunque. In buona sostanza obiettivo del lavoro, perfettamente centrato, è mettere in campo una concezione organica della musica che viene ricondotta in un unico arco culturale combinando idee che in genere non sono messe in correlazione fra di loro. In particolare, nella prima parte Pogliani, avvalendosi anche della collaborazione di Michel Villaz e Laurent Vercueil, si muove tra fisica, chimica, astronomia, biologia, acustica, medicina, mentre nella seconda parte Furfaro, partendo dalla sua formazione storico-politologica e antroposociale oltre che musicale, illustra le sue idee traendo ispirazione dalle occasioni più disparate come una lettura, una serata al cinema, una foto, una ricorrenza, un’intervista tutte su filo del discorso musicale.
In conclusione un volume che vuole essere uno stimolo ad una riflessione complessiva su come lo sviluppo dell’arte musicale abbia interessato ed investito tutto l’arco dello scibile umano.
Amedeo Furfaro – “Pasolini – Luoghi, incontri, suoni” – The Writer – pgg. 103 – € 12,00
 In questo ulteriore volume, pubblicato nei primi mesi di quest’anno, Furfaro raccoglie i suoi scritti dedicati a Pasolini e riguardanti essenzialmente tre aspetti, luoghi, incontri e suoni. Di particolare importanza, per quanto concerne “A proposito di jazz”, la terza tranche in cui si tenta una panoramica del rapporto di Pasolini con la musica. L’Autore esamina quindi i vari aspetti delle relazioni di Pasolini con la musica partendo dalle colonne sonore dei suoi film per passare ad una discografia essenziale (jazz escluso) che copre gli anni dal 1960 al 1975 in cui sono elencati brani che vedono Pasolini nella veste di paroliere. Negli anni ’80 si collocano alcuni lavori discografici che hanno il merito di ripercorrere tappe importanti dell’excursus creativo pasoliniano, come “La musica nel cinema di Pasolini” (General Music 1984) in cui Morricone riassume le sue musiche per cinque pellicole firmate Pasolini. Interessante anche un altro lavoro, sempre dell’84, “Pour Pier Paolo, Poèmes de Pier Paolo Pasolini mis en musique par Giovanna Marini (Le Chant du monde). Negli anni seguenti Pasolini continua ad ispirare molte pagine musicali, dagli omaggi espliciti di cantanti e gruppi come Pino Marino, Massimiliano Larocca, Radio Dervish fino a compositori come Nicola Piovani e a registi come Nanni Moretti.
In questo ulteriore volume, pubblicato nei primi mesi di quest’anno, Furfaro raccoglie i suoi scritti dedicati a Pasolini e riguardanti essenzialmente tre aspetti, luoghi, incontri e suoni. Di particolare importanza, per quanto concerne “A proposito di jazz”, la terza tranche in cui si tenta una panoramica del rapporto di Pasolini con la musica. L’Autore esamina quindi i vari aspetti delle relazioni di Pasolini con la musica partendo dalle colonne sonore dei suoi film per passare ad una discografia essenziale (jazz escluso) che copre gli anni dal 1960 al 1975 in cui sono elencati brani che vedono Pasolini nella veste di paroliere. Negli anni ’80 si collocano alcuni lavori discografici che hanno il merito di ripercorrere tappe importanti dell’excursus creativo pasoliniano, come “La musica nel cinema di Pasolini” (General Music 1984) in cui Morricone riassume le sue musiche per cinque pellicole firmate Pasolini. Interessante anche un altro lavoro, sempre dell’84, “Pour Pier Paolo, Poèmes de Pier Paolo Pasolini mis en musique par Giovanna Marini (Le Chant du monde). Negli anni seguenti Pasolini continua ad ispirare molte pagine musicali, dagli omaggi espliciti di cantanti e gruppi come Pino Marino, Massimiliano Larocca, Radio Dervish fino a compositori come Nicola Piovani e a registi come Nanni Moretti.
Ovviamente anche il mondo del jazz ha omaggiato Pasolini; Furfaro ricorda al riguardo la performance del Roberto Gatto in “Accattone” e la “Suite per Pierpaolo” a cura di Glauco Venier con Alba Nacicovitch. Ma è in “Appunti per un’Orestiade Africana” che la relazione fra Pasolini e il jazz trova il suo baricentro; ciò in ragione del fatto che buona parte della colonna sonora è affidata a jazzisti quali Gato Barbieri, Marcello Melis e Famoudou Don Moye. A seguire una discografia in cui il jazz “latu sensu” tiene a sottolineare Amedeo, compare a fianco della figura di Pasolini.
Guido Michelone – “Il jazz e i mondi” – Arcana – pgg. 390 – € 24,00
 Davvero infaticabile Guido Michelone, didatta, studioso, giornalista e scrittore tra i più prolifici che il mondo del jazz italiano conosca. Ecco, quindi, una sua nuova fatica editoriale significativamente intitolata “Il jazz e i mondi”. Un titolo che può esplicativo non potrebbe essere. Nelle circa 400 pagine del volume, l’Autore, grazie ai numerosi viaggi compiuti tra Usa, Brasile, Giappone, Canada, Nord Africa e Medioriente, ci racconta, in maniera chiara ed esplicita com’è suo costume, il come e perché il jazz ha trovato diritto di cittadinanza in tutti questi Paesi
Davvero infaticabile Guido Michelone, didatta, studioso, giornalista e scrittore tra i più prolifici che il mondo del jazz italiano conosca. Ecco, quindi, una sua nuova fatica editoriale significativamente intitolata “Il jazz e i mondi”. Un titolo che può esplicativo non potrebbe essere. Nelle circa 400 pagine del volume, l’Autore, grazie ai numerosi viaggi compiuti tra Usa, Brasile, Giappone, Canada, Nord Africa e Medioriente, ci racconta, in maniera chiara ed esplicita com’è suo costume, il come e perché il jazz ha trovato diritto di cittadinanza in tutti questi Paesi
Si tratta di una narrazione a tratti affascinante in quanto si capisce finalmente come il jazz abbia potuto perdere le sue caratteristiche originarie per assumere le connotazioni di una musica universale senza più confini ma specchio della civiltà di ogni singolo Paese, come risultato necessario di quella contaminazione tra le diverse culture di ogni angolo del mondo. Di qui una sorta di viaggio straordinario, suddiviso in 29 capitoli dedicati ognuno ad una parte del mondo, elencate in ordine alfabetico, per cui si parte dall’Afghanistan per chiudere con “Zingari in jazz” dedicato alla musica manouche. Nel libro, accanto a nome e cognome di ogni jazzman, viene indicato lo strumento musicale mentre alla fine di ogni capitolo è riportata tra parentesi la data, grosso modo compresa tra il 2001 e il 2022, ad indicare il periodo in cui viene redatto il resoconto musicale del viaggio compiuto nella nazione indicata.
Ogni capitolo è impreziosito da una accurata discografia mentre il volume nel suo insieme è completato da una sempre utile bibliografia. Purtroppo manca quell’indice analitico che in un volume del genere sarebbe risultato particolarmente importante.
Renzo Ruggeri – “Elementi di Musica Jazz: CORSO BASE per fisarmonica” – Voglia d’Arte Production – pgg.165 – € 25,00
 “Questo lavoro di Ruggieri – condotto con serietà e competenza – è un avvenimento per la fisarmonica.” Gianni Coscia
“Questo lavoro di Ruggieri – condotto con serietà e competenza – è un avvenimento per la fisarmonica.” Gianni Coscia
Con queste parole il grande patriarca della fisarmonica jazz italiana ha tenuto a battesimo l’uscita della prima versione del testo, circa 25 anni fa, quando esso rappresentava il primo libro internazionale per questo strumento con elementi di jazz moderno.
Ruggieri – da esperto didatta – affronta la materia in maniera profonda proponendo una suddivisione razionale dei capitoli, non lesinando esercizi pratici di grande efficacia. La nuova versione si propone una riscrittura del testo, un ampliamento degli argomenti in base alle esperienze degli anni di utilizzo, una razionalizzazione degli schemi e degli esercizi. Sicuramente è stato il primo testo ad introdurre in maniera approfondita dei “policordi” ovvero la pressione di più tasti contemporaneamente nella mano sinistra, tecnica che lo stesso Ruggieri definisce imperfetta ma molto efficace.
La vera novità è rappresentata, comunque, dalle “backing tracks” dei brani del metodo (nuove composizioni sulle strutture armoniche di famosi standard) suonate da affermati professionisti: Maurizio Rolli (contrabbasso), Mauro De Federicis (chitarra), Niki Barulli (batteria). Quest’ultime tutte disponibili gratuitamente sui circuiti online sia in versione completa che “minus bass”, o “minus harmony”, o “minus drums” a simulare le diverse situazioni che lo studente incontrerà.
Da sottolineare la sempre “elegante ed efficace” vena melodica di Ruggieri che si manifesta anche negli esercizi.
Di prossima uscita la versione inglese e nei prossimi anni quella INTERMEDIA e AVANZATA.
Distribuito in tutto il mondo da AMAZON è possibile acquistarlo direttamente su:
https://www.amazon.it/dp/B095GD37SN
Le basi sono disponibili gratuitamente su:
SPOTIFY
https://open.spotify.com/album/3gupaPMqTIuQekv9J8cwzL?si=NG6oHNIfTKa9eGMQQDIyXA
YOUTUBE
https://youtu.be/r0EVSxyEOB4
Vincenzo Staiano – “Solid – Quel diavolo di Scott LaFaro” – Arcana – pgg. 174 – € 16,00
 Ecco un volume che sarà ben accolto da tutti gli appassionati di jazz, in special modo dai pianisti e dai contrabbassisti. Racconta, infatti, la storia di un connubio assolutamente straordinario, un incontro che ha cambiato la storia del jazz in relazione al classico combo pianoforte, batteria, contrabbasso. Ci si riferisce ovviamente alla straordinaria intesa che nell’arco di pochissimo tempo si costituì tra Bill Evans e Scott LaFaro, un’intesa che sconvolse definitivamente la gerarchia degli strumenti nel trio (completato all’epoca da Paul Motian) cosicché il pianoforte perse il ruolo di guida per essere affiancato, a pari condizioni, da batteria e contrabbasso. Certo, a dirlo oggi, sembra qualcosa di scontato ma se si risale all’epoca in cui Evans e LaFaro si incontrarono, vale a dire il 1959, si scoprirà come la musica proposta dal trio fosse assolutamente rivoluzionaria. In questo suo scritto Staiano pone l’accento sulla figura del contrabbassista prematuramente scomparso nel 1961, offrendone un ritratto illuminante anche perché ci fa comprendere come, già prima di incontrare Bill Evans, fosse artista in possesso di una propria ben specifica cifra stilistica. Particolare attenzione viene, così, dedicata al periodo che va dal 1955, quando Scott lascia l’università di Itaca per iniziare il suo primo tour come professionista, sino a quel tragico incidente che il 6 luglio del 1961 gli costa la vita. Grazie ad un racconto ben articolato, sorretto da una prosa che conosce l’italiano, il volume si legge quasi tutto d’un fiato arricchito da una serie di contributi originali. In effetti in Italia pochissimo era stato scritto su LaFaro per cui il libro di Vincenzo Staiano assume un’importanza particolare. L’autore, per questa sua prima pregevole monografia, si è avvalso della biografia di Scotty (con questo nomignolo era noto LaFaro e questo si utilizza nel libro) redatta dalla sorella Helene, nonché di una grande quantità di contributi sull’artista, come l’intervista di Martin Williams apparsa sul periodico “Jazz Review”, un articolo del 1968 di Jean-Pierre Binchet su “Jazz Magazine”, un sito web a lui dedicato nel 1998 da Charles A. Ralston, nonché di moltissimi altri contributi elencati nella ricca appendice bibliografica e webgrafica, cui si affianca una discografia.
Ecco un volume che sarà ben accolto da tutti gli appassionati di jazz, in special modo dai pianisti e dai contrabbassisti. Racconta, infatti, la storia di un connubio assolutamente straordinario, un incontro che ha cambiato la storia del jazz in relazione al classico combo pianoforte, batteria, contrabbasso. Ci si riferisce ovviamente alla straordinaria intesa che nell’arco di pochissimo tempo si costituì tra Bill Evans e Scott LaFaro, un’intesa che sconvolse definitivamente la gerarchia degli strumenti nel trio (completato all’epoca da Paul Motian) cosicché il pianoforte perse il ruolo di guida per essere affiancato, a pari condizioni, da batteria e contrabbasso. Certo, a dirlo oggi, sembra qualcosa di scontato ma se si risale all’epoca in cui Evans e LaFaro si incontrarono, vale a dire il 1959, si scoprirà come la musica proposta dal trio fosse assolutamente rivoluzionaria. In questo suo scritto Staiano pone l’accento sulla figura del contrabbassista prematuramente scomparso nel 1961, offrendone un ritratto illuminante anche perché ci fa comprendere come, già prima di incontrare Bill Evans, fosse artista in possesso di una propria ben specifica cifra stilistica. Particolare attenzione viene, così, dedicata al periodo che va dal 1955, quando Scott lascia l’università di Itaca per iniziare il suo primo tour come professionista, sino a quel tragico incidente che il 6 luglio del 1961 gli costa la vita. Grazie ad un racconto ben articolato, sorretto da una prosa che conosce l’italiano, il volume si legge quasi tutto d’un fiato arricchito da una serie di contributi originali. In effetti in Italia pochissimo era stato scritto su LaFaro per cui il libro di Vincenzo Staiano assume un’importanza particolare. L’autore, per questa sua prima pregevole monografia, si è avvalso della biografia di Scotty (con questo nomignolo era noto LaFaro e questo si utilizza nel libro) redatta dalla sorella Helene, nonché di una grande quantità di contributi sull’artista, come l’intervista di Martin Williams apparsa sul periodico “Jazz Review”, un articolo del 1968 di Jean-Pierre Binchet su “Jazz Magazine”, un sito web a lui dedicato nel 1998 da Charles A. Ralston, nonché di moltissimi altri contributi elencati nella ricca appendice bibliografica e webgrafica, cui si affianca una discografia.
La figura di LaFaro assume così una valenza particolare sottolineata anche dal titolo del libro, “Solid”, che come ci spiega lo stesso Staiano richiama l’essenza di un messaggio inviato a Scott da Miles Davis, un messaggio con cui il trombettista gli faceva capire di volerlo nella sua formazione come contrabbassista.
da Gerlando Gatto | 09/Mag/2022 | I nostri CD, Primo piano, Recensioni
I NOSTRI CD

 Jon Balke Siwan – “Hafla” – ECM
Jon Balke Siwan – “Hafla” – ECM
A distanza di tanti secoli ancora sopravvive il mito di Al-Andalus ovvero di quella Spagna medievale musulmana, in cui sotto la guida di colti principi arabi, musulmani, ebrei e cristiani vivevano tutti insieme senza distinzione alcuna di razza e/o di religione. Ecco, questo mito viene ora riattualizzato dalla musica di Siwan, il collettivo musicale transculturale e trans-idiomatico guidato dal tastierista e compositore norvegese Jon Balke, giunto al suo terzo album dedicato alla materia in oggetto. Questa volta uno accanto all’altro troviamo un musicista kemençe turco (Derya Turkan), un maestro iraniano del tombak (Pedram Khavar Zamini), un batterista norvegese di aperte vedute (Helge Norbakken), una nutrita sezione di archi specialisti del barocco guidata da Bjarte Ejke e una cantante algerina, Mona Boutchebak, che interpreta testi e di Wallada bint al-Mustakfi, la principessa omayyade di Cordoba dell’XI secolo e di altri poeti a lei contemporanei quali Ibn Zaydun (1003-1071, suo appassionato amante) e Ibn Sara As-Santarini (1043-1123). L’album non si presta ad un semplice ascolto né tanto meno ad una facile lettura. Si tratta di musica complessa, caratterizzata da un contesto in cui le parole hanno un peso spesso importante, e da un inusuale impasto sonoro determinato dalla coesistenza di strumenti che appartengono a mondi culturali diversi. Il leader tenta di assemblare il tutto con l’ impegno e la passione che gli sono propri, anche se il risultato non sempre è dei migliori.
 Flavio Boltro, Fabio Giachino – “Things to Say” – Cam Jazz
Flavio Boltro, Fabio Giachino – “Things to Say” – Cam Jazz
Suonare in duo è sempre molto impegnativo, forse più della prova in solitario. Il fatto è che quando ci si esibisce in due occorre che i musicisti si conoscano molto bene e riescano così a precedere le intenzioni l’uno dell’altro sì da assicurare alla musica una fluidità che non conosce intoppi. Ecco, tutto ciò lo si ritrova in questo album interpretato da due grandi jazzisti italiani. Flavio Boltro (classe 1961) è artista oramai maturo che ha raggiunto una perfetta padronanza dello strumento il che gli consente di evidenziare un bel suono, pieno, ricco supportato da un fraseggio mai fine a se stesso e da una indubbia capacità di intonare suadenti linee melodiche. Giachino (classe 1986) è un pianista che ha conquistato pubblico e critica grazie ad uno stile raffinato in cui sottile ironia e padronanza della dinamica si coniugano mirabilmente, il tutto declinato con una personale dimensione dello spazio (lo si ascolti in “Prelude to Salina”). In programma un repertorio tutto composto da original a firma soprattutto di Fabio Giachino il che conferma vieppiù la maturità di questo pianista. Di qui una musica che scorre fluida caratterizzata spesso da notevole intensità emotiva e soprattutto da una perfetta intesa tra i due musicisti che, pur proveniendo da ambienti diversi, riescono a fondere le loro esperienze in un unicum raffinato. Ed è una sensazione che si percepisce immediatamente sin dall’ascolto del primo brano in programma, “Piccola Nina” di Flavio Boltro, sino a quel “Spicy Blues” ancora di Boltro che chiude l’album.
 Avishai Cohen – “Naked Truth” – ECM
Avishai Cohen – “Naked Truth” – ECM
Tra le stelle di primaria grandezza che rifulgono nel panorama jazzistico internazionale, un suo posto di rilievo ce l’ha sicuramente il trombettista israeliano Avishai Cohen. Registrato negli Studios La Buissonne a Pernes-les-Fontaines nel Sud della Francia, nel settembre del 2021, sotto la produzione ECM, l’album ci consegna un Cohen sotto certi aspetti inediti. Abbandonate le atmosfere “elettriche” del precedente album, il trombettista si consegna al suo pubblico in estrema sincerità, con una musica tutta giocata sul coté dell’intimismo e declinata attraverso otto parti di una lunga suite intitolata “Naked Truth” e da un brano conclusivo, “Departure”. Avishai suona con la perizia che ben conosciamo ma è l’atmosfera generale dell’album che, come si diceva, lo proietta in una luce diversa. Perfettamente coadiuvato da Yonathan Avishai al piano, dal bassista Barak Mori e dal batterista Ziv Ravitz, il leader disegna una sorta di percorso che si snoda coerentemente quasi illustrando vari stati d’animo. Così si passa da pezzi di chiara impronta crepuscolare a frammenti in cui la tromba pare schiarirsi e aprirsi ad orizzonti più rosei fino a sfiorare il clima tipico delle ballad.
Da sottolineare come, accanto al leader, suona uno splendido Yonathan Avishai il cui pianoforte si pone come autentico alter-ego del leader prendendo egli stesso in mano il pallino del discorso (si ascolti al riguardo la convincente Part.V).
Come si accennava, il disco si chiude con la poesia “Departure”, dell’autrice israeliana Zelda Schneurson Mishkovsky (1914.1984), recitata dallo stesso Cohen sul tappeto strumentale degli altri musicisti.
 Claudio Cojaniz – “Orfani” – Caligola
Claudio Cojaniz – “Orfani” – Caligola
Poeta della tastiera. Così mi sento di definire Claudio Cojaniz dopo l’ascolto di questo bell’album registrato nell’aprile del 2021 a Treviso dall’oramai rodato quartetto del pianista completato da un sempre straordinario Alessandro Turchet al contrabbasso (a mio avviso uno dei migliori bassisti italiani), Luca Colussi alla batteria e Luca Grizzo percussioni. In repertorio sette composizioni dello stesso Cojaniz. Conosco Claudio oramai da tanti anni ma francamente non so dire con precisione a quali “orfani” si riferisce. Orfani di cosa? Di chi? Personalmente ho avvertito, comunque, nella musica di Cojaniz una sorta di dolore di fondo, di grande malinconia come se l’artista volesse farci riflettere sui tanti guai che in questo momento affliggono l’umanità. Certo, non ci si riferisce alla guerra ché l’album è stato inciso prima, ma resta egualmente la sensazione di un disagio, di un modo di vedere una realtà che non ci piace più di tanto. Ecco, penso che in questo caso il riferimento al blues, non tanto come struttura, ma come musica che rispecchia uno stato d’animo, sia assolutamente presente. E la cosa non stupisce più di tanto ove si tenga presente da un canto la lunga militanza di Cojaniz nell’ambito del jazz (il suo pianismo è ancora una volta coerente, del tutto idoneo alle sue volontà espressive), dall’altro i frequenti richiami africaneggianti che il musicista ha già fatto nei precedenti lavori. Insomma un artista che dimostra, ancora una volta, una profonda conoscenza del linguaggio jazzistico non solo dal punto di vista musicale ma anche da ciò che questo linguaggio ha rappresentato – e ancora oggi rappresenta – per le popolazioni di colore negli States…e non solo.
 Lorenzo De Finti Quartet – “Mysterium Lunae” – Losen
Lorenzo De Finti Quartet – “Mysterium Lunae” – Losen
Strano ma vero, un quartetto italiano che incide per una etichetta norvegese e non è la prima volta dato che il pianista Lorenzo De Finti ha già inciso per la Losen altri due album. Ma veniamo a quest’ultimo “Mysterium Lunae” registrato a Torino nei primi tre giorni del luglio 2021. Per quest’ultima fatica discografica, il gruppo si è arricchito di un prestigioso elemento, il trombettista e flicornista Alberto Mandarini unanimemente considerato musicista a 360 gradi. A completare il gruppo Stefano Dall’Ora al basso e Marco Castiglioni alla batteria. In programma sei brani firmati congiuntamente da De Fanti e Dall’Ora. De Finti è musicista di larga esperienza avendo suonato in orchestre sinfoniche, nella celebrata Instabile Orchestra e accanto a Paolo Conte in molte tournées. Ciò gli ha permesso di elaborare un proprio stile caratterizzato da un sound originale e dalla capacità di scavare a fondo in ogni composizione per trarne ogni possibile implicazione. E tutto ciò si evince dall’ascolto dell’album in oggetto che si apre con la composizione forse più interessante, “Mysterium Lunae”, che si richiama espressamente all’antica metafora per cui un oggetto freddo può diventare fonte di bellezza riflettendo, però, una luce più grande proveniente da qualcos’altro. Ecco quindi questo vero e proprio richiamo alla speranza, sentimento che nel corso della pandemia (periodo in cui è stato registrato il CD) purtroppo è andato quasi perso. Ma i quattro non si limitano a focalizzare uno stato d’animo ché l’album prosegue con una serie di atmosfere cangianti grazie all’attento uso dei colori e delle dinamiche che appaiono già patrimonio consolidato del quartetto.
 Joey DeFrancesco – “More Music” – Mack Avenue
Joey DeFrancesco – “More Music” – Mack Avenue
Non c’è dubbio alcuno che tra quanti suonano ancora oggi l’organo Hammond Joey DeFrancesco sia tra i più bravi. Ma il nostro non si limita a maneggiare con maestria l’organo dal momento che suona bene anche la tromba, il sax tenore, le tastiere e il piano. E ce ne dà prova in questo album in cui presenta undici composizioni (ben dieci a sua firma) in cui, accompagnato da una ritmica composta da Michael Ode alla batteria e Lucas Brown chitarra, organo e tastiere, si diverte ad evidenziare il suo multistrumentismo. E lo fa già in apertura interpretando alla tromba il brano “Free” che, a scanso di equivoci, nulla a che vedere ha con il free jazz. Eccolo ancora alla tromba nel blues “Where to Go”, mentre nelle due ballads, “Lady G” ed “Angel Calling”, si misura con il sax tenore… ma tutto ciò non sarebbe stato sufficiente senza un brano cantato… e voila “And If You Please”, cosicché in alcuni brani l’Hammond B3 viene suonato da Lucas Brown, anch’egli polistrumentista di assoluto livello. Da quanto sin qui detto risulta abbastanza evidente come tutto l’album sia all’insegna della gioia di suonare, di poter eseguire senza tema di essere criticati la musica che piace. Certo, se ci si dovesse poi chiedere in quale veste preferiamo Joey, la risposta non può che essere una ed una sola: all’organo Hammond di cui DeFrancesco rimane uno straordinario interprete, capace di trarre dallo strumento tutta una serie di nuances, di sfumature che pochi altri sanno imitare.
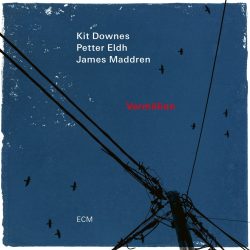 Kit Downes – “Vermillion” – ECM
Kit Downes – “Vermillion” – ECM
Dopo i suoi due precedenti album per ECM, “Dreamlife of Debris” del 2019 e “Obsidian” del 2017 in cui suonava un organo da chiesa a canne, il musicista inglese Kit Downes si ripresenta alla testa di un classico piano-trio coadiuvato dallo svedese Petter Edh già ammirato nel trio di Django Bates al contrabbasso e il britannico James Maddren alla batteria. In realtà al momento della registrazione di questo album, i tre si conoscevano già bene avendo suonato assieme sotto l’insegna di Trio Enemy. Questo “Vermillion” risente molto della formazione musicale del leader: abituato a frequentare quasi indistintamente territori classici, moderni e jazzistici, il pianista infonde alla sua musica uno spirito affatto particolare che la pone piuttosto lontana da ciò che normalmente si immagina debba essere un trio di jazz. In effetti qui non troviamo una continua pulsazione ritmica, né linee melodiche facilmente identificabili ma un flusso costante di musica tutta giocata su toni meditativi. Ovviamente – Evans insegna – non c’è alcuna gerarchia fra i tre strumenti che dialogano su un piano di assoluta parità alla ricerca di un’espressività interiore che mai viene meno. Di qui la sensazione, non si sa bene quanto veritiera, che la scrittura la faccia da padrona sull’improvvisazione. Insomma una sorta di viaggio introspettivo declinato attraverso dieci composizioni di pianista e contrabbassista e la cover di Jimi Hendrix, “Castles Made of Sand” tratto da “Axis: bold as Love” del 1967che chiude meravigliosamente l’album.
 Mathias Eick – “When We Leave” – ECM
Mathias Eick – “When We Leave” – ECM
Il trombettista Mathias Eick è uno di quei musicisti che mai ti delude. Ogni suo album è una summa di quel che oggi dovrebbe rappresentare, a nostro avviso, la figura del jazzista, vale a dire un musicista che pur conoscendo perfettamente la tradizione, volge lo sguardo al futuro. E lo fa con la piena consapevolezza dei propri mezzi espressivi. Ingredienti, questi, che si ritrovano appieno in “When We Leave” registrato a Oslo nell’agosto 2020 da un organico piuttosto ampio guidato da Mathias Eick (nell’occasione anche alle tastiere) e completato da Andreas Ulvo al piano, dal bassista Audun Erlien, da Hakon Aase violino e percussioni, dai due batteristi e percussionisti Torstein Lofthus e Helge Andreas Norbakken e dal chitarrista Stian Carstensen il cui apporto risulta tutt’altro che secondario. Come abbiamo già avuto modo di apprezzare nei suoi precedenti lavori, la musica di Eick si mantiene su atmosfere intimiste, malinconiche, declinata attraverso il fitto colloquio dei musicisti che sembrano aderire perfettamente a quelle che sono le linee guida dettate dal leader. Di qui una insieme di linee melodiche sempre riconoscibili, un perfetto controllo del ritmo ben supportato da una sezione quanto mai precisa ed efficiente, ed un gioco sulle dinamiche che spesso si fa apprezzare per la sua originalità. Tra i vari strumentisti precedentemente citati, da sottolineare ancora una volta la prova del violinista Hakon Aase che oltre ad eseguire spesso il tema all’unisono con la tromba del leader, si produce in pregevoli assolo. Ma il fulcro di tutto è sempre lui, Mathias Eick il cui strumento si staglia sempre preciso, puntuale, così come le sue capacità compositive dato che tutti i brani dell’album sono dovuti alla sua penna.
 Antonio Flinta – “Secrets of a Kiri Tree” – Autoprod.
Antonio Flinta – “Secrets of a Kiri Tree” – Autoprod.
Sono passati circa due anni da quando, discutendo con Antonio Flinta, gli chiesi come mai non si fosse ancora cimentato al piano-solo dopo una intensa carriera. Antonio mi rispose che l’avrebbe fatto solo se si fosse sentito pronto. Il momento è arrivato ed ecco questo “Secrets of a Kiri Tree” in cui il pianista cileno ci spinge a guardarci nel profondo, a riscoprire quel che abbiamo dentro, anche se per farlo probabilmente abbiamo bisogno di qualcuno che si spinga in tal senso. E per ottenere tale scopo Flinta sceglie un repertorio tanto vasto quanto difficile. Ecco quindi Paco de Lucia con “Cancion de amor”, accanto a George Fragos (“I Hear a Rhapsody”), la straordinaria Violeta Parra (“Gracias a la vida”) assieme al gigante del jazz Thelonious Monk (”’Round Midnight”) il tutto completato da tre originals di Antonio. A nostro avviso il meglio dell’album lo si ritrova nelle composizioni dello stesso pianista. Scevro da qualsivoglia preoccupazione se non quella di lasciarsi andare al proprio istinto, Flinta inanella una serie di improvvisazioni davvero notevoli in cui mai si perde il filo del discorso tanto è solida la base su cui l’artista costruisce i suoi edifici musicali. Così risulta quanto mai arduo distinguere le parti improvvisate da quelle scritte, ammesso poi che la cosa abbia un minimo di importanza. Così il pianismo di Flinta scorre fluido sicuro, lucido, essenziale, mai sovracaricato di orpelli inutili e pur tuttavia sempre in grado di incuriosire l’ascoltatore. Quanto agli altri brani, abbiamo particolarmente apprezzato la versione di “Gracias a la vida” che conserva intatta la sua dolce e malinconica linea melodica.
 Tord Gustavsen – “Opening” – ECM
Tord Gustavsen – “Opening” – ECM
Ancora un piano-trio questa volta di marca norvegese. A costituirlo sono infatti il pianista Tord Gustavsen, il contrabbassista Steinar Raknes (responsabile anche di un sapiente e sobrio uso dell’elettronica) e il batterista Jarle Vespestad ovvero tre dei migliori musicisti che il panorama jazz norvegese possa oggi offrire. E il risultato è in effetti di grande rilevanza. Certo non scopriamo in questa sede lo straordinario talento del pianista, ma fa immenso piacere constatare come uno dopo l’altro tutti i lavori di Tord si mantengano su un livello di assoluta eccellenza. In programma, questa volta, dodici brani di cui nove a firma del leader cui si aggiungono un brano traditional e due pezzi firmati rispettivamente da Geir Tveitt – figura centrale del movimento culturale norvegese negli anni ’30 – e da Egil Hovland, compositore classico che si formò studiando tra gli altri con Aaron Copland e a Firenze con Luigi Dallapiccola. E da queste poche note si può già comprendere quanto ampio sia l’universo musicale di riferimento di Gustavsen e quindi dell’intero trio. Di qui una musica saldamente ancorata al patrimonio norvegese, e nordico più in generale. Ecco quindi la rivisitazione, già al secondo pezzo, di un brano abbastanza celebrato in Svezia, “Visa från Rättvik” (Vista dalla città di Rättvik), già inserito da Jan Johansson – uno tra i più grandi pianisti svedesi di cui Gustavsen ha dichiarato di sentire l’influenza – nell’album del 1964, “Jazz pa Svenska”, album che all’epoca vendette la stratosferica cifra di 250.000 copie. Gustavsen stravolge il pezzo rendendolo praticamente suo e lo stesso fa per tutta la durata dell’album mai offrendo musica banale o scontata. Si ascolti, ad esempio, il suo modo di intendere il tango in “Helensburgh Tango”, lontano che più non si potrebbe dalle atmosfere tipiche tanguere. Splendida la versione di “Var Sterk, Min Sjel” assolutamente rispettosa dell’originale del già citato Egil Hovland.
 Roberto Laneri – “Musica finta / Blue Prints” – Da Vinci Classics
Roberto Laneri – “Musica finta / Blue Prints” – Da Vinci Classics
Roberto Laneri – “South of No Border” – Black Sweat Records
Il polistrumentista Roberto Laneri si ripresenta con due album registrati rispettivamente nel 1998 e in un arco temporale che va dal 2014 al 2018. Ma procediamo con ordine. “Musica finta / Blue Prints”, registrato come si diceva nel 1998 ma pubblicato solo nei primi mesi del 2020, va inquadrato correttamente grazie al sottotitolo “A Study in Metamusicology”. Si tratta, cioè, di un album assai complesso, di lettura difficile, in cui Laneri – come egli stesso afferma, suonando al sax soprano alcuni rags di Scott Joplin ha provato ad introdurre dei cambiamenti nel testo, dapprima minimi, poi sempre più articolati, fino ad arrivare alla composizione di pezzi autonomi e paralleli, da suonarsi assieme ai pezzi originali. “L’effetto di questa estremizzazione – aggiunge Laneri – è paragonabile alle prospettive impossibili di Escher, oppure ai disegni tridimensionali generati al computer, dai quali possono emergere immagini complementari eppur assai diverse da quelle immediatamente apparenti”. Fin qui le premesse metodologiche. Ma il risultato musicale? Laneri presenta composizioni originali, unite a quelle di Schumann, Schubert ma anche Joplin e Jelly Roll Morton. Quindi linguaggi differenti ricondotti ad unità per una sorta di opera di ampio respiro divisa in cinque capitoli. Per questa impresa Laneri (sax soprano, sampling e sound treatment) ha chiamato accanto a sé la pianista Maria Jolanda Masciovecchio e Alan Ferry come spoken voice.
 “South of No Border” (come si diceva registrato tra il 2014 e il 2018 ma anch’esso pubblicato poche settimane fa) vede Roberto Laneri (clarinetto, clarinetto basso, sax sopranino, sax soprano e alto, didjeridoo, shruti box, voce e percussioni) alla testa di un gruppo comprendente Giuppi Paone voce, Raffaela Siniscalchi voce, Eleonora Vulpiani chitarra, Luigi Polsini contrabbasso e Laugi Marino zarb. Contrariamente al primo album, in questo caso il repertorio è come una sorta di finestra affacciata sulle musiche del mondo. Ecco, quindi, dopo l’apertura affidata alle melodie orientaleggianti di “Malia” (scritta da Laneri), il choro brasiliano “Tico-Tico no fubá” (scritto da Zequinha de Abreu nel 1917, accanto al bolero cubano “Contigo En La Distancia” scritto dal cantautore César Portillo de la Luz quando aveva 24 anni nel 1946, il tutto impreziosito da 4 original del leader. A confronto con un tale repertorio, Laneri dà ancora una volta prova non solo della sua indiscussa preparazione tecnica ma anche della profonda conoscenza del panorama musicale internazionale. Le sue interpretazioni risultano, quindi, assolutamente pertinenti: traendo feconda ispirazione da svariate tradizioni, riesce a produrre una sintesi che non conosce confini geografici grazie ad una concezione visionaria della musica senza barriere. Insomma un disco originale nella concezione e nell’esecuzione.
“South of No Border” (come si diceva registrato tra il 2014 e il 2018 ma anch’esso pubblicato poche settimane fa) vede Roberto Laneri (clarinetto, clarinetto basso, sax sopranino, sax soprano e alto, didjeridoo, shruti box, voce e percussioni) alla testa di un gruppo comprendente Giuppi Paone voce, Raffaela Siniscalchi voce, Eleonora Vulpiani chitarra, Luigi Polsini contrabbasso e Laugi Marino zarb. Contrariamente al primo album, in questo caso il repertorio è come una sorta di finestra affacciata sulle musiche del mondo. Ecco, quindi, dopo l’apertura affidata alle melodie orientaleggianti di “Malia” (scritta da Laneri), il choro brasiliano “Tico-Tico no fubá” (scritto da Zequinha de Abreu nel 1917, accanto al bolero cubano “Contigo En La Distancia” scritto dal cantautore César Portillo de la Luz quando aveva 24 anni nel 1946, il tutto impreziosito da 4 original del leader. A confronto con un tale repertorio, Laneri dà ancora una volta prova non solo della sua indiscussa preparazione tecnica ma anche della profonda conoscenza del panorama musicale internazionale. Le sue interpretazioni risultano, quindi, assolutamente pertinenti: traendo feconda ispirazione da svariate tradizioni, riesce a produrre una sintesi che non conosce confini geografici grazie ad una concezione visionaria della musica senza barriere. Insomma un disco originale nella concezione e nell’esecuzione.
 Roberto Magris – “Match Point” – JMood / Roberto Magris – “Duo & Trio” – JMood
Roberto Magris – “Match Point” – JMood / Roberto Magris – “Duo & Trio” – JMood
Tra i musicisti che riescono a conservare un alto livello delle proprie produzioni, lavorando in ambedue le sponte dell’Atlantico, c’è sicuramente il pianista Roberto Magris di cui segnaliamo due nuove uscite. Il primo – “Match Point” – registrato a Miami l’8 dicembre del 2018, è stato a ben ragione considerato da critici statunitensi come uno degli album più interessanti pubblicati negli ultimi mesi. “Match Point” vede il pianista triestino alla testa di un quartetto dai mille colori completato dal cubano Alfredo Chacon al vibrafono e percussioni, dal batterista Rodolfo Zunica proveniente dal Costa Rica e dallo statunitense Dion Kerr al basso. In repertorio otto brani equamente divisi tra composizioni dello stesso Magris e brani di giganti della tastiera quali Richard Kermode tastierista americano, noto soprattutto per essersi esibito con Janis Joplin, Malo e Santana, McCoy Tyner, Thelonious Monk, Randy Weston. Da quanto sin qui detto è già possibile avere un’idea della musica che Magris ci propone, una musica che, saldamente ancorata alla produzione, presenta quel tocco di “latino” che impreziosisce il tutto. Al riguardo basti ascoltare “Caban Bamboo Highlife” di Randy Weston, uno dei jazzisti preferiti da Magris, con Chacon e Zuniga in grande evidenza.
In “Duo & Trio” Magris adotta una formula diversa esibendosi in sei brani in duo con il sassofonista Mark Colby e in cinque pezzi in gruppo con Elisa Pruett al basso, Brian Steever alla batteria mentre Pablo Sanhueza alle congas è presente solo in “Melody for C” di Sonny Clark e “Samba Rasta” di Andrew Hill. Per il resto i compositori visitati da Magris fanno parte dell’Olimpo della musica quali Elmo Hope, Bernstein, Ray Noble, Shuman, Kurt Weill; il tutto completato, come al solito, da alcune composizioni dello stesso Magris. L’ascolto dell’album lascia pienamente soddisfatti per almeno due ordini di motivi: innanzitutto la straordinaria maestria di Roberto Magris che, dall’alto della sua immensa preparazione pianistica, affronta con estrema disinvoltura partiture assai diversificate tra di loro (eccolo intimista e toccante in “Old Folks”, classico nell’accezione più completa del termine in “Cherokee”, trascinante improvvisatore in “Melody for C”); in secondo luogo per la scelta di collaboratori sempre di livello. Da segnalare, in questa occasione il lavoro del sassofonista Mark Colby che sia al tenore sia al soprano evidenzia una forte personalità scevra da qualsivoglia intento di stupire chi ti ascolta.
 Dino & Franco Piana Ensemble – “Reflections” –Alfa Music
Dino & Franco Piana Ensemble – “Reflections” –Alfa Music
Attualmente l’ensemble diretto dalla premiata ditta “Dino & Franco Piana” è una delle migliori formazioni del jazz attuale. Ciò anche perché nel suo ambito, oltre ai citati leader, figurano artisti di grande spessore quali la pianista Stefania Tallini, il bassista Dario Deidda e il batterista Roberto Gatto. In quest’ultima fatica discografica il gruppo è affiancato dalla B.i.m. Orchestra mentre il repertorio comprende dieci brani di cui ben sei composti da Franco Piana (altresì flicornista e arrangiatore del gruppo), altri due original dovuti rispettivamente a Lorenzo Corsi e Stefania Tallini e due standard, “Skylark” di Hoagy Carmichael e “Embraceable You” di George Gershwin. Il progetto nasce durante il lockdown dalle riflessioni dei due leader che hanno focalizzato l’attenzione sulle molteplici possibilità d’espressione che i vari organici possono offrire. Di qui il far ricorso, per ogni brano, ad un organico diverso. Si inizia così da “Skylark”, suonato dal trombone di Dino Piana in solo, passando poi a brani in duo – trio – quartetto – quintetto – sestetto, fino ad arrivare ad arrangiamenti per quartetto d’archi (B.i.m. Orchestra), 4 flauti, piano e flicorno. Come le precedenti prove dei Piana, anche questo album entra di diritto tra i migliori album di jazz italiano pubblicati negli ultimi mesi in quanto la bellezza dei temi è supportata e valorizzata da arrangiamenti ben strutturati e altrettanto ben eseguiti da una formazione che presenta anche individualità di tutto rispetto. Senza dimenticare i due leader – di cui comunque spesse volte abbiamo tessuto le lodi – bisogna sottolineare l’apporto di Stefania Tallini che si conferma jazzista a tutto tondo capace sia di sviluppare suadenti linee melodiche sia di imporre un ritmo preciso e coinvolgente (la si ascolti in “D and F”). Ma la citazione di questo brano è solo un esempio ché tutto l’album merita di essere ascoltato.
 Valentina Ranalli, Enrico Pieranunzi – “Cantare Pieranunzi” – Alfa Music
Valentina Ranalli, Enrico Pieranunzi – “Cantare Pieranunzi” – Alfa Music
Enrico Pieranunzi Quintet – “The Extra Something” – Cam Jazz
Quasi contemporaneamente sono usciti due pregevoli album che vedono impegnato Enrico Pieranunzi. Nel primo – “Cantare Pieranunzi” – il pianista romano si presenta nella triplice veste di leader dello Youth Project (con Giuseppe Romagnoli al basso, Cesare Mangiocavallo alla batteria e Giacomo Serino alla tromba), compositore e arrangiatore. Il tutto al servizio della vocalist Valentina Ranalli. La genesi dell’album è assai particolare e ce la illustra lo stesso Pieranunzi nelle note che accompagnano il CD: in buona sostanza “Cantare Pieranunzi” è il frutto della tesi di laurea in canto jazz presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma di Valentina Ranalli che ha presentato un lavoro incentrato su pezzi del pianista, cui ha aggiunto le parole in italiano, inglese, francese e napoletano. Incuriosito dall’iniziativa e dopo aver ascoltato la vocalist, Pieranunzi decide di mettere il tutto su disco e bene ha fatto dal momento che l’album è di assoluto livello. Le undici tracce contenute nell’album sono interpretati dalla Ranalli con sincera partecipazione dialogando intensamente con il pianoforte di Enrico: si ascolti, ad esempio, “You Know”. Ma è tutta la performance della cantante che convince e che fa ottimamente sperare per il suo futuro; fra i pezzi da segnalare “Suspension points” fatto di poche note ma di tanta emozione, e “Persona” in cui la Ranalli si trova particolarmente a suo agio esprimendosi nella lingua della sua terra, il partenopeo.
 Completamente diverso il secondo album – “The Extra Something” – registrato live il 13 e 14 gennaio 2016 al Village Vanguard da un quintetto che vedeva il pianista romano in compagnia di Diego Urcola tromba e trombone (semplicemente straordinario nella title tracke), Seamus Blake sax tenore (particolarmente convincente in “Atoms”), Ben Street basso e Adam Cruz batteria. E per quanti seguono il jazz non c’è bisogno di altre parole per sottolineare il valore assoluto della band. Valore assoluto che si evidenzia in tutto il repertorio, sette brani tutti composti dal pianista. Pieranunzi, come spesso gli capita, è in uno stato di grazie e conduce il gruppo con mano sicura, del tutto consapevole dell’intesa che ha raggiunto con i compagni di viaggio. Dal punto di vista compositivo non scopriamo certo oggi il suo senso della struttura che mai l’abbandona, per cui se consideriamo tutti questi elementi si capisce bene perché il ben noto Brian Morton abbia incluso Enrico tra “i più significativi musicisti contemporanei”. Nelle note di copertina Pieranunzi dedica espressamente questo terzo CD Live at The Village Vanguard a Lorraine Gordon in memoriam, senza la quale né questo né i precedenti due si sarebbero potuti realizzare. Ricordiamo per inciso che il pianista romano è forse l’unico musicista italiano nella veste di leader ed uno dei pochissimi europei ad aver suonato nel leggendario jazz club a forma di diamante aperto da Max Gordon nel 1935 al 178 Seventh Avenue South di Manhattan.
Completamente diverso il secondo album – “The Extra Something” – registrato live il 13 e 14 gennaio 2016 al Village Vanguard da un quintetto che vedeva il pianista romano in compagnia di Diego Urcola tromba e trombone (semplicemente straordinario nella title tracke), Seamus Blake sax tenore (particolarmente convincente in “Atoms”), Ben Street basso e Adam Cruz batteria. E per quanti seguono il jazz non c’è bisogno di altre parole per sottolineare il valore assoluto della band. Valore assoluto che si evidenzia in tutto il repertorio, sette brani tutti composti dal pianista. Pieranunzi, come spesso gli capita, è in uno stato di grazie e conduce il gruppo con mano sicura, del tutto consapevole dell’intesa che ha raggiunto con i compagni di viaggio. Dal punto di vista compositivo non scopriamo certo oggi il suo senso della struttura che mai l’abbandona, per cui se consideriamo tutti questi elementi si capisce bene perché il ben noto Brian Morton abbia incluso Enrico tra “i più significativi musicisti contemporanei”. Nelle note di copertina Pieranunzi dedica espressamente questo terzo CD Live at The Village Vanguard a Lorraine Gordon in memoriam, senza la quale né questo né i precedenti due si sarebbero potuti realizzare. Ricordiamo per inciso che il pianista romano è forse l’unico musicista italiano nella veste di leader ed uno dei pochissimi europei ad aver suonato nel leggendario jazz club a forma di diamante aperto da Max Gordon nel 1935 al 178 Seventh Avenue South di Manhattan.
 Serena Spedicato – “Io che amo solo te” – Dodicilune
Serena Spedicato – “Io che amo solo te” – Dodicilune
Non sempre la bellezza della confezione corrisponde alla bontà del contenuto. In questo caso, la Dodicilune ha realizzato qualcosa di eccellente affidando alla vocalist Serena Spedicato (utilizzata anche come splendida voce narrante) un repertorio per noi italiani impossibile da dimenticare, all’interno di una confezione sobriamente elegante. In realtà Serena Spedicato e lo scrittore Osvaldo Piliego avevano dato vita a questo loro progetto originale come concerto/spettacolo con la regia di Riccardo Lanzarone, che solo successivamente è approdato alla forma libro/cd. Così la Dodicilune ci presenta un prezioso libretto, con la grafica di Marina Damato, autrice delle foto con Maurizio Bizzochetti, e i testi inediti di Osvaldo Piliego che accompagnano dodici brani tra i più belli e rappresentativi del cantautorato italiano, rielaborati in una forma nuova grazie agli arrangiamenti del fisarmonicista Vince Abbracciante coadiuvato da Nando Di Modugno (chitarra classica) e Giorgio Vendola (contrabbasso). Le canzoni proposte appartengono tutte alla cd. “scuola genovese” vale a dire Luigi Tenco, Fabrizio De André, Gino Paoli, Sergio Endrigo, Umberto Bindi, Bruno Lauzi. In buona sostanza tutto il lavoro ruota attorno ai cantautori che sono cresciuti e si sono formati in quel di Genova, ove sul finire degli anni Cinquanta si sviluppò un movimento culturale e artistico che rivoluzionò il mondo della canzone italiana. Ed è proprio questo clima che si respira ascoltando l’album. Molte le positività del lavoro: le centrate interpretazioni della vocalist che evidenzia una musicalità ed una sensibilità non comuni, i testi intelligenti che aiutano (soprattutto i più giovani) a capire ciò che si ascolta, ma soprattutto gli arrangiamenti di Vince Abbracciante che oramai non ne sbaglia una. Misurarsi con dei veri e proprio mostri sacri della musica non è certo impresa facile: ebbene il fisarmonicista ha affrontato l’impresa con passione e professionalità regalandoci degli arrangiamenti che, senza alcunché togliere al fascino originario, hanno rivestito i brani di una patina jazzistica pertinente ed affascinante. Ovviamente più che positiva anche l’apporto di Nando Di Modugno e Giorgio Vendola per un album di sicuro rilievo.
 Andrés Thor – Hereby – Losen
Andrés Thor – Hereby – Losen
Siamo veramente grati alla norvegese Losen Records per la possibilità che ci offre di far conoscere al pubblico italiano dei veri e propri talenti che, non avendo ancora raggiunto fama internazionale, difficilmente raggiungono le nostre platee. E’ il caso del chitarrista islandese Andrés Thor che, giunto al suo settimo album da leader, si presenta al pubblico alla testa di un trio completato dall’altro islandese Magnús Trygvason Eliassen batteria e dal francese Nicolas Moreaux contrabbasso. Quello di Thor è un fraseggio molto personale, pulito, chiaro, senza alcuna pretesa di sperimentalismo o di sensazionalismo. La sua idea di guidare il trio si avvicina molto alla lezione impartita da Bill Evans con Scott LaFaro. Quindi una formazione che si muove su basi paritetiche in cui ognuno può improvvisare ed esprimere la propria personalità all’interno di una cornice ben delineata dalle nove composizioni tutte a firma dello stesso Thor. Da un punto di vista prettamente chitarristico, Thor è chiaramente ispirato da tre grandi esponenti della chitarra jazz – Jim Hall, John Scofield e Pat Metheny – mentre sotto un profilo più generale tra i suoi maggiori interessi figurano rock band come i Led Zeppelin e i Doors nonché Jimi Hendrix e John Coltrane. Come si nota un universo di riferimento assai ampio che Thor dimostra di aver assorbito molto bene soprattutto nel modo in cui costruisce le sue composizioni, dotate tutte di un eccellente senso architettonico e ben arrangiate. Da sottolineare che mentre nei primi sette brani Andrés utilizza la chitarra elettrica, negli ultimi due imbraccia lo strumento acustico senza che ciò influenzi minimamente l’omogeneità dell’album.
 Mark Turner – “Return From The Stars” – ECM
Mark Turner – “Return From The Stars” – ECM
Registrato a New York nel novembre del 2019, questo album vede impegnato un quartetto piano-less guidato dal sassofonista Mark Turner e completato da Jason Palmer alla tromba, Joe Martin al contrabbasso e Jonathan Pinson alla batteria. L’album si inserisce in quella nuova corrente musicale che si allontana molto dal jazz mainstream per inserirsi in ciò che si può definire “musica moderna” tout court. Ma, a questo punto, qualcuno potrebbe chiedersi: si tratta ancora di jazz? Lasciamo ad altri la risposta a questo inutile quesito per soffermarci su un altro interrogativo molto più pregnante: si tratta di musica di qualità o no? La risposta non può che essere positiva: si, si tratta di musica di qualità dal momento che risponde ad alcuni requisiti facilmente individuabili. Intendiamo riferirci, innanzitutto, alla natura delle composizioni: Turner scrive benissimo, con perfetto senso delle proporzioni, lasciando ad ognuno dei suoi collaboratori il giusto spazio pur essendo comunque in condizione di ricondurre il discorso ad unità; il tutto corroborato dalla capacità di creare una omogeneità di fondo. Ma ciò sarebbe stato inutile se ad interpretare queste complesse partiture non ci fossero stati dei musicisti completi, preparati. Si ascolti, ad esempio, con quanta pertinenza il trombettista segua il leader nelle sue escursioni o di come il batterista riesca ad inserire il suo drumming nelle complesse trame disegnate dal leader mentre il basso non perde un colpo nel supportare il ritmo del gruppo. Insomma un disco tutto da gustare, per palati raffinati.
 Cristina Zavalloni – “Parlami di me” – Egea
Cristina Zavalloni – “Parlami di me” – Egea
“Parlami di me” è il suggestivo titolo di questo nuovo album dedicato alle musiche di Nino Rota, all’anagrafe Giovanni Rota Rinaldi, scomparso nel 1979 e a ben ragione considerato, a livello mondiale, uno dei massimi esponenti dei compositori che hanno dedicato la loro vita al cinema. Basti ricordare le colonne sonore di quasi tutti i film di Fellini nonché le colonne sonore del Padrino e Il padrino – Parte II vincendo, per quest’ultimo, il Premio Oscar alla migliore colonna sonora. Evidentemente il connubio tra jazz e musiche da film non è certo una novità eppure ogni nuovo album del genere va ascoltato con la massima attenzione data la delicatezza della materia. In effetti estrapolare tale musiche dal contesto per cui sono nate e farne un qualcosa a sé stante è impresa tutt’altro che banale. A cimentarsi con questo difficile compito è ora una delle nostre migliori vocalist, Cristina Zavalloni, accompagnata da quattro musicisti di assoluto livello quali Gabriele Mirabassi al clarinetto, Cristiano Arcelli al sax soprano (nonché responsabile degli ottimi arrangiamenti), Massimo Morganti al trombone e Manuel Magrini al pianoforte, cui si aggiunge il ClaraEnsemble, sestetto costituito da flauto, contrabbasso, due violini, viola e violoncello. Un organico, quindi, piuttosto ampio che si attaglia perfettamente sia alla voce della Zavalloni sia agli arrangiamento di Arcelli. La vocalist entra quasi in punta di piedi nell’universo di Nino Rota, ma subito dopo se ne appropria, lo fa suo e lo reinterpreta con chiavi sempre originali pur nulla perdendo dell’originario fascino. Così riascoltiamo alcune perle del Maestro che hanno stupendamente accompagnato le immagini volute dai più grandi registi italiani da Fellini a Visconti, da Wertmuller a Zeffirelli…Il repertorio dell’album si completa con l’unica canzone scritta integralmente, dalla Zavalloni, “Prova tu”, che si integra perfettamente nel discorso generale portato avanti da “Parlami di me”.
Gerlando Gatto
 A dire il vero, dopo il primo melodico Sanremo del ’51, una decisa aura jazz si era avvertita in Nati per la Musica, un programma con Jula De Palma, Quartetto Cetra, Teddy Reno che si avvaleva delle orchestre di ritmi moderni di Gorni Kramer e Lelio Luttazzi, la cui sigla è ascoltabile sul Portale della Canzone Italiana dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi (www.canzone italiana.it/1zlns). Sorella Radio avrebbe dato anche in seguito significativi contributi alla causa jazzistica – si pensi all’uso fatto da Radio1 dello stacco di “Country“ tratto dal cd “My Song” di Jarrett con Garbarek, Danielson e Christensen (ECM, 1977) – ma il copioso materiale di Mamma Rai, con il ricchissimo archivio sonoro ad oggi digitalizzato, meriterebbe di essere approfondito in altra sede. Torniamo allora al come eravamo tramite il cosa guardavamo. Dopo la vittoria di Modugno all’Ariston nel ’58, con una “Nel blu dipinto di blu” a ritmo swing, nell’anno di grazia televisivo 1961 passavano in video le immagini di Moderato Swing che era anche il titolo della sigla di Piero Umiliani. Un biennio ancora per poi sentire il canto e la tromba di Nini Rosso echeggiare in “I ragazzi del jazz”, sigla di Fuori I ’Orchestra, epica trasmissione, per la regia di Lino Procacci, che si avvaleva della direzione musicale dello stesso Umiliani. Si trattava di una rubrica che si occupava “di musica equidistante fra quella leggerissima e quella classica“ (www.umiliani.com) che rimane una pietra miliare della televisione italiana. Fra i numeri fissi c’erano quello dedicato al Jazz made in Italy ed l’altro spazio denominato Parole e musica che registrava partecipazioni lussuose tipo la cantante Helen Merrill. Da segnalare che Umiliani avrebbe poi collaborato con I Marc 4 (acronimo di Maurizio Majorana, Antonello Vannucchi, Roberto Podio, Carlo Pes), gruppo operante fra ’60 e ’76, a cui è da ascrivere la sigla di Prima Visione (su album Ricordi, 1974). Il 1963 resta un anno significativo per il jazz sul piccolo schermo anche perché decollava in Italia, con TV7, l’idea di utilizzare un brano jazz come intro di un programma d’inchiesta. Per l’occasione la scelta cadeva su “Intermission Riff” di Stan Kenton, poi sostituita con una storica versione dell’Equipe 84. A fine decennio toccava alla serie tv Nero Wolf diretta da Giuliana Berlinguer con Tino Buazzelli, vedere impressi i titoli di testa e di coda dalla tromba di Nunzio Rotondo sulla base elettronica di Romolo Grano, musica da noir con echi dal lungometraggio di Louis Malle Ascenseur pour l’échafaud, del ’58, sonorizzato da Miles Davis, trombettista a cui Rotondo è stato spesso accostato. Ed avrebbe “aperto” un thriller televisivo il compositore Berto Pisano con la sua “Blue Shadow”, sigla lounge dello sceneggiato Ho incontrato un’ombra del 1974, che figura nella classifica stilata da “Rolling Stone” il 26 agosto 2020 in Fantasmi e storie maledette. Le migliori sigle della tv italiana del mistero degli anni ’70. In tema di rotocalchi da menzionare che AZ un fatto come e perché (in onda dal ‘70 fino al luglio ’76) adottava un pezzo del repertorio jazz, esattamente “Hard to Keep My Mind of You”, di Woody Herman.
A dire il vero, dopo il primo melodico Sanremo del ’51, una decisa aura jazz si era avvertita in Nati per la Musica, un programma con Jula De Palma, Quartetto Cetra, Teddy Reno che si avvaleva delle orchestre di ritmi moderni di Gorni Kramer e Lelio Luttazzi, la cui sigla è ascoltabile sul Portale della Canzone Italiana dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi (www.canzone italiana.it/1zlns). Sorella Radio avrebbe dato anche in seguito significativi contributi alla causa jazzistica – si pensi all’uso fatto da Radio1 dello stacco di “Country“ tratto dal cd “My Song” di Jarrett con Garbarek, Danielson e Christensen (ECM, 1977) – ma il copioso materiale di Mamma Rai, con il ricchissimo archivio sonoro ad oggi digitalizzato, meriterebbe di essere approfondito in altra sede. Torniamo allora al come eravamo tramite il cosa guardavamo. Dopo la vittoria di Modugno all’Ariston nel ’58, con una “Nel blu dipinto di blu” a ritmo swing, nell’anno di grazia televisivo 1961 passavano in video le immagini di Moderato Swing che era anche il titolo della sigla di Piero Umiliani. Un biennio ancora per poi sentire il canto e la tromba di Nini Rosso echeggiare in “I ragazzi del jazz”, sigla di Fuori I ’Orchestra, epica trasmissione, per la regia di Lino Procacci, che si avvaleva della direzione musicale dello stesso Umiliani. Si trattava di una rubrica che si occupava “di musica equidistante fra quella leggerissima e quella classica“ (www.umiliani.com) che rimane una pietra miliare della televisione italiana. Fra i numeri fissi c’erano quello dedicato al Jazz made in Italy ed l’altro spazio denominato Parole e musica che registrava partecipazioni lussuose tipo la cantante Helen Merrill. Da segnalare che Umiliani avrebbe poi collaborato con I Marc 4 (acronimo di Maurizio Majorana, Antonello Vannucchi, Roberto Podio, Carlo Pes), gruppo operante fra ’60 e ’76, a cui è da ascrivere la sigla di Prima Visione (su album Ricordi, 1974). Il 1963 resta un anno significativo per il jazz sul piccolo schermo anche perché decollava in Italia, con TV7, l’idea di utilizzare un brano jazz come intro di un programma d’inchiesta. Per l’occasione la scelta cadeva su “Intermission Riff” di Stan Kenton, poi sostituita con una storica versione dell’Equipe 84. A fine decennio toccava alla serie tv Nero Wolf diretta da Giuliana Berlinguer con Tino Buazzelli, vedere impressi i titoli di testa e di coda dalla tromba di Nunzio Rotondo sulla base elettronica di Romolo Grano, musica da noir con echi dal lungometraggio di Louis Malle Ascenseur pour l’échafaud, del ’58, sonorizzato da Miles Davis, trombettista a cui Rotondo è stato spesso accostato. Ed avrebbe “aperto” un thriller televisivo il compositore Berto Pisano con la sua “Blue Shadow”, sigla lounge dello sceneggiato Ho incontrato un’ombra del 1974, che figura nella classifica stilata da “Rolling Stone” il 26 agosto 2020 in Fantasmi e storie maledette. Le migliori sigle della tv italiana del mistero degli anni ’70. In tema di rotocalchi da menzionare che AZ un fatto come e perché (in onda dal ‘70 fino al luglio ’76) adottava un pezzo del repertorio jazz, esattamente “Hard to Keep My Mind of You”, di Woody Herman. Dal giornalismo d’inchiesta a quello sportivo: nel ’78 era il turno di Jazz Band di Hengel Gualdi a far da “preludio” a Novantesimo minuto, storica rubrica di RaiSport, e come non citare, dal campionario di La Domenica Sportiva, “Dribbling” di Piero Umiliani (1967), “Winning The West” della Buddy Rich Big Band (1973), “Mexico” di Danilo Rea e Roberto Gatto (1985), “Breakout” di Spyro Gira (1991)? Spostandoci alla “pagina” spettacoli, fra il ’76 e il ‘78, Rete 2 dava spazio in Odeon al pianista Keith Emerson (senza Lake e Palmer) in “Odeon Rag” arrangiamento di “Maple Leaf Rag” di Scott Joplin, subentrato in luogo del precedente “Honky Tonk Train Blues”, autore il pianista Meade Lux Lewis. Il filone spettacolistico avrebbe registrato più in là significativi esempi con lo scat di Lucio Dalla con gli Stadio che annuncia Lunedifilm per un buon ventennio fino al 2002 e l’ellingtoniano “Take The A Train” di Strayhorn a fare da intro ai trailer cinematografici assemblati da AnicaFlash per la rassegna delle novità cinematografiche “di stagione”. Si diceva come luogo fertile per la semina tv di suoni jazz da filtrare nelle orecchie dei telespettatori fosse l’informazione. Gettonatissima rimane al riguardo la sigla di Mixer (1980-1996) ovvero “Jazz Carnival” dei brasiliani Azimuth, specialisti del samba doido, genere fusion-funky. Latin come nelle radiocronache di Tutto il calcio minuto per minuto, dove Herb Alpert e Tijuana Brass interpretano “A Taste of Honey”, brano di stampo pop, in repertorio a Beatles e Giganti (“In paese è festa”). Per la tv italiana va ricordato che, fuori dal reticolo giornalistico, si contano altre occasioni più dirette di esposizione per la musica jazz filtrata tramite il piccolo schermo. La Portobello Jazz Band di Lino Patruno “presentava” il programma di Enzo Tortora (cfr. La tana delle sigle in tds.sigletv.net) nel 1978, stesso anno dello sceneggiato in 3 puntate Jazz Band di Pupi Avati, colonna sonora di Amedeo Tommasi, con il clarino di Hengel Gualdi in evidenza nelle sigle di apertura e chiusura, “Jazz Band” e “Swing Time” ; poi ancora Di Jazz in Jazz, programma “dedicato” con relativa sigla a cura dell’Orchestra Big Band della Rai diretta da Giampiero Boneschi e Franco Cerri (www.teche.rai.it). “Schegge”, queste ultime, che costituivano una vetrina per il jazz di casa nostra in una situazione in cui il format varietà si teneva alquanto distante, a differenza di quanto avveniva negli U.S.A. . Dalle nostre parti vanno citati comunque Milleluci, show datato 1974, nella cui sigla finale “Non gioco più” Mina duetta con l’armonica di Toots Thielemans, Palcoscenico, in onda fra 1980 e 1981, con Milva accompagnata da Astor Piazzolla mentre scorrono i titoli di coda in “Fumo e odore di caffè” e Premiatissima del 1985 dove il crooner Johnny Dorelli canta “La cosa si fa“ su base swing “metropolitano. Lo sdoganamento delle sigle jazz nei varietà proseguiva con Renzo Arbore (e Gegè Telesforo) a cui si deve “Smorza e’ lights (Such a night)” incipit di Telepatria International, inizio trasmissioni il 6 dicembre 1981 (www.arboristeria.it – Renzo Arbore Channel). Per la cronaca il 18 marzo 1981, e fino al 1989, sarebbe andata in onda la prima edizione di Quark di Piero Angela, conduttore nonché apprezzato pianista jazz. La trasmissione di divulgazione scientifica sarebbe stata simbioticamente legata alla sigla, la “Air for G String” di Bach, eseguita da The Swingle Singers, pubblicata nell’album “Jazz Sèbastian Bach” (1963), peraltro incisa anche insieme al Modern Jazz Quartet in “Place Vendòme”, album del ’68 della Philips. Terminiamo questa breve carrellata, che non include per sintesi le emittenti private/commerciali pro-tempore, per ricordare la sigla swing di DOC Musica e altro a denominazione d’origine controllata (1987-1988) di Arbore, Telesforo e Monica Nannini, esempio di come coinvolgere il jazz in un contenitore di buona musica. Il breve excursus è stato uno squarcio fugace su una jazz age, grossomodo racchiusa fra ’54 e ’94, un fugace momento di (bel) spaesizzazione musicale segnato, al proprio interno, dal passaggio dall’analogico al digitale, fase che precedeva la successiva della tv satellite e quella attuale della connessione via internet con la diffusione dei social e di new media come le web-tv con piattaforme on demand. E’ stato osservato che nella tv generalista di oggi “il jazz non ha più la stessa presa pubblica di un tempo” (cfr. Il jazz e le sigle radiotelevisive, riccardofacchi.wordpress.com, 2/8/2016). E “CiakClub.it” ha pubblicato, a firma di Alberto Candiani, un elenco con Le 20 migliori sigle televisive di sempre: Da Friends a Il trono di spade la lista delle più affascinanti iconiche e meglio congeniate sigle delle serie tv senza che ne compaia qualcuna (simil)jazz. Vero! Ci sono molti set televisivi in cui il jazz fa comparse episodiche. C’è poi che, a causa dell’affinarsi delle tecnologie digitali, molte sigle vengono confezionate a tavolino e, perdendo in istantaneità, sono sempre meno frutto di incisioni live né tantomeno vengono selezionate fra materiali preesistenti. Ed è forse tutto ciò che ammanta quei “primi quarant’anni” di tv “eterea” di un irripetibile sapore amarcord.
Dal giornalismo d’inchiesta a quello sportivo: nel ’78 era il turno di Jazz Band di Hengel Gualdi a far da “preludio” a Novantesimo minuto, storica rubrica di RaiSport, e come non citare, dal campionario di La Domenica Sportiva, “Dribbling” di Piero Umiliani (1967), “Winning The West” della Buddy Rich Big Band (1973), “Mexico” di Danilo Rea e Roberto Gatto (1985), “Breakout” di Spyro Gira (1991)? Spostandoci alla “pagina” spettacoli, fra il ’76 e il ‘78, Rete 2 dava spazio in Odeon al pianista Keith Emerson (senza Lake e Palmer) in “Odeon Rag” arrangiamento di “Maple Leaf Rag” di Scott Joplin, subentrato in luogo del precedente “Honky Tonk Train Blues”, autore il pianista Meade Lux Lewis. Il filone spettacolistico avrebbe registrato più in là significativi esempi con lo scat di Lucio Dalla con gli Stadio che annuncia Lunedifilm per un buon ventennio fino al 2002 e l’ellingtoniano “Take The A Train” di Strayhorn a fare da intro ai trailer cinematografici assemblati da AnicaFlash per la rassegna delle novità cinematografiche “di stagione”. Si diceva come luogo fertile per la semina tv di suoni jazz da filtrare nelle orecchie dei telespettatori fosse l’informazione. Gettonatissima rimane al riguardo la sigla di Mixer (1980-1996) ovvero “Jazz Carnival” dei brasiliani Azimuth, specialisti del samba doido, genere fusion-funky. Latin come nelle radiocronache di Tutto il calcio minuto per minuto, dove Herb Alpert e Tijuana Brass interpretano “A Taste of Honey”, brano di stampo pop, in repertorio a Beatles e Giganti (“In paese è festa”). Per la tv italiana va ricordato che, fuori dal reticolo giornalistico, si contano altre occasioni più dirette di esposizione per la musica jazz filtrata tramite il piccolo schermo. La Portobello Jazz Band di Lino Patruno “presentava” il programma di Enzo Tortora (cfr. La tana delle sigle in tds.sigletv.net) nel 1978, stesso anno dello sceneggiato in 3 puntate Jazz Band di Pupi Avati, colonna sonora di Amedeo Tommasi, con il clarino di Hengel Gualdi in evidenza nelle sigle di apertura e chiusura, “Jazz Band” e “Swing Time” ; poi ancora Di Jazz in Jazz, programma “dedicato” con relativa sigla a cura dell’Orchestra Big Band della Rai diretta da Giampiero Boneschi e Franco Cerri (www.teche.rai.it). “Schegge”, queste ultime, che costituivano una vetrina per il jazz di casa nostra in una situazione in cui il format varietà si teneva alquanto distante, a differenza di quanto avveniva negli U.S.A. . Dalle nostre parti vanno citati comunque Milleluci, show datato 1974, nella cui sigla finale “Non gioco più” Mina duetta con l’armonica di Toots Thielemans, Palcoscenico, in onda fra 1980 e 1981, con Milva accompagnata da Astor Piazzolla mentre scorrono i titoli di coda in “Fumo e odore di caffè” e Premiatissima del 1985 dove il crooner Johnny Dorelli canta “La cosa si fa“ su base swing “metropolitano. Lo sdoganamento delle sigle jazz nei varietà proseguiva con Renzo Arbore (e Gegè Telesforo) a cui si deve “Smorza e’ lights (Such a night)” incipit di Telepatria International, inizio trasmissioni il 6 dicembre 1981 (www.arboristeria.it – Renzo Arbore Channel). Per la cronaca il 18 marzo 1981, e fino al 1989, sarebbe andata in onda la prima edizione di Quark di Piero Angela, conduttore nonché apprezzato pianista jazz. La trasmissione di divulgazione scientifica sarebbe stata simbioticamente legata alla sigla, la “Air for G String” di Bach, eseguita da The Swingle Singers, pubblicata nell’album “Jazz Sèbastian Bach” (1963), peraltro incisa anche insieme al Modern Jazz Quartet in “Place Vendòme”, album del ’68 della Philips. Terminiamo questa breve carrellata, che non include per sintesi le emittenti private/commerciali pro-tempore, per ricordare la sigla swing di DOC Musica e altro a denominazione d’origine controllata (1987-1988) di Arbore, Telesforo e Monica Nannini, esempio di come coinvolgere il jazz in un contenitore di buona musica. Il breve excursus è stato uno squarcio fugace su una jazz age, grossomodo racchiusa fra ’54 e ’94, un fugace momento di (bel) spaesizzazione musicale segnato, al proprio interno, dal passaggio dall’analogico al digitale, fase che precedeva la successiva della tv satellite e quella attuale della connessione via internet con la diffusione dei social e di new media come le web-tv con piattaforme on demand. E’ stato osservato che nella tv generalista di oggi “il jazz non ha più la stessa presa pubblica di un tempo” (cfr. Il jazz e le sigle radiotelevisive, riccardofacchi.wordpress.com, 2/8/2016). E “CiakClub.it” ha pubblicato, a firma di Alberto Candiani, un elenco con Le 20 migliori sigle televisive di sempre: Da Friends a Il trono di spade la lista delle più affascinanti iconiche e meglio congeniate sigle delle serie tv senza che ne compaia qualcuna (simil)jazz. Vero! Ci sono molti set televisivi in cui il jazz fa comparse episodiche. C’è poi che, a causa dell’affinarsi delle tecnologie digitali, molte sigle vengono confezionate a tavolino e, perdendo in istantaneità, sono sempre meno frutto di incisioni live né tantomeno vengono selezionate fra materiali preesistenti. Ed è forse tutto ciò che ammanta quei “primi quarant’anni” di tv “eterea” di un irripetibile sapore amarcord.

 Debutto discografico per Chiara Pelloni, con Eve, album a marchio Caligola Records, che “racconta” di una donna in un viaggio verso la Spagna le cui tappe sono costituite da otto canzoni: un’interprete di sé stessa, essendo anche “liricista” oltre che autrice musicale di brani eseguiti con Matteo Pontegavelli (tr.), Alvaro Zarzuela (tr.ne), Francesco Salmaso (sax ten.), Lorenzo Mazzochetti (p), Francesco Zaccanti (cb) e Riccardo Cocetti (dr.), formazione ben assortita che “pedina” il canto con discrezione. Ed una voce, quella della Pelloni, che lascia insinuare venature pop sul sostrato armonico costruitole attorno con un gusto che è tutto jazzistico. Ne vengon fuori pezzi eterei come “Eve” e “Rebirth”, intimi come “First Peace”, ballad intense come “Blue Colored Streets” e “Please Love Me Too”, latin moderati come “Vega” e poi “Memories of You” omonimo della song di Benny Goodman, infine l’accorata “Quello che conta”. Dunque il suo approdo biennale nei Paesi Baschi, dove si è perfezionata con Deborah Carter, non ci ha restituito souvenir di cante hondo o similia. Chiara è ripartita da lì portandosi appresso un bagaglio di “canzoni di viaggio” in cui ha saputo descrivere stati d’animo ed emozioni prima ancora che paesaggi e skilines. Just like the jazz.
Debutto discografico per Chiara Pelloni, con Eve, album a marchio Caligola Records, che “racconta” di una donna in un viaggio verso la Spagna le cui tappe sono costituite da otto canzoni: un’interprete di sé stessa, essendo anche “liricista” oltre che autrice musicale di brani eseguiti con Matteo Pontegavelli (tr.), Alvaro Zarzuela (tr.ne), Francesco Salmaso (sax ten.), Lorenzo Mazzochetti (p), Francesco Zaccanti (cb) e Riccardo Cocetti (dr.), formazione ben assortita che “pedina” il canto con discrezione. Ed una voce, quella della Pelloni, che lascia insinuare venature pop sul sostrato armonico costruitole attorno con un gusto che è tutto jazzistico. Ne vengon fuori pezzi eterei come “Eve” e “Rebirth”, intimi come “First Peace”, ballad intense come “Blue Colored Streets” e “Please Love Me Too”, latin moderati come “Vega” e poi “Memories of You” omonimo della song di Benny Goodman, infine l’accorata “Quello che conta”. Dunque il suo approdo biennale nei Paesi Baschi, dove si è perfezionata con Deborah Carter, non ci ha restituito souvenir di cante hondo o similia. Chiara è ripartita da lì portandosi appresso un bagaglio di “canzoni di viaggio” in cui ha saputo descrivere stati d’animo ed emozioni prima ancora che paesaggi e skilines. Just like the jazz. Sarebbe forse più opportuno tradurre “Up on A Tightrope”, titolo del primo album da leader di Marta Giuliani, come La corda tesa e non Sul filo del rasoio. La vocalist marchigiana presenta infatti nove propri brani in cui, più che la tensione, è la ricerca di equilibrio ad esser protagonista. Un po’ come Il funambolo che lei canta, su testo di Giovanni Paladini che firma anche “Il cielo dei Rojava” : “non è magia, non è pazzia / questo sogno che / sopra un filo va / alto sulle ali”. L’idea espressa è quella di un percorso graduale che compie con degli amici con cui condivide lo spirito creativo e il senso del procedere con un’incertezza che, alla prova dei fatti musicali, si fa sicurezza. Ed è quella da cui traspare l’impronta di fertile autrice di partiture, di testi poeticamente validi – a partire dall’iniziale “Fleeting Beauty” – e di arrangiamenti dalle soluzioni armoniche spesso inedite, di interprete avvezza all’improvvisazione “senza fili”, di bussola del combo formato da Nico Tangherlini al piano, Gabriele Pesaresi al contrabbasso e Andrea Elisei alla batteria, rete protettiva per Marta, trapezista della voce. Da sentire, in proposito, le elucubrazioni virtuosistiche di “Colibri’ e, in “So What if I Fall?”, i raddoppi voce-tastiera. Ma piacciono anche la sospensione aerea di “Clouds”, il solo nervoso del piano. Pregevole la traduzione in musica di “Beneath The Mask” del poeta afroamericano Paul Laurence Dunbar.
Sarebbe forse più opportuno tradurre “Up on A Tightrope”, titolo del primo album da leader di Marta Giuliani, come La corda tesa e non Sul filo del rasoio. La vocalist marchigiana presenta infatti nove propri brani in cui, più che la tensione, è la ricerca di equilibrio ad esser protagonista. Un po’ come Il funambolo che lei canta, su testo di Giovanni Paladini che firma anche “Il cielo dei Rojava” : “non è magia, non è pazzia / questo sogno che / sopra un filo va / alto sulle ali”. L’idea espressa è quella di un percorso graduale che compie con degli amici con cui condivide lo spirito creativo e il senso del procedere con un’incertezza che, alla prova dei fatti musicali, si fa sicurezza. Ed è quella da cui traspare l’impronta di fertile autrice di partiture, di testi poeticamente validi – a partire dall’iniziale “Fleeting Beauty” – e di arrangiamenti dalle soluzioni armoniche spesso inedite, di interprete avvezza all’improvvisazione “senza fili”, di bussola del combo formato da Nico Tangherlini al piano, Gabriele Pesaresi al contrabbasso e Andrea Elisei alla batteria, rete protettiva per Marta, trapezista della voce. Da sentire, in proposito, le elucubrazioni virtuosistiche di “Colibri’ e, in “So What if I Fall?”, i raddoppi voce-tastiera. Ma piacciono anche la sospensione aerea di “Clouds”, il solo nervoso del piano. Pregevole la traduzione in musica di “Beneath The Mask” del poeta afroamericano Paul Laurence Dunbar. Nei festival di poesia in genere la forma di dialogo fra musica e poesia più praticata è il reading, pronipote del settecentesco “recitativo accompagnato” laddove si declama mentre scorrono note musicali a commento della declamazione. Per contro in molte performances musicali accade che sia la musica a prevalere lasciando l’intermezzo poetico a far da corollario. L’unione paritetica fra le due arti, sperimentata ab initio dagli antichi greci, trova ancora oggi delle occasioni di sperimentazione. Ed è quanto fatto da Stefano Battaglia in seno al Laboratorio Permanente di Ricerca Musicale a Siena Jazz. Un risultato, incentrato nello specifico sul gemellaggio fra Improvvisazione e poesia, è l’album Questo Tempo, della Da Vinci Jazz, in cui quattro musicisti si cimentano davanti a una breve antologia poetica novecentesca e contemporanea di matrice femminile con l’intento di “sonorizzarla” e “vocalizzarla”. Protagonisti del lavoro, oltre al ricordato pianista, la cantante Beatrice Arrigoni, il vibrafonista Nazareno Caputo e il batterista Luca Di Battista. Un’operazione avventurosa, quella di congiungere parametri musicali e metriche versicolari ma soprattutto due tipi di ispirazione, appunto poetica e musicale, che nell’ordinarietà seguono iter autonomi. Il quadrivio improvvisativo incrocia disinvoltamente il proprio comporre istantaneo a liriche di Chandra Livia Candiani, Amelia Rosselli, Margherita Guidacci, Paola Loreto, Laura Pugno, Anna Maria Ortese dando così luogo ad una galleria di “poete” in cui, saltato il passaggio del testo scritto, le liriche si adagiano su un letto naturale di suono e canto, gioia e pathos, antico e moderno, disteso loro dalla musicista bergamasca che ha eletto e riletto Questo Tempo: che è, scrive Laura Pugno, “lana bianca che cade dalle mani / non si chiude il vestito / la sabbia nella mente ha formato la perla / e non ha luce”.
Nei festival di poesia in genere la forma di dialogo fra musica e poesia più praticata è il reading, pronipote del settecentesco “recitativo accompagnato” laddove si declama mentre scorrono note musicali a commento della declamazione. Per contro in molte performances musicali accade che sia la musica a prevalere lasciando l’intermezzo poetico a far da corollario. L’unione paritetica fra le due arti, sperimentata ab initio dagli antichi greci, trova ancora oggi delle occasioni di sperimentazione. Ed è quanto fatto da Stefano Battaglia in seno al Laboratorio Permanente di Ricerca Musicale a Siena Jazz. Un risultato, incentrato nello specifico sul gemellaggio fra Improvvisazione e poesia, è l’album Questo Tempo, della Da Vinci Jazz, in cui quattro musicisti si cimentano davanti a una breve antologia poetica novecentesca e contemporanea di matrice femminile con l’intento di “sonorizzarla” e “vocalizzarla”. Protagonisti del lavoro, oltre al ricordato pianista, la cantante Beatrice Arrigoni, il vibrafonista Nazareno Caputo e il batterista Luca Di Battista. Un’operazione avventurosa, quella di congiungere parametri musicali e metriche versicolari ma soprattutto due tipi di ispirazione, appunto poetica e musicale, che nell’ordinarietà seguono iter autonomi. Il quadrivio improvvisativo incrocia disinvoltamente il proprio comporre istantaneo a liriche di Chandra Livia Candiani, Amelia Rosselli, Margherita Guidacci, Paola Loreto, Laura Pugno, Anna Maria Ortese dando così luogo ad una galleria di “poete” in cui, saltato il passaggio del testo scritto, le liriche si adagiano su un letto naturale di suono e canto, gioia e pathos, antico e moderno, disteso loro dalla musicista bergamasca che ha eletto e riletto Questo Tempo: che è, scrive Laura Pugno, “lana bianca che cade dalle mani / non si chiude il vestito / la sabbia nella mente ha formato la perla / e non ha luce”. L’opera lirica in formato cameristico, priva cioè di apparato scenico, sfavillio dei costumi, movenze attoriali dei cantanti, tessitura corale presuppone, da parte di interpreti e pubblico, una concentrazione mirata sulla musica “sola”, spoglia della cornice di “spettacolo totale” propria di quel tipo di messinscena. Il che, con i limiti del caso, alla fine può anche rivelarsi un’esaltante estrapolazione del momento compositivo. Dal canto loro i jazzisti che vi si confrontino senza voler sconfinare nella provocazione o ancor più nella dissacrazione, si trovano di fronte alla necessità di effettuare una scelta sul limite entro cui contenere la novità dell’arrangiamento, la libertà interpretativa e la creatività dell’improvvisazione senza incorrere nel peccato di lesa … Melodia. La vocalist Paola Arnesano e il fisarmonicista Vince Abbracciante, nell’album Opera! edito da Dodicilune Records, contemperano il rispetto dello spirito originario della partitura con il loro specifico approccio jazz. Dal corposo “songbook” operistico il duo ha prelevato musiche di Rossini Donizetti Bellini Verdi Leoncavallo Cilea Puccini, divinità dell’Olimpo melodrammatico, e seguendo le stecche di un ventaglio che va dal (pre)romanticismo al verismo alle suggestioni espressive del primo novecento, le ha riproposte con gusto personale ed accorto dosaggio delle componenti in campo. La Arnesano – musicista ferrata in latin e ben vocata per gli standards – ed Abbracciante – nomen omen se si pensa all’abbraccio multistyle della sua fisarmonica – hanno avvolto un involucro canoro/sonoro pertinente sia pure con alcune “zone franche” a mò di antiossidanti pietre filosofali che rimodellano arie immortali. Si va da un balcaneggiante “Io Son Docile” tratto dal “Barbiere”, alla rarefatta “Ecco Respiro Appena” ripresa dalla “Adriana Lecouvreur”, da “O Mio Babbino Caro”, fonte “Gianni Schicchi”, reso a swing, al pathos di “Vesti la Giubba”, maschera tragica di “Pagliacci”. E’ un altalenare fra i colori tenui di “Ieri Son Salita Tutta Sola” dalla “Butterfly” ed il volteggiare vocale su base sincopata di “Sempre Libera Degg’io” da “La Traviata” che è anche un inno alla varietà del Repertorio Lirico Nazionale e nel contempo alla sua unicità. C’è spazio per il walzer a tinte folk di “Mercè, Dilette Amiche” da “I Vespri Siciliani” ed il “Quando Men Vo” da “La Bohème” trasformato in chanson. Fra le chicche l’aria “Di Tal Amor Che Dirsi” da “Il Trovatore” in cui le volute belcantistiche si rivelano legittime antenate del vocalese e, dalla “Tosca”, le due perle “Vissi D’arte” ed “E Lucean le Stelle”. Non potevano mancare la “Norma” con “Casta Diva” e “Lucrezia Borgia” con “Il Segreto Per esser Felici” a completare quest’omaggio ad una nostra tradizione tuttora pulsante.
L’opera lirica in formato cameristico, priva cioè di apparato scenico, sfavillio dei costumi, movenze attoriali dei cantanti, tessitura corale presuppone, da parte di interpreti e pubblico, una concentrazione mirata sulla musica “sola”, spoglia della cornice di “spettacolo totale” propria di quel tipo di messinscena. Il che, con i limiti del caso, alla fine può anche rivelarsi un’esaltante estrapolazione del momento compositivo. Dal canto loro i jazzisti che vi si confrontino senza voler sconfinare nella provocazione o ancor più nella dissacrazione, si trovano di fronte alla necessità di effettuare una scelta sul limite entro cui contenere la novità dell’arrangiamento, la libertà interpretativa e la creatività dell’improvvisazione senza incorrere nel peccato di lesa … Melodia. La vocalist Paola Arnesano e il fisarmonicista Vince Abbracciante, nell’album Opera! edito da Dodicilune Records, contemperano il rispetto dello spirito originario della partitura con il loro specifico approccio jazz. Dal corposo “songbook” operistico il duo ha prelevato musiche di Rossini Donizetti Bellini Verdi Leoncavallo Cilea Puccini, divinità dell’Olimpo melodrammatico, e seguendo le stecche di un ventaglio che va dal (pre)romanticismo al verismo alle suggestioni espressive del primo novecento, le ha riproposte con gusto personale ed accorto dosaggio delle componenti in campo. La Arnesano – musicista ferrata in latin e ben vocata per gli standards – ed Abbracciante – nomen omen se si pensa all’abbraccio multistyle della sua fisarmonica – hanno avvolto un involucro canoro/sonoro pertinente sia pure con alcune “zone franche” a mò di antiossidanti pietre filosofali che rimodellano arie immortali. Si va da un balcaneggiante “Io Son Docile” tratto dal “Barbiere”, alla rarefatta “Ecco Respiro Appena” ripresa dalla “Adriana Lecouvreur”, da “O Mio Babbino Caro”, fonte “Gianni Schicchi”, reso a swing, al pathos di “Vesti la Giubba”, maschera tragica di “Pagliacci”. E’ un altalenare fra i colori tenui di “Ieri Son Salita Tutta Sola” dalla “Butterfly” ed il volteggiare vocale su base sincopata di “Sempre Libera Degg’io” da “La Traviata” che è anche un inno alla varietà del Repertorio Lirico Nazionale e nel contempo alla sua unicità. C’è spazio per il walzer a tinte folk di “Mercè, Dilette Amiche” da “I Vespri Siciliani” ed il “Quando Men Vo” da “La Bohème” trasformato in chanson. Fra le chicche l’aria “Di Tal Amor Che Dirsi” da “Il Trovatore” in cui le volute belcantistiche si rivelano legittime antenate del vocalese e, dalla “Tosca”, le due perle “Vissi D’arte” ed “E Lucean le Stelle”. Non potevano mancare la “Norma” con “Casta Diva” e “Lucrezia Borgia” con “Il Segreto Per esser Felici” a completare quest’omaggio ad una nostra tradizione tuttora pulsante. The Princess Theatre di Vanessa Tagliabue Yorke (Azzurra Music) è album che vanta un legame ideale con il piccolo (meno di 300 posti) Teatro della Principessa della 39ma strada a New York, una struttura che, un paio d’anni dopo l’apertura nel 1913 e per un buon quadriennio, ospitò shows in formato “medium” a confronto dei reboanti musical di Broadway. Fu allora che, a causa della ristrettezza degli spazi, Jerome Kern fu obbligato a formulare melodie con le orchestrazioni di Frank Sadler scritte per ensembles non numerosi, forgiando così quell’innovativo e snello teatro musicale “americano” dell’epoca che si associa al team autoriale Kern, Guy Bolton, P.G. Wodehouse. Quello che la vocalist rievoca, a distanza di un secolo e passa e dopo due anni di pandemia, è il senso della spazialità ridotta, che non è angustia, e che “costringe” a pensare la musica in modo più raccolto e introspettivo. Ed è con questi occhiali che va interpretata la tracklist in cui accanto a brani di Strayhorn (“A flower is a Lovesome Thing”), Carmichael (“Stardust”), Green (“I Cover The Waterfront”), Kern (“The Way To Look Tonight”), Kitchings-Herzog jr (“Some Other Springs”), la Tagliabue “liricizza” Strayhorn (“Ballad for Very Tired and Very Sad Lotus Eaters”) o “musicalizza” Yeats (“Aedh Wishes for the Cloths of Heaven”). Va da sé che il disco non è costruito in laboratorio ma è il live del concerto tenutosi a Malcesine (VR) lo scorso 19 dicembre 2021 in cui figura al piano l’esperto Paolo Birro, peraltro coautore di “Leon”, con gli interventi della tromba di Fabrizio Bosso in “I’ve Stolen” e “Dream” e nel citato pezzo ripreso da Yeats dove il trombettista figura come coautore. Non c’è di che scegliere fra la Tagliabue autrice di “Ever” o “Don’t Leave Me” con la jazzista che completa il quadro armonico, elegante e forbito, di un pianista del livello di Birro. Tutto è al suo posto, quello ottimale per la dimensione del Princess Theatre in quel 1915-18, al riparo dai lontani venti di guerra che ancora oggi come allora soffiano e che la buona musica riesce a placare.
The Princess Theatre di Vanessa Tagliabue Yorke (Azzurra Music) è album che vanta un legame ideale con il piccolo (meno di 300 posti) Teatro della Principessa della 39ma strada a New York, una struttura che, un paio d’anni dopo l’apertura nel 1913 e per un buon quadriennio, ospitò shows in formato “medium” a confronto dei reboanti musical di Broadway. Fu allora che, a causa della ristrettezza degli spazi, Jerome Kern fu obbligato a formulare melodie con le orchestrazioni di Frank Sadler scritte per ensembles non numerosi, forgiando così quell’innovativo e snello teatro musicale “americano” dell’epoca che si associa al team autoriale Kern, Guy Bolton, P.G. Wodehouse. Quello che la vocalist rievoca, a distanza di un secolo e passa e dopo due anni di pandemia, è il senso della spazialità ridotta, che non è angustia, e che “costringe” a pensare la musica in modo più raccolto e introspettivo. Ed è con questi occhiali che va interpretata la tracklist in cui accanto a brani di Strayhorn (“A flower is a Lovesome Thing”), Carmichael (“Stardust”), Green (“I Cover The Waterfront”), Kern (“The Way To Look Tonight”), Kitchings-Herzog jr (“Some Other Springs”), la Tagliabue “liricizza” Strayhorn (“Ballad for Very Tired and Very Sad Lotus Eaters”) o “musicalizza” Yeats (“Aedh Wishes for the Cloths of Heaven”). Va da sé che il disco non è costruito in laboratorio ma è il live del concerto tenutosi a Malcesine (VR) lo scorso 19 dicembre 2021 in cui figura al piano l’esperto Paolo Birro, peraltro coautore di “Leon”, con gli interventi della tromba di Fabrizio Bosso in “I’ve Stolen” e “Dream” e nel citato pezzo ripreso da Yeats dove il trombettista figura come coautore. Non c’è di che scegliere fra la Tagliabue autrice di “Ever” o “Don’t Leave Me” con la jazzista che completa il quadro armonico, elegante e forbito, di un pianista del livello di Birro. Tutto è al suo posto, quello ottimale per la dimensione del Princess Theatre in quel 1915-18, al riparo dai lontani venti di guerra che ancora oggi come allora soffiano e che la buona musica riesce a placare. L’assenza di suono, come dimostrato da John Cage, non esiste. E neanche la pausa musicale, di per sé, è sinonimo di vuoto totale. Per questo un album che si denomini Silence, come quello della vocalist Sonia Spinello e del pianista Roberto Olzer editato da Abeat, prefigura comunque delle note o comunque delle vibrazioni che giungono al “pianoforte segreto” del nostro orecchio. E non è luogo di afasie nientificazioni o rumori ma vi fluiscono semmai consonanze sussurrate, accennate, sviluppate, interagite con il violino di Eloisa Manera e il violoncello di Daniela Savoldi oltre al soprano di Massimo Valentini in “Consequences” ed al bansuri di Andrea Zaninetti in “Tell Me”. Questo lavoro, che nasce sulla scia dei cd Abeat “Steppin’ Out” e “Wonderland”, premiato in Giappone nel 2017 come miglior album vocale dalla rivista “Critique Magazine”, nel collocarsi fra le fenditure di world music, ambient jazz e classico-moderna, regala delle occasioni di “copertura” armonica del silenzio mantenendone l’aura sullo sfondo. A voler sceverare fra la dozzina di brani del compact non si può non sottolineare la bellezza di “Softly”, i colori intimi di “Silence”, la poeticità di “Attimi”, ma è tutto il mondo sonoro evocato dai musicisti a far da contrappunto al silenzio per il sound unico di questo disco candidato, ancora una volta, a proiettarsi sul proscenio internazionale.
L’assenza di suono, come dimostrato da John Cage, non esiste. E neanche la pausa musicale, di per sé, è sinonimo di vuoto totale. Per questo un album che si denomini Silence, come quello della vocalist Sonia Spinello e del pianista Roberto Olzer editato da Abeat, prefigura comunque delle note o comunque delle vibrazioni che giungono al “pianoforte segreto” del nostro orecchio. E non è luogo di afasie nientificazioni o rumori ma vi fluiscono semmai consonanze sussurrate, accennate, sviluppate, interagite con il violino di Eloisa Manera e il violoncello di Daniela Savoldi oltre al soprano di Massimo Valentini in “Consequences” ed al bansuri di Andrea Zaninetti in “Tell Me”. Questo lavoro, che nasce sulla scia dei cd Abeat “Steppin’ Out” e “Wonderland”, premiato in Giappone nel 2017 come miglior album vocale dalla rivista “Critique Magazine”, nel collocarsi fra le fenditure di world music, ambient jazz e classico-moderna, regala delle occasioni di “copertura” armonica del silenzio mantenendone l’aura sullo sfondo. A voler sceverare fra la dozzina di brani del compact non si può non sottolineare la bellezza di “Softly”, i colori intimi di “Silence”, la poeticità di “Attimi”, ma è tutto il mondo sonoro evocato dai musicisti a far da contrappunto al silenzio per il sound unico di questo disco candidato, ancora una volta, a proiettarsi sul proscenio internazionale. Gli Hermanos della cantante Barbara Casini, nell’album edito da Encore, sono il sassofonista Javier Girotto, il chitarrista Roberto Taufic e il pianista Seby Burgio. Fior di musicisti che partecipano all’esecuzione, oltre che con il proprio strumento, con interventi mirati come la quena di Girotto in “Hurry” dell’uruguagio Fattoruso e in “Tonada de Luna Llena” del venezuelano Simòn Diaz, la voce di Taufic in “Pasarero” di Carlos Aguirre, di Rosario, e in “Maria Landò” di Granda e Calvo in cui si sentono le claps di Burgio. Ma gli Hermanos di una Casini in gran spolvero di latin imbevuto da sempre nelle corde vocali li vediamo anche nella figura stratosferica del brasiliano Milton Nascimento che ha scritto “Milagre dos Peixes” con Fernando Brant e che il 4et interpreta mirabilmente in chiusura al disco. Una “squadra” di fuoriclasse con Taufic, nato in Honduras ma cresciuto in Brasile, l’italo-argentino Girotto e il siciliano Burgio che si affianca alla musicista fiorentina con in spalla il background di retaggi conoscenze e abilità, con intatto il proprio schietto versante jazz, ed un repertorio ricercato, vedansi “La Puerta” del messicano Luis Demetrio, “Candombe de la Azotea” e “La Maza” del grande Silvio Rodriguez. Non manca il “suo” Toninho Horta con “Viver de Amor” (cofirmata Bastos) e “Zamba de Carnaval” dell’argentino Cuchi Leguizamòn. Autori che configurano un orizzonte su cui la Casini impregna linee melodiche che tratteggiano il continente centrosudamericano senza cesura fra mpb e spanish tinge.
Gli Hermanos della cantante Barbara Casini, nell’album edito da Encore, sono il sassofonista Javier Girotto, il chitarrista Roberto Taufic e il pianista Seby Burgio. Fior di musicisti che partecipano all’esecuzione, oltre che con il proprio strumento, con interventi mirati come la quena di Girotto in “Hurry” dell’uruguagio Fattoruso e in “Tonada de Luna Llena” del venezuelano Simòn Diaz, la voce di Taufic in “Pasarero” di Carlos Aguirre, di Rosario, e in “Maria Landò” di Granda e Calvo in cui si sentono le claps di Burgio. Ma gli Hermanos di una Casini in gran spolvero di latin imbevuto da sempre nelle corde vocali li vediamo anche nella figura stratosferica del brasiliano Milton Nascimento che ha scritto “Milagre dos Peixes” con Fernando Brant e che il 4et interpreta mirabilmente in chiusura al disco. Una “squadra” di fuoriclasse con Taufic, nato in Honduras ma cresciuto in Brasile, l’italo-argentino Girotto e il siciliano Burgio che si affianca alla musicista fiorentina con in spalla il background di retaggi conoscenze e abilità, con intatto il proprio schietto versante jazz, ed un repertorio ricercato, vedansi “La Puerta” del messicano Luis Demetrio, “Candombe de la Azotea” e “La Maza” del grande Silvio Rodriguez. Non manca il “suo” Toninho Horta con “Viver de Amor” (cofirmata Bastos) e “Zamba de Carnaval” dell’argentino Cuchi Leguizamòn. Autori che configurano un orizzonte su cui la Casini impregna linee melodiche che tratteggiano il continente centrosudamericano senza cesura fra mpb e spanish tinge.

 Il 13, sempre alla Cavea, appuntamento con una vera e propria leggenda del jazz: Herbie Hancock. Spesso si adopera la parola “leggenda” in modo esagerato ma nel caso in questione non v’è dubbio alcuno che il termine sia più che appropriato. Non è questa la sede adatta per sintetizzare un curriculum assolutamente straordinario; basti solo dire che l’artista di Chicago, oggi ottantunenne, ha attraversato, sempre da protagonista, generi e mode come performer, compositore, arrangiatore, produttore, scopritore di talenti, inventore di nuove tendenze, senza mai perdere una coerenza di fondo. A Roma si è presentato alla testa di una band eccezionale completata da Terence Blanchard alla tromba, Lionel Loueke (chitarra), James Genus (basso) e Justin Tyson (batteria). Ascoltare un concerto di Hancock è come rivivere, in sintesi, buona parte della storia del jazz dal momento che questo artista ha sviluppato un’estetica giocata sempre su una sorta di doppio binario: da un canto virtuoso pianista del jazz acustico, dall’altro estimatore se non fondatore del funky elettronico. E questi due aspetti della sua personalità sono apparsi evidenti anche nel concerto romano; così in una prima parte abbiamo ascoltato alcuni classici del jazz come il sempre verde “Footprints” di Wayne Shorter, un altro giovanotto di 89 anni, omaggiato da Hancock che si alternava al piano e alle tastiere non disdegnando un ricorso mai esagerato al vocoder (ma che comunque se non ci fosse stato nulla avrebbe tolto alla validità del concerto). Nella seconda parte Hancock si richiamava al suo coté più funky e chiudeva il concerto con “Chameleon” brano tratto dal celebre album “Head Hunters” del 1973, scatenando l’entusiasmo del pubblico che si è accalcato a ballare sotto il palco.
Il 13, sempre alla Cavea, appuntamento con una vera e propria leggenda del jazz: Herbie Hancock. Spesso si adopera la parola “leggenda” in modo esagerato ma nel caso in questione non v’è dubbio alcuno che il termine sia più che appropriato. Non è questa la sede adatta per sintetizzare un curriculum assolutamente straordinario; basti solo dire che l’artista di Chicago, oggi ottantunenne, ha attraversato, sempre da protagonista, generi e mode come performer, compositore, arrangiatore, produttore, scopritore di talenti, inventore di nuove tendenze, senza mai perdere una coerenza di fondo. A Roma si è presentato alla testa di una band eccezionale completata da Terence Blanchard alla tromba, Lionel Loueke (chitarra), James Genus (basso) e Justin Tyson (batteria). Ascoltare un concerto di Hancock è come rivivere, in sintesi, buona parte della storia del jazz dal momento che questo artista ha sviluppato un’estetica giocata sempre su una sorta di doppio binario: da un canto virtuoso pianista del jazz acustico, dall’altro estimatore se non fondatore del funky elettronico. E questi due aspetti della sua personalità sono apparsi evidenti anche nel concerto romano; così in una prima parte abbiamo ascoltato alcuni classici del jazz come il sempre verde “Footprints” di Wayne Shorter, un altro giovanotto di 89 anni, omaggiato da Hancock che si alternava al piano e alle tastiere non disdegnando un ricorso mai esagerato al vocoder (ma che comunque se non ci fosse stato nulla avrebbe tolto alla validità del concerto). Nella seconda parte Hancock si richiamava al suo coté più funky e chiudeva il concerto con “Chameleon” brano tratto dal celebre album “Head Hunters” del 1973, scatenando l’entusiasmo del pubblico che si è accalcato a ballare sotto il palco. Il 12 luglio una vecchia e cara conoscenza del pubblico romano: John Scofield. Il chitarrista può a ben ragione essere considerato una delle massime espressioni della chitarra jazz degli ultimi decenni. Musicista eclettico, voglioso sempre di sperimentare strade nuove, questa volta si è presentato con un progetto del tutto nuovo, “Yankee Go Home”, con cui torna alle radici del rock americano, riscoprendo classici fra il folk e il rock’n’roll. Accanto a lui Jon Cowherd (pianoforte e tastiere), Vicente Archer (contrabbasso)e Josh Dion (batteria). E’ lo stesso Scofield a illustrare il senso di questo nuovo progetto, non senza elogiare i suoi compagni di viaggio: “L’idea –afferma Scofield – è di coprire successi americani/rock e canzoni folk jazz, più alcuni dei miei brani originali scritti in quel modo. Mi sto riconnettendo con molte delle mie radici Rock ‘n Roll da adolescente, naturalmente colorate dai miei 50 anni di pratica Jazz…. Questi ragazzi sono straordinariamente versatili, altrettanto bravi quando si tratta di suonare in modo interattivo e creativo. Stiamo esplorando rock, funk, country, jazz e musica libera e ci divertiamo moltissimo. Sono entusiasta di questa collaborazione”. Risultato raggiunto? Assolutamente sì; il repertorio, comprendente brani tra gli altri di Bob Dylan, Neil Young, Grateful Dead, B.B. King, Buddy Holly, viene declinato attraverso quella maestria strumentale che ben conosciamo oramai da tanti anni. Scofield è sempre lì a tessere le fila del discorso, con un solismo preciso, elegante, raffinato mai soverchiante cosicché tutti i suoi compagni di viaggio hanno la possibilità di mettersi in luce. I vari pezzi vengono riletti alla luce di quelle esperienze cui lo stesso Scofield faceva riferimento ridando loro una sorta di nuova linfa e il pubblico dimostra di apprezzare con lunghi appalusi a scena aperta. Immancabile il bis: un coinvolgente blues che evidenzia come Scofield rimanga solidamente ancorato anche alle radici della musica afro-americana.
Il 12 luglio una vecchia e cara conoscenza del pubblico romano: John Scofield. Il chitarrista può a ben ragione essere considerato una delle massime espressioni della chitarra jazz degli ultimi decenni. Musicista eclettico, voglioso sempre di sperimentare strade nuove, questa volta si è presentato con un progetto del tutto nuovo, “Yankee Go Home”, con cui torna alle radici del rock americano, riscoprendo classici fra il folk e il rock’n’roll. Accanto a lui Jon Cowherd (pianoforte e tastiere), Vicente Archer (contrabbasso)e Josh Dion (batteria). E’ lo stesso Scofield a illustrare il senso di questo nuovo progetto, non senza elogiare i suoi compagni di viaggio: “L’idea –afferma Scofield – è di coprire successi americani/rock e canzoni folk jazz, più alcuni dei miei brani originali scritti in quel modo. Mi sto riconnettendo con molte delle mie radici Rock ‘n Roll da adolescente, naturalmente colorate dai miei 50 anni di pratica Jazz…. Questi ragazzi sono straordinariamente versatili, altrettanto bravi quando si tratta di suonare in modo interattivo e creativo. Stiamo esplorando rock, funk, country, jazz e musica libera e ci divertiamo moltissimo. Sono entusiasta di questa collaborazione”. Risultato raggiunto? Assolutamente sì; il repertorio, comprendente brani tra gli altri di Bob Dylan, Neil Young, Grateful Dead, B.B. King, Buddy Holly, viene declinato attraverso quella maestria strumentale che ben conosciamo oramai da tanti anni. Scofield è sempre lì a tessere le fila del discorso, con un solismo preciso, elegante, raffinato mai soverchiante cosicché tutti i suoi compagni di viaggio hanno la possibilità di mettersi in luce. I vari pezzi vengono riletti alla luce di quelle esperienze cui lo stesso Scofield faceva riferimento ridando loro una sorta di nuova linfa e il pubblico dimostra di apprezzare con lunghi appalusi a scena aperta. Immancabile il bis: un coinvolgente blues che evidenzia come Scofield rimanga solidamente ancorato anche alle radici della musica afro-americana. La band inizia a suonare senza presentare alcunché; McCraven è uomo di poche parole, e non si concede quasi mai pause, tranne una ogni tre pezzi circa per presentare e ringraziare la sua band e per annunciare – qualche volta – il nome del prossimo pezzo. Per il resto è stata una serata di pura musica ed energia: non solo di McCraven, il cui vigore era pari alla sua abilità – mai sentito un batterista che suonasse per circa un’ora e mezza, senza mai smettere di percuotere pelli e piatti con tanta ininterrotta energia – ma anche di tutti gli altri musicisti, che durante il concerto si cimentavano con diversi tipi di percussioni. Altra nota di merito va alla varietà di brani suonati: si passa da pezzi ormai diventati standard del jazz, come “Autumn in New York”, Frank’s Tune” di Frank Strzier o “A Slice of the Top” a pezzi originali di McCraven, come “In These Times”, “The Bounce!” e un inedito tratto dal suo prossimo album in uscita a settembre.
La band inizia a suonare senza presentare alcunché; McCraven è uomo di poche parole, e non si concede quasi mai pause, tranne una ogni tre pezzi circa per presentare e ringraziare la sua band e per annunciare – qualche volta – il nome del prossimo pezzo. Per il resto è stata una serata di pura musica ed energia: non solo di McCraven, il cui vigore era pari alla sua abilità – mai sentito un batterista che suonasse per circa un’ora e mezza, senza mai smettere di percuotere pelli e piatti con tanta ininterrotta energia – ma anche di tutti gli altri musicisti, che durante il concerto si cimentavano con diversi tipi di percussioni. Altra nota di merito va alla varietà di brani suonati: si passa da pezzi ormai diventati standard del jazz, come “Autumn in New York”, Frank’s Tune” di Frank Strzier o “A Slice of the Top” a pezzi originali di McCraven, come “In These Times”, “The Bounce!” e un inedito tratto dal suo prossimo album in uscita a settembre. Il 23 la Casa de Jazz proponeva un quesito intrigante: può la sofisticata poetica di un Pieranunzi coniugarsi con l’incredibile carica energetica di Antonello Salis? In altri termini possono coesistere due musicisti stilisticamente quasi all’opposto, uniti solo dalla grande passione e dedizione alla musica? Ciò perché il concerto in programma prevedeva per l’appunto un duo di piano composto da questi due artisti che mai avevano avuto modo di incontrarsi sul palco. Grande attesa, quindi, e non a caso grande affluenza di pubblico…ripagato da un concerto sicuramente interessante. Seduti l’uno di fronte all’altro i due hanno suonato per circa un’ora e mezza sciorinando un’intesa che non era facile prevedere. Spesso si partiva da un tema che veniva sviluppato, esaminato, sviscerato fin nelle sue più intime pieghe e quindi riproposto in una veste totalmente diversa che traeva nelle capacità improvvisative dei due nuova linfa vitale. E questa volta non si può dire che l’uno si sia piegato alle esigenze dell’altro in quanto ambedue hanno sviluppato appieno le proprie tematiche che finivano con l’incontrarsi su un terreno ben frequentato sia da Enrico sia da Antonello: l’improvvisazione pura o forse meglio la capacità di creare musica strada facendo. In effetti, oltre che partire da un dato tema, i due si sono spesso avventurati anche sul foglio bianco, vale a dire cominciando a suonare senza conoscere il punto di approdo, con una maestria che solo pochi posseggono.
Il 23 la Casa de Jazz proponeva un quesito intrigante: può la sofisticata poetica di un Pieranunzi coniugarsi con l’incredibile carica energetica di Antonello Salis? In altri termini possono coesistere due musicisti stilisticamente quasi all’opposto, uniti solo dalla grande passione e dedizione alla musica? Ciò perché il concerto in programma prevedeva per l’appunto un duo di piano composto da questi due artisti che mai avevano avuto modo di incontrarsi sul palco. Grande attesa, quindi, e non a caso grande affluenza di pubblico…ripagato da un concerto sicuramente interessante. Seduti l’uno di fronte all’altro i due hanno suonato per circa un’ora e mezza sciorinando un’intesa che non era facile prevedere. Spesso si partiva da un tema che veniva sviluppato, esaminato, sviscerato fin nelle sue più intime pieghe e quindi riproposto in una veste totalmente diversa che traeva nelle capacità improvvisative dei due nuova linfa vitale. E questa volta non si può dire che l’uno si sia piegato alle esigenze dell’altro in quanto ambedue hanno sviluppato appieno le proprie tematiche che finivano con l’incontrarsi su un terreno ben frequentato sia da Enrico sia da Antonello: l’improvvisazione pura o forse meglio la capacità di creare musica strada facendo. In effetti, oltre che partire da un dato tema, i due si sono spesso avventurati anche sul foglio bianco, vale a dire cominciando a suonare senza conoscere il punto di approdo, con una maestria che solo pochi posseggono. Guidati dal funambolico sassofonista Shabaka Hutchings, il quartetto (completato dal basso tuba di Theon Cross e ben due batterie nelle mani di Eddie Hick e della giovanissima e bravissima Jas Keyser in sostituzione di Tom Skinner in tour con Thom Yorke) ha sciorinato una musica di grande intensità, basata sul fitto tappeto ritmico intessuto dalle due batterie su cui svolgevano i loro interventi i due fiati. In particolare il sax del leader, spesso effettato con delay o reverberi, non disegnava lunghe linee melodiche ma intonava frasi ritmiche e frammenti melodici ripetuti più volte mentre il basso tuba contribuiva in maniera determinante a completare il tessuto ritmico delle due batterie. Il tutto ‘condito’ da un volume molto, molto elevato a creare una musica che raggiungesse l’obiettivo di portare al massimo l’eccitazione dell’uditorio e di coinvolgerlo in una sorta di rito collettivo in cui i richiami all’Africa erano ben evidenti. Si tenga presente che il concerto si è sviluppato su una linea di continuità ininterrotta tranne due momenti in cui Shabaka Hutchings ha imbracciato un flauto di legno per intonare una splendida melodia di origine africana e il tubista si è espresso in solitudine. Obiettivo raggiunto? Quanto al coinvolgimento direi proprio di sì… anche se non al cento per cento. Nel senso che, ad esempio, il vostro cronista non si è sentito coinvolto dalla musica dei Sons of Kemet. Ed il perché non è difficile da spiegare: avendo avuto la fortuna di ascoltare anche dal vivo alcuni dei più grandi musicisti – per intenderci quelli che hanno scritto davvero la storia del jazz – non è facile lasciarsi impressionare da qualcuno che pur suonando bene non raggiunge quei vertici cui prima si faceva riferimento. Quanto ai messaggi che questa musica così aggressiva intende veicolare, ci viene in soccorso lo stesso Shabaka Hutchings affermando che “Black to the Future (ultimo album del gruppo) è un poema sonoro di invocazione del potere, del ricordo e della guarigione. Raffigura un movimento, quello della ridefinizione e riaffermazione di cosa significa lottare per il black power”. Ma anche sotto questo aspetto non riusciamo a vedere una grande novità dal momento che il jazz come musica di protesta non è certo cosa di oggi.
Guidati dal funambolico sassofonista Shabaka Hutchings, il quartetto (completato dal basso tuba di Theon Cross e ben due batterie nelle mani di Eddie Hick e della giovanissima e bravissima Jas Keyser in sostituzione di Tom Skinner in tour con Thom Yorke) ha sciorinato una musica di grande intensità, basata sul fitto tappeto ritmico intessuto dalle due batterie su cui svolgevano i loro interventi i due fiati. In particolare il sax del leader, spesso effettato con delay o reverberi, non disegnava lunghe linee melodiche ma intonava frasi ritmiche e frammenti melodici ripetuti più volte mentre il basso tuba contribuiva in maniera determinante a completare il tessuto ritmico delle due batterie. Il tutto ‘condito’ da un volume molto, molto elevato a creare una musica che raggiungesse l’obiettivo di portare al massimo l’eccitazione dell’uditorio e di coinvolgerlo in una sorta di rito collettivo in cui i richiami all’Africa erano ben evidenti. Si tenga presente che il concerto si è sviluppato su una linea di continuità ininterrotta tranne due momenti in cui Shabaka Hutchings ha imbracciato un flauto di legno per intonare una splendida melodia di origine africana e il tubista si è espresso in solitudine. Obiettivo raggiunto? Quanto al coinvolgimento direi proprio di sì… anche se non al cento per cento. Nel senso che, ad esempio, il vostro cronista non si è sentito coinvolto dalla musica dei Sons of Kemet. Ed il perché non è difficile da spiegare: avendo avuto la fortuna di ascoltare anche dal vivo alcuni dei più grandi musicisti – per intenderci quelli che hanno scritto davvero la storia del jazz – non è facile lasciarsi impressionare da qualcuno che pur suonando bene non raggiunge quei vertici cui prima si faceva riferimento. Quanto ai messaggi che questa musica così aggressiva intende veicolare, ci viene in soccorso lo stesso Shabaka Hutchings affermando che “Black to the Future (ultimo album del gruppo) è un poema sonoro di invocazione del potere, del ricordo e della guarigione. Raffigura un movimento, quello della ridefinizione e riaffermazione di cosa significa lottare per il black power”. Ma anche sotto questo aspetto non riusciamo a vedere una grande novità dal momento che il jazz come musica di protesta non è certo cosa di oggi. Smaltita la sbornia dell’“Afrofuturism” (così viene definita la musica di Sons of Kemet da chi se ne intende), ecco il 27 sempre alla Casa del Jazz, la giovane e brava sassofonista Nubya Garcia, reduce dallo straordinario successo ottenuto dal suo primo album “Source” su etichetta Concord. Bel concerto questo con una musica sì proiettata verso il futuro ma sempre memore di ciò che il jazz ha rappresentato fino ad oggi. Anche la Garcia viene fuori dalla tumultuosa scena londinese di questi ultimi anni affermandosi passo dopo passo come una delle strumentiste più preparate e fantasiose del pur vasto panorama. In effetti Nubya frequenta il sax da tanti anni riuscendo così a raggiungere una tecnica tutt’altro che banale, una tecnica comunque sempre messa al servizio dell’espressività e di una concezione musicale fortemente inclusiva dal momento che nelle sue performances sono ben riscontrabili echi di jazz spirituale, dub, reggae, ritmi latini e suoni africani. Così il concerto si è sviluppato lungo modalità contrassegnate da notevoli assolo non solo della leader ma anche del pianista-tastierista Alastair MacSween mentre la sezione ritmica (Daniel Casimir contrabbasso e Sam Jones batteria) forniva un supporto sempre preciso, puntuale, propositivo. E a proposito di ritmo, da sottolineare la sensualità dei ritmi colombiani rinverdita dalla Nubya nella riproposizione di uno dei brani più riusciti dell’intera serata, “La Cumbia Me Está Llamando”, scritta con il trio colombiano al femminile “La Perla”.
Smaltita la sbornia dell’“Afrofuturism” (così viene definita la musica di Sons of Kemet da chi se ne intende), ecco il 27 sempre alla Casa del Jazz, la giovane e brava sassofonista Nubya Garcia, reduce dallo straordinario successo ottenuto dal suo primo album “Source” su etichetta Concord. Bel concerto questo con una musica sì proiettata verso il futuro ma sempre memore di ciò che il jazz ha rappresentato fino ad oggi. Anche la Garcia viene fuori dalla tumultuosa scena londinese di questi ultimi anni affermandosi passo dopo passo come una delle strumentiste più preparate e fantasiose del pur vasto panorama. In effetti Nubya frequenta il sax da tanti anni riuscendo così a raggiungere una tecnica tutt’altro che banale, una tecnica comunque sempre messa al servizio dell’espressività e di una concezione musicale fortemente inclusiva dal momento che nelle sue performances sono ben riscontrabili echi di jazz spirituale, dub, reggae, ritmi latini e suoni africani. Così il concerto si è sviluppato lungo modalità contrassegnate da notevoli assolo non solo della leader ma anche del pianista-tastierista Alastair MacSween mentre la sezione ritmica (Daniel Casimir contrabbasso e Sam Jones batteria) forniva un supporto sempre preciso, puntuale, propositivo. E a proposito di ritmo, da sottolineare la sensualità dei ritmi colombiani rinverdita dalla Nubya nella riproposizione di uno dei brani più riusciti dell’intera serata, “La Cumbia Me Está Llamando”, scritta con il trio colombiano al femminile “La Perla”.











 Jon Balke Siwan – “Hafla” – ECM
Jon Balke Siwan – “Hafla” – ECM Flavio Boltro, Fabio Giachino – “Things to Say” – Cam Jazz
Flavio Boltro, Fabio Giachino – “Things to Say” – Cam Jazz Avishai Cohen – “Naked Truth” – ECM
Avishai Cohen – “Naked Truth” – ECM Claudio Cojaniz – “Orfani” – Caligola
Claudio Cojaniz – “Orfani” – Caligola Lorenzo De Finti Quartet – “Mysterium Lunae” – Losen
Lorenzo De Finti Quartet – “Mysterium Lunae” – Losen Joey DeFrancesco – “More Music” – Mack Avenue
Joey DeFrancesco – “More Music” – Mack Avenue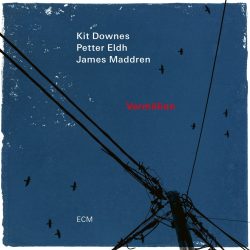 Kit Downes – “Vermillion” – ECM
Kit Downes – “Vermillion” – ECM Mathias Eick – “When We Leave” – ECM
Mathias Eick – “When We Leave” – ECM Antonio Flinta – “Secrets of a Kiri Tree” – Autoprod.
Antonio Flinta – “Secrets of a Kiri Tree” – Autoprod. Tord Gustavsen – “Opening” – ECM
Tord Gustavsen – “Opening” – ECM Roberto Laneri – “Musica finta / Blue Prints” – Da Vinci Classics
Roberto Laneri – “Musica finta / Blue Prints” – Da Vinci Classics “South of No Border” (come si diceva registrato tra il 2014 e il 2018 ma anch’esso pubblicato poche settimane fa) vede Roberto Laneri (clarinetto, clarinetto basso, sax sopranino, sax soprano e alto, didjeridoo, shruti box, voce e percussioni) alla testa di un gruppo comprendente Giuppi Paone voce, Raffaela Siniscalchi voce, Eleonora Vulpiani chitarra, Luigi Polsini contrabbasso e Laugi Marino zarb. Contrariamente al primo album, in questo caso il repertorio è come una sorta di finestra affacciata sulle musiche del mondo. Ecco, quindi, dopo l’apertura affidata alle melodie orientaleggianti di “Malia” (scritta da Laneri), il choro brasiliano “Tico-Tico no fubá” (scritto da Zequinha de Abreu nel 1917, accanto al bolero cubano “Contigo En La Distancia” scritto dal cantautore César Portillo de la Luz quando aveva 24 anni nel 1946, il tutto impreziosito da 4 original del leader. A confronto con un tale repertorio, Laneri dà ancora una volta prova non solo della sua indiscussa preparazione tecnica ma anche della profonda conoscenza del panorama musicale internazionale. Le sue interpretazioni risultano, quindi, assolutamente pertinenti: traendo feconda ispirazione da svariate tradizioni, riesce a produrre una sintesi che non conosce confini geografici grazie ad una concezione visionaria della musica senza barriere. Insomma un disco originale nella concezione e nell’esecuzione.
“South of No Border” (come si diceva registrato tra il 2014 e il 2018 ma anch’esso pubblicato poche settimane fa) vede Roberto Laneri (clarinetto, clarinetto basso, sax sopranino, sax soprano e alto, didjeridoo, shruti box, voce e percussioni) alla testa di un gruppo comprendente Giuppi Paone voce, Raffaela Siniscalchi voce, Eleonora Vulpiani chitarra, Luigi Polsini contrabbasso e Laugi Marino zarb. Contrariamente al primo album, in questo caso il repertorio è come una sorta di finestra affacciata sulle musiche del mondo. Ecco, quindi, dopo l’apertura affidata alle melodie orientaleggianti di “Malia” (scritta da Laneri), il choro brasiliano “Tico-Tico no fubá” (scritto da Zequinha de Abreu nel 1917, accanto al bolero cubano “Contigo En La Distancia” scritto dal cantautore César Portillo de la Luz quando aveva 24 anni nel 1946, il tutto impreziosito da 4 original del leader. A confronto con un tale repertorio, Laneri dà ancora una volta prova non solo della sua indiscussa preparazione tecnica ma anche della profonda conoscenza del panorama musicale internazionale. Le sue interpretazioni risultano, quindi, assolutamente pertinenti: traendo feconda ispirazione da svariate tradizioni, riesce a produrre una sintesi che non conosce confini geografici grazie ad una concezione visionaria della musica senza barriere. Insomma un disco originale nella concezione e nell’esecuzione. Roberto Magris – “Match Point” – JMood / Roberto Magris – “Duo & Trio” – JMood
Roberto Magris – “Match Point” – JMood / Roberto Magris – “Duo & Trio” – JMood Dino & Franco Piana Ensemble – “Reflections” –Alfa Music
Dino & Franco Piana Ensemble – “Reflections” –Alfa Music Valentina Ranalli, Enrico Pieranunzi – “Cantare Pieranunzi” – Alfa Music
Valentina Ranalli, Enrico Pieranunzi – “Cantare Pieranunzi” – Alfa Music Completamente diverso il secondo album – “The Extra Something” – registrato live il 13 e 14 gennaio 2016 al Village Vanguard da un quintetto che vedeva il pianista romano in compagnia di Diego Urcola tromba e trombone (semplicemente straordinario nella title tracke), Seamus Blake sax tenore (particolarmente convincente in “Atoms”), Ben Street basso e Adam Cruz batteria. E per quanti seguono il jazz non c’è bisogno di altre parole per sottolineare il valore assoluto della band. Valore assoluto che si evidenzia in tutto il repertorio, sette brani tutti composti dal pianista. Pieranunzi, come spesso gli capita, è in uno stato di grazie e conduce il gruppo con mano sicura, del tutto consapevole dell’intesa che ha raggiunto con i compagni di viaggio. Dal punto di vista compositivo non scopriamo certo oggi il suo senso della struttura che mai l’abbandona, per cui se consideriamo tutti questi elementi si capisce bene perché il ben noto Brian Morton abbia incluso Enrico tra “i più significativi musicisti contemporanei”. Nelle note di copertina Pieranunzi dedica espressamente questo terzo CD Live at The Village Vanguard a Lorraine Gordon in memoriam, senza la quale né questo né i precedenti due si sarebbero potuti realizzare. Ricordiamo per inciso che il pianista romano è forse l’unico musicista italiano nella veste di leader ed uno dei pochissimi europei ad aver suonato nel leggendario jazz club a forma di diamante aperto da Max Gordon nel 1935 al 178 Seventh Avenue South di Manhattan.
Completamente diverso il secondo album – “The Extra Something” – registrato live il 13 e 14 gennaio 2016 al Village Vanguard da un quintetto che vedeva il pianista romano in compagnia di Diego Urcola tromba e trombone (semplicemente straordinario nella title tracke), Seamus Blake sax tenore (particolarmente convincente in “Atoms”), Ben Street basso e Adam Cruz batteria. E per quanti seguono il jazz non c’è bisogno di altre parole per sottolineare il valore assoluto della band. Valore assoluto che si evidenzia in tutto il repertorio, sette brani tutti composti dal pianista. Pieranunzi, come spesso gli capita, è in uno stato di grazie e conduce il gruppo con mano sicura, del tutto consapevole dell’intesa che ha raggiunto con i compagni di viaggio. Dal punto di vista compositivo non scopriamo certo oggi il suo senso della struttura che mai l’abbandona, per cui se consideriamo tutti questi elementi si capisce bene perché il ben noto Brian Morton abbia incluso Enrico tra “i più significativi musicisti contemporanei”. Nelle note di copertina Pieranunzi dedica espressamente questo terzo CD Live at The Village Vanguard a Lorraine Gordon in memoriam, senza la quale né questo né i precedenti due si sarebbero potuti realizzare. Ricordiamo per inciso che il pianista romano è forse l’unico musicista italiano nella veste di leader ed uno dei pochissimi europei ad aver suonato nel leggendario jazz club a forma di diamante aperto da Max Gordon nel 1935 al 178 Seventh Avenue South di Manhattan. Serena Spedicato – “Io che amo solo te” – Dodicilune
Serena Spedicato – “Io che amo solo te” – Dodicilune Andrés Thor – Hereby – Losen
Andrés Thor – Hereby – Losen Mark Turner – “Return From The Stars” – ECM
Mark Turner – “Return From The Stars” – ECM Cristina Zavalloni – “Parlami di me” – Egea
Cristina Zavalloni – “Parlami di me” – Egea



