da Amedeo Furfaro | 13/Set/2022 | I nostri CD, Primo piano, Recensioni
Si viaggiare. Con i dischi lo si può fare low cost, a rischio zero quanto a code, disdette, scioperi, ritardi, scali, turbolenze e chi ne ha più ne metta. Basta avere gli album giusti dove ci si trova ed un po’ di fantasia da stimolare attraverso l’ascolto. Eccone alcuni di quelli utili a immaginare viaggi virtuali verso mete vicine o lontane.
Parlando di Jazz di Viaggio, non potevamo non iniziare con la recensione di un cd inviataci da un critico musicale italiano che vive da tempo a Hong Kong. Il suo nome è Franco Savadori, esperto di jazz, diplomato al Conservatorio G. Tartini di Trieste in timpani e strumenti a percussione e da oltre 25 anni qualificato mercante d’arte e manager di importanti gallerie. Savadori recensisce il cd dei Green Tea inFusion, gruppo del Nord-Est formatosi di recente che annovera tra i suoi componenti tre veterani della fusion e un giovanissimo talento. (Redazione)
GreenTea inFusion, “GreenTea inFusion” (Autop.)
 È proprio vero: le vecchie abitudini sono dure a morire… E così, in maniera a dir vero inaspettata, spunta questa nuovissima raccolta di tracce sonore svolte ed elaborate dagli immaginifici fratelli Fabris, Franco alle tastiere e Maurizio alle percussioni, integrati, per volere di sincronico destino, dal polistrumentista Gianni Iardino, nonché dal tornito e solido basso del giovanissimo Pietro Liut. Come d’abitudine propria al navigato Franco, non a caso forgiatosi anche sui campi di calcio, anche in questa circostanza è stata data piena preminenza al gioco di squadra collettivo, in un contesto di perfetta parità all’interno dei singoli ruoli esecutivi, per quanto sei degli otto brani incisi siano nati dalla felice vena compositiva di Gianni Iardino, pianista d’estrazione accademica, ma saxofonista per immagamento timbrico, come ben si può cogliere dall’ascolto di questa manciata di acquarelli timbrico-armonici. Una musica, questa, veramente posta in (in)fusione), ove le sensazioni speziate delle sonorità riportano ad un mélange ricco di rimandi, ispirazioni, citazioni appena accennate, fondali sonori che in parte inducono alla nostalgia per gusti antichi, all’improvviso riaffiorati per via retronasale, di quelli celati negli anfratti più reconditi di memorie archiviate, ma mai del tutto sopite. Tutto può accadere, e tutto accade, entro le mura all’apparenza ordinate di questi brani. La celebrazione della post-post-modernità in musica? L’amore per il bricolage di generi, stili e prassi organizzative? Forse, può darsi: ma lungi dall’essere una musica preparata “a tavolino”, questi brani procedono lisci e senza alcuna forzatura proprio al pari d’una suadente e profumata tisana dai risvolti concilianti e dagli intenti lenitivi.
È proprio vero: le vecchie abitudini sono dure a morire… E così, in maniera a dir vero inaspettata, spunta questa nuovissima raccolta di tracce sonore svolte ed elaborate dagli immaginifici fratelli Fabris, Franco alle tastiere e Maurizio alle percussioni, integrati, per volere di sincronico destino, dal polistrumentista Gianni Iardino, nonché dal tornito e solido basso del giovanissimo Pietro Liut. Come d’abitudine propria al navigato Franco, non a caso forgiatosi anche sui campi di calcio, anche in questa circostanza è stata data piena preminenza al gioco di squadra collettivo, in un contesto di perfetta parità all’interno dei singoli ruoli esecutivi, per quanto sei degli otto brani incisi siano nati dalla felice vena compositiva di Gianni Iardino, pianista d’estrazione accademica, ma saxofonista per immagamento timbrico, come ben si può cogliere dall’ascolto di questa manciata di acquarelli timbrico-armonici. Una musica, questa, veramente posta in (in)fusione), ove le sensazioni speziate delle sonorità riportano ad un mélange ricco di rimandi, ispirazioni, citazioni appena accennate, fondali sonori che in parte inducono alla nostalgia per gusti antichi, all’improvviso riaffiorati per via retronasale, di quelli celati negli anfratti più reconditi di memorie archiviate, ma mai del tutto sopite. Tutto può accadere, e tutto accade, entro le mura all’apparenza ordinate di questi brani. La celebrazione della post-post-modernità in musica? L’amore per il bricolage di generi, stili e prassi organizzative? Forse, può darsi: ma lungi dall’essere una musica preparata “a tavolino”, questi brani procedono lisci e senza alcuna forzatura proprio al pari d’una suadente e profumata tisana dai risvolti concilianti e dagli intenti lenitivi.
Queste composizioni sono toccate e benedette dalla capacità comune all’intero gruppo di tendere ad una sorta di laconicità opulenta, tra cetre russe, kalimbe equatoriali, koti estremo orientali e tanto altro ancora, che, ben si noti, trova la propria base nel mozartiano lavoro compiuto da Maurizio Fabris alle percussioni, dove la pesantezza batteristica viene sostituita da una elegantissima levità percussiva, tanto timbricamente varia quanto dinamicamente contenuta nell’alveo della sonorità generale. Bello pure l’intreccio dei fondali, distribuiti tra le tastiere di Franco e Gianni, a supporto del traboccante itinerare del contralto dello stesso Iardino, mai dimentico della passionalità melodica, con probabilità la vera carta vincente della godibilità totale di questo fresco e delicato lavoro. Un’operazione portata a termine da quattro anime empaticamente musicali, il cui scopo primario era quello di riuscire a replicare su CD una musica scaturita per il puro gusto di creare assieme la giusta miscela timbrica per le vostre assetate orecchie. Quindi: buon ascolto e buona bevuta. (Franco Savadori)
*** ed ora, spazio alle recensioni di Amedeo Furfaro
Tatiana Valle & Giovanni Guaccero – “Canto Estrangeiro” – Encore Music
 E’ come se alla storia piacesse … shakerare e sperimentare, nel proprio scorrere, nuovi cocktail. L’alchimia è avvenuta con la musica del Brasile dove la cultura dei conquistadores portoghesi, mixata con “spezie” locali, ha plasmato uno specifico heritage generando forme come choro, maxixe e samba, così “distanti” da fado e fandango, a volerne sottolineare la distanza dall’eredità culturale della madrepatria. Con la quale peraltro il rapporto è continuato ad esistere e vive tuttora in Europa, Italia compresa, a causa dell’approdarvi di artisti brasiliani in analogia ad altri colleghi ispanoamericani. Canto Estrangeiro, album della Encore Music a firma della vocalist Tatiana Valle e del pianista Giovanni Guaccero, è una tela sonora e canora del Brasile fuori dal Brasile, un paese-doppio, un’immagine riflessa richiamata e ricamata da Guaccero sui versi di Luis Elòi Stein a partire da Lingua Minha che precede una dozzina di splendide composizioni. Ne ha scritto la musica da “straniero” che ha assimilato Jobim, de Hollanda, Nascimento, il poeta de Moraes….per un viaggio “di ritorno” verso il Rio Grande do Sul, dal Tevere, il cui “voucher” è un compact carioca curato in ogni particolare. Vi hanno partecipato il batterista Bruno Marcozzi, la flautista Barbara Piperno, il chitarrista-mandolinista Marco Ruviaro, con ospiti Giancarlo Bianchetti alla chitarra elettrica, Henrique Cazes al cavaquinho, Fred Martins al canto, Carlos Cèsar Motta alle percussioni e Francesco Maria Parazzoli al cello. Nell’insieme il Brasile di Guaccero-Stein e della Valle non risulta oleografico né saporifero di vintage bensì è partecipe dell’oggi in ruoli di protagonista fra le nuove correnti della musica tropicale ad influsso jazz che spirano forti oltre l’Atlantico.
E’ come se alla storia piacesse … shakerare e sperimentare, nel proprio scorrere, nuovi cocktail. L’alchimia è avvenuta con la musica del Brasile dove la cultura dei conquistadores portoghesi, mixata con “spezie” locali, ha plasmato uno specifico heritage generando forme come choro, maxixe e samba, così “distanti” da fado e fandango, a volerne sottolineare la distanza dall’eredità culturale della madrepatria. Con la quale peraltro il rapporto è continuato ad esistere e vive tuttora in Europa, Italia compresa, a causa dell’approdarvi di artisti brasiliani in analogia ad altri colleghi ispanoamericani. Canto Estrangeiro, album della Encore Music a firma della vocalist Tatiana Valle e del pianista Giovanni Guaccero, è una tela sonora e canora del Brasile fuori dal Brasile, un paese-doppio, un’immagine riflessa richiamata e ricamata da Guaccero sui versi di Luis Elòi Stein a partire da Lingua Minha che precede una dozzina di splendide composizioni. Ne ha scritto la musica da “straniero” che ha assimilato Jobim, de Hollanda, Nascimento, il poeta de Moraes….per un viaggio “di ritorno” verso il Rio Grande do Sul, dal Tevere, il cui “voucher” è un compact carioca curato in ogni particolare. Vi hanno partecipato il batterista Bruno Marcozzi, la flautista Barbara Piperno, il chitarrista-mandolinista Marco Ruviaro, con ospiti Giancarlo Bianchetti alla chitarra elettrica, Henrique Cazes al cavaquinho, Fred Martins al canto, Carlos Cèsar Motta alle percussioni e Francesco Maria Parazzoli al cello. Nell’insieme il Brasile di Guaccero-Stein e della Valle non risulta oleografico né saporifero di vintage bensì è partecipe dell’oggi in ruoli di protagonista fra le nuove correnti della musica tropicale ad influsso jazz che spirano forti oltre l’Atlantico.
Aiòn – “Me vs Myself” – Alterjinga
 Ricorda a momenti le elucubrazioni fonetiche di Bobby McFerrin l’album di Aiòn Me Vs Myself (Giorgio Pinardi) edito da Alterjinga, per lo scavo, a livello di vocalizzazione, effettuato su realtà musicali remote. Non cambia l’approccio sia che provengano dall’Africa della tribù Dagara in “Yelbongura” o dal gaelico in “Scriob” o dal danese arcaico di “Hyggelig”. C’è, in genere, una “manipolazione” dei materiali musicali trattati – e questo accade ancora in “Leys” – che forse lo stesso Demetrio Stratos oggi non avrebbe disdegnato nelle proprie “investigazioni” tendenti a far “cantare la voce”. Il lavoro continua con “Waldeinsamkeit”, impronunciabile termine tedesco che non ha una diretta traduzione in inglese e che vuol dire essere in connessione con la natura (e con la musica) e con “Rwty” (Sfinge in antico egiziano) a riprova di come, in musica, la ricerca etimologica si possa coniugare con quella etnologica. Chiudono l’album il desertico “Kamtar” quindi “aPHaSIa” (stesso significato in italiano) e “Nèkya” ovverossia la discesa agli inferi dei greci, detta in termini psicanalitici il processo younghiano di scoperta dell’inconscio.
Ricorda a momenti le elucubrazioni fonetiche di Bobby McFerrin l’album di Aiòn Me Vs Myself (Giorgio Pinardi) edito da Alterjinga, per lo scavo, a livello di vocalizzazione, effettuato su realtà musicali remote. Non cambia l’approccio sia che provengano dall’Africa della tribù Dagara in “Yelbongura” o dal gaelico in “Scriob” o dal danese arcaico di “Hyggelig”. C’è, in genere, una “manipolazione” dei materiali musicali trattati – e questo accade ancora in “Leys” – che forse lo stesso Demetrio Stratos oggi non avrebbe disdegnato nelle proprie “investigazioni” tendenti a far “cantare la voce”. Il lavoro continua con “Waldeinsamkeit”, impronunciabile termine tedesco che non ha una diretta traduzione in inglese e che vuol dire essere in connessione con la natura (e con la musica) e con “Rwty” (Sfinge in antico egiziano) a riprova di come, in musica, la ricerca etimologica si possa coniugare con quella etnologica. Chiudono l’album il desertico “Kamtar” quindi “aPHaSIa” (stesso significato in italiano) e “Nèkya” ovverossia la discesa agli inferi dei greci, detta in termini psicanalitici il processo younghiano di scoperta dell’inconscio.
Bincoletto-Vio-Trabucco-Drago – “Duende” – Abeat Records
 Il Duende, per Garcia Lorca, è un imprecisato non so che proprio di alcuni toreri, pittori, poeti, musicisti, uno “stile vivo”, “creaciòn en acto”, fluido irresistibile che arriva al pubblico e che, nei “suoni neri” del jazz, è stato da alcuni associato alla Holiday ed a Miles Davis. Il ribattezzare Duende un progetto discografico, come hanno fatto la vocalist Rita Bincoletto, il chitarrista Diego Vio, il percussionista Max Trabucco e l’ospite Anais Drago, violinista, assume l’intento di traslare la cultura flamenca del poeta spagnolo ricercando le relazioni di quel “potere” nel pianeta liquido del Mediterraneo. La loro traversata geOnirica in un ondoso campo largo li porta fino alla Grecia del traditional “Amygdalaki Tsakisa” ed al Medio Oriente di “Isfahan Trip”; quindi, tramite “Desert Way”, eccoli incrociare figure reali (“Isola”) e mitologiche (“Tres Sirenas”). Un lavoro “waterworld” pubblicato da Abeat Records che consta di nove brani in tutto per la maggior parte scritti e/o arrangiati da Bincoletto, Vio e Trabucco, navigatori fra i suoni marini.
Il Duende, per Garcia Lorca, è un imprecisato non so che proprio di alcuni toreri, pittori, poeti, musicisti, uno “stile vivo”, “creaciòn en acto”, fluido irresistibile che arriva al pubblico e che, nei “suoni neri” del jazz, è stato da alcuni associato alla Holiday ed a Miles Davis. Il ribattezzare Duende un progetto discografico, come hanno fatto la vocalist Rita Bincoletto, il chitarrista Diego Vio, il percussionista Max Trabucco e l’ospite Anais Drago, violinista, assume l’intento di traslare la cultura flamenca del poeta spagnolo ricercando le relazioni di quel “potere” nel pianeta liquido del Mediterraneo. La loro traversata geOnirica in un ondoso campo largo li porta fino alla Grecia del traditional “Amygdalaki Tsakisa” ed al Medio Oriente di “Isfahan Trip”; quindi, tramite “Desert Way”, eccoli incrociare figure reali (“Isola”) e mitologiche (“Tres Sirenas”). Un lavoro “waterworld” pubblicato da Abeat Records che consta di nove brani in tutto per la maggior parte scritti e/o arrangiati da Bincoletto, Vio e Trabucco, navigatori fra i suoni marini.
Vincenzo Caruso – “Chansons sous les Doigts” – Dodicilune
 Chansons sous les doigts è una selezione di 19 canzoni francesi arrangiate per piano da Vincenzo Caruso che ci ricorda quanto ci siano vicini, in musica, i cugini transalpini. Sono tratteggiate, nell’album Dodicilune, in modo essenziale, scarnificate del testo con focus sulla melodia e l’armonizzazione con sensibilità moderna. Caruso se ne innamorò giovanissimo tramite gli spartiti inviatigli dallo zio Antonio Di Domenico, chansonnier ed editore a Parigi, coltivando nel tempo una passione pianistica che lo avrebbe portato a collaborare a Irma la Douce, la famosa commedia musicata da Marguerite Monnot, di cui ripropone nel disco la “Piccola Suite per Piano”. I temi proposti sono di nomi altisonanti come Henry Salvador (“Syracuse”), Gilbert Becaud (“Quand il est mort le poète”), Georges Brassens (“J’ai rendez vous avec vous”) … L’antologia rappresenta un omaggio alla chanson in cui il pianoforte contende lo scettro di strumento principe alla fisarmonica e, nel contempo, ne offre un’ampia gamma – “Le tango corse”, lo swing di “On est pas là pour se faire engueler”, l’incipit musorgskiano di “Comèdie”, il walzer di “Domani”, il distillar note alla Satie di “Le deserteur” – che ne saggia la tavolozza espressiva e coloristica. Il disco è chiuso da “Après l’ourage” che potrebbe, perche no, commentare un film di Méliès, muto, tanto la narrazione è affidata alle dieci dita, les doigts, sulla tastiera.
Chansons sous les doigts è una selezione di 19 canzoni francesi arrangiate per piano da Vincenzo Caruso che ci ricorda quanto ci siano vicini, in musica, i cugini transalpini. Sono tratteggiate, nell’album Dodicilune, in modo essenziale, scarnificate del testo con focus sulla melodia e l’armonizzazione con sensibilità moderna. Caruso se ne innamorò giovanissimo tramite gli spartiti inviatigli dallo zio Antonio Di Domenico, chansonnier ed editore a Parigi, coltivando nel tempo una passione pianistica che lo avrebbe portato a collaborare a Irma la Douce, la famosa commedia musicata da Marguerite Monnot, di cui ripropone nel disco la “Piccola Suite per Piano”. I temi proposti sono di nomi altisonanti come Henry Salvador (“Syracuse”), Gilbert Becaud (“Quand il est mort le poète”), Georges Brassens (“J’ai rendez vous avec vous”) … L’antologia rappresenta un omaggio alla chanson in cui il pianoforte contende lo scettro di strumento principe alla fisarmonica e, nel contempo, ne offre un’ampia gamma – “Le tango corse”, lo swing di “On est pas là pour se faire engueler”, l’incipit musorgskiano di “Comèdie”, il walzer di “Domani”, il distillar note alla Satie di “Le deserteur” – che ne saggia la tavolozza espressiva e coloristica. Il disco è chiuso da “Après l’ourage” che potrebbe, perche no, commentare un film di Méliès, muto, tanto la narrazione è affidata alle dieci dita, les doigts, sulla tastiera.
TMR – “Tuscany Music Revolution” – Aut Records
 Ci sono tre quarti d’ora buoni di musica nell’album TMR Tuscany Music Revolution, prodotto dalla label tedesca Aut Records, divisa in sette parti di durata varia che va dai due agli otto minuti. Ne è protagonista l’Improvvisazione con consonanze (II) e minimalismi (III), africanerie (IV) e simil-musica d’oggi (V)… Il parterre artistico internazionale (V. Sutera, v; M. Mazzini, cl; E. Novali, pf; A. Braida, pf; F. Calcagno, cl; A. Bolzoni, g; L. Pissavini, cb; S. Di Benedetto, cb; D. Koutè (perc); S. Scucces (vib.), G. Lattuada (perc); L. D’Erasmo (frame dr); S. Grasso (dr) non “inscena” un ritorno al postfree semmai si pone in termini di attualizzazione e “rivoluzionaria” evoluzione di quell’area creativa che l’ Europa, Italia compresa, ha espresso anche in anni recenti dall’asse anglo-olandese fin giù a scendere sulla cartina geomusicale. Il collettivo è un esempio di interazione democratica e paritaria che, al pari di stormi liberi ma coordinati, delinea impreviste dinamie sonore e traiettorie mutaforma, in un fluttuare a volte sincronico altre no comunque ancorato alla struttura dei vari insiemi che si avvicendano.
Ci sono tre quarti d’ora buoni di musica nell’album TMR Tuscany Music Revolution, prodotto dalla label tedesca Aut Records, divisa in sette parti di durata varia che va dai due agli otto minuti. Ne è protagonista l’Improvvisazione con consonanze (II) e minimalismi (III), africanerie (IV) e simil-musica d’oggi (V)… Il parterre artistico internazionale (V. Sutera, v; M. Mazzini, cl; E. Novali, pf; A. Braida, pf; F. Calcagno, cl; A. Bolzoni, g; L. Pissavini, cb; S. Di Benedetto, cb; D. Koutè (perc); S. Scucces (vib.), G. Lattuada (perc); L. D’Erasmo (frame dr); S. Grasso (dr) non “inscena” un ritorno al postfree semmai si pone in termini di attualizzazione e “rivoluzionaria” evoluzione di quell’area creativa che l’ Europa, Italia compresa, ha espresso anche in anni recenti dall’asse anglo-olandese fin giù a scendere sulla cartina geomusicale. Il collettivo è un esempio di interazione democratica e paritaria che, al pari di stormi liberi ma coordinati, delinea impreviste dinamie sonore e traiettorie mutaforma, in un fluttuare a volte sincronico altre no comunque ancorato alla struttura dei vari insiemi che si avvicendano.
Pietro Lazazzara – “Gypsy Jazz Style” – Stradivarius
 Il chitarrismo manouche, quello praticato a livelli alti di nomadismo dei polpastrelli, può talora lasciar trasparire una certa patina di “monadismo”, per così dire, quando vi si riscontra unità inclusiva del connotato stilistico di base. E’ il caso dell’album Gypsy Jazz Style di Pietro Lazazzara (Stradivarius), seconda uscita discografica a sua firma, con una dozzina di inediti eseguiti all’insegna della convergenza di varietà e contaminazioni. L’ ensemble annovera Antonio Solazzo al basso, Francesco Clemente e Sabrina Loforese al volino, Maria Pia Lazazzara al violoncello, Luigi Vania alla viola, Nicoletta Di Sabato al flauto e Giuseppe Magistro al tamburello. Campeggia sullo sfondo, sin dal primo brano “Mister Swing”, l’ologramma di Django. Poi la musica, strada facendo, si fa intima in “Precious”, intinta di classico in “La via di Pia”, melò in “Walk with Me”, walzer notturno in “The Tale of the Moon”, flamenco in “La tela di Picasso”, tarant(ell)a in “Puglia”, moderato swing in “Blue Night”, sostenuto in “La joie de vivre”, è balcanica in “Circus”, tutta coracon in “Spanish Boulevard”, infine tripudio di note in “Impro in D Minor” con il gruppo che si trasforma in Gypsy Jazz Style Kings.
Il chitarrismo manouche, quello praticato a livelli alti di nomadismo dei polpastrelli, può talora lasciar trasparire una certa patina di “monadismo”, per così dire, quando vi si riscontra unità inclusiva del connotato stilistico di base. E’ il caso dell’album Gypsy Jazz Style di Pietro Lazazzara (Stradivarius), seconda uscita discografica a sua firma, con una dozzina di inediti eseguiti all’insegna della convergenza di varietà e contaminazioni. L’ ensemble annovera Antonio Solazzo al basso, Francesco Clemente e Sabrina Loforese al volino, Maria Pia Lazazzara al violoncello, Luigi Vania alla viola, Nicoletta Di Sabato al flauto e Giuseppe Magistro al tamburello. Campeggia sullo sfondo, sin dal primo brano “Mister Swing”, l’ologramma di Django. Poi la musica, strada facendo, si fa intima in “Precious”, intinta di classico in “La via di Pia”, melò in “Walk with Me”, walzer notturno in “The Tale of the Moon”, flamenco in “La tela di Picasso”, tarant(ell)a in “Puglia”, moderato swing in “Blue Night”, sostenuto in “La joie de vivre”, è balcanica in “Circus”, tutta coracon in “Spanish Boulevard”, infine tripudio di note in “Impro in D Minor” con il gruppo che si trasforma in Gypsy Jazz Style Kings.
Giovanni Angelini – “Freedom Rhythm” – A.MA Records
 “Voyager” è uno dei brani di punta del secondo album firmato dal batterista Giovanni Angelini dal titolo Freedom Rhythm, otto brani, scritti di proprio pugno, dal groove eclettico che mette assieme jazz funk afro soul e che non disdegna il guardare indietro, fino ai fab ’70. Ovviamente si tratta di un jazzista moderno ma con il piacere di far “viaggiare” la propria musica nello spaziotempo pilotandola da bandleader. Piace pensare che il “ritmo in libertà” sia anche quello del drummer che si svincola, crea, costruisce, si autointerpreta. Ed è infatti la veste di compositore quella che vi rispecchia le qualità di ideatore di strutture compless(iv)e caratterizzate da franca immediatezza e circolarità di un suono plasmato con Vince Abbracciante al piano, Dario Giacovelli al basso, Alberto Parmegiani alla chitarra, Gaetano Partipilo all’alto sax, Giuseppe Todisco alla tromba, Antonio Fallacara al trombone quindi Giovanni Astorino al cello. Ai quali si aggiunge il canto di Simona Severini con la “gemma” di “I Need Your Smile”. La sezione dei tre fiati assume un ruolo energico nello sviluppo dei temi (e nell’alternarsi improvvisativo) dalle linee melodiche che effettivamente rimangono impresse, un po’ tutte, da “Subway” fino a “Unity”, “Release The Monkey”, “Wuelva”, “Compass”, e nel contempo si muovono su scansioni metriche e schemi accordali nient’affatto scontati. Insomma ancora un bel prodotto del catalogo A.Ma Records!
“Voyager” è uno dei brani di punta del secondo album firmato dal batterista Giovanni Angelini dal titolo Freedom Rhythm, otto brani, scritti di proprio pugno, dal groove eclettico che mette assieme jazz funk afro soul e che non disdegna il guardare indietro, fino ai fab ’70. Ovviamente si tratta di un jazzista moderno ma con il piacere di far “viaggiare” la propria musica nello spaziotempo pilotandola da bandleader. Piace pensare che il “ritmo in libertà” sia anche quello del drummer che si svincola, crea, costruisce, si autointerpreta. Ed è infatti la veste di compositore quella che vi rispecchia le qualità di ideatore di strutture compless(iv)e caratterizzate da franca immediatezza e circolarità di un suono plasmato con Vince Abbracciante al piano, Dario Giacovelli al basso, Alberto Parmegiani alla chitarra, Gaetano Partipilo all’alto sax, Giuseppe Todisco alla tromba, Antonio Fallacara al trombone quindi Giovanni Astorino al cello. Ai quali si aggiunge il canto di Simona Severini con la “gemma” di “I Need Your Smile”. La sezione dei tre fiati assume un ruolo energico nello sviluppo dei temi (e nell’alternarsi improvvisativo) dalle linee melodiche che effettivamente rimangono impresse, un po’ tutte, da “Subway” fino a “Unity”, “Release The Monkey”, “Wuelva”, “Compass”, e nel contempo si muovono su scansioni metriche e schemi accordali nient’affatto scontati. Insomma ancora un bel prodotto del catalogo A.Ma Records!
Massimo Barbiero – “In Hora Mortis”
 Con In Hora Mortis la ricerca musicale del percussionista Massimo Barbiero, ancora una volta al confine fra filosofia e psicanalisi, si ritrova ad investigare, per il tramite del suono inteso come elemento vitale primario, il momento terminale del vivere. Un argomento che da Platone a Epicuro a Freud ha appassionato e arrovellato il pensiero umano antico e moderno. Barbiero lo affronta con gli “strumenti” che gli sono più congeniali e cioè quelli del suo ricco set percussivo. Per l’occasione suddivide l’hora in più momenti temporali gradualizzandola secondo una scala emotiva augmentante che non tradisce pathos mortiferi o pianti greci. La musica “domina” la possibile angoscia, la esorcizza, prende atto che i minuti che preludono all’ultimo atto dell’esistenza sono vita tout court e come tali possono essere vissuti magari riprodotti e sonorizzati da gong campane ritmi… Barbiero materializza così la propria “fantasia di sparizione” (Fagioli) in un disco coraggioso per Il tema che affronta e offre una lettura del tutto originale del fine vita che va ad installarsi in un percorso artistico di sperimentata coerenza culturale.
Con In Hora Mortis la ricerca musicale del percussionista Massimo Barbiero, ancora una volta al confine fra filosofia e psicanalisi, si ritrova ad investigare, per il tramite del suono inteso come elemento vitale primario, il momento terminale del vivere. Un argomento che da Platone a Epicuro a Freud ha appassionato e arrovellato il pensiero umano antico e moderno. Barbiero lo affronta con gli “strumenti” che gli sono più congeniali e cioè quelli del suo ricco set percussivo. Per l’occasione suddivide l’hora in più momenti temporali gradualizzandola secondo una scala emotiva augmentante che non tradisce pathos mortiferi o pianti greci. La musica “domina” la possibile angoscia, la esorcizza, prende atto che i minuti che preludono all’ultimo atto dell’esistenza sono vita tout court e come tali possono essere vissuti magari riprodotti e sonorizzati da gong campane ritmi… Barbiero materializza così la propria “fantasia di sparizione” (Fagioli) in un disco coraggioso per Il tema che affronta e offre una lettura del tutto originale del fine vita che va ad installarsi in un percorso artistico di sperimentata coerenza culturale.
Amedeo Furfaro
da Flaviano Bosco | 29/Ago/2022 | News, Primo piano, Recensioni
Pubblichiamo la seconda parte della recensione di Flaviano Bosco sul Festival Internazionale Udin&Jazz, 32esima edizione, svoltosi a Udine dal 25 giugno al 16 luglio 2022 (clicca qui per leggere la prima parte)
Rosa Brunello è una delle certezze della giovane musica italiana. Figlia d’arte, di ottima formazione, è coinvolta in innumerevoli progetti musicali ed ha al proprio attivo molte collaborazioni anche con artisti internazionali. Il suo quintetto è composto da professionisti della sua stessa pasta che in qualche modo gravitano attorno al pianeta creativo dell’estroso trombonista Gianluca Petrella. La contrabbassista ha voluto mettere a frutto le sue innumerevoli esperienze musicali in un’incisione che interpreta le ultime tendenze del jazz che vedono come capofila i soliti giovani leoni della scena inglese con i loro mash-up di elettronica, nu-jazz, free form, Techno, Trance, World Music, tutte etichette giornalistiche che non dicono moltissimo ma che servono a delimitare un oggetto musicale, altrimenti non facilmente definibile. La musicista si è dimostrata coraggiosa e ardita a provarci, certo ha investito molto del suo talento in un progetto che ha buone prospettive ma che, almeno dal vivo, dimostra qualche reticenza o quanto meno il bisogno di essere maggiormente rodato. Comunque l’insieme è una perfetta espressione della forza gentile e del cuore cortese e generoso della giovane, affascinante contrabbassista che forse potrebbe osare di più.
-

-
Rosa Brunello, U&J 32 ph Luca A. d’Agostino
-

-
Rosa Brunello, U&J 32 ph Angelo Salvin
-

-
Al Di Meola, U&J 32 ph Luca A. d’Agostino
-

-
Al Di Meola, U&J 32 ph Angelo Salvin
Completamente fuori registro invece il celebre chitarrista Al Di Meola, la cui esibizione ispirata alle canzoni dei Beatles (Across the Universe) era tra le più attese dell’intera rassegna. Nessuno può mettere in dubbio le sue capacità tecniche e la sua meritata fama a livello mondiale ma a Udine ha dimostrato un’assoluta mancanza di rispetto per il suo pubblico e un’insospettabile irascibilità prendendosela con l’organizzazione e con il service fin dal sound check pomeridiano.
Irritato e risentito, per motivi probabilmente nemmeno chiari a lui stesso, si è fatto attendere per più di un’ora dal pubblico ignaro già in sala. Dopo mille esortazioni e preghiere dell’organizzazione si è deciso a salire sul palco accolto da una selva di fischi e di booo del pubblico che l’aveva tanto atteso. Non si è minimamente scusato rivolgendo parole decisamente insultanti ai tanti paganti accorsi per ascoltare la sua arte. Ne è seguita, naturalmente, un’esibizione nervosa, scostante, sbrigativa e autoreferenziale; il chitarrista ha suonato al peggio di sé con sommo rancore e nessuna empatia. Una serata sbagliata può capitare a tutti ma il chitarrista ha davvero passato il segno.
Molto meglio la serata successiva con la presentazione dell’ultimo lavoro del vulcanico collettivo italiano C’Mon Tigre e quello del Vjay Iyer Trio, incredibile protagonista della scena jazz mondiale.
I primi sono l’esempio perfetto di ciò che si può intendere per musica socialmente impegnata che però non abdica anche alla propria funzione d’intrattenimento. “Scenario”, l’ultimo album dell’ensemble ad organico variabile, vive letteralmente dei suoni della diaspora migrante dei nostri fratelli in cammino lungo le vie della speranza e della libertà. C’Mon Tigre collabora da anni con il fotografo di guerra della Magnum Photos, Paolo Pellegrini, che ha documentato, tra l’altro, il dramma dei profughi delle guerre africane e mediorientali sia sulla rotta balcanica, sia su quella Mediterranea. Con gran gusto estetico per il light design e le coreografie, l’ensemble sonorizza sul palcoscenico quella drammatica esperienza esistenziale, visivamente documentata dalle fotografie, facendo riferimento all’Afrobeat, al indie-rock, alla world music nelle loro declinazioni elettroniche e clubbing in un’atmosfera complessiva che forza le frontiere del jazz fino a dissolverle. Un’esibizione che davvero ha lasciato un segno nel cuore di tutti.
-

-
C’Mon Tigre U&J 32 – ph Luca A. d’Agostino
-

-
C’Mon Tigre U&J 32 – ph Luca A. d’Agostino
-

-
C’Mon Tigre U&J 32 – ph Angelo Salvin
-

-
VIJAY IYER Trio – ph Luca A. d’Agostino
-

-
VIJAY IYER Trio – ph Angelo Salvin
-

-
VIJAY IYER Trio – ph GC Peressotti
Indimenticabile anche il concerto di Vijay Iyer della contrabbassista Linda May Han Ho e del batterista Tyshawn Sorey. Un trio all star di musicisti straordinariamente dotati, al vertice del nuovo jazz a livello planetario. Nemmeno qui sono mancati i riferimenti all’impegno civile e politico della musica. Il pianista ha come modello d’ispirazione primaria l’opera poetica di Amiri Baraka con il quale ebbe una fruttuosa collaborazione. Sappiamo bene quanto fosse radicale la critica al regime capitalistico e schiavistico del poeta afroamericano che nel 2008 fu anch’egli ospite graditissimo di Udin&Jazz. Iyer a proprio modo se ne fa portavoce con una musica tellurica e carica di una bellezza abrasiva e indiavolata che non lascia indifferenti, esplosiva e perfino tribalistica nella sua essenza esplosiva e dirompente. In concerto, il trio s’impegna in lunghissime, compatte e travolgenti suite che sono un’esperienza immersiva e totale per musicisti e pubblico uniti in un percorso interiore di eccezionale valore.
-

-
Max De Tomassi Radio 1 Rai “Torcida” e Ivan Lins – ph Luca A. d’Agostino
-

-
Ivan Lins U&J 32 – Foto Luca A. d’Agostino
-

-
Ivan Lins U&J 32 – ph Angelo Salvin
-

-
Ivan Lins U&J 32 – ph GC Peressotti
-

-
Ivan Lins U&J 32 – Foto Luca A. d’Agostino/Phocus Agency © 2022
-

-
Ivan Lins U&J 32 – ph Luca A. d’Agostino/
Tra le conferme del festival anche quest’anno la “serata brasiliana” ispirata dal conduttore radiofonico Max De Tomassi, grande esperto della musica latinoamericana che durante tutta questa edizione di Udine&Jazz trasmetteva le cronache della rassegna in diretta su Radio Uno RAI nel suo programma estivo “Torcida”.
Il concerto del cantautore Ivan Lins, autentico monumento vivente della musica Popular brasileira, è stato il meraviglioso compimento di un breve interessante percorso tra interviste e approfondimenti che anche quest’anno ha avvicinato il pubblico di Udine all’universo creativo della musica tropicale.
Lins ha deliziato il pubblico con le sue melodie suadenti fatte di lontane nostalgie e dolcezze di caramelle tra sofisticato jazz main stream e ritmi sudamericani del Samba e della Bossa Nova.
-

-
Snarky Puppy U&J 32 – ph Luca A. d’Agostino
-

-
Snarky Puppy U&J 32 – ph Luca A. d’Agostino
-

-
Snarky Puppy U&J 32 – ph Luca A. d’Agostino
-

-
Snarky Puppy U&J 32 – ph Angelo Salvin
-

-
Snarky Puppy U&J 32 – ph Angelo Salvin
-

-
Snarky Puppy U&J 32 – ph GC Peressotti
L’evento finale della rassegna udinese, il concerto degli Snarky Puppy è andato in scena in un gremitissimo Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Centinaia di fan aspettavano con ansia da mesi questo concerto che non ha deluso per nulla le aspettative. Il supergruppo di League e Lawrence ha una preparazione tecnica e una capacità esecutiva fuori dall’ordinario che lascia basiti e ipnotizzati gli ascoltatori. Grandissima e coinvolgente la verve compositiva del gruppo che sul palcoscenico rivela un’energia che fa sognare e ballare e che fin dalle prime note disegna un largo sorriso sul volto di tutti da una parte all’altra del palcoscenico. Generosissimi si sono impegnati in un acclamatissima esibizione, con trionfale, meritata ovazione finale di tutto il teatro giusta conclusione di un festival come sempre tutto maiuscolo.
Dulcis in fundo da non dimenticare due iniziative per nulla minori che rivelano la cifra della manifestazione e le sue prospettive.
Il festival ha attivato un’interessante collaborazione con il collettivo Muud, acronimo di Musica a Udine, che normalmente si occupa di promuovere giovani artisti locali attraverso un canale di podcasting finalizzato alla condivisione di contenuti culturali sui social. Il sodalizio già sperimentato nelle due edizioni Winter di Udin&Jazz, ha trasmesso in diretta streaming interviste e succulenti approfondimenti in deliziosi dopo-concerto in un accogliente pub della notte udinese.
-

-
Muud Podcast – U&J 32 Michael League Snarky Puppy
-

-
Concerto/Laboratorio Jazz Bambini U&J 32 – ph Angelo Salvin
-

-
Concerto/Laboratorio Jazz Bambini U&J 32 – ph Angelo Salvin
-

-
Concerto/Laboratorio Jazz Bambini U&J 32 – ph Angelo Salvin
Di grande significato il gioioso Workshop d’introduzione al Jazz dedicato ai bambini nel quale, attraverso suoni e giochi, i più piccoli hanno giocato con le note blu. La loro fresca, genuina creatività è la migliore garanzia per il futuro della musica; al loro cuore è dedicata ogni emozione, saranno loro a decidere direzione e prospettive, qualunque percorso sceglieranno sarà quello giusto perché apparterrà solo a loro, di tutto il resto avrà ragione il tempo.
In fondo a queste righe è utile ripetere una celebre frase di John Coltrane che come sempre ci esorta a meditare sull’Amore supremo:
“Il Jazz se si vuole chiamarlo così, è un’espressione musicale; e questa musica per me è un’espressione degli ideali più alti: c’è dunque bisogno di Fratellanza, e credo che con la fratellanza non ci sarebbe povertà. E con la fratellanza non ci sarebbe nemmeno la guerra… with brotherhood, there would be no war.”
Flaviano Bosco
A Proposito di Jazz ringrazia Udin&Jazz Festival e il suo ufficio stampa per la collaborazione e i fotografi Luca A. d’Agostino, Angelo Salvin e Gianni Carlo Peressotti per le immagini.
da Amedeo Furfaro | 03/Ago/2022 | Editoriali, News, Primo piano
La televisione è stata spesso oggetto di critiche in quanto possibile veicolo di regresso culturale delle masse. Umberto Eco, a proposito dell’uomo circuìto dai mass media, scriveva che “poiché uno dei compensi narcotici a cui ha diritto è l’evasione nel sogno, gli vengono presentati di solito degli ideali tra lui e quelli con cui si possa stabilire una tensione” (Diario Minimo, 1961). La tematica dei rapporti fra musica e mass media investe anche un genere non definibile “narcotizzante” come il jazz nella sua relazione con la tv. In proposito, in Italia, si sono verificati dei momenti di avvicinamento fra i due termini del rapporto che consentono di abbozzare dei lineamenti di storia televisiva “vista” attraverso il fil rouge delle sigle jazz.
—
Donald Bogle ha osservato che “attorno al 1950 i sets tv arrivavano nelle case degli americani trasformandone gradualmente abitudini e prospettive” (Blacks in American Films and Television, New York, Fireside, 1989). E David Johnson di recente ha annotato che “come la tv si insinuava nell’entertainment dell’America di metà 900, musicisti e compositori, molti con esperienze jazz, venivano chiamati a scrivere temi ed “attacchi” per varietà e programmi” (Heard It On The Tv: Jazz Takes On Television Themes, indianapublicmedia.org, 12/5/2021). Osservazioni in parte trasferibili, con le dovute proporzioni, all’Italia che, dal 1954, dai primi vagiti della neonata tv, subiva il modificarsi di usi, linguaggio, immaginario collettivo in un contesto di rapida trasformazione economica, sociale e culturale, a causa anche alla spinta dei mass media. Su queste colonne, fra le sottotracce della nostra storia televisiva, abbiamo provato a “rintracciare” un argomento abbastanza sottaciuto, quello delle sigle (e intersigle) che sono poi l’antipasto e il post prandium del programma televisivo, nello specifico quelle dialoganti lato sensu in jazz o comunque prodotte od associabili a jazzisti. Come “la radio degli anni Cinquanta è a cavallo tra conservazione e trasformazione” (cfr. sub voce Cultura e educazione, l’Universale Radio, Milano, 2006) così il nuovo medium, già dai primi anni di vita, attenzionava sonorità che erano espressione di differenti musiche del mondo. Su un tale sfondo il jazz riusciva man mano a ritagliarsi spazi nei palinsesti e ad essere presente in filmati, notiziari, dossier, speciali, spot e jingle (cfr. Jazz e pubblicità, “A proposito di Jazz”, 9/4/2021), programmi a quiz, a premi e a cotillon, varietà, sceneggiati e “originali televisivi”, serie tv. Già nell’Italia della ricostruzione postbellica la dimensione locale non più autarchica si era confrontata sulla globale “importando” liberamente musica che durante il regime era proibita. Con l’avvento del medium tv le sigle di fatto fungevano da possibile cavallo di Troia per conquistare al jazz spazio in audio/video e lasciar trapelare le note di Woody Herman, Stan Kenton, Duke Ellington, Toots Thielemans … e vari artefici di una musica che in quegli anni non veniva più percepita solo come intrattenimento omologante bensì anche quale propaggine di quella cultura neroamericana propria di una comunità oppressa non dominante. Una comunità in fibrillante opposizione politica e spiccato antagonismo sociale i cui risvolti rimbalzavano nelle lettere, nelle arti, nella musica. Ma entriamo nel dettaglio. In Italia, nel 1957, coetanea di Carosello, vedeva la luce in tv Telematch. La trasmissione a premi era introdotta dalle note di “Marching Strings” dell’orchestra di Ray Martin, il bandleader di “The Swingin’ Marchin’ Band” (RCA, 1958). Light music, la sua, che rappresentava però un’apertura internazionale verso la musica easy listening d’oltrefrontiera sul Programma Nazionale e in prima serata. Parallelamente, alla radio, nel 1960, Adriano Mazzoletti, da un anno collaboratore della Rai, debuttava con la Coppa del Jazz promuovendo in tal modo una più stabile programmazione in senso jazzistico sul mezzo radiofonico i cui primordi risalgono all’antenato Eiar Jazz del 1929.
 A dire il vero, dopo il primo melodico Sanremo del ’51, una decisa aura jazz si era avvertita in Nati per la Musica, un programma con Jula De Palma, Quartetto Cetra, Teddy Reno che si avvaleva delle orchestre di ritmi moderni di Gorni Kramer e Lelio Luttazzi, la cui sigla è ascoltabile sul Portale della Canzone Italiana dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi (www.canzone italiana.it/1zlns). Sorella Radio avrebbe dato anche in seguito significativi contributi alla causa jazzistica – si pensi all’uso fatto da Radio1 dello stacco di “Country“ tratto dal cd “My Song” di Jarrett con Garbarek, Danielson e Christensen (ECM, 1977) – ma il copioso materiale di Mamma Rai, con il ricchissimo archivio sonoro ad oggi digitalizzato, meriterebbe di essere approfondito in altra sede. Torniamo allora al come eravamo tramite il cosa guardavamo. Dopo la vittoria di Modugno all’Ariston nel ’58, con una “Nel blu dipinto di blu” a ritmo swing, nell’anno di grazia televisivo 1961 passavano in video le immagini di Moderato Swing che era anche il titolo della sigla di Piero Umiliani. Un biennio ancora per poi sentire il canto e la tromba di Nini Rosso echeggiare in “I ragazzi del jazz”, sigla di Fuori I ’Orchestra, epica trasmissione, per la regia di Lino Procacci, che si avvaleva della direzione musicale dello stesso Umiliani. Si trattava di una rubrica che si occupava “di musica equidistante fra quella leggerissima e quella classica“ (www.umiliani.com) che rimane una pietra miliare della televisione italiana. Fra i numeri fissi c’erano quello dedicato al Jazz made in Italy ed l’altro spazio denominato Parole e musica che registrava partecipazioni lussuose tipo la cantante Helen Merrill. Da segnalare che Umiliani avrebbe poi collaborato con I Marc 4 (acronimo di Maurizio Majorana, Antonello Vannucchi, Roberto Podio, Carlo Pes), gruppo operante fra ’60 e ’76, a cui è da ascrivere la sigla di Prima Visione (su album Ricordi, 1974). Il 1963 resta un anno significativo per il jazz sul piccolo schermo anche perché decollava in Italia, con TV7, l’idea di utilizzare un brano jazz come intro di un programma d’inchiesta. Per l’occasione la scelta cadeva su “Intermission Riff” di Stan Kenton, poi sostituita con una storica versione dell’Equipe 84. A fine decennio toccava alla serie tv Nero Wolf diretta da Giuliana Berlinguer con Tino Buazzelli, vedere impressi i titoli di testa e di coda dalla tromba di Nunzio Rotondo sulla base elettronica di Romolo Grano, musica da noir con echi dal lungometraggio di Louis Malle Ascenseur pour l’échafaud, del ’58, sonorizzato da Miles Davis, trombettista a cui Rotondo è stato spesso accostato. Ed avrebbe “aperto” un thriller televisivo il compositore Berto Pisano con la sua “Blue Shadow”, sigla lounge dello sceneggiato Ho incontrato un’ombra del 1974, che figura nella classifica stilata da “Rolling Stone” il 26 agosto 2020 in Fantasmi e storie maledette. Le migliori sigle della tv italiana del mistero degli anni ’70. In tema di rotocalchi da menzionare che AZ un fatto come e perché (in onda dal ‘70 fino al luglio ’76) adottava un pezzo del repertorio jazz, esattamente “Hard to Keep My Mind of You”, di Woody Herman.
A dire il vero, dopo il primo melodico Sanremo del ’51, una decisa aura jazz si era avvertita in Nati per la Musica, un programma con Jula De Palma, Quartetto Cetra, Teddy Reno che si avvaleva delle orchestre di ritmi moderni di Gorni Kramer e Lelio Luttazzi, la cui sigla è ascoltabile sul Portale della Canzone Italiana dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi (www.canzone italiana.it/1zlns). Sorella Radio avrebbe dato anche in seguito significativi contributi alla causa jazzistica – si pensi all’uso fatto da Radio1 dello stacco di “Country“ tratto dal cd “My Song” di Jarrett con Garbarek, Danielson e Christensen (ECM, 1977) – ma il copioso materiale di Mamma Rai, con il ricchissimo archivio sonoro ad oggi digitalizzato, meriterebbe di essere approfondito in altra sede. Torniamo allora al come eravamo tramite il cosa guardavamo. Dopo la vittoria di Modugno all’Ariston nel ’58, con una “Nel blu dipinto di blu” a ritmo swing, nell’anno di grazia televisivo 1961 passavano in video le immagini di Moderato Swing che era anche il titolo della sigla di Piero Umiliani. Un biennio ancora per poi sentire il canto e la tromba di Nini Rosso echeggiare in “I ragazzi del jazz”, sigla di Fuori I ’Orchestra, epica trasmissione, per la regia di Lino Procacci, che si avvaleva della direzione musicale dello stesso Umiliani. Si trattava di una rubrica che si occupava “di musica equidistante fra quella leggerissima e quella classica“ (www.umiliani.com) che rimane una pietra miliare della televisione italiana. Fra i numeri fissi c’erano quello dedicato al Jazz made in Italy ed l’altro spazio denominato Parole e musica che registrava partecipazioni lussuose tipo la cantante Helen Merrill. Da segnalare che Umiliani avrebbe poi collaborato con I Marc 4 (acronimo di Maurizio Majorana, Antonello Vannucchi, Roberto Podio, Carlo Pes), gruppo operante fra ’60 e ’76, a cui è da ascrivere la sigla di Prima Visione (su album Ricordi, 1974). Il 1963 resta un anno significativo per il jazz sul piccolo schermo anche perché decollava in Italia, con TV7, l’idea di utilizzare un brano jazz come intro di un programma d’inchiesta. Per l’occasione la scelta cadeva su “Intermission Riff” di Stan Kenton, poi sostituita con una storica versione dell’Equipe 84. A fine decennio toccava alla serie tv Nero Wolf diretta da Giuliana Berlinguer con Tino Buazzelli, vedere impressi i titoli di testa e di coda dalla tromba di Nunzio Rotondo sulla base elettronica di Romolo Grano, musica da noir con echi dal lungometraggio di Louis Malle Ascenseur pour l’échafaud, del ’58, sonorizzato da Miles Davis, trombettista a cui Rotondo è stato spesso accostato. Ed avrebbe “aperto” un thriller televisivo il compositore Berto Pisano con la sua “Blue Shadow”, sigla lounge dello sceneggiato Ho incontrato un’ombra del 1974, che figura nella classifica stilata da “Rolling Stone” il 26 agosto 2020 in Fantasmi e storie maledette. Le migliori sigle della tv italiana del mistero degli anni ’70. In tema di rotocalchi da menzionare che AZ un fatto come e perché (in onda dal ‘70 fino al luglio ’76) adottava un pezzo del repertorio jazz, esattamente “Hard to Keep My Mind of You”, di Woody Herman.
 Dal giornalismo d’inchiesta a quello sportivo: nel ’78 era il turno di Jazz Band di Hengel Gualdi a far da “preludio” a Novantesimo minuto, storica rubrica di RaiSport, e come non citare, dal campionario di La Domenica Sportiva, “Dribbling” di Piero Umiliani (1967), “Winning The West” della Buddy Rich Big Band (1973), “Mexico” di Danilo Rea e Roberto Gatto (1985), “Breakout” di Spyro Gira (1991)? Spostandoci alla “pagina” spettacoli, fra il ’76 e il ‘78, Rete 2 dava spazio in Odeon al pianista Keith Emerson (senza Lake e Palmer) in “Odeon Rag” arrangiamento di “Maple Leaf Rag” di Scott Joplin, subentrato in luogo del precedente “Honky Tonk Train Blues”, autore il pianista Meade Lux Lewis. Il filone spettacolistico avrebbe registrato più in là significativi esempi con lo scat di Lucio Dalla con gli Stadio che annuncia Lunedifilm per un buon ventennio fino al 2002 e l’ellingtoniano “Take The A Train” di Strayhorn a fare da intro ai trailer cinematografici assemblati da AnicaFlash per la rassegna delle novità cinematografiche “di stagione”. Si diceva come luogo fertile per la semina tv di suoni jazz da filtrare nelle orecchie dei telespettatori fosse l’informazione. Gettonatissima rimane al riguardo la sigla di Mixer (1980-1996) ovvero “Jazz Carnival” dei brasiliani Azimuth, specialisti del samba doido, genere fusion-funky. Latin come nelle radiocronache di Tutto il calcio minuto per minuto, dove Herb Alpert e Tijuana Brass interpretano “A Taste of Honey”, brano di stampo pop, in repertorio a Beatles e Giganti (“In paese è festa”). Per la tv italiana va ricordato che, fuori dal reticolo giornalistico, si contano altre occasioni più dirette di esposizione per la musica jazz filtrata tramite il piccolo schermo. La Portobello Jazz Band di Lino Patruno “presentava” il programma di Enzo Tortora (cfr. La tana delle sigle in tds.sigletv.net) nel 1978, stesso anno dello sceneggiato in 3 puntate Jazz Band di Pupi Avati, colonna sonora di Amedeo Tommasi, con il clarino di Hengel Gualdi in evidenza nelle sigle di apertura e chiusura, “Jazz Band” e “Swing Time” ; poi ancora Di Jazz in Jazz, programma “dedicato” con relativa sigla a cura dell’Orchestra Big Band della Rai diretta da Giampiero Boneschi e Franco Cerri (www.teche.rai.it). “Schegge”, queste ultime, che costituivano una vetrina per il jazz di casa nostra in una situazione in cui il format varietà si teneva alquanto distante, a differenza di quanto avveniva negli U.S.A. . Dalle nostre parti vanno citati comunque Milleluci, show datato 1974, nella cui sigla finale “Non gioco più” Mina duetta con l’armonica di Toots Thielemans, Palcoscenico, in onda fra 1980 e 1981, con Milva accompagnata da Astor Piazzolla mentre scorrono i titoli di coda in “Fumo e odore di caffè” e Premiatissima del 1985 dove il crooner Johnny Dorelli canta “La cosa si fa“ su base swing “metropolitano. Lo sdoganamento delle sigle jazz nei varietà proseguiva con Renzo Arbore (e Gegè Telesforo) a cui si deve “Smorza e’ lights (Such a night)” incipit di Telepatria International, inizio trasmissioni il 6 dicembre 1981 (www.arboristeria.it – Renzo Arbore Channel). Per la cronaca il 18 marzo 1981, e fino al 1989, sarebbe andata in onda la prima edizione di Quark di Piero Angela, conduttore nonché apprezzato pianista jazz. La trasmissione di divulgazione scientifica sarebbe stata simbioticamente legata alla sigla, la “Air for G String” di Bach, eseguita da The Swingle Singers, pubblicata nell’album “Jazz Sèbastian Bach” (1963), peraltro incisa anche insieme al Modern Jazz Quartet in “Place Vendòme”, album del ’68 della Philips. Terminiamo questa breve carrellata, che non include per sintesi le emittenti private/commerciali pro-tempore, per ricordare la sigla swing di DOC Musica e altro a denominazione d’origine controllata (1987-1988) di Arbore, Telesforo e Monica Nannini, esempio di come coinvolgere il jazz in un contenitore di buona musica. Il breve excursus è stato uno squarcio fugace su una jazz age, grossomodo racchiusa fra ’54 e ’94, un fugace momento di (bel) spaesizzazione musicale segnato, al proprio interno, dal passaggio dall’analogico al digitale, fase che precedeva la successiva della tv satellite e quella attuale della connessione via internet con la diffusione dei social e di new media come le web-tv con piattaforme on demand. E’ stato osservato che nella tv generalista di oggi “il jazz non ha più la stessa presa pubblica di un tempo” (cfr. Il jazz e le sigle radiotelevisive, riccardofacchi.wordpress.com, 2/8/2016). E “CiakClub.it” ha pubblicato, a firma di Alberto Candiani, un elenco con Le 20 migliori sigle televisive di sempre: Da Friends a Il trono di spade la lista delle più affascinanti iconiche e meglio congeniate sigle delle serie tv senza che ne compaia qualcuna (simil)jazz. Vero! Ci sono molti set televisivi in cui il jazz fa comparse episodiche. C’è poi che, a causa dell’affinarsi delle tecnologie digitali, molte sigle vengono confezionate a tavolino e, perdendo in istantaneità, sono sempre meno frutto di incisioni live né tantomeno vengono selezionate fra materiali preesistenti. Ed è forse tutto ciò che ammanta quei “primi quarant’anni” di tv “eterea” di un irripetibile sapore amarcord.
Dal giornalismo d’inchiesta a quello sportivo: nel ’78 era il turno di Jazz Band di Hengel Gualdi a far da “preludio” a Novantesimo minuto, storica rubrica di RaiSport, e come non citare, dal campionario di La Domenica Sportiva, “Dribbling” di Piero Umiliani (1967), “Winning The West” della Buddy Rich Big Band (1973), “Mexico” di Danilo Rea e Roberto Gatto (1985), “Breakout” di Spyro Gira (1991)? Spostandoci alla “pagina” spettacoli, fra il ’76 e il ‘78, Rete 2 dava spazio in Odeon al pianista Keith Emerson (senza Lake e Palmer) in “Odeon Rag” arrangiamento di “Maple Leaf Rag” di Scott Joplin, subentrato in luogo del precedente “Honky Tonk Train Blues”, autore il pianista Meade Lux Lewis. Il filone spettacolistico avrebbe registrato più in là significativi esempi con lo scat di Lucio Dalla con gli Stadio che annuncia Lunedifilm per un buon ventennio fino al 2002 e l’ellingtoniano “Take The A Train” di Strayhorn a fare da intro ai trailer cinematografici assemblati da AnicaFlash per la rassegna delle novità cinematografiche “di stagione”. Si diceva come luogo fertile per la semina tv di suoni jazz da filtrare nelle orecchie dei telespettatori fosse l’informazione. Gettonatissima rimane al riguardo la sigla di Mixer (1980-1996) ovvero “Jazz Carnival” dei brasiliani Azimuth, specialisti del samba doido, genere fusion-funky. Latin come nelle radiocronache di Tutto il calcio minuto per minuto, dove Herb Alpert e Tijuana Brass interpretano “A Taste of Honey”, brano di stampo pop, in repertorio a Beatles e Giganti (“In paese è festa”). Per la tv italiana va ricordato che, fuori dal reticolo giornalistico, si contano altre occasioni più dirette di esposizione per la musica jazz filtrata tramite il piccolo schermo. La Portobello Jazz Band di Lino Patruno “presentava” il programma di Enzo Tortora (cfr. La tana delle sigle in tds.sigletv.net) nel 1978, stesso anno dello sceneggiato in 3 puntate Jazz Band di Pupi Avati, colonna sonora di Amedeo Tommasi, con il clarino di Hengel Gualdi in evidenza nelle sigle di apertura e chiusura, “Jazz Band” e “Swing Time” ; poi ancora Di Jazz in Jazz, programma “dedicato” con relativa sigla a cura dell’Orchestra Big Band della Rai diretta da Giampiero Boneschi e Franco Cerri (www.teche.rai.it). “Schegge”, queste ultime, che costituivano una vetrina per il jazz di casa nostra in una situazione in cui il format varietà si teneva alquanto distante, a differenza di quanto avveniva negli U.S.A. . Dalle nostre parti vanno citati comunque Milleluci, show datato 1974, nella cui sigla finale “Non gioco più” Mina duetta con l’armonica di Toots Thielemans, Palcoscenico, in onda fra 1980 e 1981, con Milva accompagnata da Astor Piazzolla mentre scorrono i titoli di coda in “Fumo e odore di caffè” e Premiatissima del 1985 dove il crooner Johnny Dorelli canta “La cosa si fa“ su base swing “metropolitano. Lo sdoganamento delle sigle jazz nei varietà proseguiva con Renzo Arbore (e Gegè Telesforo) a cui si deve “Smorza e’ lights (Such a night)” incipit di Telepatria International, inizio trasmissioni il 6 dicembre 1981 (www.arboristeria.it – Renzo Arbore Channel). Per la cronaca il 18 marzo 1981, e fino al 1989, sarebbe andata in onda la prima edizione di Quark di Piero Angela, conduttore nonché apprezzato pianista jazz. La trasmissione di divulgazione scientifica sarebbe stata simbioticamente legata alla sigla, la “Air for G String” di Bach, eseguita da The Swingle Singers, pubblicata nell’album “Jazz Sèbastian Bach” (1963), peraltro incisa anche insieme al Modern Jazz Quartet in “Place Vendòme”, album del ’68 della Philips. Terminiamo questa breve carrellata, che non include per sintesi le emittenti private/commerciali pro-tempore, per ricordare la sigla swing di DOC Musica e altro a denominazione d’origine controllata (1987-1988) di Arbore, Telesforo e Monica Nannini, esempio di come coinvolgere il jazz in un contenitore di buona musica. Il breve excursus è stato uno squarcio fugace su una jazz age, grossomodo racchiusa fra ’54 e ’94, un fugace momento di (bel) spaesizzazione musicale segnato, al proprio interno, dal passaggio dall’analogico al digitale, fase che precedeva la successiva della tv satellite e quella attuale della connessione via internet con la diffusione dei social e di new media come le web-tv con piattaforme on demand. E’ stato osservato che nella tv generalista di oggi “il jazz non ha più la stessa presa pubblica di un tempo” (cfr. Il jazz e le sigle radiotelevisive, riccardofacchi.wordpress.com, 2/8/2016). E “CiakClub.it” ha pubblicato, a firma di Alberto Candiani, un elenco con Le 20 migliori sigle televisive di sempre: Da Friends a Il trono di spade la lista delle più affascinanti iconiche e meglio congeniate sigle delle serie tv senza che ne compaia qualcuna (simil)jazz. Vero! Ci sono molti set televisivi in cui il jazz fa comparse episodiche. C’è poi che, a causa dell’affinarsi delle tecnologie digitali, molte sigle vengono confezionate a tavolino e, perdendo in istantaneità, sono sempre meno frutto di incisioni live né tantomeno vengono selezionate fra materiali preesistenti. Ed è forse tutto ciò che ammanta quei “primi quarant’anni” di tv “eterea” di un irripetibile sapore amarcord.
Amedeo Furfaro
da Gerlando Gatto | 09/Mag/2022 | I nostri CD, Primo piano, Recensioni
I NOSTRI CD

 Jon Balke Siwan – “Hafla” – ECM
Jon Balke Siwan – “Hafla” – ECM
A distanza di tanti secoli ancora sopravvive il mito di Al-Andalus ovvero di quella Spagna medievale musulmana, in cui sotto la guida di colti principi arabi, musulmani, ebrei e cristiani vivevano tutti insieme senza distinzione alcuna di razza e/o di religione. Ecco, questo mito viene ora riattualizzato dalla musica di Siwan, il collettivo musicale transculturale e trans-idiomatico guidato dal tastierista e compositore norvegese Jon Balke, giunto al suo terzo album dedicato alla materia in oggetto. Questa volta uno accanto all’altro troviamo un musicista kemençe turco (Derya Turkan), un maestro iraniano del tombak (Pedram Khavar Zamini), un batterista norvegese di aperte vedute (Helge Norbakken), una nutrita sezione di archi specialisti del barocco guidata da Bjarte Ejke e una cantante algerina, Mona Boutchebak, che interpreta testi e di Wallada bint al-Mustakfi, la principessa omayyade di Cordoba dell’XI secolo e di altri poeti a lei contemporanei quali Ibn Zaydun (1003-1071, suo appassionato amante) e Ibn Sara As-Santarini (1043-1123). L’album non si presta ad un semplice ascolto né tanto meno ad una facile lettura. Si tratta di musica complessa, caratterizzata da un contesto in cui le parole hanno un peso spesso importante, e da un inusuale impasto sonoro determinato dalla coesistenza di strumenti che appartengono a mondi culturali diversi. Il leader tenta di assemblare il tutto con l’ impegno e la passione che gli sono propri, anche se il risultato non sempre è dei migliori.
 Flavio Boltro, Fabio Giachino – “Things to Say” – Cam Jazz
Flavio Boltro, Fabio Giachino – “Things to Say” – Cam Jazz
Suonare in duo è sempre molto impegnativo, forse più della prova in solitario. Il fatto è che quando ci si esibisce in due occorre che i musicisti si conoscano molto bene e riescano così a precedere le intenzioni l’uno dell’altro sì da assicurare alla musica una fluidità che non conosce intoppi. Ecco, tutto ciò lo si ritrova in questo album interpretato da due grandi jazzisti italiani. Flavio Boltro (classe 1961) è artista oramai maturo che ha raggiunto una perfetta padronanza dello strumento il che gli consente di evidenziare un bel suono, pieno, ricco supportato da un fraseggio mai fine a se stesso e da una indubbia capacità di intonare suadenti linee melodiche. Giachino (classe 1986) è un pianista che ha conquistato pubblico e critica grazie ad uno stile raffinato in cui sottile ironia e padronanza della dinamica si coniugano mirabilmente, il tutto declinato con una personale dimensione dello spazio (lo si ascolti in “Prelude to Salina”). In programma un repertorio tutto composto da original a firma soprattutto di Fabio Giachino il che conferma vieppiù la maturità di questo pianista. Di qui una musica che scorre fluida caratterizzata spesso da notevole intensità emotiva e soprattutto da una perfetta intesa tra i due musicisti che, pur proveniendo da ambienti diversi, riescono a fondere le loro esperienze in un unicum raffinato. Ed è una sensazione che si percepisce immediatamente sin dall’ascolto del primo brano in programma, “Piccola Nina” di Flavio Boltro, sino a quel “Spicy Blues” ancora di Boltro che chiude l’album.
 Avishai Cohen – “Naked Truth” – ECM
Avishai Cohen – “Naked Truth” – ECM
Tra le stelle di primaria grandezza che rifulgono nel panorama jazzistico internazionale, un suo posto di rilievo ce l’ha sicuramente il trombettista israeliano Avishai Cohen. Registrato negli Studios La Buissonne a Pernes-les-Fontaines nel Sud della Francia, nel settembre del 2021, sotto la produzione ECM, l’album ci consegna un Cohen sotto certi aspetti inediti. Abbandonate le atmosfere “elettriche” del precedente album, il trombettista si consegna al suo pubblico in estrema sincerità, con una musica tutta giocata sul coté dell’intimismo e declinata attraverso otto parti di una lunga suite intitolata “Naked Truth” e da un brano conclusivo, “Departure”. Avishai suona con la perizia che ben conosciamo ma è l’atmosfera generale dell’album che, come si diceva, lo proietta in una luce diversa. Perfettamente coadiuvato da Yonathan Avishai al piano, dal bassista Barak Mori e dal batterista Ziv Ravitz, il leader disegna una sorta di percorso che si snoda coerentemente quasi illustrando vari stati d’animo. Così si passa da pezzi di chiara impronta crepuscolare a frammenti in cui la tromba pare schiarirsi e aprirsi ad orizzonti più rosei fino a sfiorare il clima tipico delle ballad.
Da sottolineare come, accanto al leader, suona uno splendido Yonathan Avishai il cui pianoforte si pone come autentico alter-ego del leader prendendo egli stesso in mano il pallino del discorso (si ascolti al riguardo la convincente Part.V).
Come si accennava, il disco si chiude con la poesia “Departure”, dell’autrice israeliana Zelda Schneurson Mishkovsky (1914.1984), recitata dallo stesso Cohen sul tappeto strumentale degli altri musicisti.
 Claudio Cojaniz – “Orfani” – Caligola
Claudio Cojaniz – “Orfani” – Caligola
Poeta della tastiera. Così mi sento di definire Claudio Cojaniz dopo l’ascolto di questo bell’album registrato nell’aprile del 2021 a Treviso dall’oramai rodato quartetto del pianista completato da un sempre straordinario Alessandro Turchet al contrabbasso (a mio avviso uno dei migliori bassisti italiani), Luca Colussi alla batteria e Luca Grizzo percussioni. In repertorio sette composizioni dello stesso Cojaniz. Conosco Claudio oramai da tanti anni ma francamente non so dire con precisione a quali “orfani” si riferisce. Orfani di cosa? Di chi? Personalmente ho avvertito, comunque, nella musica di Cojaniz una sorta di dolore di fondo, di grande malinconia come se l’artista volesse farci riflettere sui tanti guai che in questo momento affliggono l’umanità. Certo, non ci si riferisce alla guerra ché l’album è stato inciso prima, ma resta egualmente la sensazione di un disagio, di un modo di vedere una realtà che non ci piace più di tanto. Ecco, penso che in questo caso il riferimento al blues, non tanto come struttura, ma come musica che rispecchia uno stato d’animo, sia assolutamente presente. E la cosa non stupisce più di tanto ove si tenga presente da un canto la lunga militanza di Cojaniz nell’ambito del jazz (il suo pianismo è ancora una volta coerente, del tutto idoneo alle sue volontà espressive), dall’altro i frequenti richiami africaneggianti che il musicista ha già fatto nei precedenti lavori. Insomma un artista che dimostra, ancora una volta, una profonda conoscenza del linguaggio jazzistico non solo dal punto di vista musicale ma anche da ciò che questo linguaggio ha rappresentato – e ancora oggi rappresenta – per le popolazioni di colore negli States…e non solo.
 Lorenzo De Finti Quartet – “Mysterium Lunae” – Losen
Lorenzo De Finti Quartet – “Mysterium Lunae” – Losen
Strano ma vero, un quartetto italiano che incide per una etichetta norvegese e non è la prima volta dato che il pianista Lorenzo De Finti ha già inciso per la Losen altri due album. Ma veniamo a quest’ultimo “Mysterium Lunae” registrato a Torino nei primi tre giorni del luglio 2021. Per quest’ultima fatica discografica, il gruppo si è arricchito di un prestigioso elemento, il trombettista e flicornista Alberto Mandarini unanimemente considerato musicista a 360 gradi. A completare il gruppo Stefano Dall’Ora al basso e Marco Castiglioni alla batteria. In programma sei brani firmati congiuntamente da De Fanti e Dall’Ora. De Finti è musicista di larga esperienza avendo suonato in orchestre sinfoniche, nella celebrata Instabile Orchestra e accanto a Paolo Conte in molte tournées. Ciò gli ha permesso di elaborare un proprio stile caratterizzato da un sound originale e dalla capacità di scavare a fondo in ogni composizione per trarne ogni possibile implicazione. E tutto ciò si evince dall’ascolto dell’album in oggetto che si apre con la composizione forse più interessante, “Mysterium Lunae”, che si richiama espressamente all’antica metafora per cui un oggetto freddo può diventare fonte di bellezza riflettendo, però, una luce più grande proveniente da qualcos’altro. Ecco quindi questo vero e proprio richiamo alla speranza, sentimento che nel corso della pandemia (periodo in cui è stato registrato il CD) purtroppo è andato quasi perso. Ma i quattro non si limitano a focalizzare uno stato d’animo ché l’album prosegue con una serie di atmosfere cangianti grazie all’attento uso dei colori e delle dinamiche che appaiono già patrimonio consolidato del quartetto.
 Joey DeFrancesco – “More Music” – Mack Avenue
Joey DeFrancesco – “More Music” – Mack Avenue
Non c’è dubbio alcuno che tra quanti suonano ancora oggi l’organo Hammond Joey DeFrancesco sia tra i più bravi. Ma il nostro non si limita a maneggiare con maestria l’organo dal momento che suona bene anche la tromba, il sax tenore, le tastiere e il piano. E ce ne dà prova in questo album in cui presenta undici composizioni (ben dieci a sua firma) in cui, accompagnato da una ritmica composta da Michael Ode alla batteria e Lucas Brown chitarra, organo e tastiere, si diverte ad evidenziare il suo multistrumentismo. E lo fa già in apertura interpretando alla tromba il brano “Free” che, a scanso di equivoci, nulla a che vedere ha con il free jazz. Eccolo ancora alla tromba nel blues “Where to Go”, mentre nelle due ballads, “Lady G” ed “Angel Calling”, si misura con il sax tenore… ma tutto ciò non sarebbe stato sufficiente senza un brano cantato… e voila “And If You Please”, cosicché in alcuni brani l’Hammond B3 viene suonato da Lucas Brown, anch’egli polistrumentista di assoluto livello. Da quanto sin qui detto risulta abbastanza evidente come tutto l’album sia all’insegna della gioia di suonare, di poter eseguire senza tema di essere criticati la musica che piace. Certo, se ci si dovesse poi chiedere in quale veste preferiamo Joey, la risposta non può che essere una ed una sola: all’organo Hammond di cui DeFrancesco rimane uno straordinario interprete, capace di trarre dallo strumento tutta una serie di nuances, di sfumature che pochi altri sanno imitare.
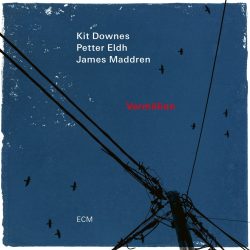 Kit Downes – “Vermillion” – ECM
Kit Downes – “Vermillion” – ECM
Dopo i suoi due precedenti album per ECM, “Dreamlife of Debris” del 2019 e “Obsidian” del 2017 in cui suonava un organo da chiesa a canne, il musicista inglese Kit Downes si ripresenta alla testa di un classico piano-trio coadiuvato dallo svedese Petter Edh già ammirato nel trio di Django Bates al contrabbasso e il britannico James Maddren alla batteria. In realtà al momento della registrazione di questo album, i tre si conoscevano già bene avendo suonato assieme sotto l’insegna di Trio Enemy. Questo “Vermillion” risente molto della formazione musicale del leader: abituato a frequentare quasi indistintamente territori classici, moderni e jazzistici, il pianista infonde alla sua musica uno spirito affatto particolare che la pone piuttosto lontana da ciò che normalmente si immagina debba essere un trio di jazz. In effetti qui non troviamo una continua pulsazione ritmica, né linee melodiche facilmente identificabili ma un flusso costante di musica tutta giocata su toni meditativi. Ovviamente – Evans insegna – non c’è alcuna gerarchia fra i tre strumenti che dialogano su un piano di assoluta parità alla ricerca di un’espressività interiore che mai viene meno. Di qui la sensazione, non si sa bene quanto veritiera, che la scrittura la faccia da padrona sull’improvvisazione. Insomma una sorta di viaggio introspettivo declinato attraverso dieci composizioni di pianista e contrabbassista e la cover di Jimi Hendrix, “Castles Made of Sand” tratto da “Axis: bold as Love” del 1967che chiude meravigliosamente l’album.
 Mathias Eick – “When We Leave” – ECM
Mathias Eick – “When We Leave” – ECM
Il trombettista Mathias Eick è uno di quei musicisti che mai ti delude. Ogni suo album è una summa di quel che oggi dovrebbe rappresentare, a nostro avviso, la figura del jazzista, vale a dire un musicista che pur conoscendo perfettamente la tradizione, volge lo sguardo al futuro. E lo fa con la piena consapevolezza dei propri mezzi espressivi. Ingredienti, questi, che si ritrovano appieno in “When We Leave” registrato a Oslo nell’agosto 2020 da un organico piuttosto ampio guidato da Mathias Eick (nell’occasione anche alle tastiere) e completato da Andreas Ulvo al piano, dal bassista Audun Erlien, da Hakon Aase violino e percussioni, dai due batteristi e percussionisti Torstein Lofthus e Helge Andreas Norbakken e dal chitarrista Stian Carstensen il cui apporto risulta tutt’altro che secondario. Come abbiamo già avuto modo di apprezzare nei suoi precedenti lavori, la musica di Eick si mantiene su atmosfere intimiste, malinconiche, declinata attraverso il fitto colloquio dei musicisti che sembrano aderire perfettamente a quelle che sono le linee guida dettate dal leader. Di qui una insieme di linee melodiche sempre riconoscibili, un perfetto controllo del ritmo ben supportato da una sezione quanto mai precisa ed efficiente, ed un gioco sulle dinamiche che spesso si fa apprezzare per la sua originalità. Tra i vari strumentisti precedentemente citati, da sottolineare ancora una volta la prova del violinista Hakon Aase che oltre ad eseguire spesso il tema all’unisono con la tromba del leader, si produce in pregevoli assolo. Ma il fulcro di tutto è sempre lui, Mathias Eick il cui strumento si staglia sempre preciso, puntuale, così come le sue capacità compositive dato che tutti i brani dell’album sono dovuti alla sua penna.
 Antonio Flinta – “Secrets of a Kiri Tree” – Autoprod.
Antonio Flinta – “Secrets of a Kiri Tree” – Autoprod.
Sono passati circa due anni da quando, discutendo con Antonio Flinta, gli chiesi come mai non si fosse ancora cimentato al piano-solo dopo una intensa carriera. Antonio mi rispose che l’avrebbe fatto solo se si fosse sentito pronto. Il momento è arrivato ed ecco questo “Secrets of a Kiri Tree” in cui il pianista cileno ci spinge a guardarci nel profondo, a riscoprire quel che abbiamo dentro, anche se per farlo probabilmente abbiamo bisogno di qualcuno che si spinga in tal senso. E per ottenere tale scopo Flinta sceglie un repertorio tanto vasto quanto difficile. Ecco quindi Paco de Lucia con “Cancion de amor”, accanto a George Fragos (“I Hear a Rhapsody”), la straordinaria Violeta Parra (“Gracias a la vida”) assieme al gigante del jazz Thelonious Monk (”’Round Midnight”) il tutto completato da tre originals di Antonio. A nostro avviso il meglio dell’album lo si ritrova nelle composizioni dello stesso pianista. Scevro da qualsivoglia preoccupazione se non quella di lasciarsi andare al proprio istinto, Flinta inanella una serie di improvvisazioni davvero notevoli in cui mai si perde il filo del discorso tanto è solida la base su cui l’artista costruisce i suoi edifici musicali. Così risulta quanto mai arduo distinguere le parti improvvisate da quelle scritte, ammesso poi che la cosa abbia un minimo di importanza. Così il pianismo di Flinta scorre fluido sicuro, lucido, essenziale, mai sovracaricato di orpelli inutili e pur tuttavia sempre in grado di incuriosire l’ascoltatore. Quanto agli altri brani, abbiamo particolarmente apprezzato la versione di “Gracias a la vida” che conserva intatta la sua dolce e malinconica linea melodica.
 Tord Gustavsen – “Opening” – ECM
Tord Gustavsen – “Opening” – ECM
Ancora un piano-trio questa volta di marca norvegese. A costituirlo sono infatti il pianista Tord Gustavsen, il contrabbassista Steinar Raknes (responsabile anche di un sapiente e sobrio uso dell’elettronica) e il batterista Jarle Vespestad ovvero tre dei migliori musicisti che il panorama jazz norvegese possa oggi offrire. E il risultato è in effetti di grande rilevanza. Certo non scopriamo in questa sede lo straordinario talento del pianista, ma fa immenso piacere constatare come uno dopo l’altro tutti i lavori di Tord si mantengano su un livello di assoluta eccellenza. In programma, questa volta, dodici brani di cui nove a firma del leader cui si aggiungono un brano traditional e due pezzi firmati rispettivamente da Geir Tveitt – figura centrale del movimento culturale norvegese negli anni ’30 – e da Egil Hovland, compositore classico che si formò studiando tra gli altri con Aaron Copland e a Firenze con Luigi Dallapiccola. E da queste poche note si può già comprendere quanto ampio sia l’universo musicale di riferimento di Gustavsen e quindi dell’intero trio. Di qui una musica saldamente ancorata al patrimonio norvegese, e nordico più in generale. Ecco quindi la rivisitazione, già al secondo pezzo, di un brano abbastanza celebrato in Svezia, “Visa från Rättvik” (Vista dalla città di Rättvik), già inserito da Jan Johansson – uno tra i più grandi pianisti svedesi di cui Gustavsen ha dichiarato di sentire l’influenza – nell’album del 1964, “Jazz pa Svenska”, album che all’epoca vendette la stratosferica cifra di 250.000 copie. Gustavsen stravolge il pezzo rendendolo praticamente suo e lo stesso fa per tutta la durata dell’album mai offrendo musica banale o scontata. Si ascolti, ad esempio, il suo modo di intendere il tango in “Helensburgh Tango”, lontano che più non si potrebbe dalle atmosfere tipiche tanguere. Splendida la versione di “Var Sterk, Min Sjel” assolutamente rispettosa dell’originale del già citato Egil Hovland.
 Roberto Laneri – “Musica finta / Blue Prints” – Da Vinci Classics
Roberto Laneri – “Musica finta / Blue Prints” – Da Vinci Classics
Roberto Laneri – “South of No Border” – Black Sweat Records
Il polistrumentista Roberto Laneri si ripresenta con due album registrati rispettivamente nel 1998 e in un arco temporale che va dal 2014 al 2018. Ma procediamo con ordine. “Musica finta / Blue Prints”, registrato come si diceva nel 1998 ma pubblicato solo nei primi mesi del 2020, va inquadrato correttamente grazie al sottotitolo “A Study in Metamusicology”. Si tratta, cioè, di un album assai complesso, di lettura difficile, in cui Laneri – come egli stesso afferma, suonando al sax soprano alcuni rags di Scott Joplin ha provato ad introdurre dei cambiamenti nel testo, dapprima minimi, poi sempre più articolati, fino ad arrivare alla composizione di pezzi autonomi e paralleli, da suonarsi assieme ai pezzi originali. “L’effetto di questa estremizzazione – aggiunge Laneri – è paragonabile alle prospettive impossibili di Escher, oppure ai disegni tridimensionali generati al computer, dai quali possono emergere immagini complementari eppur assai diverse da quelle immediatamente apparenti”. Fin qui le premesse metodologiche. Ma il risultato musicale? Laneri presenta composizioni originali, unite a quelle di Schumann, Schubert ma anche Joplin e Jelly Roll Morton. Quindi linguaggi differenti ricondotti ad unità per una sorta di opera di ampio respiro divisa in cinque capitoli. Per questa impresa Laneri (sax soprano, sampling e sound treatment) ha chiamato accanto a sé la pianista Maria Jolanda Masciovecchio e Alan Ferry come spoken voice.
 “South of No Border” (come si diceva registrato tra il 2014 e il 2018 ma anch’esso pubblicato poche settimane fa) vede Roberto Laneri (clarinetto, clarinetto basso, sax sopranino, sax soprano e alto, didjeridoo, shruti box, voce e percussioni) alla testa di un gruppo comprendente Giuppi Paone voce, Raffaela Siniscalchi voce, Eleonora Vulpiani chitarra, Luigi Polsini contrabbasso e Laugi Marino zarb. Contrariamente al primo album, in questo caso il repertorio è come una sorta di finestra affacciata sulle musiche del mondo. Ecco, quindi, dopo l’apertura affidata alle melodie orientaleggianti di “Malia” (scritta da Laneri), il choro brasiliano “Tico-Tico no fubá” (scritto da Zequinha de Abreu nel 1917, accanto al bolero cubano “Contigo En La Distancia” scritto dal cantautore César Portillo de la Luz quando aveva 24 anni nel 1946, il tutto impreziosito da 4 original del leader. A confronto con un tale repertorio, Laneri dà ancora una volta prova non solo della sua indiscussa preparazione tecnica ma anche della profonda conoscenza del panorama musicale internazionale. Le sue interpretazioni risultano, quindi, assolutamente pertinenti: traendo feconda ispirazione da svariate tradizioni, riesce a produrre una sintesi che non conosce confini geografici grazie ad una concezione visionaria della musica senza barriere. Insomma un disco originale nella concezione e nell’esecuzione.
“South of No Border” (come si diceva registrato tra il 2014 e il 2018 ma anch’esso pubblicato poche settimane fa) vede Roberto Laneri (clarinetto, clarinetto basso, sax sopranino, sax soprano e alto, didjeridoo, shruti box, voce e percussioni) alla testa di un gruppo comprendente Giuppi Paone voce, Raffaela Siniscalchi voce, Eleonora Vulpiani chitarra, Luigi Polsini contrabbasso e Laugi Marino zarb. Contrariamente al primo album, in questo caso il repertorio è come una sorta di finestra affacciata sulle musiche del mondo. Ecco, quindi, dopo l’apertura affidata alle melodie orientaleggianti di “Malia” (scritta da Laneri), il choro brasiliano “Tico-Tico no fubá” (scritto da Zequinha de Abreu nel 1917, accanto al bolero cubano “Contigo En La Distancia” scritto dal cantautore César Portillo de la Luz quando aveva 24 anni nel 1946, il tutto impreziosito da 4 original del leader. A confronto con un tale repertorio, Laneri dà ancora una volta prova non solo della sua indiscussa preparazione tecnica ma anche della profonda conoscenza del panorama musicale internazionale. Le sue interpretazioni risultano, quindi, assolutamente pertinenti: traendo feconda ispirazione da svariate tradizioni, riesce a produrre una sintesi che non conosce confini geografici grazie ad una concezione visionaria della musica senza barriere. Insomma un disco originale nella concezione e nell’esecuzione.
 Roberto Magris – “Match Point” – JMood / Roberto Magris – “Duo & Trio” – JMood
Roberto Magris – “Match Point” – JMood / Roberto Magris – “Duo & Trio” – JMood
Tra i musicisti che riescono a conservare un alto livello delle proprie produzioni, lavorando in ambedue le sponte dell’Atlantico, c’è sicuramente il pianista Roberto Magris di cui segnaliamo due nuove uscite. Il primo – “Match Point” – registrato a Miami l’8 dicembre del 2018, è stato a ben ragione considerato da critici statunitensi come uno degli album più interessanti pubblicati negli ultimi mesi. “Match Point” vede il pianista triestino alla testa di un quartetto dai mille colori completato dal cubano Alfredo Chacon al vibrafono e percussioni, dal batterista Rodolfo Zunica proveniente dal Costa Rica e dallo statunitense Dion Kerr al basso. In repertorio otto brani equamente divisi tra composizioni dello stesso Magris e brani di giganti della tastiera quali Richard Kermode tastierista americano, noto soprattutto per essersi esibito con Janis Joplin, Malo e Santana, McCoy Tyner, Thelonious Monk, Randy Weston. Da quanto sin qui detto è già possibile avere un’idea della musica che Magris ci propone, una musica che, saldamente ancorata alla produzione, presenta quel tocco di “latino” che impreziosisce il tutto. Al riguardo basti ascoltare “Caban Bamboo Highlife” di Randy Weston, uno dei jazzisti preferiti da Magris, con Chacon e Zuniga in grande evidenza.
In “Duo & Trio” Magris adotta una formula diversa esibendosi in sei brani in duo con il sassofonista Mark Colby e in cinque pezzi in gruppo con Elisa Pruett al basso, Brian Steever alla batteria mentre Pablo Sanhueza alle congas è presente solo in “Melody for C” di Sonny Clark e “Samba Rasta” di Andrew Hill. Per il resto i compositori visitati da Magris fanno parte dell’Olimpo della musica quali Elmo Hope, Bernstein, Ray Noble, Shuman, Kurt Weill; il tutto completato, come al solito, da alcune composizioni dello stesso Magris. L’ascolto dell’album lascia pienamente soddisfatti per almeno due ordini di motivi: innanzitutto la straordinaria maestria di Roberto Magris che, dall’alto della sua immensa preparazione pianistica, affronta con estrema disinvoltura partiture assai diversificate tra di loro (eccolo intimista e toccante in “Old Folks”, classico nell’accezione più completa del termine in “Cherokee”, trascinante improvvisatore in “Melody for C”); in secondo luogo per la scelta di collaboratori sempre di livello. Da segnalare, in questa occasione il lavoro del sassofonista Mark Colby che sia al tenore sia al soprano evidenzia una forte personalità scevra da qualsivoglia intento di stupire chi ti ascolta.
 Dino & Franco Piana Ensemble – “Reflections” –Alfa Music
Dino & Franco Piana Ensemble – “Reflections” –Alfa Music
Attualmente l’ensemble diretto dalla premiata ditta “Dino & Franco Piana” è una delle migliori formazioni del jazz attuale. Ciò anche perché nel suo ambito, oltre ai citati leader, figurano artisti di grande spessore quali la pianista Stefania Tallini, il bassista Dario Deidda e il batterista Roberto Gatto. In quest’ultima fatica discografica il gruppo è affiancato dalla B.i.m. Orchestra mentre il repertorio comprende dieci brani di cui ben sei composti da Franco Piana (altresì flicornista e arrangiatore del gruppo), altri due original dovuti rispettivamente a Lorenzo Corsi e Stefania Tallini e due standard, “Skylark” di Hoagy Carmichael e “Embraceable You” di George Gershwin. Il progetto nasce durante il lockdown dalle riflessioni dei due leader che hanno focalizzato l’attenzione sulle molteplici possibilità d’espressione che i vari organici possono offrire. Di qui il far ricorso, per ogni brano, ad un organico diverso. Si inizia così da “Skylark”, suonato dal trombone di Dino Piana in solo, passando poi a brani in duo – trio – quartetto – quintetto – sestetto, fino ad arrivare ad arrangiamenti per quartetto d’archi (B.i.m. Orchestra), 4 flauti, piano e flicorno. Come le precedenti prove dei Piana, anche questo album entra di diritto tra i migliori album di jazz italiano pubblicati negli ultimi mesi in quanto la bellezza dei temi è supportata e valorizzata da arrangiamenti ben strutturati e altrettanto ben eseguiti da una formazione che presenta anche individualità di tutto rispetto. Senza dimenticare i due leader – di cui comunque spesse volte abbiamo tessuto le lodi – bisogna sottolineare l’apporto di Stefania Tallini che si conferma jazzista a tutto tondo capace sia di sviluppare suadenti linee melodiche sia di imporre un ritmo preciso e coinvolgente (la si ascolti in “D and F”). Ma la citazione di questo brano è solo un esempio ché tutto l’album merita di essere ascoltato.
 Valentina Ranalli, Enrico Pieranunzi – “Cantare Pieranunzi” – Alfa Music
Valentina Ranalli, Enrico Pieranunzi – “Cantare Pieranunzi” – Alfa Music
Enrico Pieranunzi Quintet – “The Extra Something” – Cam Jazz
Quasi contemporaneamente sono usciti due pregevoli album che vedono impegnato Enrico Pieranunzi. Nel primo – “Cantare Pieranunzi” – il pianista romano si presenta nella triplice veste di leader dello Youth Project (con Giuseppe Romagnoli al basso, Cesare Mangiocavallo alla batteria e Giacomo Serino alla tromba), compositore e arrangiatore. Il tutto al servizio della vocalist Valentina Ranalli. La genesi dell’album è assai particolare e ce la illustra lo stesso Pieranunzi nelle note che accompagnano il CD: in buona sostanza “Cantare Pieranunzi” è il frutto della tesi di laurea in canto jazz presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma di Valentina Ranalli che ha presentato un lavoro incentrato su pezzi del pianista, cui ha aggiunto le parole in italiano, inglese, francese e napoletano. Incuriosito dall’iniziativa e dopo aver ascoltato la vocalist, Pieranunzi decide di mettere il tutto su disco e bene ha fatto dal momento che l’album è di assoluto livello. Le undici tracce contenute nell’album sono interpretati dalla Ranalli con sincera partecipazione dialogando intensamente con il pianoforte di Enrico: si ascolti, ad esempio, “You Know”. Ma è tutta la performance della cantante che convince e che fa ottimamente sperare per il suo futuro; fra i pezzi da segnalare “Suspension points” fatto di poche note ma di tanta emozione, e “Persona” in cui la Ranalli si trova particolarmente a suo agio esprimendosi nella lingua della sua terra, il partenopeo.
 Completamente diverso il secondo album – “The Extra Something” – registrato live il 13 e 14 gennaio 2016 al Village Vanguard da un quintetto che vedeva il pianista romano in compagnia di Diego Urcola tromba e trombone (semplicemente straordinario nella title tracke), Seamus Blake sax tenore (particolarmente convincente in “Atoms”), Ben Street basso e Adam Cruz batteria. E per quanti seguono il jazz non c’è bisogno di altre parole per sottolineare il valore assoluto della band. Valore assoluto che si evidenzia in tutto il repertorio, sette brani tutti composti dal pianista. Pieranunzi, come spesso gli capita, è in uno stato di grazie e conduce il gruppo con mano sicura, del tutto consapevole dell’intesa che ha raggiunto con i compagni di viaggio. Dal punto di vista compositivo non scopriamo certo oggi il suo senso della struttura che mai l’abbandona, per cui se consideriamo tutti questi elementi si capisce bene perché il ben noto Brian Morton abbia incluso Enrico tra “i più significativi musicisti contemporanei”. Nelle note di copertina Pieranunzi dedica espressamente questo terzo CD Live at The Village Vanguard a Lorraine Gordon in memoriam, senza la quale né questo né i precedenti due si sarebbero potuti realizzare. Ricordiamo per inciso che il pianista romano è forse l’unico musicista italiano nella veste di leader ed uno dei pochissimi europei ad aver suonato nel leggendario jazz club a forma di diamante aperto da Max Gordon nel 1935 al 178 Seventh Avenue South di Manhattan.
Completamente diverso il secondo album – “The Extra Something” – registrato live il 13 e 14 gennaio 2016 al Village Vanguard da un quintetto che vedeva il pianista romano in compagnia di Diego Urcola tromba e trombone (semplicemente straordinario nella title tracke), Seamus Blake sax tenore (particolarmente convincente in “Atoms”), Ben Street basso e Adam Cruz batteria. E per quanti seguono il jazz non c’è bisogno di altre parole per sottolineare il valore assoluto della band. Valore assoluto che si evidenzia in tutto il repertorio, sette brani tutti composti dal pianista. Pieranunzi, come spesso gli capita, è in uno stato di grazie e conduce il gruppo con mano sicura, del tutto consapevole dell’intesa che ha raggiunto con i compagni di viaggio. Dal punto di vista compositivo non scopriamo certo oggi il suo senso della struttura che mai l’abbandona, per cui se consideriamo tutti questi elementi si capisce bene perché il ben noto Brian Morton abbia incluso Enrico tra “i più significativi musicisti contemporanei”. Nelle note di copertina Pieranunzi dedica espressamente questo terzo CD Live at The Village Vanguard a Lorraine Gordon in memoriam, senza la quale né questo né i precedenti due si sarebbero potuti realizzare. Ricordiamo per inciso che il pianista romano è forse l’unico musicista italiano nella veste di leader ed uno dei pochissimi europei ad aver suonato nel leggendario jazz club a forma di diamante aperto da Max Gordon nel 1935 al 178 Seventh Avenue South di Manhattan.
 Serena Spedicato – “Io che amo solo te” – Dodicilune
Serena Spedicato – “Io che amo solo te” – Dodicilune
Non sempre la bellezza della confezione corrisponde alla bontà del contenuto. In questo caso, la Dodicilune ha realizzato qualcosa di eccellente affidando alla vocalist Serena Spedicato (utilizzata anche come splendida voce narrante) un repertorio per noi italiani impossibile da dimenticare, all’interno di una confezione sobriamente elegante. In realtà Serena Spedicato e lo scrittore Osvaldo Piliego avevano dato vita a questo loro progetto originale come concerto/spettacolo con la regia di Riccardo Lanzarone, che solo successivamente è approdato alla forma libro/cd. Così la Dodicilune ci presenta un prezioso libretto, con la grafica di Marina Damato, autrice delle foto con Maurizio Bizzochetti, e i testi inediti di Osvaldo Piliego che accompagnano dodici brani tra i più belli e rappresentativi del cantautorato italiano, rielaborati in una forma nuova grazie agli arrangiamenti del fisarmonicista Vince Abbracciante coadiuvato da Nando Di Modugno (chitarra classica) e Giorgio Vendola (contrabbasso). Le canzoni proposte appartengono tutte alla cd. “scuola genovese” vale a dire Luigi Tenco, Fabrizio De André, Gino Paoli, Sergio Endrigo, Umberto Bindi, Bruno Lauzi. In buona sostanza tutto il lavoro ruota attorno ai cantautori che sono cresciuti e si sono formati in quel di Genova, ove sul finire degli anni Cinquanta si sviluppò un movimento culturale e artistico che rivoluzionò il mondo della canzone italiana. Ed è proprio questo clima che si respira ascoltando l’album. Molte le positività del lavoro: le centrate interpretazioni della vocalist che evidenzia una musicalità ed una sensibilità non comuni, i testi intelligenti che aiutano (soprattutto i più giovani) a capire ciò che si ascolta, ma soprattutto gli arrangiamenti di Vince Abbracciante che oramai non ne sbaglia una. Misurarsi con dei veri e proprio mostri sacri della musica non è certo impresa facile: ebbene il fisarmonicista ha affrontato l’impresa con passione e professionalità regalandoci degli arrangiamenti che, senza alcunché togliere al fascino originario, hanno rivestito i brani di una patina jazzistica pertinente ed affascinante. Ovviamente più che positiva anche l’apporto di Nando Di Modugno e Giorgio Vendola per un album di sicuro rilievo.
 Andrés Thor – Hereby – Losen
Andrés Thor – Hereby – Losen
Siamo veramente grati alla norvegese Losen Records per la possibilità che ci offre di far conoscere al pubblico italiano dei veri e propri talenti che, non avendo ancora raggiunto fama internazionale, difficilmente raggiungono le nostre platee. E’ il caso del chitarrista islandese Andrés Thor che, giunto al suo settimo album da leader, si presenta al pubblico alla testa di un trio completato dall’altro islandese Magnús Trygvason Eliassen batteria e dal francese Nicolas Moreaux contrabbasso. Quello di Thor è un fraseggio molto personale, pulito, chiaro, senza alcuna pretesa di sperimentalismo o di sensazionalismo. La sua idea di guidare il trio si avvicina molto alla lezione impartita da Bill Evans con Scott LaFaro. Quindi una formazione che si muove su basi paritetiche in cui ognuno può improvvisare ed esprimere la propria personalità all’interno di una cornice ben delineata dalle nove composizioni tutte a firma dello stesso Thor. Da un punto di vista prettamente chitarristico, Thor è chiaramente ispirato da tre grandi esponenti della chitarra jazz – Jim Hall, John Scofield e Pat Metheny – mentre sotto un profilo più generale tra i suoi maggiori interessi figurano rock band come i Led Zeppelin e i Doors nonché Jimi Hendrix e John Coltrane. Come si nota un universo di riferimento assai ampio che Thor dimostra di aver assorbito molto bene soprattutto nel modo in cui costruisce le sue composizioni, dotate tutte di un eccellente senso architettonico e ben arrangiate. Da sottolineare che mentre nei primi sette brani Andrés utilizza la chitarra elettrica, negli ultimi due imbraccia lo strumento acustico senza che ciò influenzi minimamente l’omogeneità dell’album.
 Mark Turner – “Return From The Stars” – ECM
Mark Turner – “Return From The Stars” – ECM
Registrato a New York nel novembre del 2019, questo album vede impegnato un quartetto piano-less guidato dal sassofonista Mark Turner e completato da Jason Palmer alla tromba, Joe Martin al contrabbasso e Jonathan Pinson alla batteria. L’album si inserisce in quella nuova corrente musicale che si allontana molto dal jazz mainstream per inserirsi in ciò che si può definire “musica moderna” tout court. Ma, a questo punto, qualcuno potrebbe chiedersi: si tratta ancora di jazz? Lasciamo ad altri la risposta a questo inutile quesito per soffermarci su un altro interrogativo molto più pregnante: si tratta di musica di qualità o no? La risposta non può che essere positiva: si, si tratta di musica di qualità dal momento che risponde ad alcuni requisiti facilmente individuabili. Intendiamo riferirci, innanzitutto, alla natura delle composizioni: Turner scrive benissimo, con perfetto senso delle proporzioni, lasciando ad ognuno dei suoi collaboratori il giusto spazio pur essendo comunque in condizione di ricondurre il discorso ad unità; il tutto corroborato dalla capacità di creare una omogeneità di fondo. Ma ciò sarebbe stato inutile se ad interpretare queste complesse partiture non ci fossero stati dei musicisti completi, preparati. Si ascolti, ad esempio, con quanta pertinenza il trombettista segua il leader nelle sue escursioni o di come il batterista riesca ad inserire il suo drumming nelle complesse trame disegnate dal leader mentre il basso non perde un colpo nel supportare il ritmo del gruppo. Insomma un disco tutto da gustare, per palati raffinati.
 Cristina Zavalloni – “Parlami di me” – Egea
Cristina Zavalloni – “Parlami di me” – Egea
“Parlami di me” è il suggestivo titolo di questo nuovo album dedicato alle musiche di Nino Rota, all’anagrafe Giovanni Rota Rinaldi, scomparso nel 1979 e a ben ragione considerato, a livello mondiale, uno dei massimi esponenti dei compositori che hanno dedicato la loro vita al cinema. Basti ricordare le colonne sonore di quasi tutti i film di Fellini nonché le colonne sonore del Padrino e Il padrino – Parte II vincendo, per quest’ultimo, il Premio Oscar alla migliore colonna sonora. Evidentemente il connubio tra jazz e musiche da film non è certo una novità eppure ogni nuovo album del genere va ascoltato con la massima attenzione data la delicatezza della materia. In effetti estrapolare tale musiche dal contesto per cui sono nate e farne un qualcosa a sé stante è impresa tutt’altro che banale. A cimentarsi con questo difficile compito è ora una delle nostre migliori vocalist, Cristina Zavalloni, accompagnata da quattro musicisti di assoluto livello quali Gabriele Mirabassi al clarinetto, Cristiano Arcelli al sax soprano (nonché responsabile degli ottimi arrangiamenti), Massimo Morganti al trombone e Manuel Magrini al pianoforte, cui si aggiunge il ClaraEnsemble, sestetto costituito da flauto, contrabbasso, due violini, viola e violoncello. Un organico, quindi, piuttosto ampio che si attaglia perfettamente sia alla voce della Zavalloni sia agli arrangiamento di Arcelli. La vocalist entra quasi in punta di piedi nell’universo di Nino Rota, ma subito dopo se ne appropria, lo fa suo e lo reinterpreta con chiavi sempre originali pur nulla perdendo dell’originario fascino. Così riascoltiamo alcune perle del Maestro che hanno stupendamente accompagnato le immagini volute dai più grandi registi italiani da Fellini a Visconti, da Wertmuller a Zeffirelli…Il repertorio dell’album si completa con l’unica canzone scritta integralmente, dalla Zavalloni, “Prova tu”, che si integra perfettamente nel discorso generale portato avanti da “Parlami di me”.
Gerlando Gatto
da Redazione | 04/Apr/2022 | Interviste, News, Primo piano
È con vero piacere che “A proposito di jazz” accoglie tra i suoi collaboratori un giovane musicista appena laureato con 110 e lode al Conservatorio di Latina. Il suo nome: Daniele Mele. Daniele, classe ’97, inizia a studiare pianoforte all’età di 13 anni. Dopo una doverosa formazione classica con il M. Ilaria Liberati intraprende gli studi Jazz presso il Conservatorio “O. Respighi” di Latina sotto la guida del M. Andrea Beneventano, dove, come si diceva si diploma con lode. Approfondisce gli studi con Andrea Rea, Roberto Bottalico, Ignasi Terraza, Kevin Harris, e si forma seguendo masterclass di Jazz e di musica classica in tutta Italia (Berklee, Siena Jazz, Arcevia Jazz, etc.).
L’inizio di questa collaborazione con il nostro blog è di quelli che lasciano il segno: si tratta, infatti, di una approfondita intervista con Kenny Barron, pianista e compositore tra i più importanti ancora sulla scena.
Nato a Filadelfia, il 9 giugno 1943, Kenny si esibisce da quando aveva quindici anni e in tutto questo arco di tempo ha saputo sviluppare uno stile personale che lo colloca tra i grandi della tastiera di tutti i tempi: ancora oggi le sue registrazioni con Stan Getz nulla hanno perso dell’originario fascino così come quelle del gruppo Sphere di cui nel 1980 fu uno dei fondatori, con Charlie Rouse (sax), Buster Williams (basso) e Ben Riley (batteria).
E, alla grandezza dell’artista, si è sempre accompagnata una statura umana di straordinaria dolcezza: chi scrive queste note ha avuto l’opportunità di intervistarlo oramai parecchi anni fa e ne conserva un ricordo bellissimo dovuto proprio alla gentilezza e alla disponibilità dell’uomo. Gentilezza e disponibilità che dimostra appieno in questa intervista che pubblichiamo qui di seguito. (G.G.)
-

-
Kenny Barron, Daniele Mele
-

-
Kenny Barron
Ore 9:00 (New York) il giorno 25/04/2021.
-Sono molto emozionato in questo momento e la ringrazio per avermi concesso quest’intervista.
“Oh, è un piacere”.
–Prima parlavo con mio padre, gli stavo dicendo che credo ci sia una grande differenza tra musica jazz e musica pop: se voglio parlare con un “nome importante” del Jazz posso avere qualche possibilità di farlo, mentre credo che se volessi parlare con un idolo del pop avrei maggiori difficoltà.
“Sì, lo penso anch’io”. (ride)
-Sì… il jazz è più popolare del pop!
“È vero”.
–Mi fa piacere sapere che sta bene. Vorrei chiederle della vaccinazione, perché so che si è vaccinato: è andato tutto bene?
“Oh sì, ho avuto due dosi di Moderna. Due dosi, quindi… ora sono a posto”.
-Benissimo. Questo è un periodo assurdo!
“Sì, lo è”.
-Se non le spiace, parleremo di alcuni punti che mi interessano particolarmente. So che ha suonato in Italia ad Umbria Jazz con numerosi musicisti, e mi piacerebbe sapere quale fu la sua prima volta qui e perché.
“La prima volta in Italia fu… wow… nel 1963? ’63 o ’64, ero con Dizzy Gillespie. Sì, eravamo a Milano”.
-Era una tappa del tour che faceste in giro per il mondo?
“Sì, suonammo in Piazza Duomo e la cattedrale è incredibilmente bella. Quella fu la prima volta”.
-Le piace l’Italia?
“La amo. La gente, il popolo… non si può mangiare male in Italia. È veramente difficile!”.
–È vero. E invece cosa mi dice del suo rapporto con la musica italiana? Per esempio, io sono di Napoli, nel Sud Italia. Sono cresciuto ascoltando “O sole mio” e “Tu sì ‘na cosa grande”. Conosce queste canzoni?
“Oh sì, le ho sentite tante volte. Non ho mai saputo i nomi dei compositori, ma le ho sentite tante volte”.
-Ok! Ha qualche aneddoto particolare dell’Italia, o ci sono musicisti di sua conoscenza qui?
“Ah… beh, ovviamente una delle mie persone preferite è Dado (Moroni, NdT). Abbiamo suonato insieme in duo, e numerose volte abbiamo fatto dei tour suonando la musica di Monk, eravamo quattro pianisti. A dire il vero abbiamo un progetto insieme per il prossimo anno, penso a Budapest… ho suonato con lui tante volte, e gli voglio bene. La prima volta che ho incontrato Dado è stata ad un seminario in una città vicino Genova, Nervi.
-Stava partecipando ad un seminario su di lei?
“No no, in realtà era il mio interprete!”.
-Ah, bello! (si ride)
“Siamo diventati presto amici, e lì l’ho sentito suonare per la prima volta. In realtà c’era una jam session ogni sera lì al club. Andai per sentirlo suonare e ne rimasi affascinato, è un musicista incredibile… anche con contrabbasso e batteria!
-Oh… non lo sapevo!
”Oh sì, lo assumerei! Per suonare il contrabbasso, e lo assumerei anche per suonare la batteria”.
-Interessante…
“E ho fatto una registrazione con Stefano, Stefano Di Battista, alcuni anni fa. E il contrabbassista, di cui non ricordo il nome ora…”
-Forse Rosciglione? Giorgio o Dario Rosciglione?
“Oh, no. Li conosco, padre e figlio. Era un musicista più giovane. Comunque tutti bravi musicisti”.
-Bene. Adesso mi piacerebbe parlare con lei dei tre album che amo. Il primo è “Canta Brasil”. Lo adoro! Sa, ballo salsa e bachata con la mia fidanzata…
“Ah-ah, wow!”.
–Sì, ballavo prima del Covid ovviamente, ora è tutto chiuso. Ma mi piace, perciò quando ascolto questo tipo di ritmi inizio a ballare e a muovermi. Mi è davvero piaciuto quell’album, e sbaglio se affermo che è iniziato tutto con L’uomo, Dizzy Gillespie?
“Oh, più o meno; in realtà non suonavamo così tanti pezzi brasiliani… ma quell’esperienza è stata d’introduzione alla musica brasiliana: suonavamo “Desafinado”, “Samba De Uma Nota So”. Tuttavia, ciò che davvero mi avvicinò alla musica brasiliana fu ascoltare “Brasil ‘65”, sai… nel 1965! Stavo ascoltando la radio a San Francisco, quando passarono proprio quell’album e ne rimasi folgorato. C’erano chitarre eccezionali, poi Wanda De Sah, e il pianista, era il leader, Sergio Mendes… fu il gruppo che mi portò alla musica brasiliana. Da quel momento in poi ho lavorato con Stan Getz, che suonava molto questo tipo di musica, e poi ho fatto ricerche e ascoltato musica Brasiliana più datata, quella della scuola del Samba. Poi ho conosciuto Nilson Matta, Duduka da Fonseca e Romero Lubambo, e iniziammo a suonare e suonare insieme. Mi insegnarono molti ritmi differenti, e da dove provenivano… questi ritmi vengono dal Nord del Brasile, questi altri dal Sud. Iniziai a lavorare con loro. E così fondammo la band, Canta Brasil”.
-Mi scusi ma vorrei sapere qualcosa di più su Gillespie. Com’era al di fuori del mondo musicale? Ho iniziato a studiare il jazz un po’ di tempo fa, e lui è uno di quei grandi nomi che si devono necessariamente studiare, e da cui si deve prendere il più possibile.
“Fuori dal mondo musicale? Era un grande, davvero una persona cortese, anche molto divertente… fuori dal mondo musicale”.
-Non lo era durante la musica?
“Oh sì, era egualmente divertente! Ma molte persone pensavano che fosse solo apparenza, invece lui era così anche fuori dal palco. Era divertente, molto cortese e molto rispettoso”.
– Quindi il vostro tour mondiale si è tenuto tra il ’62 e il ’66. Che cosa mi dice rispetto alle tappe? Mi ha parlato di Milano, nel ’63.
“Sì, in Italia. Ma abbiamo suonato anche in altri posti: Copenaghen, in Svezia, Varsavia in Polonia, che al tempo era ancora comunista”.
-E fuori dall’Europa?
“Non abbiamo suonato fuori dall’Europa. Abbiamo fatto solo un tour europeo, e quella fu la prima volta che andai in Europa. Fu un inizio fantastico per me!”.
-Sì, posso immaginarlo! (si ride) Parliamo del secondo album, si intitola “Two as One”, l’album con Buster Williams.
“Oh Buster!”.
-E questo lavoro è di particolare importanza per gli italiani, perché è stato registrato a Perugia al Teatro Morlacchi.
“Sì”.
– Ricordo “All of You” e “Someday My Prince Will Come”, e l’ostinato di Buster… 40 secondi forse sul fa, e poi tutto il sound che si apre quando suona il Re basso e con tutte quelle frequenze che arricchiscono la musica. Meraviglioso!
“Certo”(ride)
-E Buster Williams? Com’è?
“Io amo suonare con Buster Williams. In effetti ho appena visto un video su di lui… non so se avete Amazon Prime in Italia”.
-Ce l’abbiamo.
“Si intitola “Bass To Infinity”. È tutto sulla sua vita, ci sono alcune interviste con Herbie Hancock, Lenny White… tutti suonavano insieme a Buster. Dura un’ora, è molto interessante. Sai lui è buddista, perciò parla della sua pratica e di molte altre cose. Ci conosciamo dal 1958, quando eravamo entrambi adolescenti a Philadelphia. Lo conosco da molto tempo, abbiamo lavorato molto insieme… è uno dei miei contrabbassisti preferiti in tutto il mondo”.
-Ho letto che ha suonato con… c’è qualcuno con cui non ha suonato? Ha suonato davvero con tutti!
“Sì, tutti. Le cantanti lo amano, ha lavorato con Nancy Wilson per molto tempo, e anche Sarah Vaughan. Questo video racconta anche delle prime volte in cui uscì per esibirsi, appena terminata la scuola superiore, con Gene Ammons e Sonny Stitt, e di quando ha dovuto avere il permesso da sua madre… dagli un’occhiata!”.
-Senz’altro. Sa… l’inizio della mia tesi di laurea contiene una frase su Philadelphia, e sul fatto che tutti i grandi musicisti sono di lì. È una specie di magia. (ridono)
“Non tutti, ma molti sono di lì! Io penso che una delle ragioni, prima di tutto, è che è molto vicina a New York, a solo due ore di guida. Perciò Philadelphia era una delle tappe principali per i musicisti che provenivano da New York, e io ricordo di aver visto Kenny Dorham e molte altre persone che semplicemente scendevano per andare a fare un concerto a Philly. E si può arrivare a Philadelphia per una sera, e poi tornare indietro quando il concerto è finito. Ai tempi aveva due Club principali che presentavano musicisti di fama mondiale, uno si chiamava Pep’s e l’altro Showboat. Vedevo ‘Trane, Yusef Lateef e Miles suonare lì, e molti altri. Philly era un luogo dove si lavorava, e penso sia per questa ragione che c’erano molti giovani musicisti, incluso me, che poi migliorarono con tutta quella musica attorno.
-Capisco.
“Philly aveva anche molti posti di lavoro per questi giovani musicisti, ci sono molti club in cui ho lavorato. Ed era una gran cosa, avere posti in cui suonare. Questo mi ha aiutato nella crescita, c’erano altri giovani musicisti con cui ho socializzato che sono ancora in giro! C’erano Sonny Fortune, beh lui è venuto a mancare ora, siamo cresciuti insieme… e Buster come sai. Philly era proprio un gran posto”.
-Il prossimo musicista di cui vorrei parlare è anche lui di Philly, e ora mi riferisco al terzo album, che è anche il mio preferito: sto parlando di “People Time”.
“Oh, Stan!”.
-Sì, questo album è la ragione per cui ho iniziato a studiare la sua musica e il suo modo di suonare il pianoforte. È vero che lui la considerava l’altra metà della mela, in senso musicale?
“Ehm, non lo so… così diceva! (ride) Beh, credo che per dirlo lo pensasse davvero. Musicalmente eravamo… empatici? Avevamo un approccio alla musica simile, la melodia era importante”.
-Sì! Sa Kenny, ho sempre l’impressione che quando Stan smette di suonare lei continui a suonare il sassofono ma usando il piano, e viceversa.
“Ah!” (ride)
– È incredibile! Davvero, mi sembra che siate come connessi.
“Sì, lo credo anch’io. Entrambi amavamo la liricità, e questo è importante. Stan poteva suonare una ballad e farti piangere, con il suo sound e le sue idee e la sua creatività. Quello fu un concerto interessante, specialmente in duo, lui era… beh, sono sicuro che conosci la storia”.
-La conosco.
“Era malato al tempo, quando registrammo in duo. Aveva una sorta di tumore del sangue, perciò sentiva molto dolore. Dovevamo registrare per tre sere, ma andammo avanti soltanto per due, lui non riuscì a finire l’ultima sera. Avemmo solo un altro concerto insieme dopo quell’episodio, a Parigi, e non riusciva a suonare molto. Lui suonava la melodia e io feci la maggior parte dei soli al pianoforte, e quella fu l’ultima volta che lo vidi”.
-Mi dispiace molto.
“Era marzo e io lo chiamai un mese più tardi, per sapere come stesse. Mi disse che stava bene e che avrebbe suonato per il prossimo tour, e poi a giugno… è venuto a mancare. Abbiamo perso una bella persona.
-Sì. Secondo me Stan Getz e Paul Desmond sono due grandi sassofonisti che rimarranno nella storia del jazz
“Davvero?”.
-Sì, mi piacciono davvero tanto. Sicuramente c’è anche Charlie Parker, e tutti quei sassofonisti formidabili che sono fuori da ogni sorta di classificazione. Ma mi piacciono molto Paul e Stan per il modo che hanno di suonare.
“Quindi tu ami… il loro sound?”.
-Sì.
“Lo apprezzo. Paul aveva un sound molto morbido e snello, tenero. E una delle prime registrazioni che ho ascoltato era di Dave Brubeck e Paul Desmond, era ‘Jazz Goes To College’”.
-Sì, me la ricordo. Forse anni ’60?
“In realtà tardi anni ’50, perché ancora vivevo a Philly. Questo era uno dei miei pezzi preferiti”.
– Solo un’ultima cosa su Stan Getz… in quale occasione iniziò a collaborare con lui, a quanti anni? Ha mai rimpianto di non averlo conosciuto prima?
“Rimpiango sempre di non aver conosciuto prima le persone, ma sono lieto quando le conosco! Ricevetti una chiamata per lavorare con lui, per sostituire Chick Corea. Allora aveva una band con Stanley Clarke, Tony Williams e Chick. Mi chiamò e mi chiese di prendere il suo posto, questa fu la prima volta che lavorai con Stan. Era incredibile, suonavamo tutta la musica di Chick Corea. Penso si chiamasse “Captain Marvel Band” o qualcosa del genere. Era un piccolo tour, suonammo per poche serate soprattutto in Sud Carolina e a Baltimora. Quando partimmo Stan mi disse: “Sei davvero un musicista con esperienza”, e per me quello era un grande complimento. Per un po’ non l’ho più sentito, e poi pochi mesi dopo mi chiamò per un posto alla Stanford University”.
-Ho capito.
“Artist-in-residence. Mi chiamò per chiedermi di andare lì e suonare in alcuni concerti con lui. Da quel momento iniziammo ad andare in Europa durante l’estate perché io insegnavo alla Rutgers University e lui a Stanford, perciò non potevamo provare molto durante l’anno accademico. Ma in estate andammo a tutti i grandi festival d’Europa. Aveva una buona band, con Victor Lewis e Rufus Reid. Facemmo un paio di registrazioni a Montmartre con il quartetto, e un paio in duo. Sempre grande musica, grande scrittura. Registrammo un pezzo elettronico dal titolo “Apasionado”, in California. Mi piaceva, per me era qualcosa di diverso! C’erano gli archi e tutti i tipi di strumenti elettronici. Una grande esperienza che non avevo mai fatto prima”.
-Ok. Dato che lo ha accennato, mi piacerebbe parlare dell’insegnamento. Lei era un insegnante di pianoforte alla Rutgers University, e poi alla Julliard, la vecchia Manhattan School.
“Esatto”.
-Insegna ancora? O ha lasciato?
“No, mi sono congedato”.
-Perché, se posso chiedere?
“Beh, sto invecchiando! (ride) A un certo punto senti che hai bisogno di imparare qualcosa, ed io avevo bisogno di imparare altro. Avevo bisogno di ascoltare altre persone suonare, in un certo senso di “istruirmi”. Gli studenti erano bravi, intendo bravi davvero… che cosa avevo da dare loro? A Manhattan c’erano Gerald Clayton, Aaron Parks, era uno dei miei studenti, e molti altri… alla Julliard avevo Jonathan Batiste, alla Rutgers Terence Blanchard, Harry Allen. E tutti loro suonavano benissimo il pianoforte!”.
-Com’era un sua lezione tipo? Cosa faceva durante l’ora?
“Sostanzialmente suonavamo insieme. Ho sempre avuto due pianoforti nella mia aula. Suonavamo insieme perché questo mi permetteva di capire cosa effettivamente sapessero o non sapessero suonare. Insomma, erano al punto in cui io non avevo bisogno di dire loro “questo è un accordo di Do”, non avevano bisogno di questo da me: sapevano già come come suonare. Eravamo interessati a sottigliezze e rifiniture, e idee su tocco, frasi, cose del genere”.
-Quindi le sue lezioni erano come delle performance dal vivo, ma guidate?
“Sì, una cosa di questo tipo! Suonavamo e poi ci fermavamo, e dicevo “Ok, qui stiamo suonando una ballad, non dovete suonare così rigidamente, non c’è bisogno di suonare così tante note in questa ballad… lasciate spazio, anche il silenzio è parte della musica”, cose così. E penso che la prendessero molto seriamente”.
-Quindi… ha dei suggerimenti per diventare un buon insegnante? C’è un ingrediente speciale?
“No, non penso. Certo dipende, le persone hanno diversi modi di insegnare. Il mio modo di insegnare era quello di ascoltare i musicisti e sentire costa potevano fare, e sfidarli. Prendevamo una canzone e la suonavamo per 30 minuti, e poi facevamo un botta e risposta, per fare esercizio. E poi provavamo a sfidarci l’un l’altro, ed è un bene quando gli studenti provano a sfidare anche te. (si ride) Ho imparato molto anch’io”.
-Ok.
“Non è tipo “sono il tuo insegnante e tu fai quello che dico”, a quel livello non è così. È più uno scambio di idee. Imparo da loro, loro imparano da me”.
-Certo, grazie mille. Parliamo adesso di composizione. Lei ha composto molto: adoro “Until Then e Sunshower”, in particolare. Quanto pensa sia importante scrivere pezzi originali, che abbiano la propria firma?
“Penso sia importante, e che si debba scrivere il più possibile. Quello che cerco nella scrittura, quello che cerco di raggiungere nella composizione è… la semplicità. Non scrivo cose in 11/8, 9… non scrivo cose in tempi strani. Non sento la musica in quel modo! Alcuni musicisti lo fanno comodamente e mi piace ascoltarli, ma il mio approccio è più che altro fatto di melodie semplici, armonie che forse qualche volta sono ingannevoli… o forse non qualche volta! Per me funziona la semplicità”.
-Sì. Stavo pensando… lei reputa questo un passaggio fondamentale? Un passaggio che un musicista deve fare per sentirsi completo? O pensa che si possa saltare?
“Intendi saltare la scrittura?”.
-Sì.
“Beh, non tutti i musicisti sono compositori, alcuni di loro non scrivono. Ma, come dice qualcuno, l’improvvisazione è composizione, solo che non è scritta”.
-Infatti.
“Un musicista Jazz compone tutto il tempo… quando inizia a scrivere, quella è una composizione! (si ride) Ma molti musicisti semplicemente non sono per la scrittura, e li capisco. Io penso che sia un altro aspetto di te che dovresti esplorare”.
-Ok. Guardi, una volta ho frequentato una masterclass di Billy Childs. Secondo me è un grande compositore.
“Sì, lo è.”
-E ha detto qualcosa che io ritengo incredibile. Ha detto: “Il segreto del comporre è creare qualcosa di sorprendente, e allo stesso tempo inevitabile”.
“Sì, ok”.
-Mi suona come qualcosa del tipo: “Devi creare musica che ha dei legami con il passato, in modo che ascoltandola tu sappia dove sta andando, ma che abbia anche qualcosa di sorprendente che ne cambia la direzione”, no?
“Sì, sì, sì”.
-È d’accordo?
“Sono d’accordo. E ho ascoltato abbastanza musica di Billy Childs, è un compositore brillante”.
-Lei ricorda un buon consiglio che qualcuno le ha dato recentemente o nel passato, o un evento particolare che ha cambiato il suo modo di comporre e suonare?
“Ehm… sì! Qualcuno una volta mi diede un’idea che io poi ho provato ad applicare: prova a suonare il tuo solo nello spazio di una quinta perfetta. Tutte le tue parti di improvvisazione. Ovviamente non puoi farlo chorus dopo chorus dopo chorus, ma fai una prova. Quanto puoi suonare solo in quel piccolo spazio di una quinta perfetta?”.
-Non ho capito bene, Mr. Barron…
“Sul pianoforte, una quinta perfetta, da Do a Sol. E stai suonando una canzone, qualunque essa sia, prova a suonare tutto all’interno di quella quinta perfetta, cromaticamente”.
-Ok!
“E vedi come va. È qualcosa che puoi provare… potresti restare sorpreso. Perché qualsiasi nota tu metta insieme funzionerà contro qualsiasi accordo suonerai. Deve essere risolto, ma funziona. Questo è un consiglio che qualcuno mi diede e che ho provato. È qualcosa da ricordare”.
-Ok, ora… l’ultima parte. Oltre la musica, sono curioso rispetto alla giornata tipica di Kenny Barron. Ci sono delle cose particolari che ama fare nel tempo libero, se non suona?
“Mi piace leggere molto. Mi piace leggere romanzi”.
-Che tipo di romanzi?
“Mi piace James Patterson, romanzi gialli e cose di questo tipo”.
-Sì! Le piace Zafon? Carlos Ruiz Zafon?
“Oh, non lo conosco”.
-No? È bravo! E Dan Brown?… quello de “Il Codice Da Vinci”.
-“Oh sì sì l’ho letto! (ridono di gran gusto) L’ho letto. In realtà ho anche visto il film”.
-Sì… mi scusi, l’ho interrotta.
“No, non fa niente. Stavo dicendo che durante il Covid non c’è molto altro da fare, perché altrimenti andrei da qualche parte, ascolto musica o cose di questo tipo. Perciò questo è ciò che faccio, leggo e provo anche a cucinare!”.
-Cosa cucina?
“Schnitzel… bistecca! Cose del genere”.
-Le piace la pizza?
“La amo. E a Napoli ho mangiato la migliore pizza della mia vita.”
-Wow! Si ricorda il posto?
“No, ma era così fina… con l’aglio…non ricordo perché mi ci hanno portato. Quella fu la migliore pizza che io abbia mai mangiato. E amo anche mangiare! (si ride) Che è un male!
-No. Non è un male! Sa, quest’anno mi ha fatto realizzare appieno che ci sono anche altre cose oltre alla musica. E se si usano queste cose per nutrire il proprio “appetito musicale”, ci si sentirà più rilassati nel suonare e meglio in generale.
“Lo penso anch’io. Bisogna essere una persona a tutto tondo, il che significa fare tutto nella vita, non solo musica. Ci sono persone ossessionate dalla musica, è tutto ciò che fanno: 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ascoltano e praticano musica, scrivono musica 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Vorrei essere una di queste persone, ma non lo sono. Ci sono altre cose che catturano la mia attenzione, come la politica o quanto accade nel mondo. Ora c’è il processo di Minneapolis (per la morte di George Floyd, NdT) che mi interessa”.
-Sì, anche a me.
“Succedono anche altre cose. Possono ispirare la tua musica, in un certo qual modo”.
-Sono d’accordo. Quali sono i suoi piani per il futuro? Ci sono nuovi album in cantiere, nuovi progetti?
“Non al momento. C’è un sassofonista, Greg Abate. Ha fatto delle registrazioni di… circa 15 miei pezzi, con il trio. Suona il sassofono contralto, e ha sovrainciso il sassofono e scritto una sorta di sezione di sax in alcuni dei pezzi. È abbastanza interessante! Ma penso che l’unica cosa che vorrei fare prossimamente è un solo, e poi forse un duo, con batteria o percussioni o… un violoncello! Sì qualcosa del genere. Ed è economico da produrre perché non devo pagare me stesso. (ride)”.

Kenny Barron, Udine, Teatro Palamostre, 10.04.2018 Note Nuove
-Verrà in Italia?
“Ci sono dei piani, non so se verranno cancellati o no a questo punto. Penso che a Perugia o Pescara ci potrò essere”.
-Lo spero!
“Lo spero anch’io! E ci sono altre cose… ce n’è una in una città chiamata… Merano? Non Milano, Merano”.
-Sì, nel nord Italia.
“Sì, non sono sicuro che accadrà. Ma penso che per luglio o agosto le cose miglioreranno almeno un po’, lo spero”.
-Sì, ed io sarò lì ad aspettarla! Vaccinato ovviamente, spero di poterla conoscere e abbracciarla nella vita reale.
“Ok! Grazie molte”.
–Le sono molto grato, grazie mille.
“È stato un piacere!”.
–Ci vediamo presto allora.
“Ok, ciao!”.
-Grazie, arrivederci!
Daniele Mele
da Amedeo Furfaro | 19/Feb/2022 | Guide all'ascolto, News, Primo piano
Lo scorso 8 febbraio è stato approvato dalla Camera, dopo il Senato, il disegno di legge di riforma costituzionale che prevede fra l’altro un nuovo comma dell’art. 9 della Costituzione che statuisce il rinvio al legislatore ordinario della definizione di modi e forme per la tutela degli animali (oltre che, finalmente, dell’ambiente e non solo del paesaggio).
La riserva di legge è una novità che recepisce i contenuti del Trattato sul Funzionamento UE nel punto di cui all’art. 13 laddove è sancito che “ l’Unione e gli stati membri devono, poiché gli animali sono esseri senzienti, porre attenzione totale alle necessità degli animali”. La senzienza è ora dunque uno status giuridico riconosciuto agli animali nell’ordinamento giuridico italiano. Ed è lo spunto per alcune riflessioni, su queste colonne, su che tipo eventuale di senzienza musicale possa sussistere fra l’ animale e l’uomo.
È il caso anzitutto di sottolineare che diversi compositori si sono ispirati al mondo animale. La fantasia zoologica del Carnevale degli animali di Saint-Saëns è una splendida occasione celebrativa del legame fra uomo e animali attraverso le note. Così dicasi della fiaba Pierino e il lupo di Prokof’ev, che cinquant’anni dopo, nel 1936, “doppia” gli animali con gli strumenti (uccellino/flauto, anatra/oboe, gatto/clarinetto, lupo/corni). Un ventennio ancora ed è Olivier Messiaen a scrivere le partiture pianistiche del Catalogue d’Oiseaux con i canti di uccello classificati, nella prefazione, in gridi, strofe, cadenze-assoli … ciò a otto secoli dal Cantico delle Creature!
Immaginazione, ispirazione, onomatopea. La Animal House offre un campionario di possibili suoni per concerti e dischi.
La primordiale polifonia del Concordu e Tenore di Orosei, coro sardo che ha collaborato fra gli altri con Salis e Sissoko, si fonda sull’armonia di contra (verso della pecora), bassu (imitazione del bue) e mesuvoche (fischio del vento).
Non solo le voci, anche gli strumenti giocano una loro parte. Nel jazz c’è chi, come il sax di Dewey Redman nell’album Look for the Black Star del 1975, produce animaleschi suoni gutturali. O come il percussionista Airto Moreira che usa con Miles Davis la cuica, tamburo ad attrito brasiliano tipico del samba, il cui suono, alle origini, in Africa, era associato al ruggito della leonessa (secondo altri vicino al vocio della scimmia).
Oltre alla aneddotica, la prospettiva può riguardare progetti più ampi e persino trend stilistici.
Il trombettista Wynton Marsalis, in Spaces, ha associato i movimenti della suite affidata alla Lincoln Center Orchestra di volta in volta a galline, leoni, rane…(S. Mohamed, npr.org/2016 ).
Molto prima di lui era stato Ellington a creare nei ’20s il leopardato ed esotico jungle style che ricreava in note le atmosfere della giungla africana. Non solo. Gli animali a volte possono diventare attori in scena.
Nel 1990 fece scalpore, all’Europa Jazz Festival di Noci, una mucca che sfilava davanti al palco durante il concerto del pianista russo Sergey Kuryokhin.
Nei live il compianto leader dei Pop Mekhanika era solito inserire cavalli, oche con bande musicali (come avvenuto nella rassegna pugliese), il tutto per una scena “totale” con situazioni “allargate” bipedi-quadrupedi di spettacolarità circense. Era la sua una maniera follemente geniale di stravolgere l’idea stessa di concerto coinvolgendo nella esibizione esseri viventi presi dall’ambiente circostante, (re)incarnando una tradizione che vede il jazz lasciarsi alle spalle l’accademia per farsi pura performance.
-

-
Sergey Kuryokhin
-

-
Pink Floyd cover
-

-
Il Carnevale degli animali – Camille Saint-Saëns
Gli animali, è notorio, fanno capolino in tanti testi e titoli di brani musicali.
Si sfogli al riguardo la classifica “per mucche” stilata nel 2001 dal “Music Research Group” di Leicester che vede ai primi posti REM, Simon and Garfunkel davanti al Beethoven ovviamente della Pastorale. Senza essere esperti di zoomusicologia si è incuriositi dalla circostanza che grazie alla musica i maiali ingrassino meglio e le pecore producano lana in quantità superiore.
Certamente più che il guardare il “gatto pianista” su YouTube o l’esecuzione “a quattro zampe” su tastiera di una coppia di micetti del tutto speciale od anche la jazz band che suonando “When The Saints” ravvicina a sè un gruppo di vacche al pascolo.
Gesti meccanici, certo. Non è lecito immaginare nella realtà una fattoria degli animali canterina come Nella vecchia fattoria. Tuttavia viene da riflettere sull’accoglienza che, nel nostro immaginario musicale, hanno gli animali. Al punto di redigere graduatorie come “30 Best Horse Songs” (horseillustrated.com) e di dedicare intere cover a mucche tipo Atom Heart Mother , quinto album dei Pink Floyd.
Guardando in dettaglio al repertorio jazzistico si annoverano Silver Swan Rag di Joplin e Tiger Rag della ODJB, Watch Dog, nella versione di Etta James, la Animal Dance del Modern Jazz Quartet, e perché no il sincopato Maramao perché sei morto. Rinviamo comunque alla lettura delle Songs about animals riportate da John Dennis su www.theguardian il 28/4/2011 per un quadro più completo (sarebbe interessante stilarlo anche per le songs italiane, a partire magari da Una zebra a pois).
Nei testi della popular, citazione d’obbligo per The Dog Song di Nellie McKay e per le orecchiabili Felix The Cat e Dolce Lassie, ed ancora da serie tv La canzone di Rin Tin Tin , le varie sigle dell’inossidabile Commissario Rex e nei cartoni animati quella di Titti e (gatto) Silvestro.
Ci sarebbe poi una marea di canzoni “ juniores “– da Johnny Bassotto di Lauzi ad Al lupo al lupo di Dalla, da Occhi di gatto a 44 gatti, e alle varie melodie dedicate ai vari Micio e Fido di casa nostra, molti dei quali, diciamoci la verità, funzionano da antistress per i rispettivi padroni.
Ma la senzienza ci porta infine ad approfondire l’altro “punto di vista” nel rapporto musicale di cui sopra , quello animale.
Esiste un filone di studi, si prenda ad esempio il “Journal of Feline Medicine and Surgery” dell’Università della Louisiana, relativo a ricerche che comprovano le proprietà tranquillizzanti di certa musica nei confronti di cani e gatti. Il film degli Aristogatti aveva visto lontano? In un certo senso si, ma la propensione verso il jazz non è diffusa.
Secondo il “Vet.Journal” dello scorso 19 gennaio, in uno scritto di materia musicoterapica specifico sui gatti, i compositori preferiti sarebbero Bach e Chopin le cui melodie darebbero un effetto calmante nel far superare loro il logorio della moderna vita da cani (e gatti). Una croccante scoperta, questa, in linea con gli esperimenti sulle galline che fanno più uova sentendo Mozart e sulle vacche che, nell’ascoltare sinfonica, producono più latte per come a suo tempo assodato da altri accreditati studiosi statunitensi ed all’esperienza della Muzak Inc. che produceva musica poi diffusa in stalle e pollai.
Alcuni ricercatori hanno spostato il tiro verso reggae e soft rock che, a detta della Scottish SPCA, associazione che collabora con l’università di Glasgow, pare piacciano ai cani (midogguide.com/it/dog) che per contro odierebbero l’heavy metal.
Per tornare al jazz, chissà se, come avvenuto per Elègie di Gabriel Fauret, l’amico animale intra moenia non si senta sopito, sedotto da Bill Evans!
A dire il vero il dailyJournal.net del 13 luglio 2017 ci ha rassicurato al riguardo – “gli animali possono gioire dei suoni smooth del jazz” – nel presentare una serie di concerti allo zoo di Indianapolis. Ma la cronaca giornalistica non è detto combaci con la evidenza scientifica. Sul jazz, a proposito di animali acquatici e suoni del mare, sarebbero gli squali, secondo uno studio australiano pubblicato su “Animal Cognition” ripreso da “National Geographic”, a manifestare “propensione per questo genere musicale” (corriere.it, 21/5/2018).
E David Rothenberg, filosofo compositore e clarinettista jazz, è giunto alla conclusione che “è possibile creare sicuramente un linguaggio di interposizione, anche casualmente jazz, che si raccorda per raccogliere segnali non decifrabili in prima approssimazione” (cfr. E. Garzia, Jazz ed ispirazione “animalista”, percorsimusicali.eu, 1/9/2015).
Resta il fatto che molti risultati scientifici inerenti ai “senzienti” felini e canidi domestici paiono a tutti gli effetti acquisiti. Col timore per i collezionisti che cani e gatti alla fine se ne possano contendere i dischi di jazz a suono di morsi e graffi!
Amedeo Furfaro
 È proprio vero: le vecchie abitudini sono dure a morire… E così, in maniera a dir vero inaspettata, spunta questa nuovissima raccolta di tracce sonore svolte ed elaborate dagli immaginifici fratelli Fabris, Franco alle tastiere e Maurizio alle percussioni, integrati, per volere di sincronico destino, dal polistrumentista Gianni Iardino, nonché dal tornito e solido basso del giovanissimo Pietro Liut. Come d’abitudine propria al navigato Franco, non a caso forgiatosi anche sui campi di calcio, anche in questa circostanza è stata data piena preminenza al gioco di squadra collettivo, in un contesto di perfetta parità all’interno dei singoli ruoli esecutivi, per quanto sei degli otto brani incisi siano nati dalla felice vena compositiva di Gianni Iardino, pianista d’estrazione accademica, ma saxofonista per immagamento timbrico, come ben si può cogliere dall’ascolto di questa manciata di acquarelli timbrico-armonici. Una musica, questa, veramente posta in (in)fusione), ove le sensazioni speziate delle sonorità riportano ad un mélange ricco di rimandi, ispirazioni, citazioni appena accennate, fondali sonori che in parte inducono alla nostalgia per gusti antichi, all’improvviso riaffiorati per via retronasale, di quelli celati negli anfratti più reconditi di memorie archiviate, ma mai del tutto sopite. Tutto può accadere, e tutto accade, entro le mura all’apparenza ordinate di questi brani. La celebrazione della post-post-modernità in musica? L’amore per il bricolage di generi, stili e prassi organizzative? Forse, può darsi: ma lungi dall’essere una musica preparata “a tavolino”, questi brani procedono lisci e senza alcuna forzatura proprio al pari d’una suadente e profumata tisana dai risvolti concilianti e dagli intenti lenitivi.
È proprio vero: le vecchie abitudini sono dure a morire… E così, in maniera a dir vero inaspettata, spunta questa nuovissima raccolta di tracce sonore svolte ed elaborate dagli immaginifici fratelli Fabris, Franco alle tastiere e Maurizio alle percussioni, integrati, per volere di sincronico destino, dal polistrumentista Gianni Iardino, nonché dal tornito e solido basso del giovanissimo Pietro Liut. Come d’abitudine propria al navigato Franco, non a caso forgiatosi anche sui campi di calcio, anche in questa circostanza è stata data piena preminenza al gioco di squadra collettivo, in un contesto di perfetta parità all’interno dei singoli ruoli esecutivi, per quanto sei degli otto brani incisi siano nati dalla felice vena compositiva di Gianni Iardino, pianista d’estrazione accademica, ma saxofonista per immagamento timbrico, come ben si può cogliere dall’ascolto di questa manciata di acquarelli timbrico-armonici. Una musica, questa, veramente posta in (in)fusione), ove le sensazioni speziate delle sonorità riportano ad un mélange ricco di rimandi, ispirazioni, citazioni appena accennate, fondali sonori che in parte inducono alla nostalgia per gusti antichi, all’improvviso riaffiorati per via retronasale, di quelli celati negli anfratti più reconditi di memorie archiviate, ma mai del tutto sopite. Tutto può accadere, e tutto accade, entro le mura all’apparenza ordinate di questi brani. La celebrazione della post-post-modernità in musica? L’amore per il bricolage di generi, stili e prassi organizzative? Forse, può darsi: ma lungi dall’essere una musica preparata “a tavolino”, questi brani procedono lisci e senza alcuna forzatura proprio al pari d’una suadente e profumata tisana dai risvolti concilianti e dagli intenti lenitivi. E’ come se alla storia piacesse … shakerare e sperimentare, nel proprio scorrere, nuovi cocktail. L’alchimia è avvenuta con la musica del Brasile dove la cultura dei conquistadores portoghesi, mixata con “spezie” locali, ha plasmato uno specifico heritage generando forme come choro, maxixe e samba, così “distanti” da fado e fandango, a volerne sottolineare la distanza dall’eredità culturale della madrepatria. Con la quale peraltro il rapporto è continuato ad esistere e vive tuttora in Europa, Italia compresa, a causa dell’approdarvi di artisti brasiliani in analogia ad altri colleghi ispanoamericani. Canto Estrangeiro, album della Encore Music a firma della vocalist Tatiana Valle e del pianista Giovanni Guaccero, è una tela sonora e canora del Brasile fuori dal Brasile, un paese-doppio, un’immagine riflessa richiamata e ricamata da Guaccero sui versi di Luis Elòi Stein a partire da Lingua Minha che precede una dozzina di splendide composizioni. Ne ha scritto la musica da “straniero” che ha assimilato Jobim, de Hollanda, Nascimento, il poeta de Moraes….per un viaggio “di ritorno” verso il Rio Grande do Sul, dal Tevere, il cui “voucher” è un compact carioca curato in ogni particolare. Vi hanno partecipato il batterista Bruno Marcozzi, la flautista Barbara Piperno, il chitarrista-mandolinista Marco Ruviaro, con ospiti Giancarlo Bianchetti alla chitarra elettrica, Henrique Cazes al cavaquinho, Fred Martins al canto, Carlos Cèsar Motta alle percussioni e Francesco Maria Parazzoli al cello. Nell’insieme il Brasile di Guaccero-Stein e della Valle non risulta oleografico né saporifero di vintage bensì è partecipe dell’oggi in ruoli di protagonista fra le nuove correnti della musica tropicale ad influsso jazz che spirano forti oltre l’Atlantico.
E’ come se alla storia piacesse … shakerare e sperimentare, nel proprio scorrere, nuovi cocktail. L’alchimia è avvenuta con la musica del Brasile dove la cultura dei conquistadores portoghesi, mixata con “spezie” locali, ha plasmato uno specifico heritage generando forme come choro, maxixe e samba, così “distanti” da fado e fandango, a volerne sottolineare la distanza dall’eredità culturale della madrepatria. Con la quale peraltro il rapporto è continuato ad esistere e vive tuttora in Europa, Italia compresa, a causa dell’approdarvi di artisti brasiliani in analogia ad altri colleghi ispanoamericani. Canto Estrangeiro, album della Encore Music a firma della vocalist Tatiana Valle e del pianista Giovanni Guaccero, è una tela sonora e canora del Brasile fuori dal Brasile, un paese-doppio, un’immagine riflessa richiamata e ricamata da Guaccero sui versi di Luis Elòi Stein a partire da Lingua Minha che precede una dozzina di splendide composizioni. Ne ha scritto la musica da “straniero” che ha assimilato Jobim, de Hollanda, Nascimento, il poeta de Moraes….per un viaggio “di ritorno” verso il Rio Grande do Sul, dal Tevere, il cui “voucher” è un compact carioca curato in ogni particolare. Vi hanno partecipato il batterista Bruno Marcozzi, la flautista Barbara Piperno, il chitarrista-mandolinista Marco Ruviaro, con ospiti Giancarlo Bianchetti alla chitarra elettrica, Henrique Cazes al cavaquinho, Fred Martins al canto, Carlos Cèsar Motta alle percussioni e Francesco Maria Parazzoli al cello. Nell’insieme il Brasile di Guaccero-Stein e della Valle non risulta oleografico né saporifero di vintage bensì è partecipe dell’oggi in ruoli di protagonista fra le nuove correnti della musica tropicale ad influsso jazz che spirano forti oltre l’Atlantico. Ricorda a momenti le elucubrazioni fonetiche di Bobby McFerrin l’album di Aiòn Me Vs Myself (Giorgio Pinardi) edito da Alterjinga, per lo scavo, a livello di vocalizzazione, effettuato su realtà musicali remote. Non cambia l’approccio sia che provengano dall’Africa della tribù Dagara in “Yelbongura” o dal gaelico in “Scriob” o dal danese arcaico di “Hyggelig”. C’è, in genere, una “manipolazione” dei materiali musicali trattati – e questo accade ancora in “Leys” – che forse lo stesso Demetrio Stratos oggi non avrebbe disdegnato nelle proprie “investigazioni” tendenti a far “cantare la voce”. Il lavoro continua con “Waldeinsamkeit”, impronunciabile termine tedesco che non ha una diretta traduzione in inglese e che vuol dire essere in connessione con la natura (e con la musica) e con “Rwty” (Sfinge in antico egiziano) a riprova di come, in musica, la ricerca etimologica si possa coniugare con quella etnologica. Chiudono l’album il desertico “Kamtar” quindi “aPHaSIa” (stesso significato in italiano) e “Nèkya” ovverossia la discesa agli inferi dei greci, detta in termini psicanalitici il processo younghiano di scoperta dell’inconscio.
Ricorda a momenti le elucubrazioni fonetiche di Bobby McFerrin l’album di Aiòn Me Vs Myself (Giorgio Pinardi) edito da Alterjinga, per lo scavo, a livello di vocalizzazione, effettuato su realtà musicali remote. Non cambia l’approccio sia che provengano dall’Africa della tribù Dagara in “Yelbongura” o dal gaelico in “Scriob” o dal danese arcaico di “Hyggelig”. C’è, in genere, una “manipolazione” dei materiali musicali trattati – e questo accade ancora in “Leys” – che forse lo stesso Demetrio Stratos oggi non avrebbe disdegnato nelle proprie “investigazioni” tendenti a far “cantare la voce”. Il lavoro continua con “Waldeinsamkeit”, impronunciabile termine tedesco che non ha una diretta traduzione in inglese e che vuol dire essere in connessione con la natura (e con la musica) e con “Rwty” (Sfinge in antico egiziano) a riprova di come, in musica, la ricerca etimologica si possa coniugare con quella etnologica. Chiudono l’album il desertico “Kamtar” quindi “aPHaSIa” (stesso significato in italiano) e “Nèkya” ovverossia la discesa agli inferi dei greci, detta in termini psicanalitici il processo younghiano di scoperta dell’inconscio. Il Duende, per Garcia Lorca, è un imprecisato non so che proprio di alcuni toreri, pittori, poeti, musicisti, uno “stile vivo”, “creaciòn en acto”, fluido irresistibile che arriva al pubblico e che, nei “suoni neri” del jazz, è stato da alcuni associato alla Holiday ed a Miles Davis. Il ribattezzare Duende un progetto discografico, come hanno fatto la vocalist Rita Bincoletto, il chitarrista Diego Vio, il percussionista Max Trabucco e l’ospite Anais Drago, violinista, assume l’intento di traslare la cultura flamenca del poeta spagnolo ricercando le relazioni di quel “potere” nel pianeta liquido del Mediterraneo. La loro traversata geOnirica in un ondoso campo largo li porta fino alla Grecia del traditional “Amygdalaki Tsakisa” ed al Medio Oriente di “Isfahan Trip”; quindi, tramite “Desert Way”, eccoli incrociare figure reali (“Isola”) e mitologiche (“Tres Sirenas”). Un lavoro “waterworld” pubblicato da Abeat Records che consta di nove brani in tutto per la maggior parte scritti e/o arrangiati da Bincoletto, Vio e Trabucco, navigatori fra i suoni marini.
Il Duende, per Garcia Lorca, è un imprecisato non so che proprio di alcuni toreri, pittori, poeti, musicisti, uno “stile vivo”, “creaciòn en acto”, fluido irresistibile che arriva al pubblico e che, nei “suoni neri” del jazz, è stato da alcuni associato alla Holiday ed a Miles Davis. Il ribattezzare Duende un progetto discografico, come hanno fatto la vocalist Rita Bincoletto, il chitarrista Diego Vio, il percussionista Max Trabucco e l’ospite Anais Drago, violinista, assume l’intento di traslare la cultura flamenca del poeta spagnolo ricercando le relazioni di quel “potere” nel pianeta liquido del Mediterraneo. La loro traversata geOnirica in un ondoso campo largo li porta fino alla Grecia del traditional “Amygdalaki Tsakisa” ed al Medio Oriente di “Isfahan Trip”; quindi, tramite “Desert Way”, eccoli incrociare figure reali (“Isola”) e mitologiche (“Tres Sirenas”). Un lavoro “waterworld” pubblicato da Abeat Records che consta di nove brani in tutto per la maggior parte scritti e/o arrangiati da Bincoletto, Vio e Trabucco, navigatori fra i suoni marini. Chansons sous les doigts è una selezione di 19 canzoni francesi arrangiate per piano da Vincenzo Caruso che ci ricorda quanto ci siano vicini, in musica, i cugini transalpini. Sono tratteggiate, nell’album Dodicilune, in modo essenziale, scarnificate del testo con focus sulla melodia e l’armonizzazione con sensibilità moderna. Caruso se ne innamorò giovanissimo tramite gli spartiti inviatigli dallo zio Antonio Di Domenico, chansonnier ed editore a Parigi, coltivando nel tempo una passione pianistica che lo avrebbe portato a collaborare a Irma la Douce, la famosa commedia musicata da Marguerite Monnot, di cui ripropone nel disco la “Piccola Suite per Piano”. I temi proposti sono di nomi altisonanti come Henry Salvador (“Syracuse”), Gilbert Becaud (“Quand il est mort le poète”), Georges Brassens (“J’ai rendez vous avec vous”) … L’antologia rappresenta un omaggio alla chanson in cui il pianoforte contende lo scettro di strumento principe alla fisarmonica e, nel contempo, ne offre un’ampia gamma – “Le tango corse”, lo swing di “On est pas là pour se faire engueler”, l’incipit musorgskiano di “Comèdie”, il walzer di “Domani”, il distillar note alla Satie di “Le deserteur” – che ne saggia la tavolozza espressiva e coloristica. Il disco è chiuso da “Après l’ourage” che potrebbe, perche no, commentare un film di Méliès, muto, tanto la narrazione è affidata alle dieci dita, les doigts, sulla tastiera.
Chansons sous les doigts è una selezione di 19 canzoni francesi arrangiate per piano da Vincenzo Caruso che ci ricorda quanto ci siano vicini, in musica, i cugini transalpini. Sono tratteggiate, nell’album Dodicilune, in modo essenziale, scarnificate del testo con focus sulla melodia e l’armonizzazione con sensibilità moderna. Caruso se ne innamorò giovanissimo tramite gli spartiti inviatigli dallo zio Antonio Di Domenico, chansonnier ed editore a Parigi, coltivando nel tempo una passione pianistica che lo avrebbe portato a collaborare a Irma la Douce, la famosa commedia musicata da Marguerite Monnot, di cui ripropone nel disco la “Piccola Suite per Piano”. I temi proposti sono di nomi altisonanti come Henry Salvador (“Syracuse”), Gilbert Becaud (“Quand il est mort le poète”), Georges Brassens (“J’ai rendez vous avec vous”) … L’antologia rappresenta un omaggio alla chanson in cui il pianoforte contende lo scettro di strumento principe alla fisarmonica e, nel contempo, ne offre un’ampia gamma – “Le tango corse”, lo swing di “On est pas là pour se faire engueler”, l’incipit musorgskiano di “Comèdie”, il walzer di “Domani”, il distillar note alla Satie di “Le deserteur” – che ne saggia la tavolozza espressiva e coloristica. Il disco è chiuso da “Après l’ourage” che potrebbe, perche no, commentare un film di Méliès, muto, tanto la narrazione è affidata alle dieci dita, les doigts, sulla tastiera. Ci sono tre quarti d’ora buoni di musica nell’album TMR Tuscany Music Revolution, prodotto dalla label tedesca Aut Records, divisa in sette parti di durata varia che va dai due agli otto minuti. Ne è protagonista l’Improvvisazione con consonanze (II) e minimalismi (III), africanerie (IV) e simil-musica d’oggi (V)… Il parterre artistico internazionale (V. Sutera, v; M. Mazzini, cl; E. Novali, pf; A. Braida, pf; F. Calcagno, cl; A. Bolzoni, g; L. Pissavini, cb; S. Di Benedetto, cb; D. Koutè (perc); S. Scucces (vib.), G. Lattuada (perc); L. D’Erasmo (frame dr); S. Grasso (dr) non “inscena” un ritorno al postfree semmai si pone in termini di attualizzazione e “rivoluzionaria” evoluzione di quell’area creativa che l’ Europa, Italia compresa, ha espresso anche in anni recenti dall’asse anglo-olandese fin giù a scendere sulla cartina geomusicale. Il collettivo è un esempio di interazione democratica e paritaria che, al pari di stormi liberi ma coordinati, delinea impreviste dinamie sonore e traiettorie mutaforma, in un fluttuare a volte sincronico altre no comunque ancorato alla struttura dei vari insiemi che si avvicendano.
Ci sono tre quarti d’ora buoni di musica nell’album TMR Tuscany Music Revolution, prodotto dalla label tedesca Aut Records, divisa in sette parti di durata varia che va dai due agli otto minuti. Ne è protagonista l’Improvvisazione con consonanze (II) e minimalismi (III), africanerie (IV) e simil-musica d’oggi (V)… Il parterre artistico internazionale (V. Sutera, v; M. Mazzini, cl; E. Novali, pf; A. Braida, pf; F. Calcagno, cl; A. Bolzoni, g; L. Pissavini, cb; S. Di Benedetto, cb; D. Koutè (perc); S. Scucces (vib.), G. Lattuada (perc); L. D’Erasmo (frame dr); S. Grasso (dr) non “inscena” un ritorno al postfree semmai si pone in termini di attualizzazione e “rivoluzionaria” evoluzione di quell’area creativa che l’ Europa, Italia compresa, ha espresso anche in anni recenti dall’asse anglo-olandese fin giù a scendere sulla cartina geomusicale. Il collettivo è un esempio di interazione democratica e paritaria che, al pari di stormi liberi ma coordinati, delinea impreviste dinamie sonore e traiettorie mutaforma, in un fluttuare a volte sincronico altre no comunque ancorato alla struttura dei vari insiemi che si avvicendano. Il chitarrismo manouche, quello praticato a livelli alti di nomadismo dei polpastrelli, può talora lasciar trasparire una certa patina di “monadismo”, per così dire, quando vi si riscontra unità inclusiva del connotato stilistico di base. E’ il caso dell’album Gypsy Jazz Style di Pietro Lazazzara (Stradivarius), seconda uscita discografica a sua firma, con una dozzina di inediti eseguiti all’insegna della convergenza di varietà e contaminazioni. L’ ensemble annovera Antonio Solazzo al basso, Francesco Clemente e Sabrina Loforese al volino, Maria Pia Lazazzara al violoncello, Luigi Vania alla viola, Nicoletta Di Sabato al flauto e Giuseppe Magistro al tamburello. Campeggia sullo sfondo, sin dal primo brano “Mister Swing”, l’ologramma di Django. Poi la musica, strada facendo, si fa intima in “Precious”, intinta di classico in “La via di Pia”, melò in “Walk with Me”, walzer notturno in “The Tale of the Moon”, flamenco in “La tela di Picasso”, tarant(ell)a in “Puglia”, moderato swing in “Blue Night”, sostenuto in “La joie de vivre”, è balcanica in “Circus”, tutta coracon in “Spanish Boulevard”, infine tripudio di note in “Impro in D Minor” con il gruppo che si trasforma in Gypsy Jazz Style Kings.
Il chitarrismo manouche, quello praticato a livelli alti di nomadismo dei polpastrelli, può talora lasciar trasparire una certa patina di “monadismo”, per così dire, quando vi si riscontra unità inclusiva del connotato stilistico di base. E’ il caso dell’album Gypsy Jazz Style di Pietro Lazazzara (Stradivarius), seconda uscita discografica a sua firma, con una dozzina di inediti eseguiti all’insegna della convergenza di varietà e contaminazioni. L’ ensemble annovera Antonio Solazzo al basso, Francesco Clemente e Sabrina Loforese al volino, Maria Pia Lazazzara al violoncello, Luigi Vania alla viola, Nicoletta Di Sabato al flauto e Giuseppe Magistro al tamburello. Campeggia sullo sfondo, sin dal primo brano “Mister Swing”, l’ologramma di Django. Poi la musica, strada facendo, si fa intima in “Precious”, intinta di classico in “La via di Pia”, melò in “Walk with Me”, walzer notturno in “The Tale of the Moon”, flamenco in “La tela di Picasso”, tarant(ell)a in “Puglia”, moderato swing in “Blue Night”, sostenuto in “La joie de vivre”, è balcanica in “Circus”, tutta coracon in “Spanish Boulevard”, infine tripudio di note in “Impro in D Minor” con il gruppo che si trasforma in Gypsy Jazz Style Kings. “Voyager” è uno dei brani di punta del secondo album firmato dal batterista Giovanni Angelini dal titolo Freedom Rhythm, otto brani, scritti di proprio pugno, dal groove eclettico che mette assieme jazz funk afro soul e che non disdegna il guardare indietro, fino ai fab ’70. Ovviamente si tratta di un jazzista moderno ma con il piacere di far “viaggiare” la propria musica nello spaziotempo pilotandola da bandleader. Piace pensare che il “ritmo in libertà” sia anche quello del drummer che si svincola, crea, costruisce, si autointerpreta. Ed è infatti la veste di compositore quella che vi rispecchia le qualità di ideatore di strutture compless(iv)e caratterizzate da franca immediatezza e circolarità di un suono plasmato con Vince Abbracciante al piano, Dario Giacovelli al basso, Alberto Parmegiani alla chitarra, Gaetano Partipilo all’alto sax, Giuseppe Todisco alla tromba, Antonio Fallacara al trombone quindi Giovanni Astorino al cello. Ai quali si aggiunge il canto di Simona Severini con la “gemma” di “I Need Your Smile”. La sezione dei tre fiati assume un ruolo energico nello sviluppo dei temi (e nell’alternarsi improvvisativo) dalle linee melodiche che effettivamente rimangono impresse, un po’ tutte, da “Subway” fino a “Unity”, “Release The Monkey”, “Wuelva”, “Compass”, e nel contempo si muovono su scansioni metriche e schemi accordali nient’affatto scontati. Insomma ancora un bel prodotto del catalogo A.Ma Records!
“Voyager” è uno dei brani di punta del secondo album firmato dal batterista Giovanni Angelini dal titolo Freedom Rhythm, otto brani, scritti di proprio pugno, dal groove eclettico che mette assieme jazz funk afro soul e che non disdegna il guardare indietro, fino ai fab ’70. Ovviamente si tratta di un jazzista moderno ma con il piacere di far “viaggiare” la propria musica nello spaziotempo pilotandola da bandleader. Piace pensare che il “ritmo in libertà” sia anche quello del drummer che si svincola, crea, costruisce, si autointerpreta. Ed è infatti la veste di compositore quella che vi rispecchia le qualità di ideatore di strutture compless(iv)e caratterizzate da franca immediatezza e circolarità di un suono plasmato con Vince Abbracciante al piano, Dario Giacovelli al basso, Alberto Parmegiani alla chitarra, Gaetano Partipilo all’alto sax, Giuseppe Todisco alla tromba, Antonio Fallacara al trombone quindi Giovanni Astorino al cello. Ai quali si aggiunge il canto di Simona Severini con la “gemma” di “I Need Your Smile”. La sezione dei tre fiati assume un ruolo energico nello sviluppo dei temi (e nell’alternarsi improvvisativo) dalle linee melodiche che effettivamente rimangono impresse, un po’ tutte, da “Subway” fino a “Unity”, “Release The Monkey”, “Wuelva”, “Compass”, e nel contempo si muovono su scansioni metriche e schemi accordali nient’affatto scontati. Insomma ancora un bel prodotto del catalogo A.Ma Records! Con In Hora Mortis la ricerca musicale del percussionista Massimo Barbiero, ancora una volta al confine fra filosofia e psicanalisi, si ritrova ad investigare, per il tramite del suono inteso come elemento vitale primario, il momento terminale del vivere. Un argomento che da Platone a Epicuro a Freud ha appassionato e arrovellato il pensiero umano antico e moderno. Barbiero lo affronta con gli “strumenti” che gli sono più congeniali e cioè quelli del suo ricco set percussivo. Per l’occasione suddivide l’hora in più momenti temporali gradualizzandola secondo una scala emotiva augmentante che non tradisce pathos mortiferi o pianti greci. La musica “domina” la possibile angoscia, la esorcizza, prende atto che i minuti che preludono all’ultimo atto dell’esistenza sono vita tout court e come tali possono essere vissuti magari riprodotti e sonorizzati da gong campane ritmi… Barbiero materializza così la propria “fantasia di sparizione” (Fagioli) in un disco coraggioso per Il tema che affronta e offre una lettura del tutto originale del fine vita che va ad installarsi in un percorso artistico di sperimentata coerenza culturale.
Con In Hora Mortis la ricerca musicale del percussionista Massimo Barbiero, ancora una volta al confine fra filosofia e psicanalisi, si ritrova ad investigare, per il tramite del suono inteso come elemento vitale primario, il momento terminale del vivere. Un argomento che da Platone a Epicuro a Freud ha appassionato e arrovellato il pensiero umano antico e moderno. Barbiero lo affronta con gli “strumenti” che gli sono più congeniali e cioè quelli del suo ricco set percussivo. Per l’occasione suddivide l’hora in più momenti temporali gradualizzandola secondo una scala emotiva augmentante che non tradisce pathos mortiferi o pianti greci. La musica “domina” la possibile angoscia, la esorcizza, prende atto che i minuti che preludono all’ultimo atto dell’esistenza sono vita tout court e come tali possono essere vissuti magari riprodotti e sonorizzati da gong campane ritmi… Barbiero materializza così la propria “fantasia di sparizione” (Fagioli) in un disco coraggioso per Il tema che affronta e offre una lettura del tutto originale del fine vita che va ad installarsi in un percorso artistico di sperimentata coerenza culturale.


























 A dire il vero, dopo il primo melodico Sanremo del ’51, una decisa aura jazz si era avvertita in Nati per la Musica, un programma con Jula De Palma, Quartetto Cetra, Teddy Reno che si avvaleva delle orchestre di ritmi moderni di Gorni Kramer e Lelio Luttazzi, la cui sigla è ascoltabile sul Portale della Canzone Italiana dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi (www.canzone italiana.it/1zlns). Sorella Radio avrebbe dato anche in seguito significativi contributi alla causa jazzistica – si pensi all’uso fatto da Radio1 dello stacco di “Country“ tratto dal cd “My Song” di Jarrett con Garbarek, Danielson e Christensen (ECM, 1977) – ma il copioso materiale di Mamma Rai, con il ricchissimo archivio sonoro ad oggi digitalizzato, meriterebbe di essere approfondito in altra sede. Torniamo allora al come eravamo tramite il cosa guardavamo. Dopo la vittoria di Modugno all’Ariston nel ’58, con una “Nel blu dipinto di blu” a ritmo swing, nell’anno di grazia televisivo 1961 passavano in video le immagini di Moderato Swing che era anche il titolo della sigla di Piero Umiliani. Un biennio ancora per poi sentire il canto e la tromba di Nini Rosso echeggiare in “I ragazzi del jazz”, sigla di Fuori I ’Orchestra, epica trasmissione, per la regia di Lino Procacci, che si avvaleva della direzione musicale dello stesso Umiliani. Si trattava di una rubrica che si occupava “di musica equidistante fra quella leggerissima e quella classica“ (
A dire il vero, dopo il primo melodico Sanremo del ’51, una decisa aura jazz si era avvertita in Nati per la Musica, un programma con Jula De Palma, Quartetto Cetra, Teddy Reno che si avvaleva delle orchestre di ritmi moderni di Gorni Kramer e Lelio Luttazzi, la cui sigla è ascoltabile sul Portale della Canzone Italiana dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi (www.canzone italiana.it/1zlns). Sorella Radio avrebbe dato anche in seguito significativi contributi alla causa jazzistica – si pensi all’uso fatto da Radio1 dello stacco di “Country“ tratto dal cd “My Song” di Jarrett con Garbarek, Danielson e Christensen (ECM, 1977) – ma il copioso materiale di Mamma Rai, con il ricchissimo archivio sonoro ad oggi digitalizzato, meriterebbe di essere approfondito in altra sede. Torniamo allora al come eravamo tramite il cosa guardavamo. Dopo la vittoria di Modugno all’Ariston nel ’58, con una “Nel blu dipinto di blu” a ritmo swing, nell’anno di grazia televisivo 1961 passavano in video le immagini di Moderato Swing che era anche il titolo della sigla di Piero Umiliani. Un biennio ancora per poi sentire il canto e la tromba di Nini Rosso echeggiare in “I ragazzi del jazz”, sigla di Fuori I ’Orchestra, epica trasmissione, per la regia di Lino Procacci, che si avvaleva della direzione musicale dello stesso Umiliani. Si trattava di una rubrica che si occupava “di musica equidistante fra quella leggerissima e quella classica“ ( Dal giornalismo d’inchiesta a quello sportivo: nel ’78 era il turno di Jazz Band di Hengel Gualdi a far da “preludio” a Novantesimo minuto, storica rubrica di RaiSport, e come non citare, dal campionario di La Domenica Sportiva, “Dribbling” di Piero Umiliani (1967), “Winning The West” della Buddy Rich Big Band (1973), “Mexico” di Danilo Rea e Roberto Gatto (1985), “Breakout” di Spyro Gira (1991)? Spostandoci alla “pagina” spettacoli, fra il ’76 e il ‘78, Rete 2 dava spazio in Odeon al pianista Keith Emerson (senza Lake e Palmer) in “Odeon Rag” arrangiamento di “Maple Leaf Rag” di Scott Joplin, subentrato in luogo del precedente “Honky Tonk Train Blues”, autore il pianista Meade Lux Lewis. Il filone spettacolistico avrebbe registrato più in là significativi esempi con lo scat di Lucio Dalla con gli Stadio che annuncia Lunedifilm per un buon ventennio fino al 2002 e l’ellingtoniano “Take The A Train” di Strayhorn a fare da intro ai trailer cinematografici assemblati da AnicaFlash per la rassegna delle novità cinematografiche “di stagione”. Si diceva come luogo fertile per la semina tv di suoni jazz da filtrare nelle orecchie dei telespettatori fosse l’informazione. Gettonatissima rimane al riguardo la sigla di Mixer (1980-1996) ovvero “Jazz Carnival” dei brasiliani Azimuth, specialisti del samba doido, genere fusion-funky. Latin come nelle radiocronache di Tutto il calcio minuto per minuto, dove Herb Alpert e Tijuana Brass interpretano “A Taste of Honey”, brano di stampo pop, in repertorio a Beatles e Giganti (“In paese è festa”). Per la tv italiana va ricordato che, fuori dal reticolo giornalistico, si contano altre occasioni più dirette di esposizione per la musica jazz filtrata tramite il piccolo schermo. La Portobello Jazz Band di Lino Patruno “presentava” il programma di Enzo Tortora (cfr. La tana delle sigle in tds.sigletv.net) nel 1978, stesso anno dello sceneggiato in 3 puntate Jazz Band di Pupi Avati, colonna sonora di Amedeo Tommasi, con il clarino di Hengel Gualdi in evidenza nelle sigle di apertura e chiusura, “Jazz Band” e “Swing Time” ; poi ancora Di Jazz in Jazz, programma “dedicato” con relativa sigla a cura dell’Orchestra Big Band della Rai diretta da Giampiero Boneschi e Franco Cerri (
Dal giornalismo d’inchiesta a quello sportivo: nel ’78 era il turno di Jazz Band di Hengel Gualdi a far da “preludio” a Novantesimo minuto, storica rubrica di RaiSport, e come non citare, dal campionario di La Domenica Sportiva, “Dribbling” di Piero Umiliani (1967), “Winning The West” della Buddy Rich Big Band (1973), “Mexico” di Danilo Rea e Roberto Gatto (1985), “Breakout” di Spyro Gira (1991)? Spostandoci alla “pagina” spettacoli, fra il ’76 e il ‘78, Rete 2 dava spazio in Odeon al pianista Keith Emerson (senza Lake e Palmer) in “Odeon Rag” arrangiamento di “Maple Leaf Rag” di Scott Joplin, subentrato in luogo del precedente “Honky Tonk Train Blues”, autore il pianista Meade Lux Lewis. Il filone spettacolistico avrebbe registrato più in là significativi esempi con lo scat di Lucio Dalla con gli Stadio che annuncia Lunedifilm per un buon ventennio fino al 2002 e l’ellingtoniano “Take The A Train” di Strayhorn a fare da intro ai trailer cinematografici assemblati da AnicaFlash per la rassegna delle novità cinematografiche “di stagione”. Si diceva come luogo fertile per la semina tv di suoni jazz da filtrare nelle orecchie dei telespettatori fosse l’informazione. Gettonatissima rimane al riguardo la sigla di Mixer (1980-1996) ovvero “Jazz Carnival” dei brasiliani Azimuth, specialisti del samba doido, genere fusion-funky. Latin come nelle radiocronache di Tutto il calcio minuto per minuto, dove Herb Alpert e Tijuana Brass interpretano “A Taste of Honey”, brano di stampo pop, in repertorio a Beatles e Giganti (“In paese è festa”). Per la tv italiana va ricordato che, fuori dal reticolo giornalistico, si contano altre occasioni più dirette di esposizione per la musica jazz filtrata tramite il piccolo schermo. La Portobello Jazz Band di Lino Patruno “presentava” il programma di Enzo Tortora (cfr. La tana delle sigle in tds.sigletv.net) nel 1978, stesso anno dello sceneggiato in 3 puntate Jazz Band di Pupi Avati, colonna sonora di Amedeo Tommasi, con il clarino di Hengel Gualdi in evidenza nelle sigle di apertura e chiusura, “Jazz Band” e “Swing Time” ; poi ancora Di Jazz in Jazz, programma “dedicato” con relativa sigla a cura dell’Orchestra Big Band della Rai diretta da Giampiero Boneschi e Franco Cerri (
 Jon Balke Siwan – “Hafla” – ECM
Jon Balke Siwan – “Hafla” – ECM Flavio Boltro, Fabio Giachino – “Things to Say” – Cam Jazz
Flavio Boltro, Fabio Giachino – “Things to Say” – Cam Jazz Avishai Cohen – “Naked Truth” – ECM
Avishai Cohen – “Naked Truth” – ECM Claudio Cojaniz – “Orfani” – Caligola
Claudio Cojaniz – “Orfani” – Caligola Lorenzo De Finti Quartet – “Mysterium Lunae” – Losen
Lorenzo De Finti Quartet – “Mysterium Lunae” – Losen Joey DeFrancesco – “More Music” – Mack Avenue
Joey DeFrancesco – “More Music” – Mack Avenue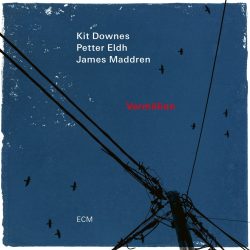 Kit Downes – “Vermillion” – ECM
Kit Downes – “Vermillion” – ECM Mathias Eick – “When We Leave” – ECM
Mathias Eick – “When We Leave” – ECM Antonio Flinta – “Secrets of a Kiri Tree” – Autoprod.
Antonio Flinta – “Secrets of a Kiri Tree” – Autoprod. Tord Gustavsen – “Opening” – ECM
Tord Gustavsen – “Opening” – ECM Roberto Laneri – “Musica finta / Blue Prints” – Da Vinci Classics
Roberto Laneri – “Musica finta / Blue Prints” – Da Vinci Classics “South of No Border” (come si diceva registrato tra il 2014 e il 2018 ma anch’esso pubblicato poche settimane fa) vede Roberto Laneri (clarinetto, clarinetto basso, sax sopranino, sax soprano e alto, didjeridoo, shruti box, voce e percussioni) alla testa di un gruppo comprendente Giuppi Paone voce, Raffaela Siniscalchi voce, Eleonora Vulpiani chitarra, Luigi Polsini contrabbasso e Laugi Marino zarb. Contrariamente al primo album, in questo caso il repertorio è come una sorta di finestra affacciata sulle musiche del mondo. Ecco, quindi, dopo l’apertura affidata alle melodie orientaleggianti di “Malia” (scritta da Laneri), il choro brasiliano “Tico-Tico no fubá” (scritto da Zequinha de Abreu nel 1917, accanto al bolero cubano “Contigo En La Distancia” scritto dal cantautore César Portillo de la Luz quando aveva 24 anni nel 1946, il tutto impreziosito da 4 original del leader. A confronto con un tale repertorio, Laneri dà ancora una volta prova non solo della sua indiscussa preparazione tecnica ma anche della profonda conoscenza del panorama musicale internazionale. Le sue interpretazioni risultano, quindi, assolutamente pertinenti: traendo feconda ispirazione da svariate tradizioni, riesce a produrre una sintesi che non conosce confini geografici grazie ad una concezione visionaria della musica senza barriere. Insomma un disco originale nella concezione e nell’esecuzione.
“South of No Border” (come si diceva registrato tra il 2014 e il 2018 ma anch’esso pubblicato poche settimane fa) vede Roberto Laneri (clarinetto, clarinetto basso, sax sopranino, sax soprano e alto, didjeridoo, shruti box, voce e percussioni) alla testa di un gruppo comprendente Giuppi Paone voce, Raffaela Siniscalchi voce, Eleonora Vulpiani chitarra, Luigi Polsini contrabbasso e Laugi Marino zarb. Contrariamente al primo album, in questo caso il repertorio è come una sorta di finestra affacciata sulle musiche del mondo. Ecco, quindi, dopo l’apertura affidata alle melodie orientaleggianti di “Malia” (scritta da Laneri), il choro brasiliano “Tico-Tico no fubá” (scritto da Zequinha de Abreu nel 1917, accanto al bolero cubano “Contigo En La Distancia” scritto dal cantautore César Portillo de la Luz quando aveva 24 anni nel 1946, il tutto impreziosito da 4 original del leader. A confronto con un tale repertorio, Laneri dà ancora una volta prova non solo della sua indiscussa preparazione tecnica ma anche della profonda conoscenza del panorama musicale internazionale. Le sue interpretazioni risultano, quindi, assolutamente pertinenti: traendo feconda ispirazione da svariate tradizioni, riesce a produrre una sintesi che non conosce confini geografici grazie ad una concezione visionaria della musica senza barriere. Insomma un disco originale nella concezione e nell’esecuzione. Roberto Magris – “Match Point” – JMood / Roberto Magris – “Duo & Trio” – JMood
Roberto Magris – “Match Point” – JMood / Roberto Magris – “Duo & Trio” – JMood Dino & Franco Piana Ensemble – “Reflections” –Alfa Music
Dino & Franco Piana Ensemble – “Reflections” –Alfa Music Valentina Ranalli, Enrico Pieranunzi – “Cantare Pieranunzi” – Alfa Music
Valentina Ranalli, Enrico Pieranunzi – “Cantare Pieranunzi” – Alfa Music Completamente diverso il secondo album – “The Extra Something” – registrato live il 13 e 14 gennaio 2016 al Village Vanguard da un quintetto che vedeva il pianista romano in compagnia di Diego Urcola tromba e trombone (semplicemente straordinario nella title tracke), Seamus Blake sax tenore (particolarmente convincente in “Atoms”), Ben Street basso e Adam Cruz batteria. E per quanti seguono il jazz non c’è bisogno di altre parole per sottolineare il valore assoluto della band. Valore assoluto che si evidenzia in tutto il repertorio, sette brani tutti composti dal pianista. Pieranunzi, come spesso gli capita, è in uno stato di grazie e conduce il gruppo con mano sicura, del tutto consapevole dell’intesa che ha raggiunto con i compagni di viaggio. Dal punto di vista compositivo non scopriamo certo oggi il suo senso della struttura che mai l’abbandona, per cui se consideriamo tutti questi elementi si capisce bene perché il ben noto Brian Morton abbia incluso Enrico tra “i più significativi musicisti contemporanei”. Nelle note di copertina Pieranunzi dedica espressamente questo terzo CD Live at The Village Vanguard a Lorraine Gordon in memoriam, senza la quale né questo né i precedenti due si sarebbero potuti realizzare. Ricordiamo per inciso che il pianista romano è forse l’unico musicista italiano nella veste di leader ed uno dei pochissimi europei ad aver suonato nel leggendario jazz club a forma di diamante aperto da Max Gordon nel 1935 al 178 Seventh Avenue South di Manhattan.
Completamente diverso il secondo album – “The Extra Something” – registrato live il 13 e 14 gennaio 2016 al Village Vanguard da un quintetto che vedeva il pianista romano in compagnia di Diego Urcola tromba e trombone (semplicemente straordinario nella title tracke), Seamus Blake sax tenore (particolarmente convincente in “Atoms”), Ben Street basso e Adam Cruz batteria. E per quanti seguono il jazz non c’è bisogno di altre parole per sottolineare il valore assoluto della band. Valore assoluto che si evidenzia in tutto il repertorio, sette brani tutti composti dal pianista. Pieranunzi, come spesso gli capita, è in uno stato di grazie e conduce il gruppo con mano sicura, del tutto consapevole dell’intesa che ha raggiunto con i compagni di viaggio. Dal punto di vista compositivo non scopriamo certo oggi il suo senso della struttura che mai l’abbandona, per cui se consideriamo tutti questi elementi si capisce bene perché il ben noto Brian Morton abbia incluso Enrico tra “i più significativi musicisti contemporanei”. Nelle note di copertina Pieranunzi dedica espressamente questo terzo CD Live at The Village Vanguard a Lorraine Gordon in memoriam, senza la quale né questo né i precedenti due si sarebbero potuti realizzare. Ricordiamo per inciso che il pianista romano è forse l’unico musicista italiano nella veste di leader ed uno dei pochissimi europei ad aver suonato nel leggendario jazz club a forma di diamante aperto da Max Gordon nel 1935 al 178 Seventh Avenue South di Manhattan. Serena Spedicato – “Io che amo solo te” – Dodicilune
Serena Spedicato – “Io che amo solo te” – Dodicilune Andrés Thor – Hereby – Losen
Andrés Thor – Hereby – Losen Mark Turner – “Return From The Stars” – ECM
Mark Turner – “Return From The Stars” – ECM Cristina Zavalloni – “Parlami di me” – Egea
Cristina Zavalloni – “Parlami di me” – Egea














