da Beniamino Gatto | 18/Mar/2024 | Eventi, I nostri Eventi, News, Primo piano, Recensioni
Se mi si consente l’espressione, si è chiuso con il classico “botto” il secondo ciclo de “L’Altra Metà del Jazz” ideato e condotto da Gerlando Gatto alla Casa del Jazz di Roma.
Martedì scorso, per la serata conclusiva che ha visto come ospiti Cinzia Tedesco e Laura Sciocchetti, sala praticamente piena e pubblico sinceramente entusiasta ad applaudire sia le interviste sia le performance delle due straordinarie vocalist.
Questi appuntamenti avevano un preciso obiettivo: prendendo spunto dal libro di Gatto “L’Altra Metà del Jazz”, si voleva portare a conoscenza del pubblico il fatto che oramai la scena jazzistica è frequentata da un gran numero di jazziste che sul piano artistico nulla hanno da invidiare ai colleghi “maschi”. Di qui la scelta di 22 musiciste, due per ciascuna serata, una già affermata, l’altra in sicura crescita.
Ebbene, a conti fatti, si può ben affermare che tutte le musiciste invitate hanno dato prova di un talento indiscusso che ha letteralmente affascinato il pubblico accorso, sempre numeroso.
Per corroborare il presupposto di tutta l’iniziativa, alla fine dell’ultima serata mi sono divertito a chiedere il parere di alcuni spettatori e le risposte sono state pressoché unanimi: “Ottimo format e ottima la scelta delle artiste”, “Strepitosa Cinzia, suadente Laura, elegante l’intervistatore”, “Bella la formula che tende a far conoscere chi c’è oltre l’artista”.
In effetti Gatto, con le sue interviste, ha sempre inteso mostrare al pubblico chi sono i personaggi da lui intervistati al di là del profilo pubblico facilmente rintracciabile dai dischi e sui social. E ovviamente anche l’ultima serata si è dipanata lungo questo filo conduttore con una specificità: Gatto ha sempre dichiarato di conoscere bene le musiciste da lui intervistate tranne qualche eccezione tra cui la vocalist che ha chiuso la serata vale a dire Laura Sciocchetti.
Ma procediamo con ordine.
-

- Cinzia Tedesco, Gerlando Gatto
-

- Cinzia Tedesco, Gerlando Gatto, Pino Jodice
-

- Cinzia Tedesco, Gerlando Gatto, Pino Jodice
-

- Cinzia Tedesco, Gerlando Gatto
-

- Cinzia Tedesco, Pino Jodice
-

- Cinzia Tedesco, Gerlando Gatto
-

- Cinzia Tedesco, Gerlando Gatto
Come accennato, la vocalist Cinzia Tedesco ha aperto la serata raccontando la sua storia, confermando l’intuizione di Gatto che voluto mettere in luce il suo lato umano, al di là del suo nutrito curriculum artistico. Cinzia, per una forma di pudore interiore, tende a non far trasparire il suo essere, la sua anima. Ciononostante, vuoi per l’atmosfera creatasi nell’incontro, vuoi per la consapevolezza che l’intento di Gatto era unicamente quello di farla sentire a proprio agio, la vocalist parla a ruota libera ripercorrendo con partecipazione e non senza una punta di orgoglio i vari stadi della sua vita: dall’infanzia vissuta in un aeroporto militare, ai suoi studi e ai traguardi conseguiti grazie al duro lavoro e all’impegno: si dichiara infatti soddisfatta e talvolta anche sorpresa di quello che è riuscita ad ottenere, oltre che curiosa di quanto ancora può raggiungere. Parlando più specificatamente della sua carriera, racconta di aver iniziato a cantare con la band del padre, polistrumentista autodidatta ed ex cantante, che organizzava dei concerti in aeroporto, alle feste di matrimonio ed anche alle feste patronali; per quanto riguarda invece la formazione esterna alla musica, Cinzia ha studiato informatica all’università e si è laureata a pieni voti, laurea che la porterà a lavorare per alcune aziende di alto profilo soprattutto nel campo della direzione commerciale e, proprio per questo, a trasferirsi a Roma.
Alla ormai consueta domanda di Gatto sulle eventuali difficoltà riscontrate nell’ambiente dovute al suo essere donna, Cinzia risponde parlando delle iniziative a cui prende parte che si occupano proprio di questo tema, dando particolare spazio al suo lavoro come ambasciatrice della rete Inclusione Donna, che si occupa di portare avanti istanze a livello istituzionale riguardo alla prevalenza di uomini, negli organi direzionali di numerose aziende, uomini con i quali, puntualizza Cinzia, non ha alcun malvolere, così come verso i numerosi musicisti con cui ha lavorato. Ciò non toglie, comunque, che sia necessario un lavoro più incisivo per avere una presenza maggiore di donne, ad esempio nelle direzioni artistiche dei vari festival, dominate da uomini che spesso guardano con titubanza le artiste, in primis le vocalist; Cinzia ci tiene tuttavia a precisare la sua posizione contro i festival cosiddetti “al femminile”, colpevoli a suo dire di attuare una ghettizzazione delle artiste, e un loro confinamento in un recinto ad esse riservato.
Virando invece sul lato più intimo della sua vita, parla del suo matrimonio che resiste da tanti anni, affermando che nonostante la difficoltà di mantenere un rapporto così duraturo, data la sua professione, qualcosa di bello si può costruire, e a questo proposito spende delle bellissime parole per il giovane figlio presente in prima fila.
Riguardo alla sua carriera, si parla maggiormente della pubblicazione dei due ultimi lavori, Verdi’s Mood e Mister Puccini, ambedue frutto di una rivisitazione in chiave jazzistica di brani tratti dai due capolavori.
Verdi’s Mood del 2015 è, al di là dell’indiscusso valore artistico, nasce anche dall’intraprendenza dell’artista che racconta di come, a disco finito, si sia recata al quartier generale della Sony Italia a Milano ottenendo un colloquio con Luciano Rebeggiani. Alla di lui domanda sul perché proprio quel disco tra tanti dovesse essere pubblicato, lei diede una risposta tanto semplice quanto incisiva e decisa: “Perché questo disco merita.” Tale affermazione venne confermata da Rebeggiani quando, tre mesi dopo, le comunicò la sua decisione di pubblicare il disco e di inserirlo nel catalogo jazz della Sony Italia. Sui meriti del disco, Cinzia afferma che essi risiedono nella capacità di costituire un ponte tra il grande passato di Verdi e il presente. Inoltre, un elemento distintivo del disco è la pertinenza delle sue rielaborazioni con il materiale originale. Questo principio le fu inculcato da Pippo Baudo, con il quale ha avuto il piacere di lavorare, ovvero il rispetto per il materiale di base durante qualsivoglia rivisitazione.
Dedica infine due parole all’uso dello scat e a ciò che esso rappresenta per lei, vale a dire un senso di libertà, di “lancio” di note che provengono dai sentimenti più profondi provati in quel preciso momento e fa giustamente notare come lo scat di una performance dal vivo difficilmente venga replicato in tutta la sua interezza in un’altra occasione, donando ad ogni esibizione un’unicità altrimenti non così facilmente raggiungibile.
I brani eseguiti da Cinzia, in coppia con il celeberrimo pianista Pino Jodice, sono stati Sailing di Christopher Cross, riarrangiata da Jodice, Celeste Aida e In quelle trine morbide rispettivamente tratte dall’Aida di Verdi e dalla Manon Lescaut di Puccini, e RiTe TiMe, tratto dall’omonimo disco del 2004 registrato insieme a Jodice.
-

- Laura Sciocchetti, Danilo Blaiotta, Gerlando Gatto
-

- Laura Sciocchetti, Danilo Blaiotta, Gerlando Gatto
-

- Laura Sciocchetti, Danilo Blaiotta
-

- Laura Sciocchetti, Danilo Blaiotta, Gerlando Gatto
-

- Sciocchetti, Tedesco, Blaiotta, Jodice, Gatto
-

- Sciocchetti, Tedesco, Blaiotta, Jodice, Gatto
Il secondo tempo ha visto come protagonista la vocalist Laura Sciocchetti, accompagnata da Danilo Blaiotta, già al fianco della cantante Chiara Viola. Laura racconta di aver iniziato a cantare molto presto e che poi, da adolescente, ha cominciato a studiare da autodidatta pianoforte e chitarra per accompagnare le sue canzoni: il suo primo contatto con il jazz invece avverrà a 20 anni, ma in questo caso si può parlare più che altro di una “riscoperta”; infatti il primissimo incontro con il jazz lo aveva avuto, seppure in maniera inconsapevole, durante la sua infanzia grazie al fratello, sassofonista, grande appassionato del genere; quindi, oltre a suonare il suo strumento, ascoltava molti dischi dei grandi dell’olimpo jazzistico quali Davis, Parker o Coltrane. Laura spiega come la sua carriera sia iniziata sostituendo un’altra vocalist in un concerto, e come sia continuata studiando al Conservatorio Santa Cecilia con Elisabetta Antonini, Maria Pia de Vito e Carla Marcotulli – come suoi modelli, cita artiste quali Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Carmen McRae e Gretchen Parlato, ma anche vocalist al di fuori del genere e più vicine al mondo del folk come Joni Mitchell.
Parlando più approfonditamente della sua carriera, racconta con affetto sia la sua esperienza come voce solista nell’Orchestra Nazionale di Jazz dei Conservatori italiani, diretta da Pino Jodice, le selezioni svolte tra tutti i conservatori d’Italia e dei due tour fatti con l’orchestra (uno basato su rivisitazioni in chiave jazz di colonne sonore di cartoni animati, l’altro un tributo alla canzone napoletana), sia la registrazione nel 2020 del suo primo e finora unico disco Characters, in cui sono contenuti sette brani originali e due cover di Joni Mitchell e Thelonious Monk. Infine racconta della sua passione per la tecnica vocale dello scat, da lei definito “croce e delizia, cruccio di ogni cantante jazz” a cui ha dedicato la propria tesi di laurea e di come, sebbene all’inizio avesse cercato di imitare le grandi cantanti del passato e copiare le vocali e i fonemi da loro usati, col tempo sia riuscita a trovare la propria strada.
I primi tre brani presentati sono state composizioni originali di Laura: Emily, adattamento in musica di una poesia di Emily Dickinson, Medo con testo di Chiara Viola e The Witch, con testo di Chiara Morucci; come ultimo brano lei e Danilo hanno scelto di interpretare una toccante cover di The Circle Game di Joni Mitchell.
Una considerazione finale: ascoltate queste interpretazioni abbiamo lasciato la Casa del Jazz con la consapevolezza di un talento che non ha ancora trovato la giusta dimensione ma che sicuramente c’è. Speriamo quindi che Laura – lei per prima – se ne renda conto e che intensifichi la sua attività: ne varrà sicuramente la pena… per lei… ma soprattutto per noi.
Beniamino Gatto
da Gerlando Gatto | 27/Ott/2022 | I nostri CD, Primo piano, Recensioni

I Nostri Cd by Gerlando Gatto
 Francesco Cusa, Giorgia Santoro – “The Black Shoes” – Dodicilune
Francesco Cusa, Giorgia Santoro – “The Black Shoes” – Dodicilune
Album denso di contenuti questo registrato dalla flautista salentina Giorgia Santoro e dal batterista siciliano Francesco Cusa, artisti ben noti e apprezzati nel panorama jazzistico non solo nazionale. In repertorio diciassette composizioni, sedici originali più la conclusiva “Un Joueur de flûte berce les ruines” del grande Francis Poulenc. Il punto di partenza è declinato chiaramente nel titolo: le scarpe nere sono quelle del jazzista che proprio attraverso la musica tende verso il cielo. Il terreno su cui si muovono i due è quello della libera improvvisazione con un linguaggio ben coerente con gli obiettivi prefissati. Di qui il ruolo diverso assunto dai due strumenti: la batteria che quasi personifica la vita terrena con tutti i suoi pesi, mentre i flauti – la Santoro ne usa tutta la ‘famiglia’ – sembra indirizzare la musica verso l’alto. Ciò detto è comunque difficile se non impossibile penetrare nella mente dei due artisti e stabilire senza ombra di dubbio cosa volessero rappresentare. Alle nostre orecchie si presenta una musica tutt’altro che facile, in cui si nota una ricerca che si sostanzia in improvvisazione come composizione istantanea, tra le cui pieghe alle volte si intravvede qualche traccia di linea tematica, come nel caso di “Whisper”. Il tutto sostenuto da un bagaglio tecnico di notevole spessore e da una comune fonte d’ispirazione.
 Franco D’Andrea, DJ Rocca – “Franco D’Andrea Meets DJ Rocca” – Parco della Musica Records 3 CD
Franco D’Andrea, DJ Rocca – “Franco D’Andrea Meets DJ Rocca” – Parco della Musica Records 3 CD
Conosciamo Franco D’Andrea da tanti, tanti anni e quelle non poche volte in cui ci siamo confrontati sulla sua arte, sul futuro della musica, sulle possibilità insite nel jazz abbiamo sempre trovato un musicista, un artista, un uomo mai appagato ma sempre rivolto al futuro, alla ricerca di nuove situazioni che gli permettano di esprimersi al meglio. Ecco, quindi, questo triplo album registrato alla fine del 2021, in cui D’Andrea si confronta con Luca Roccatagliati (in arte Dj Rocca) musicista con il quale aveva già avuto modo di collaborare in due precedenti occasioni ma non in duo. Ovviamente in quest’ultimo lavoro le cose cambiano in modo radicale. D’Andrea si trova a dover connettere il proprio strumento con un suo “pari” che disegna paesaggi sonori in maniera totalmente diversa, mai dando tregua al compagno d’avventura in un rimpallo costante. Di qui un’incessante ricerca soprattutto sul suono, sulle combinazioni timbriche, cosa tutt’altro che banale dati gli strumenti in azione. Quasi inutile sottolineare come in questa registrazione così come in ogni concerto dei due, non esista alcuna scaletta ma tutto nasca spontaneamente nel momento stesso in cui gli artisti decidono di intervenire. Insomma questa realizzazione discografica ci consegna due artisti impegnati al massimo e particolarmente attratti da questo lavoro. Prova ne sia che l’album, verrà ripresentato in alcuni concerti che, se avete la possibilità, vi consiglio vivamente di andare a sentire.
 Giovanni Falzone, Glauco Venier – “Dialogo espressivo” – Parco della Musica Records
Giovanni Falzone, Glauco Venier – “Dialogo espressivo” – Parco della Musica Records
All’insegna della melodia questo album che vede come protagonisti il trombettista Giovanni Falzone e Glauco Venier in una sorta di incontro che congiunge l’Italia dal momento che Glauco è friulano mentre Falzone è cresciuto in Sicilia. Ma a parte questa curiosità geografica, l’album, registrato il 3 agosto del 2020, si segnala per ben altre particolarità. Innanzitutto la qualità artistica dei due musicisti che oramai da tempo si caratterizzano non solo per le capacità strumentali ma anche per quelle interpretative; in secondo luogo la gradevolezza del repertorio: undici brani tutti composti dal trombettista il quale sottolinea come fosse suo preciso obiettivo mettere al centro del progetto la ricerca melodica, il suono acustico e l’essenzialità del duo. Obiettivo perfettamente centrato in quanto sin dal primo brano si percepisce compiutamente quella che sarà la cifra stilistica dell’intero album tutto giocato per l’appunto su un dialogo spontaneo, naturale, che pone in primo piano l’espressività: di qui il titolo “Dialogo espressivo” quanto mai centrato, cosa che raramente accade. I pezzi sono tutti godibili anche se personalmente preferisco “Il poeta del silenzio” anche questo titolo assai significativo dal momento che il brano è dedicato a Enrico Rava; particolarmente suggestivi anche gli altri due omaggi rivolti a Kenny Wheeler e Tomasz Stanko, come a dire tre trombettisti che hanno contribuito a forgiare lo stile del musicista siciliano.
 Biagio Marino, Zeno De Rossi – “Break Seal Gently” – Fonterossa
Biagio Marino, Zeno De Rossi – “Break Seal Gently” – Fonterossa
Biagio Marino (chitarra elettrica, effetti) e Zeno De Rossi (batteria, percussioni) sono gli autori di questo “Break Seal Gently” uscito il 6 settembre per Fonterossa Records, l’etichetta fondata dalla contrabbassista Silvia Bolognesi. Il duo, al debutto discografico, si muove su quel territorio di confine che lambisce jazz, rock e free improvisation, ma lo fa sempre con grande lucidità e proprietà di linguaggio. D’altro canto si tratta di due musicisti che possono vantare un curriculum di assoluta eccellenza. In particolare Biagio Marino, nato a Eboli nel 1972 e residente a Bologna, ha alle spalle lunghi anni di approfonditi studi e sperimentazioni che l’hanno portato ad elaborare particolari tecniche chitarristiche basate sull’uso di accordature anomale, tecniche poi impiegate nei suoi progetti sempre caratterizzati da un sound affatto particolare come nel caso dell’album in oggetto. Zeno De Rossi (Verona – 1970) è artista completo sotto ogni punti di vista prova ne sia che attualmente è uno dei batteristi-percussionisti più richiesti sulla scena. Le sue collaborazioni davvero non si contano; in questa sede basti citare quelle con Hank Roberts, Wayne Horvitz, Bill Frisell, Greg Cohen, Ralph Alessi, , David Murray… In questo album i due hanno la possibilità di esplicitare appieno il proprio talento. Sei brani tutti scritti dal chitarrista in cui sognanti ambientazioni (“La grande pellicola effimera”) si incrociano con atmosfere in cui aleggia l’influenza del grande Frisell. Si tenga presente come il disco arrivi dopo una fase di maturazione iniziata nel 2021 e cementata attraverso tutta una serie di concerti.
 Roberto Ottaviano, Alexander Hawkins – “Charlie’s Blue Skylight” – Dodicilune
Roberto Ottaviano, Alexander Hawkins – “Charlie’s Blue Skylight” – Dodicilune
Roberto Ottaviano al sax soprano e Alexander Hawkins al pianoforte acustico ed elettrico sono i superlativi interpreti di questo omaggio alla musica di Charles Mingus nel centenario della sua nascita (Nogales, 22 aprile 1922). Dedicare a Mingus un qualcosa è impresa da far tremare le vene ai polsi ma i due l’affrontano con il piglio e la determinazione giuste…per non parlare della classe e dell’originalità che costituiscono elementi fondamentali della poetica dei due artisti. Di qui un album assolutamente convincente declinato attraverso undici composizioni di Mingus tra cui brani arcinoti come “Pithecanthropus Erectus”, “Self Portrait In Three Colors” e “Haitian Fight Song” e pezzi meno eseguiti come “Canon” o “Hobo Ho”. Ma, a prescindere dai brani, i due si muovono sorretti da una intesa perfettamente, dialogando strettamente per tutta la durata dell’album, senza un solo attimo in cui si avverta un benché minimo calo di tensione. Il sax di Ottaviano appare lucido, preciso, timbricamente superbo come sempre mentre il pianismo di Hawkins è perfettamente a suo agio con le non semplici partiture del contrabbassista. In definitiva i due artisti, pur rimanendo rispettosi delle strutture architettoniche e delle trame narrative mingusiane, non rinunciano ad aggiungere un quid di originalità che conferisce al lavoro una propria pregnanza. Assolutamente inutile evidenziare un brano rispetto all’altro: vanno tutti ascoltati con la massima attenzione e la soddisfazione sarà massima.
 Barre Phillips, György Kurtag jr. – “Face à Face” – ECM
Barre Phillips, György Kurtag jr. – “Face à Face” – ECM
Barre Phillips, Daniele Roccato – “Confluence” – Parco della Musica Records
Una doverosa avvertenza: qui non siamo nel campo del jazz propriamente detto ma in un terreno quasi di confine tra la musica moderna europea e una certa forma di sperimentalismo, basato totalmente sull’improvvisazione, pratica che i tre musicisti conoscono assai bene. Per cui se volete ascoltare questi album – per altro assai interessanti– è d’obbligo una buona dose di concentrazione che vi consenta di seguire le evoluzioni degli artisti. L’iniziativa per la registrazione del primo album parte dal contrabbassista che dopo aver ascoltato lo specialista di effetti elettronici ungherese lo vuole al suo fianco. Nasce così questo “Face à Face” registrato a Pernes-les Fontaines tra il settembre del 2020 e il settembre del 2021. Come sottolinea lo stesso Kurtag, i due si sono trovati in piena sintonia nel mantenere l’intensità del dialogo. Inutile, quindi, cercare una qualsivoglia traccia di linea melodica, occorre lasciarsi andare totalmente al flusso sonoro che scaturisce dai due artisti. I quali sono impegnati a disegnare cangianti atmosfere a seconda di chi, in quel momento, detiene le redini dell’incontro. Di qui un universo sonoro che nasconde grandi sorprese come l’incalzante “Stand Alone” a parere di chi scrive il pezzo migliore dell’album, seguito da un altro brano di grande spessore, il conclusivo Forest Shout, un brevissimo, suggestivo bozzetto. Interessante sottolineare come i due artisti riescono a far convivere il sound di uno strumento acustico e tradizionale come il contrabbasso con le sonorità ultra moderne della strumentazione di Kurtag, davvero un esempio di come in musica quasi nulla sia impossibile.
 In “Confluence”, registrato live nella Sala accademica del Conservatorio Santa Cecilia, a Roma, il primo marzo del 2020 il contrabbassista statunitense si trova a collaborare con un altro contrabbassista, Daniele Roccato, musicista che da anni si dedica all’interazione fra più contrabbassi, essendo tra l’altro il fondatore dell’ensemble Ludus Gravis, un gruppo di soli contrabbassisti (spesso nove) che si è affermato nel mono della musica moderna eseguendo partiture, fra gli altri, di Hans Werner Henze, Sofia Gubaidulina, Terry Riley, Gavin Bryars, Stefano Scodanibbio. Come evidenziato in apertura, i due contrabbassisti si incontrano sul terreno dell’improvvisazione libera e dal convergere di questi due percorsi musicali, totalmente diversi, emergono nuovi paesaggi che siamo sicuri saranno ancora nuovi e diversi se i due avranno modo di incidere un altro album. Insomma un’immersione totale in una sorta di università sonora per chi ama questo strumento. Un’ultima notazione: davvero belle le foto che accompagnano l’album.
In “Confluence”, registrato live nella Sala accademica del Conservatorio Santa Cecilia, a Roma, il primo marzo del 2020 il contrabbassista statunitense si trova a collaborare con un altro contrabbassista, Daniele Roccato, musicista che da anni si dedica all’interazione fra più contrabbassi, essendo tra l’altro il fondatore dell’ensemble Ludus Gravis, un gruppo di soli contrabbassisti (spesso nove) che si è affermato nel mono della musica moderna eseguendo partiture, fra gli altri, di Hans Werner Henze, Sofia Gubaidulina, Terry Riley, Gavin Bryars, Stefano Scodanibbio. Come evidenziato in apertura, i due contrabbassisti si incontrano sul terreno dell’improvvisazione libera e dal convergere di questi due percorsi musicali, totalmente diversi, emergono nuovi paesaggi che siamo sicuri saranno ancora nuovi e diversi se i due avranno modo di incidere un altro album. Insomma un’immersione totale in una sorta di università sonora per chi ama questo strumento. Un’ultima notazione: davvero belle le foto che accompagnano l’album.
 Enrico Rava, Fred Hersch – “The song s You” – ECM
Enrico Rava, Fred Hersch – “The song s You” – ECM
Registrato a Lugano nel novembre 2021, “The Song is You” è il frutto di un incontro tra due straordinari musicisti che pur partendo da situazioni piuttosto differenziate, trovano un magnifico punto di intesa negli otto brani presentati nell’album. In effetti il repertorio comprende oltre a due brani con la loro firma “Child’s Song” di (Hersch) e “The Trial” (Rava), alcuni standard come “Misterioso” e “‘Round Midnight” di Thelonious Monk, “The Song Is You” di Jerome Kern, “Retrato em Branco e Preto” di Jobim -Chico Buarque e “I’m Getting Sentimental Over You” di George Bassman-Ned Washington. Per chi conosce anche se non approfonditamente questi due artisti, è facile capire come l’improvvisazione sia la chiave di lettura più appropriata per entrare nel mood dell’album. Sia Rava sia Hersch evidenziano una certa predilezione per linee melodiche riconoscibili e affascinanti e da questo idem sentire iniziano il loro discorso che li porterà a ridare nuova linfa a brani già iper noti come “Round Midnight” o “Retrato em Branco e Preto”. Ma anche nei due original la cifra stilistica dell’album non si discosta da quanto detto in precedenza. I due continuano a narrare le loro storie senza nulla sacrificare del proprio bagaglio ma facendo confluire l’uno nell’altro le capacità improvvisative ed esplorative. Insomma un album che tiene fede a quanto ci si poteva attendere da due giganti del jazz quali Enrico Rava e Fred Hersch.
Gerlando Gatto
da Gerlando Gatto | 02/Ago/2022 | Eventi, News, Primo piano
Dopo un periodo di relativa stasi per motivi facilmente individuabili, Roma è tornata ad essere attrattiva per gli passionati di jazz. Così da un canto l’Auditorium (con pochi ma eccellenti appuntamenti) dall’altro la Casa del Jazz con la sua consueta rassegna estiva, stanno fornendo ai cultori del jazz parecchi appuntamenti degni di rilievo, su alcuni dei quali mi soffermerò qui di seguito.
Il 10 luglio, alla Cavea dell’Auditorium, appuntamento con Gregory Porter. Sono oramai parecchi anni che conosco ad apprezzo questo vocalist e ancora una volta la sua performance ha corrisposto in pieno alle mie aspettative. La sua musicalità, il feeling che riesce a trasmettere agli ascoltatori, il suo senso del ritmo, il modo in cui riesce ad interpretare qualsiasi testo sono davvero straordinari. E non è certo un caso che la sua carriera artistica sia costellata da grandi successi e riconoscimenti tra cui due Grammy Awards per Miglior Album Vocale.

Per celebrare un decennio di successi, Gregory Porter ha pubblicato “Still Rising”, un doppio album contenente 34 tracce tra brani inediti, covers, duetti e una selezione speciale delle sue canzoni più amate. Ed è proprio sul repertorio di quest’ultimo doppio album che si è incentrata la performance romana. Ben coadiuvato da Hip Crawford al piano, Tivon Pennicott al sax tenore, Emanuel Harrold alla batteria, Jahmal Nichols al basso elettrico e Ondrej Pivec all’organo (gli stessi che l’hanno accompagnato nella già citata ultima fatica discografica) Porter ha dato ancora una volta un saggio di bravura proponendo una musica in cui era facile scorgere echi di soul, di gospel, di blues, financo di pop, mescolati in un unicum tanto originale quanto suggestivo. Ed è stato a tratti entusiasmante sentirlo duettare con alcuni dei suoi compagni di viaggio in un concerto tutto sommato breve ma di grande intensità.
Ascoltando Porter viene naturale un parallelo con i nostri giovani rampanti: beh, penso che ai vari San Giovanni, Albe, LDA, Ultimo e via discorrendo non farebbe male ascoltare qualche disco di chi sa cantare veramente bene. Ma questo è un tema che mi sollecita oramai da tempo e su cui prima o poi vorrò intervenire.
 Il 13, sempre alla Cavea, appuntamento con una vera e propria leggenda del jazz: Herbie Hancock. Spesso si adopera la parola “leggenda” in modo esagerato ma nel caso in questione non v’è dubbio alcuno che il termine sia più che appropriato. Non è questa la sede adatta per sintetizzare un curriculum assolutamente straordinario; basti solo dire che l’artista di Chicago, oggi ottantunenne, ha attraversato, sempre da protagonista, generi e mode come performer, compositore, arrangiatore, produttore, scopritore di talenti, inventore di nuove tendenze, senza mai perdere una coerenza di fondo. A Roma si è presentato alla testa di una band eccezionale completata da Terence Blanchard alla tromba, Lionel Loueke (chitarra), James Genus (basso) e Justin Tyson (batteria). Ascoltare un concerto di Hancock è come rivivere, in sintesi, buona parte della storia del jazz dal momento che questo artista ha sviluppato un’estetica giocata sempre su una sorta di doppio binario: da un canto virtuoso pianista del jazz acustico, dall’altro estimatore se non fondatore del funky elettronico. E questi due aspetti della sua personalità sono apparsi evidenti anche nel concerto romano; così in una prima parte abbiamo ascoltato alcuni classici del jazz come il sempre verde “Footprints” di Wayne Shorter, un altro giovanotto di 89 anni, omaggiato da Hancock che si alternava al piano e alle tastiere non disdegnando un ricorso mai esagerato al vocoder (ma che comunque se non ci fosse stato nulla avrebbe tolto alla validità del concerto). Nella seconda parte Hancock si richiamava al suo coté più funky e chiudeva il concerto con “Chameleon” brano tratto dal celebre album “Head Hunters” del 1973, scatenando l’entusiasmo del pubblico che si è accalcato a ballare sotto il palco.
Il 13, sempre alla Cavea, appuntamento con una vera e propria leggenda del jazz: Herbie Hancock. Spesso si adopera la parola “leggenda” in modo esagerato ma nel caso in questione non v’è dubbio alcuno che il termine sia più che appropriato. Non è questa la sede adatta per sintetizzare un curriculum assolutamente straordinario; basti solo dire che l’artista di Chicago, oggi ottantunenne, ha attraversato, sempre da protagonista, generi e mode come performer, compositore, arrangiatore, produttore, scopritore di talenti, inventore di nuove tendenze, senza mai perdere una coerenza di fondo. A Roma si è presentato alla testa di una band eccezionale completata da Terence Blanchard alla tromba, Lionel Loueke (chitarra), James Genus (basso) e Justin Tyson (batteria). Ascoltare un concerto di Hancock è come rivivere, in sintesi, buona parte della storia del jazz dal momento che questo artista ha sviluppato un’estetica giocata sempre su una sorta di doppio binario: da un canto virtuoso pianista del jazz acustico, dall’altro estimatore se non fondatore del funky elettronico. E questi due aspetti della sua personalità sono apparsi evidenti anche nel concerto romano; così in una prima parte abbiamo ascoltato alcuni classici del jazz come il sempre verde “Footprints” di Wayne Shorter, un altro giovanotto di 89 anni, omaggiato da Hancock che si alternava al piano e alle tastiere non disdegnando un ricorso mai esagerato al vocoder (ma che comunque se non ci fosse stato nulla avrebbe tolto alla validità del concerto). Nella seconda parte Hancock si richiamava al suo coté più funky e chiudeva il concerto con “Chameleon” brano tratto dal celebre album “Head Hunters” del 1973, scatenando l’entusiasmo del pubblico che si è accalcato a ballare sotto il palco.
E veniamo adesso ai concerti alla Casa del Jazz.
 Il 12 luglio una vecchia e cara conoscenza del pubblico romano: John Scofield. Il chitarrista può a ben ragione essere considerato una delle massime espressioni della chitarra jazz degli ultimi decenni. Musicista eclettico, voglioso sempre di sperimentare strade nuove, questa volta si è presentato con un progetto del tutto nuovo, “Yankee Go Home”, con cui torna alle radici del rock americano, riscoprendo classici fra il folk e il rock’n’roll. Accanto a lui Jon Cowherd (pianoforte e tastiere), Vicente Archer (contrabbasso)e Josh Dion (batteria). E’ lo stesso Scofield a illustrare il senso di questo nuovo progetto, non senza elogiare i suoi compagni di viaggio: “L’idea –afferma Scofield – è di coprire successi americani/rock e canzoni folk jazz, più alcuni dei miei brani originali scritti in quel modo. Mi sto riconnettendo con molte delle mie radici Rock ‘n Roll da adolescente, naturalmente colorate dai miei 50 anni di pratica Jazz…. Questi ragazzi sono straordinariamente versatili, altrettanto bravi quando si tratta di suonare in modo interattivo e creativo. Stiamo esplorando rock, funk, country, jazz e musica libera e ci divertiamo moltissimo. Sono entusiasta di questa collaborazione”. Risultato raggiunto? Assolutamente sì; il repertorio, comprendente brani tra gli altri di Bob Dylan, Neil Young, Grateful Dead, B.B. King, Buddy Holly, viene declinato attraverso quella maestria strumentale che ben conosciamo oramai da tanti anni. Scofield è sempre lì a tessere le fila del discorso, con un solismo preciso, elegante, raffinato mai soverchiante cosicché tutti i suoi compagni di viaggio hanno la possibilità di mettersi in luce. I vari pezzi vengono riletti alla luce di quelle esperienze cui lo stesso Scofield faceva riferimento ridando loro una sorta di nuova linfa e il pubblico dimostra di apprezzare con lunghi appalusi a scena aperta. Immancabile il bis: un coinvolgente blues che evidenzia come Scofield rimanga solidamente ancorato anche alle radici della musica afro-americana.
Il 12 luglio una vecchia e cara conoscenza del pubblico romano: John Scofield. Il chitarrista può a ben ragione essere considerato una delle massime espressioni della chitarra jazz degli ultimi decenni. Musicista eclettico, voglioso sempre di sperimentare strade nuove, questa volta si è presentato con un progetto del tutto nuovo, “Yankee Go Home”, con cui torna alle radici del rock americano, riscoprendo classici fra il folk e il rock’n’roll. Accanto a lui Jon Cowherd (pianoforte e tastiere), Vicente Archer (contrabbasso)e Josh Dion (batteria). E’ lo stesso Scofield a illustrare il senso di questo nuovo progetto, non senza elogiare i suoi compagni di viaggio: “L’idea –afferma Scofield – è di coprire successi americani/rock e canzoni folk jazz, più alcuni dei miei brani originali scritti in quel modo. Mi sto riconnettendo con molte delle mie radici Rock ‘n Roll da adolescente, naturalmente colorate dai miei 50 anni di pratica Jazz…. Questi ragazzi sono straordinariamente versatili, altrettanto bravi quando si tratta di suonare in modo interattivo e creativo. Stiamo esplorando rock, funk, country, jazz e musica libera e ci divertiamo moltissimo. Sono entusiasta di questa collaborazione”. Risultato raggiunto? Assolutamente sì; il repertorio, comprendente brani tra gli altri di Bob Dylan, Neil Young, Grateful Dead, B.B. King, Buddy Holly, viene declinato attraverso quella maestria strumentale che ben conosciamo oramai da tanti anni. Scofield è sempre lì a tessere le fila del discorso, con un solismo preciso, elegante, raffinato mai soverchiante cosicché tutti i suoi compagni di viaggio hanno la possibilità di mettersi in luce. I vari pezzi vengono riletti alla luce di quelle esperienze cui lo stesso Scofield faceva riferimento ridando loro una sorta di nuova linfa e il pubblico dimostra di apprezzare con lunghi appalusi a scena aperta. Immancabile il bis: un coinvolgente blues che evidenzia come Scofield rimanga solidamente ancorato anche alle radici della musica afro-americana.
Il 21 uno dei concerti inseriti nell’ambito della rassegna, tutta dedicata alle nuove tendenze e, dunque, alle più interessanti proposte di jazz contemporaneo. Un mondo affascinante, in cui si incontrano jazz, soul, funk, hip-hop, elettronica e spoken word.
In particolare giovedì 21 di scena il batterista Makaya McCraven produttore e batterista emergente, definito da Down Beat come uno dei più influenti musicisti del prossimo decennio.
In effetti Makaya McCraven, figlio di Stephen McCraven, batterista di Archie Shepp tra gli altri, è tutto questo e molto di più: americano di Parigi classe ‘83, iniziato alla musica jazz dal padre, cresciuto tra gli altri con la formazione derivante dal già citato Shepp, inizia a collaborare con artisti del calibro di Kris Delmhorst e gli Apollo Sunshine, prima di stabilire un suo complesso con il bassista Junius Paul, il chitarrista Matt Gold e il trombettista già attivo autonomamente Marquis Hill, formazione con cui si è presentato alla Casa del Jazz, per un concerto che ha soddisfatto appieno le più rosee aspettative.
 La band inizia a suonare senza presentare alcunché; McCraven è uomo di poche parole, e non si concede quasi mai pause, tranne una ogni tre pezzi circa per presentare e ringraziare la sua band e per annunciare – qualche volta – il nome del prossimo pezzo. Per il resto è stata una serata di pura musica ed energia: non solo di McCraven, il cui vigore era pari alla sua abilità – mai sentito un batterista che suonasse per circa un’ora e mezza, senza mai smettere di percuotere pelli e piatti con tanta ininterrotta energia – ma anche di tutti gli altri musicisti, che durante il concerto si cimentavano con diversi tipi di percussioni. Altra nota di merito va alla varietà di brani suonati: si passa da pezzi ormai diventati standard del jazz, come “Autumn in New York”, Frank’s Tune” di Frank Strzier o “A Slice of the Top” a pezzi originali di McCraven, come “In These Times”, “The Bounce!” e un inedito tratto dal suo prossimo album in uscita a settembre.
La band inizia a suonare senza presentare alcunché; McCraven è uomo di poche parole, e non si concede quasi mai pause, tranne una ogni tre pezzi circa per presentare e ringraziare la sua band e per annunciare – qualche volta – il nome del prossimo pezzo. Per il resto è stata una serata di pura musica ed energia: non solo di McCraven, il cui vigore era pari alla sua abilità – mai sentito un batterista che suonasse per circa un’ora e mezza, senza mai smettere di percuotere pelli e piatti con tanta ininterrotta energia – ma anche di tutti gli altri musicisti, che durante il concerto si cimentavano con diversi tipi di percussioni. Altra nota di merito va alla varietà di brani suonati: si passa da pezzi ormai diventati standard del jazz, come “Autumn in New York”, Frank’s Tune” di Frank Strzier o “A Slice of the Top” a pezzi originali di McCraven, come “In These Times”, “The Bounce!” e un inedito tratto dal suo prossimo album in uscita a settembre.
Riguardo alla performance dell’”archeologo del beat”, (come si definisce lo stesso batterista), essa nel suo complesso si basava su due punti di forza: la leadership di McCraven, che con grande forza e precisione trascinava sia i suoi musicisti sia il pubblico durante le esibizioni, nonché l’approccio inedito da DJ dello stesso McCraven specie nelle sue composizioni: infatti in gran parte dei brani veniva ripetuto un leitmotif al basso, che diventava il vero centro motore della situazione, attorno a cui venivano aggiunte gradualmente la batteria, la chitarra, la tromba e varie percussioni; in seguito si passava ad una graduale elaborazione dei motiv aggiunti alla linea di basso che, rimanendo sempre costante, forniva all’ascoltatore un filo rosso che legava le varie elaborazioni e improvvisazioni e un senso di familiarità all’interno della composizione. Quest’operazione coniuga a mio parere il processo creativo di numerose canzoni house, dance ed EDM con l’improvvisazione tipica del jazz: inoltre l’enfasi posta sulle percussioni nel concerto è caratteristica anche dei beat dei brani hip hop, dove il ritmo della base è cruciale per orientare il rapper durante il brano in questione.
 Il 23 la Casa de Jazz proponeva un quesito intrigante: può la sofisticata poetica di un Pieranunzi coniugarsi con l’incredibile carica energetica di Antonello Salis? In altri termini possono coesistere due musicisti stilisticamente quasi all’opposto, uniti solo dalla grande passione e dedizione alla musica? Ciò perché il concerto in programma prevedeva per l’appunto un duo di piano composto da questi due artisti che mai avevano avuto modo di incontrarsi sul palco. Grande attesa, quindi, e non a caso grande affluenza di pubblico…ripagato da un concerto sicuramente interessante. Seduti l’uno di fronte all’altro i due hanno suonato per circa un’ora e mezza sciorinando un’intesa che non era facile prevedere. Spesso si partiva da un tema che veniva sviluppato, esaminato, sviscerato fin nelle sue più intime pieghe e quindi riproposto in una veste totalmente diversa che traeva nelle capacità improvvisative dei due nuova linfa vitale. E questa volta non si può dire che l’uno si sia piegato alle esigenze dell’altro in quanto ambedue hanno sviluppato appieno le proprie tematiche che finivano con l’incontrarsi su un terreno ben frequentato sia da Enrico sia da Antonello: l’improvvisazione pura o forse meglio la capacità di creare musica strada facendo. In effetti, oltre che partire da un dato tema, i due si sono spesso avventurati anche sul foglio bianco, vale a dire cominciando a suonare senza conoscere il punto di approdo, con una maestria che solo pochi posseggono.
Il 23 la Casa de Jazz proponeva un quesito intrigante: può la sofisticata poetica di un Pieranunzi coniugarsi con l’incredibile carica energetica di Antonello Salis? In altri termini possono coesistere due musicisti stilisticamente quasi all’opposto, uniti solo dalla grande passione e dedizione alla musica? Ciò perché il concerto in programma prevedeva per l’appunto un duo di piano composto da questi due artisti che mai avevano avuto modo di incontrarsi sul palco. Grande attesa, quindi, e non a caso grande affluenza di pubblico…ripagato da un concerto sicuramente interessante. Seduti l’uno di fronte all’altro i due hanno suonato per circa un’ora e mezza sciorinando un’intesa che non era facile prevedere. Spesso si partiva da un tema che veniva sviluppato, esaminato, sviscerato fin nelle sue più intime pieghe e quindi riproposto in una veste totalmente diversa che traeva nelle capacità improvvisative dei due nuova linfa vitale. E questa volta non si può dire che l’uno si sia piegato alle esigenze dell’altro in quanto ambedue hanno sviluppato appieno le proprie tematiche che finivano con l’incontrarsi su un terreno ben frequentato sia da Enrico sia da Antonello: l’improvvisazione pura o forse meglio la capacità di creare musica strada facendo. In effetti, oltre che partire da un dato tema, i due si sono spesso avventurati anche sul foglio bianco, vale a dire cominciando a suonare senza conoscere il punto di approdo, con una maestria che solo pochi posseggono.
Ed è stato lo stesso Pieranunzi a svelare come la musica eseguita sia stata tutta improvvisata. Tra i brani eseguiti, da ricordare una sempre suggestiva “Moon River” di Henry Mancini, una “Well, you needn’t” di Thelonious Monk che nulla ha perso dell’originario fascino, una memorabile versione di “Naima” di John Coltrane, nonché un sentito omaggio ad Ennio Morricone con “Il clan dei siciliani”.
E a conferma della splendida atmosfera che si respirava sul palco, Pieranunzi è apparso particolarmente in forma anche quando ha intrattenuto il pubblico con sagaci commenti sulla “strumentazione” di Antonello (tra cui una latta di tonno Callipo) e con un sentito ricordo della sua esperienza a fianco di Morricone.
Ed eccoci alla serata di lunedì 25. Mi reco alla Casa del Jazz al solito orario e noto immediatamente una sorta di novità: una fila interminabile di auto parcheggiate sul marciapiedi a indicare una straordinaria affluenza di pubblico. Cosa che verifico subito: i giardini della Casa del Jazz sono letteralmente invasi da una massa di giovani festanti in attesa dell’evento: il concerto di “Sons of Kemet”.
La band inglese è giunta a Roma preceduta da una formidabile campagna di stampa che la indicava come una delle massime espressioni del cosiddetto nu jazz; a richiamare il pubblico anche la considerazione che si trattava dell’ultima tournée del gruppo che nei prossimi mesi dovrebbe sciogliersi. Insomma tutto pronto per un grande successo di pubblico… che puntualmente è arrivato.
 Guidati dal funambolico sassofonista Shabaka Hutchings, il quartetto (completato dal basso tuba di Theon Cross e ben due batterie nelle mani di Eddie Hick e della giovanissima e bravissima Jas Keyser in sostituzione di Tom Skinner in tour con Thom Yorke) ha sciorinato una musica di grande intensità, basata sul fitto tappeto ritmico intessuto dalle due batterie su cui svolgevano i loro interventi i due fiati. In particolare il sax del leader, spesso effettato con delay o reverberi, non disegnava lunghe linee melodiche ma intonava frasi ritmiche e frammenti melodici ripetuti più volte mentre il basso tuba contribuiva in maniera determinante a completare il tessuto ritmico delle due batterie. Il tutto ‘condito’ da un volume molto, molto elevato a creare una musica che raggiungesse l’obiettivo di portare al massimo l’eccitazione dell’uditorio e di coinvolgerlo in una sorta di rito collettivo in cui i richiami all’Africa erano ben evidenti. Si tenga presente che il concerto si è sviluppato su una linea di continuità ininterrotta tranne due momenti in cui Shabaka Hutchings ha imbracciato un flauto di legno per intonare una splendida melodia di origine africana e il tubista si è espresso in solitudine. Obiettivo raggiunto? Quanto al coinvolgimento direi proprio di sì… anche se non al cento per cento. Nel senso che, ad esempio, il vostro cronista non si è sentito coinvolto dalla musica dei Sons of Kemet. Ed il perché non è difficile da spiegare: avendo avuto la fortuna di ascoltare anche dal vivo alcuni dei più grandi musicisti – per intenderci quelli che hanno scritto davvero la storia del jazz – non è facile lasciarsi impressionare da qualcuno che pur suonando bene non raggiunge quei vertici cui prima si faceva riferimento. Quanto ai messaggi che questa musica così aggressiva intende veicolare, ci viene in soccorso lo stesso Shabaka Hutchings affermando che “Black to the Future (ultimo album del gruppo) è un poema sonoro di invocazione del potere, del ricordo e della guarigione. Raffigura un movimento, quello della ridefinizione e riaffermazione di cosa significa lottare per il black power”. Ma anche sotto questo aspetto non riusciamo a vedere una grande novità dal momento che il jazz come musica di protesta non è certo cosa di oggi.
Guidati dal funambolico sassofonista Shabaka Hutchings, il quartetto (completato dal basso tuba di Theon Cross e ben due batterie nelle mani di Eddie Hick e della giovanissima e bravissima Jas Keyser in sostituzione di Tom Skinner in tour con Thom Yorke) ha sciorinato una musica di grande intensità, basata sul fitto tappeto ritmico intessuto dalle due batterie su cui svolgevano i loro interventi i due fiati. In particolare il sax del leader, spesso effettato con delay o reverberi, non disegnava lunghe linee melodiche ma intonava frasi ritmiche e frammenti melodici ripetuti più volte mentre il basso tuba contribuiva in maniera determinante a completare il tessuto ritmico delle due batterie. Il tutto ‘condito’ da un volume molto, molto elevato a creare una musica che raggiungesse l’obiettivo di portare al massimo l’eccitazione dell’uditorio e di coinvolgerlo in una sorta di rito collettivo in cui i richiami all’Africa erano ben evidenti. Si tenga presente che il concerto si è sviluppato su una linea di continuità ininterrotta tranne due momenti in cui Shabaka Hutchings ha imbracciato un flauto di legno per intonare una splendida melodia di origine africana e il tubista si è espresso in solitudine. Obiettivo raggiunto? Quanto al coinvolgimento direi proprio di sì… anche se non al cento per cento. Nel senso che, ad esempio, il vostro cronista non si è sentito coinvolto dalla musica dei Sons of Kemet. Ed il perché non è difficile da spiegare: avendo avuto la fortuna di ascoltare anche dal vivo alcuni dei più grandi musicisti – per intenderci quelli che hanno scritto davvero la storia del jazz – non è facile lasciarsi impressionare da qualcuno che pur suonando bene non raggiunge quei vertici cui prima si faceva riferimento. Quanto ai messaggi che questa musica così aggressiva intende veicolare, ci viene in soccorso lo stesso Shabaka Hutchings affermando che “Black to the Future (ultimo album del gruppo) è un poema sonoro di invocazione del potere, del ricordo e della guarigione. Raffigura un movimento, quello della ridefinizione e riaffermazione di cosa significa lottare per il black power”. Ma anche sotto questo aspetto non riusciamo a vedere una grande novità dal momento che il jazz come musica di protesta non è certo cosa di oggi.
Quindi ben vengano gruppi del genere ma se mi si dice che questa è la nuova strada che il jazz si avvia a percorrere devo confessare che il jazz dei prossimi anni non mi avrà tra i suoi massimi sostenitori. Ovviamente la cosa poco importerà ai più ma a mio avviso il ruolo di un cronista-critico non è quello di affermare sempre che tutto va bene, ma anche di esprimere qualche perplessità, sempre motivandole, è ovvio.
 Smaltita la sbornia dell’“Afrofuturism” (così viene definita la musica di Sons of Kemet da chi se ne intende), ecco il 27 sempre alla Casa del Jazz, la giovane e brava sassofonista Nubya Garcia, reduce dallo straordinario successo ottenuto dal suo primo album “Source” su etichetta Concord. Bel concerto questo con una musica sì proiettata verso il futuro ma sempre memore di ciò che il jazz ha rappresentato fino ad oggi. Anche la Garcia viene fuori dalla tumultuosa scena londinese di questi ultimi anni affermandosi passo dopo passo come una delle strumentiste più preparate e fantasiose del pur vasto panorama. In effetti Nubya frequenta il sax da tanti anni riuscendo così a raggiungere una tecnica tutt’altro che banale, una tecnica comunque sempre messa al servizio dell’espressività e di una concezione musicale fortemente inclusiva dal momento che nelle sue performances sono ben riscontrabili echi di jazz spirituale, dub, reggae, ritmi latini e suoni africani. Così il concerto si è sviluppato lungo modalità contrassegnate da notevoli assolo non solo della leader ma anche del pianista-tastierista Alastair MacSween mentre la sezione ritmica (Daniel Casimir contrabbasso e Sam Jones batteria) forniva un supporto sempre preciso, puntuale, propositivo. E a proposito di ritmo, da sottolineare la sensualità dei ritmi colombiani rinverdita dalla Nubya nella riproposizione di uno dei brani più riusciti dell’intera serata, “La Cumbia Me Está Llamando”, scritta con il trio colombiano al femminile “La Perla”.
Smaltita la sbornia dell’“Afrofuturism” (così viene definita la musica di Sons of Kemet da chi se ne intende), ecco il 27 sempre alla Casa del Jazz, la giovane e brava sassofonista Nubya Garcia, reduce dallo straordinario successo ottenuto dal suo primo album “Source” su etichetta Concord. Bel concerto questo con una musica sì proiettata verso il futuro ma sempre memore di ciò che il jazz ha rappresentato fino ad oggi. Anche la Garcia viene fuori dalla tumultuosa scena londinese di questi ultimi anni affermandosi passo dopo passo come una delle strumentiste più preparate e fantasiose del pur vasto panorama. In effetti Nubya frequenta il sax da tanti anni riuscendo così a raggiungere una tecnica tutt’altro che banale, una tecnica comunque sempre messa al servizio dell’espressività e di una concezione musicale fortemente inclusiva dal momento che nelle sue performances sono ben riscontrabili echi di jazz spirituale, dub, reggae, ritmi latini e suoni africani. Così il concerto si è sviluppato lungo modalità contrassegnate da notevoli assolo non solo della leader ma anche del pianista-tastierista Alastair MacSween mentre la sezione ritmica (Daniel Casimir contrabbasso e Sam Jones batteria) forniva un supporto sempre preciso, puntuale, propositivo. E a proposito di ritmo, da sottolineare la sensualità dei ritmi colombiani rinverdita dalla Nubya nella riproposizione di uno dei brani più riusciti dell’intera serata, “La Cumbia Me Está Llamando”, scritta con il trio colombiano al femminile “La Perla”.
Gerlando & Beny Gatto
da Gerlando Gatto | 09/Mag/2022 | I nostri CD, Primo piano, Recensioni
I NOSTRI CD

 Jon Balke Siwan – “Hafla” – ECM
Jon Balke Siwan – “Hafla” – ECM
A distanza di tanti secoli ancora sopravvive il mito di Al-Andalus ovvero di quella Spagna medievale musulmana, in cui sotto la guida di colti principi arabi, musulmani, ebrei e cristiani vivevano tutti insieme senza distinzione alcuna di razza e/o di religione. Ecco, questo mito viene ora riattualizzato dalla musica di Siwan, il collettivo musicale transculturale e trans-idiomatico guidato dal tastierista e compositore norvegese Jon Balke, giunto al suo terzo album dedicato alla materia in oggetto. Questa volta uno accanto all’altro troviamo un musicista kemençe turco (Derya Turkan), un maestro iraniano del tombak (Pedram Khavar Zamini), un batterista norvegese di aperte vedute (Helge Norbakken), una nutrita sezione di archi specialisti del barocco guidata da Bjarte Ejke e una cantante algerina, Mona Boutchebak, che interpreta testi e di Wallada bint al-Mustakfi, la principessa omayyade di Cordoba dell’XI secolo e di altri poeti a lei contemporanei quali Ibn Zaydun (1003-1071, suo appassionato amante) e Ibn Sara As-Santarini (1043-1123). L’album non si presta ad un semplice ascolto né tanto meno ad una facile lettura. Si tratta di musica complessa, caratterizzata da un contesto in cui le parole hanno un peso spesso importante, e da un inusuale impasto sonoro determinato dalla coesistenza di strumenti che appartengono a mondi culturali diversi. Il leader tenta di assemblare il tutto con l’ impegno e la passione che gli sono propri, anche se il risultato non sempre è dei migliori.
 Flavio Boltro, Fabio Giachino – “Things to Say” – Cam Jazz
Flavio Boltro, Fabio Giachino – “Things to Say” – Cam Jazz
Suonare in duo è sempre molto impegnativo, forse più della prova in solitario. Il fatto è che quando ci si esibisce in due occorre che i musicisti si conoscano molto bene e riescano così a precedere le intenzioni l’uno dell’altro sì da assicurare alla musica una fluidità che non conosce intoppi. Ecco, tutto ciò lo si ritrova in questo album interpretato da due grandi jazzisti italiani. Flavio Boltro (classe 1961) è artista oramai maturo che ha raggiunto una perfetta padronanza dello strumento il che gli consente di evidenziare un bel suono, pieno, ricco supportato da un fraseggio mai fine a se stesso e da una indubbia capacità di intonare suadenti linee melodiche. Giachino (classe 1986) è un pianista che ha conquistato pubblico e critica grazie ad uno stile raffinato in cui sottile ironia e padronanza della dinamica si coniugano mirabilmente, il tutto declinato con una personale dimensione dello spazio (lo si ascolti in “Prelude to Salina”). In programma un repertorio tutto composto da original a firma soprattutto di Fabio Giachino il che conferma vieppiù la maturità di questo pianista. Di qui una musica che scorre fluida caratterizzata spesso da notevole intensità emotiva e soprattutto da una perfetta intesa tra i due musicisti che, pur proveniendo da ambienti diversi, riescono a fondere le loro esperienze in un unicum raffinato. Ed è una sensazione che si percepisce immediatamente sin dall’ascolto del primo brano in programma, “Piccola Nina” di Flavio Boltro, sino a quel “Spicy Blues” ancora di Boltro che chiude l’album.
 Avishai Cohen – “Naked Truth” – ECM
Avishai Cohen – “Naked Truth” – ECM
Tra le stelle di primaria grandezza che rifulgono nel panorama jazzistico internazionale, un suo posto di rilievo ce l’ha sicuramente il trombettista israeliano Avishai Cohen. Registrato negli Studios La Buissonne a Pernes-les-Fontaines nel Sud della Francia, nel settembre del 2021, sotto la produzione ECM, l’album ci consegna un Cohen sotto certi aspetti inediti. Abbandonate le atmosfere “elettriche” del precedente album, il trombettista si consegna al suo pubblico in estrema sincerità, con una musica tutta giocata sul coté dell’intimismo e declinata attraverso otto parti di una lunga suite intitolata “Naked Truth” e da un brano conclusivo, “Departure”. Avishai suona con la perizia che ben conosciamo ma è l’atmosfera generale dell’album che, come si diceva, lo proietta in una luce diversa. Perfettamente coadiuvato da Yonathan Avishai al piano, dal bassista Barak Mori e dal batterista Ziv Ravitz, il leader disegna una sorta di percorso che si snoda coerentemente quasi illustrando vari stati d’animo. Così si passa da pezzi di chiara impronta crepuscolare a frammenti in cui la tromba pare schiarirsi e aprirsi ad orizzonti più rosei fino a sfiorare il clima tipico delle ballad.
Da sottolineare come, accanto al leader, suona uno splendido Yonathan Avishai il cui pianoforte si pone come autentico alter-ego del leader prendendo egli stesso in mano il pallino del discorso (si ascolti al riguardo la convincente Part.V).
Come si accennava, il disco si chiude con la poesia “Departure”, dell’autrice israeliana Zelda Schneurson Mishkovsky (1914.1984), recitata dallo stesso Cohen sul tappeto strumentale degli altri musicisti.
 Claudio Cojaniz – “Orfani” – Caligola
Claudio Cojaniz – “Orfani” – Caligola
Poeta della tastiera. Così mi sento di definire Claudio Cojaniz dopo l’ascolto di questo bell’album registrato nell’aprile del 2021 a Treviso dall’oramai rodato quartetto del pianista completato da un sempre straordinario Alessandro Turchet al contrabbasso (a mio avviso uno dei migliori bassisti italiani), Luca Colussi alla batteria e Luca Grizzo percussioni. In repertorio sette composizioni dello stesso Cojaniz. Conosco Claudio oramai da tanti anni ma francamente non so dire con precisione a quali “orfani” si riferisce. Orfani di cosa? Di chi? Personalmente ho avvertito, comunque, nella musica di Cojaniz una sorta di dolore di fondo, di grande malinconia come se l’artista volesse farci riflettere sui tanti guai che in questo momento affliggono l’umanità. Certo, non ci si riferisce alla guerra ché l’album è stato inciso prima, ma resta egualmente la sensazione di un disagio, di un modo di vedere una realtà che non ci piace più di tanto. Ecco, penso che in questo caso il riferimento al blues, non tanto come struttura, ma come musica che rispecchia uno stato d’animo, sia assolutamente presente. E la cosa non stupisce più di tanto ove si tenga presente da un canto la lunga militanza di Cojaniz nell’ambito del jazz (il suo pianismo è ancora una volta coerente, del tutto idoneo alle sue volontà espressive), dall’altro i frequenti richiami africaneggianti che il musicista ha già fatto nei precedenti lavori. Insomma un artista che dimostra, ancora una volta, una profonda conoscenza del linguaggio jazzistico non solo dal punto di vista musicale ma anche da ciò che questo linguaggio ha rappresentato – e ancora oggi rappresenta – per le popolazioni di colore negli States…e non solo.
 Lorenzo De Finti Quartet – “Mysterium Lunae” – Losen
Lorenzo De Finti Quartet – “Mysterium Lunae” – Losen
Strano ma vero, un quartetto italiano che incide per una etichetta norvegese e non è la prima volta dato che il pianista Lorenzo De Finti ha già inciso per la Losen altri due album. Ma veniamo a quest’ultimo “Mysterium Lunae” registrato a Torino nei primi tre giorni del luglio 2021. Per quest’ultima fatica discografica, il gruppo si è arricchito di un prestigioso elemento, il trombettista e flicornista Alberto Mandarini unanimemente considerato musicista a 360 gradi. A completare il gruppo Stefano Dall’Ora al basso e Marco Castiglioni alla batteria. In programma sei brani firmati congiuntamente da De Fanti e Dall’Ora. De Finti è musicista di larga esperienza avendo suonato in orchestre sinfoniche, nella celebrata Instabile Orchestra e accanto a Paolo Conte in molte tournées. Ciò gli ha permesso di elaborare un proprio stile caratterizzato da un sound originale e dalla capacità di scavare a fondo in ogni composizione per trarne ogni possibile implicazione. E tutto ciò si evince dall’ascolto dell’album in oggetto che si apre con la composizione forse più interessante, “Mysterium Lunae”, che si richiama espressamente all’antica metafora per cui un oggetto freddo può diventare fonte di bellezza riflettendo, però, una luce più grande proveniente da qualcos’altro. Ecco quindi questo vero e proprio richiamo alla speranza, sentimento che nel corso della pandemia (periodo in cui è stato registrato il CD) purtroppo è andato quasi perso. Ma i quattro non si limitano a focalizzare uno stato d’animo ché l’album prosegue con una serie di atmosfere cangianti grazie all’attento uso dei colori e delle dinamiche che appaiono già patrimonio consolidato del quartetto.
 Joey DeFrancesco – “More Music” – Mack Avenue
Joey DeFrancesco – “More Music” – Mack Avenue
Non c’è dubbio alcuno che tra quanti suonano ancora oggi l’organo Hammond Joey DeFrancesco sia tra i più bravi. Ma il nostro non si limita a maneggiare con maestria l’organo dal momento che suona bene anche la tromba, il sax tenore, le tastiere e il piano. E ce ne dà prova in questo album in cui presenta undici composizioni (ben dieci a sua firma) in cui, accompagnato da una ritmica composta da Michael Ode alla batteria e Lucas Brown chitarra, organo e tastiere, si diverte ad evidenziare il suo multistrumentismo. E lo fa già in apertura interpretando alla tromba il brano “Free” che, a scanso di equivoci, nulla a che vedere ha con il free jazz. Eccolo ancora alla tromba nel blues “Where to Go”, mentre nelle due ballads, “Lady G” ed “Angel Calling”, si misura con il sax tenore… ma tutto ciò non sarebbe stato sufficiente senza un brano cantato… e voila “And If You Please”, cosicché in alcuni brani l’Hammond B3 viene suonato da Lucas Brown, anch’egli polistrumentista di assoluto livello. Da quanto sin qui detto risulta abbastanza evidente come tutto l’album sia all’insegna della gioia di suonare, di poter eseguire senza tema di essere criticati la musica che piace. Certo, se ci si dovesse poi chiedere in quale veste preferiamo Joey, la risposta non può che essere una ed una sola: all’organo Hammond di cui DeFrancesco rimane uno straordinario interprete, capace di trarre dallo strumento tutta una serie di nuances, di sfumature che pochi altri sanno imitare.
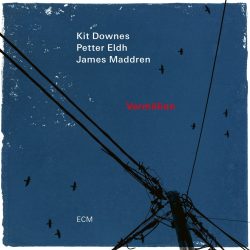 Kit Downes – “Vermillion” – ECM
Kit Downes – “Vermillion” – ECM
Dopo i suoi due precedenti album per ECM, “Dreamlife of Debris” del 2019 e “Obsidian” del 2017 in cui suonava un organo da chiesa a canne, il musicista inglese Kit Downes si ripresenta alla testa di un classico piano-trio coadiuvato dallo svedese Petter Edh già ammirato nel trio di Django Bates al contrabbasso e il britannico James Maddren alla batteria. In realtà al momento della registrazione di questo album, i tre si conoscevano già bene avendo suonato assieme sotto l’insegna di Trio Enemy. Questo “Vermillion” risente molto della formazione musicale del leader: abituato a frequentare quasi indistintamente territori classici, moderni e jazzistici, il pianista infonde alla sua musica uno spirito affatto particolare che la pone piuttosto lontana da ciò che normalmente si immagina debba essere un trio di jazz. In effetti qui non troviamo una continua pulsazione ritmica, né linee melodiche facilmente identificabili ma un flusso costante di musica tutta giocata su toni meditativi. Ovviamente – Evans insegna – non c’è alcuna gerarchia fra i tre strumenti che dialogano su un piano di assoluta parità alla ricerca di un’espressività interiore che mai viene meno. Di qui la sensazione, non si sa bene quanto veritiera, che la scrittura la faccia da padrona sull’improvvisazione. Insomma una sorta di viaggio introspettivo declinato attraverso dieci composizioni di pianista e contrabbassista e la cover di Jimi Hendrix, “Castles Made of Sand” tratto da “Axis: bold as Love” del 1967che chiude meravigliosamente l’album.
 Mathias Eick – “When We Leave” – ECM
Mathias Eick – “When We Leave” – ECM
Il trombettista Mathias Eick è uno di quei musicisti che mai ti delude. Ogni suo album è una summa di quel che oggi dovrebbe rappresentare, a nostro avviso, la figura del jazzista, vale a dire un musicista che pur conoscendo perfettamente la tradizione, volge lo sguardo al futuro. E lo fa con la piena consapevolezza dei propri mezzi espressivi. Ingredienti, questi, che si ritrovano appieno in “When We Leave” registrato a Oslo nell’agosto 2020 da un organico piuttosto ampio guidato da Mathias Eick (nell’occasione anche alle tastiere) e completato da Andreas Ulvo al piano, dal bassista Audun Erlien, da Hakon Aase violino e percussioni, dai due batteristi e percussionisti Torstein Lofthus e Helge Andreas Norbakken e dal chitarrista Stian Carstensen il cui apporto risulta tutt’altro che secondario. Come abbiamo già avuto modo di apprezzare nei suoi precedenti lavori, la musica di Eick si mantiene su atmosfere intimiste, malinconiche, declinata attraverso il fitto colloquio dei musicisti che sembrano aderire perfettamente a quelle che sono le linee guida dettate dal leader. Di qui una insieme di linee melodiche sempre riconoscibili, un perfetto controllo del ritmo ben supportato da una sezione quanto mai precisa ed efficiente, ed un gioco sulle dinamiche che spesso si fa apprezzare per la sua originalità. Tra i vari strumentisti precedentemente citati, da sottolineare ancora una volta la prova del violinista Hakon Aase che oltre ad eseguire spesso il tema all’unisono con la tromba del leader, si produce in pregevoli assolo. Ma il fulcro di tutto è sempre lui, Mathias Eick il cui strumento si staglia sempre preciso, puntuale, così come le sue capacità compositive dato che tutti i brani dell’album sono dovuti alla sua penna.
 Antonio Flinta – “Secrets of a Kiri Tree” – Autoprod.
Antonio Flinta – “Secrets of a Kiri Tree” – Autoprod.
Sono passati circa due anni da quando, discutendo con Antonio Flinta, gli chiesi come mai non si fosse ancora cimentato al piano-solo dopo una intensa carriera. Antonio mi rispose che l’avrebbe fatto solo se si fosse sentito pronto. Il momento è arrivato ed ecco questo “Secrets of a Kiri Tree” in cui il pianista cileno ci spinge a guardarci nel profondo, a riscoprire quel che abbiamo dentro, anche se per farlo probabilmente abbiamo bisogno di qualcuno che si spinga in tal senso. E per ottenere tale scopo Flinta sceglie un repertorio tanto vasto quanto difficile. Ecco quindi Paco de Lucia con “Cancion de amor”, accanto a George Fragos (“I Hear a Rhapsody”), la straordinaria Violeta Parra (“Gracias a la vida”) assieme al gigante del jazz Thelonious Monk (”’Round Midnight”) il tutto completato da tre originals di Antonio. A nostro avviso il meglio dell’album lo si ritrova nelle composizioni dello stesso pianista. Scevro da qualsivoglia preoccupazione se non quella di lasciarsi andare al proprio istinto, Flinta inanella una serie di improvvisazioni davvero notevoli in cui mai si perde il filo del discorso tanto è solida la base su cui l’artista costruisce i suoi edifici musicali. Così risulta quanto mai arduo distinguere le parti improvvisate da quelle scritte, ammesso poi che la cosa abbia un minimo di importanza. Così il pianismo di Flinta scorre fluido sicuro, lucido, essenziale, mai sovracaricato di orpelli inutili e pur tuttavia sempre in grado di incuriosire l’ascoltatore. Quanto agli altri brani, abbiamo particolarmente apprezzato la versione di “Gracias a la vida” che conserva intatta la sua dolce e malinconica linea melodica.
 Tord Gustavsen – “Opening” – ECM
Tord Gustavsen – “Opening” – ECM
Ancora un piano-trio questa volta di marca norvegese. A costituirlo sono infatti il pianista Tord Gustavsen, il contrabbassista Steinar Raknes (responsabile anche di un sapiente e sobrio uso dell’elettronica) e il batterista Jarle Vespestad ovvero tre dei migliori musicisti che il panorama jazz norvegese possa oggi offrire. E il risultato è in effetti di grande rilevanza. Certo non scopriamo in questa sede lo straordinario talento del pianista, ma fa immenso piacere constatare come uno dopo l’altro tutti i lavori di Tord si mantengano su un livello di assoluta eccellenza. In programma, questa volta, dodici brani di cui nove a firma del leader cui si aggiungono un brano traditional e due pezzi firmati rispettivamente da Geir Tveitt – figura centrale del movimento culturale norvegese negli anni ’30 – e da Egil Hovland, compositore classico che si formò studiando tra gli altri con Aaron Copland e a Firenze con Luigi Dallapiccola. E da queste poche note si può già comprendere quanto ampio sia l’universo musicale di riferimento di Gustavsen e quindi dell’intero trio. Di qui una musica saldamente ancorata al patrimonio norvegese, e nordico più in generale. Ecco quindi la rivisitazione, già al secondo pezzo, di un brano abbastanza celebrato in Svezia, “Visa från Rättvik” (Vista dalla città di Rättvik), già inserito da Jan Johansson – uno tra i più grandi pianisti svedesi di cui Gustavsen ha dichiarato di sentire l’influenza – nell’album del 1964, “Jazz pa Svenska”, album che all’epoca vendette la stratosferica cifra di 250.000 copie. Gustavsen stravolge il pezzo rendendolo praticamente suo e lo stesso fa per tutta la durata dell’album mai offrendo musica banale o scontata. Si ascolti, ad esempio, il suo modo di intendere il tango in “Helensburgh Tango”, lontano che più non si potrebbe dalle atmosfere tipiche tanguere. Splendida la versione di “Var Sterk, Min Sjel” assolutamente rispettosa dell’originale del già citato Egil Hovland.
 Roberto Laneri – “Musica finta / Blue Prints” – Da Vinci Classics
Roberto Laneri – “Musica finta / Blue Prints” – Da Vinci Classics
Roberto Laneri – “South of No Border” – Black Sweat Records
Il polistrumentista Roberto Laneri si ripresenta con due album registrati rispettivamente nel 1998 e in un arco temporale che va dal 2014 al 2018. Ma procediamo con ordine. “Musica finta / Blue Prints”, registrato come si diceva nel 1998 ma pubblicato solo nei primi mesi del 2020, va inquadrato correttamente grazie al sottotitolo “A Study in Metamusicology”. Si tratta, cioè, di un album assai complesso, di lettura difficile, in cui Laneri – come egli stesso afferma, suonando al sax soprano alcuni rags di Scott Joplin ha provato ad introdurre dei cambiamenti nel testo, dapprima minimi, poi sempre più articolati, fino ad arrivare alla composizione di pezzi autonomi e paralleli, da suonarsi assieme ai pezzi originali. “L’effetto di questa estremizzazione – aggiunge Laneri – è paragonabile alle prospettive impossibili di Escher, oppure ai disegni tridimensionali generati al computer, dai quali possono emergere immagini complementari eppur assai diverse da quelle immediatamente apparenti”. Fin qui le premesse metodologiche. Ma il risultato musicale? Laneri presenta composizioni originali, unite a quelle di Schumann, Schubert ma anche Joplin e Jelly Roll Morton. Quindi linguaggi differenti ricondotti ad unità per una sorta di opera di ampio respiro divisa in cinque capitoli. Per questa impresa Laneri (sax soprano, sampling e sound treatment) ha chiamato accanto a sé la pianista Maria Jolanda Masciovecchio e Alan Ferry come spoken voice.
 “South of No Border” (come si diceva registrato tra il 2014 e il 2018 ma anch’esso pubblicato poche settimane fa) vede Roberto Laneri (clarinetto, clarinetto basso, sax sopranino, sax soprano e alto, didjeridoo, shruti box, voce e percussioni) alla testa di un gruppo comprendente Giuppi Paone voce, Raffaela Siniscalchi voce, Eleonora Vulpiani chitarra, Luigi Polsini contrabbasso e Laugi Marino zarb. Contrariamente al primo album, in questo caso il repertorio è come una sorta di finestra affacciata sulle musiche del mondo. Ecco, quindi, dopo l’apertura affidata alle melodie orientaleggianti di “Malia” (scritta da Laneri), il choro brasiliano “Tico-Tico no fubá” (scritto da Zequinha de Abreu nel 1917, accanto al bolero cubano “Contigo En La Distancia” scritto dal cantautore César Portillo de la Luz quando aveva 24 anni nel 1946, il tutto impreziosito da 4 original del leader. A confronto con un tale repertorio, Laneri dà ancora una volta prova non solo della sua indiscussa preparazione tecnica ma anche della profonda conoscenza del panorama musicale internazionale. Le sue interpretazioni risultano, quindi, assolutamente pertinenti: traendo feconda ispirazione da svariate tradizioni, riesce a produrre una sintesi che non conosce confini geografici grazie ad una concezione visionaria della musica senza barriere. Insomma un disco originale nella concezione e nell’esecuzione.
“South of No Border” (come si diceva registrato tra il 2014 e il 2018 ma anch’esso pubblicato poche settimane fa) vede Roberto Laneri (clarinetto, clarinetto basso, sax sopranino, sax soprano e alto, didjeridoo, shruti box, voce e percussioni) alla testa di un gruppo comprendente Giuppi Paone voce, Raffaela Siniscalchi voce, Eleonora Vulpiani chitarra, Luigi Polsini contrabbasso e Laugi Marino zarb. Contrariamente al primo album, in questo caso il repertorio è come una sorta di finestra affacciata sulle musiche del mondo. Ecco, quindi, dopo l’apertura affidata alle melodie orientaleggianti di “Malia” (scritta da Laneri), il choro brasiliano “Tico-Tico no fubá” (scritto da Zequinha de Abreu nel 1917, accanto al bolero cubano “Contigo En La Distancia” scritto dal cantautore César Portillo de la Luz quando aveva 24 anni nel 1946, il tutto impreziosito da 4 original del leader. A confronto con un tale repertorio, Laneri dà ancora una volta prova non solo della sua indiscussa preparazione tecnica ma anche della profonda conoscenza del panorama musicale internazionale. Le sue interpretazioni risultano, quindi, assolutamente pertinenti: traendo feconda ispirazione da svariate tradizioni, riesce a produrre una sintesi che non conosce confini geografici grazie ad una concezione visionaria della musica senza barriere. Insomma un disco originale nella concezione e nell’esecuzione.
 Roberto Magris – “Match Point” – JMood / Roberto Magris – “Duo & Trio” – JMood
Roberto Magris – “Match Point” – JMood / Roberto Magris – “Duo & Trio” – JMood
Tra i musicisti che riescono a conservare un alto livello delle proprie produzioni, lavorando in ambedue le sponte dell’Atlantico, c’è sicuramente il pianista Roberto Magris di cui segnaliamo due nuove uscite. Il primo – “Match Point” – registrato a Miami l’8 dicembre del 2018, è stato a ben ragione considerato da critici statunitensi come uno degli album più interessanti pubblicati negli ultimi mesi. “Match Point” vede il pianista triestino alla testa di un quartetto dai mille colori completato dal cubano Alfredo Chacon al vibrafono e percussioni, dal batterista Rodolfo Zunica proveniente dal Costa Rica e dallo statunitense Dion Kerr al basso. In repertorio otto brani equamente divisi tra composizioni dello stesso Magris e brani di giganti della tastiera quali Richard Kermode tastierista americano, noto soprattutto per essersi esibito con Janis Joplin, Malo e Santana, McCoy Tyner, Thelonious Monk, Randy Weston. Da quanto sin qui detto è già possibile avere un’idea della musica che Magris ci propone, una musica che, saldamente ancorata alla produzione, presenta quel tocco di “latino” che impreziosisce il tutto. Al riguardo basti ascoltare “Caban Bamboo Highlife” di Randy Weston, uno dei jazzisti preferiti da Magris, con Chacon e Zuniga in grande evidenza.
In “Duo & Trio” Magris adotta una formula diversa esibendosi in sei brani in duo con il sassofonista Mark Colby e in cinque pezzi in gruppo con Elisa Pruett al basso, Brian Steever alla batteria mentre Pablo Sanhueza alle congas è presente solo in “Melody for C” di Sonny Clark e “Samba Rasta” di Andrew Hill. Per il resto i compositori visitati da Magris fanno parte dell’Olimpo della musica quali Elmo Hope, Bernstein, Ray Noble, Shuman, Kurt Weill; il tutto completato, come al solito, da alcune composizioni dello stesso Magris. L’ascolto dell’album lascia pienamente soddisfatti per almeno due ordini di motivi: innanzitutto la straordinaria maestria di Roberto Magris che, dall’alto della sua immensa preparazione pianistica, affronta con estrema disinvoltura partiture assai diversificate tra di loro (eccolo intimista e toccante in “Old Folks”, classico nell’accezione più completa del termine in “Cherokee”, trascinante improvvisatore in “Melody for C”); in secondo luogo per la scelta di collaboratori sempre di livello. Da segnalare, in questa occasione il lavoro del sassofonista Mark Colby che sia al tenore sia al soprano evidenzia una forte personalità scevra da qualsivoglia intento di stupire chi ti ascolta.
 Dino & Franco Piana Ensemble – “Reflections” –Alfa Music
Dino & Franco Piana Ensemble – “Reflections” –Alfa Music
Attualmente l’ensemble diretto dalla premiata ditta “Dino & Franco Piana” è una delle migliori formazioni del jazz attuale. Ciò anche perché nel suo ambito, oltre ai citati leader, figurano artisti di grande spessore quali la pianista Stefania Tallini, il bassista Dario Deidda e il batterista Roberto Gatto. In quest’ultima fatica discografica il gruppo è affiancato dalla B.i.m. Orchestra mentre il repertorio comprende dieci brani di cui ben sei composti da Franco Piana (altresì flicornista e arrangiatore del gruppo), altri due original dovuti rispettivamente a Lorenzo Corsi e Stefania Tallini e due standard, “Skylark” di Hoagy Carmichael e “Embraceable You” di George Gershwin. Il progetto nasce durante il lockdown dalle riflessioni dei due leader che hanno focalizzato l’attenzione sulle molteplici possibilità d’espressione che i vari organici possono offrire. Di qui il far ricorso, per ogni brano, ad un organico diverso. Si inizia così da “Skylark”, suonato dal trombone di Dino Piana in solo, passando poi a brani in duo – trio – quartetto – quintetto – sestetto, fino ad arrivare ad arrangiamenti per quartetto d’archi (B.i.m. Orchestra), 4 flauti, piano e flicorno. Come le precedenti prove dei Piana, anche questo album entra di diritto tra i migliori album di jazz italiano pubblicati negli ultimi mesi in quanto la bellezza dei temi è supportata e valorizzata da arrangiamenti ben strutturati e altrettanto ben eseguiti da una formazione che presenta anche individualità di tutto rispetto. Senza dimenticare i due leader – di cui comunque spesse volte abbiamo tessuto le lodi – bisogna sottolineare l’apporto di Stefania Tallini che si conferma jazzista a tutto tondo capace sia di sviluppare suadenti linee melodiche sia di imporre un ritmo preciso e coinvolgente (la si ascolti in “D and F”). Ma la citazione di questo brano è solo un esempio ché tutto l’album merita di essere ascoltato.
 Valentina Ranalli, Enrico Pieranunzi – “Cantare Pieranunzi” – Alfa Music
Valentina Ranalli, Enrico Pieranunzi – “Cantare Pieranunzi” – Alfa Music
Enrico Pieranunzi Quintet – “The Extra Something” – Cam Jazz
Quasi contemporaneamente sono usciti due pregevoli album che vedono impegnato Enrico Pieranunzi. Nel primo – “Cantare Pieranunzi” – il pianista romano si presenta nella triplice veste di leader dello Youth Project (con Giuseppe Romagnoli al basso, Cesare Mangiocavallo alla batteria e Giacomo Serino alla tromba), compositore e arrangiatore. Il tutto al servizio della vocalist Valentina Ranalli. La genesi dell’album è assai particolare e ce la illustra lo stesso Pieranunzi nelle note che accompagnano il CD: in buona sostanza “Cantare Pieranunzi” è il frutto della tesi di laurea in canto jazz presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma di Valentina Ranalli che ha presentato un lavoro incentrato su pezzi del pianista, cui ha aggiunto le parole in italiano, inglese, francese e napoletano. Incuriosito dall’iniziativa e dopo aver ascoltato la vocalist, Pieranunzi decide di mettere il tutto su disco e bene ha fatto dal momento che l’album è di assoluto livello. Le undici tracce contenute nell’album sono interpretati dalla Ranalli con sincera partecipazione dialogando intensamente con il pianoforte di Enrico: si ascolti, ad esempio, “You Know”. Ma è tutta la performance della cantante che convince e che fa ottimamente sperare per il suo futuro; fra i pezzi da segnalare “Suspension points” fatto di poche note ma di tanta emozione, e “Persona” in cui la Ranalli si trova particolarmente a suo agio esprimendosi nella lingua della sua terra, il partenopeo.
 Completamente diverso il secondo album – “The Extra Something” – registrato live il 13 e 14 gennaio 2016 al Village Vanguard da un quintetto che vedeva il pianista romano in compagnia di Diego Urcola tromba e trombone (semplicemente straordinario nella title tracke), Seamus Blake sax tenore (particolarmente convincente in “Atoms”), Ben Street basso e Adam Cruz batteria. E per quanti seguono il jazz non c’è bisogno di altre parole per sottolineare il valore assoluto della band. Valore assoluto che si evidenzia in tutto il repertorio, sette brani tutti composti dal pianista. Pieranunzi, come spesso gli capita, è in uno stato di grazie e conduce il gruppo con mano sicura, del tutto consapevole dell’intesa che ha raggiunto con i compagni di viaggio. Dal punto di vista compositivo non scopriamo certo oggi il suo senso della struttura che mai l’abbandona, per cui se consideriamo tutti questi elementi si capisce bene perché il ben noto Brian Morton abbia incluso Enrico tra “i più significativi musicisti contemporanei”. Nelle note di copertina Pieranunzi dedica espressamente questo terzo CD Live at The Village Vanguard a Lorraine Gordon in memoriam, senza la quale né questo né i precedenti due si sarebbero potuti realizzare. Ricordiamo per inciso che il pianista romano è forse l’unico musicista italiano nella veste di leader ed uno dei pochissimi europei ad aver suonato nel leggendario jazz club a forma di diamante aperto da Max Gordon nel 1935 al 178 Seventh Avenue South di Manhattan.
Completamente diverso il secondo album – “The Extra Something” – registrato live il 13 e 14 gennaio 2016 al Village Vanguard da un quintetto che vedeva il pianista romano in compagnia di Diego Urcola tromba e trombone (semplicemente straordinario nella title tracke), Seamus Blake sax tenore (particolarmente convincente in “Atoms”), Ben Street basso e Adam Cruz batteria. E per quanti seguono il jazz non c’è bisogno di altre parole per sottolineare il valore assoluto della band. Valore assoluto che si evidenzia in tutto il repertorio, sette brani tutti composti dal pianista. Pieranunzi, come spesso gli capita, è in uno stato di grazie e conduce il gruppo con mano sicura, del tutto consapevole dell’intesa che ha raggiunto con i compagni di viaggio. Dal punto di vista compositivo non scopriamo certo oggi il suo senso della struttura che mai l’abbandona, per cui se consideriamo tutti questi elementi si capisce bene perché il ben noto Brian Morton abbia incluso Enrico tra “i più significativi musicisti contemporanei”. Nelle note di copertina Pieranunzi dedica espressamente questo terzo CD Live at The Village Vanguard a Lorraine Gordon in memoriam, senza la quale né questo né i precedenti due si sarebbero potuti realizzare. Ricordiamo per inciso che il pianista romano è forse l’unico musicista italiano nella veste di leader ed uno dei pochissimi europei ad aver suonato nel leggendario jazz club a forma di diamante aperto da Max Gordon nel 1935 al 178 Seventh Avenue South di Manhattan.
 Serena Spedicato – “Io che amo solo te” – Dodicilune
Serena Spedicato – “Io che amo solo te” – Dodicilune
Non sempre la bellezza della confezione corrisponde alla bontà del contenuto. In questo caso, la Dodicilune ha realizzato qualcosa di eccellente affidando alla vocalist Serena Spedicato (utilizzata anche come splendida voce narrante) un repertorio per noi italiani impossibile da dimenticare, all’interno di una confezione sobriamente elegante. In realtà Serena Spedicato e lo scrittore Osvaldo Piliego avevano dato vita a questo loro progetto originale come concerto/spettacolo con la regia di Riccardo Lanzarone, che solo successivamente è approdato alla forma libro/cd. Così la Dodicilune ci presenta un prezioso libretto, con la grafica di Marina Damato, autrice delle foto con Maurizio Bizzochetti, e i testi inediti di Osvaldo Piliego che accompagnano dodici brani tra i più belli e rappresentativi del cantautorato italiano, rielaborati in una forma nuova grazie agli arrangiamenti del fisarmonicista Vince Abbracciante coadiuvato da Nando Di Modugno (chitarra classica) e Giorgio Vendola (contrabbasso). Le canzoni proposte appartengono tutte alla cd. “scuola genovese” vale a dire Luigi Tenco, Fabrizio De André, Gino Paoli, Sergio Endrigo, Umberto Bindi, Bruno Lauzi. In buona sostanza tutto il lavoro ruota attorno ai cantautori che sono cresciuti e si sono formati in quel di Genova, ove sul finire degli anni Cinquanta si sviluppò un movimento culturale e artistico che rivoluzionò il mondo della canzone italiana. Ed è proprio questo clima che si respira ascoltando l’album. Molte le positività del lavoro: le centrate interpretazioni della vocalist che evidenzia una musicalità ed una sensibilità non comuni, i testi intelligenti che aiutano (soprattutto i più giovani) a capire ciò che si ascolta, ma soprattutto gli arrangiamenti di Vince Abbracciante che oramai non ne sbaglia una. Misurarsi con dei veri e proprio mostri sacri della musica non è certo impresa facile: ebbene il fisarmonicista ha affrontato l’impresa con passione e professionalità regalandoci degli arrangiamenti che, senza alcunché togliere al fascino originario, hanno rivestito i brani di una patina jazzistica pertinente ed affascinante. Ovviamente più che positiva anche l’apporto di Nando Di Modugno e Giorgio Vendola per un album di sicuro rilievo.
 Andrés Thor – Hereby – Losen
Andrés Thor – Hereby – Losen
Siamo veramente grati alla norvegese Losen Records per la possibilità che ci offre di far conoscere al pubblico italiano dei veri e propri talenti che, non avendo ancora raggiunto fama internazionale, difficilmente raggiungono le nostre platee. E’ il caso del chitarrista islandese Andrés Thor che, giunto al suo settimo album da leader, si presenta al pubblico alla testa di un trio completato dall’altro islandese Magnús Trygvason Eliassen batteria e dal francese Nicolas Moreaux contrabbasso. Quello di Thor è un fraseggio molto personale, pulito, chiaro, senza alcuna pretesa di sperimentalismo o di sensazionalismo. La sua idea di guidare il trio si avvicina molto alla lezione impartita da Bill Evans con Scott LaFaro. Quindi una formazione che si muove su basi paritetiche in cui ognuno può improvvisare ed esprimere la propria personalità all’interno di una cornice ben delineata dalle nove composizioni tutte a firma dello stesso Thor. Da un punto di vista prettamente chitarristico, Thor è chiaramente ispirato da tre grandi esponenti della chitarra jazz – Jim Hall, John Scofield e Pat Metheny – mentre sotto un profilo più generale tra i suoi maggiori interessi figurano rock band come i Led Zeppelin e i Doors nonché Jimi Hendrix e John Coltrane. Come si nota un universo di riferimento assai ampio che Thor dimostra di aver assorbito molto bene soprattutto nel modo in cui costruisce le sue composizioni, dotate tutte di un eccellente senso architettonico e ben arrangiate. Da sottolineare che mentre nei primi sette brani Andrés utilizza la chitarra elettrica, negli ultimi due imbraccia lo strumento acustico senza che ciò influenzi minimamente l’omogeneità dell’album.
 Mark Turner – “Return From The Stars” – ECM
Mark Turner – “Return From The Stars” – ECM
Registrato a New York nel novembre del 2019, questo album vede impegnato un quartetto piano-less guidato dal sassofonista Mark Turner e completato da Jason Palmer alla tromba, Joe Martin al contrabbasso e Jonathan Pinson alla batteria. L’album si inserisce in quella nuova corrente musicale che si allontana molto dal jazz mainstream per inserirsi in ciò che si può definire “musica moderna” tout court. Ma, a questo punto, qualcuno potrebbe chiedersi: si tratta ancora di jazz? Lasciamo ad altri la risposta a questo inutile quesito per soffermarci su un altro interrogativo molto più pregnante: si tratta di musica di qualità o no? La risposta non può che essere positiva: si, si tratta di musica di qualità dal momento che risponde ad alcuni requisiti facilmente individuabili. Intendiamo riferirci, innanzitutto, alla natura delle composizioni: Turner scrive benissimo, con perfetto senso delle proporzioni, lasciando ad ognuno dei suoi collaboratori il giusto spazio pur essendo comunque in condizione di ricondurre il discorso ad unità; il tutto corroborato dalla capacità di creare una omogeneità di fondo. Ma ciò sarebbe stato inutile se ad interpretare queste complesse partiture non ci fossero stati dei musicisti completi, preparati. Si ascolti, ad esempio, con quanta pertinenza il trombettista segua il leader nelle sue escursioni o di come il batterista riesca ad inserire il suo drumming nelle complesse trame disegnate dal leader mentre il basso non perde un colpo nel supportare il ritmo del gruppo. Insomma un disco tutto da gustare, per palati raffinati.
 Cristina Zavalloni – “Parlami di me” – Egea
Cristina Zavalloni – “Parlami di me” – Egea
“Parlami di me” è il suggestivo titolo di questo nuovo album dedicato alle musiche di Nino Rota, all’anagrafe Giovanni Rota Rinaldi, scomparso nel 1979 e a ben ragione considerato, a livello mondiale, uno dei massimi esponenti dei compositori che hanno dedicato la loro vita al cinema. Basti ricordare le colonne sonore di quasi tutti i film di Fellini nonché le colonne sonore del Padrino e Il padrino – Parte II vincendo, per quest’ultimo, il Premio Oscar alla migliore colonna sonora. Evidentemente il connubio tra jazz e musiche da film non è certo una novità eppure ogni nuovo album del genere va ascoltato con la massima attenzione data la delicatezza della materia. In effetti estrapolare tale musiche dal contesto per cui sono nate e farne un qualcosa a sé stante è impresa tutt’altro che banale. A cimentarsi con questo difficile compito è ora una delle nostre migliori vocalist, Cristina Zavalloni, accompagnata da quattro musicisti di assoluto livello quali Gabriele Mirabassi al clarinetto, Cristiano Arcelli al sax soprano (nonché responsabile degli ottimi arrangiamenti), Massimo Morganti al trombone e Manuel Magrini al pianoforte, cui si aggiunge il ClaraEnsemble, sestetto costituito da flauto, contrabbasso, due violini, viola e violoncello. Un organico, quindi, piuttosto ampio che si attaglia perfettamente sia alla voce della Zavalloni sia agli arrangiamento di Arcelli. La vocalist entra quasi in punta di piedi nell’universo di Nino Rota, ma subito dopo se ne appropria, lo fa suo e lo reinterpreta con chiavi sempre originali pur nulla perdendo dell’originario fascino. Così riascoltiamo alcune perle del Maestro che hanno stupendamente accompagnato le immagini volute dai più grandi registi italiani da Fellini a Visconti, da Wertmuller a Zeffirelli…Il repertorio dell’album si completa con l’unica canzone scritta integralmente, dalla Zavalloni, “Prova tu”, che si integra perfettamente nel discorso generale portato avanti da “Parlami di me”.
Gerlando Gatto
da Redazione | 12/Gen/2022 | Appuntamenti, News, Primo piano
Dopo la pausa delle festività natalizie riprende alla grande la stagione “Latina in Jazz 2021 / 2022” del Latina Jazz Club Luciano Marinelli.
Venerdì prossimo, 14 gennaio, alle ore 20.30 presso l’auditorium del Circolo Cittadino di Latina si esibirà Dado Moroni in “Piano Solo”, appuntamento da non mancare trattandosi di un artista di assoluto livello internazionale.

Dado Moroni
Dado Moroni debutta a 17 anni con Tullio De Piscopo e Franco Ambrosetti, col quale collabora ancora oggi. Nel 1987 viene chiamato – unico europeo – insieme ai pianisti Hank Jones, Barry Harris e Roland Hanna a far parte della giuria del premio internazionale pianistico Thelonious Monk, svoltosi a Washington. Dado è uno dei pochissimi musicisti italiani la cui biografia è inserita nell’importante “Biographical Encyclopedia of Jazz” di Leonard Feather e Ira Gitler; inoltre, vanta prestigiose e continuative collaborazioni con le grandi star del jazz mondiale. Basti citare al riguardo il fatto che Moroni si trasferisce negli Stati Uniti nel 1991 entrando a far parte della scena jazz di New York e assumendo ruoli sia di bandleader sia di musicista di diverse band. Durante gli anni di permanenza nella Grande Mela suona nei club più prestigiosi tra quali il Blue Note, il Birdland e il Village Vanguard, oltre a collaborare ad alcuni album prestigiosi. Dal punto di vista discografico Moroni può vantare oltre 50 album registrati per importanti etichette discografiche quali Sony Concorde, Contemporary Telarc Mons, TCB Record e Enja.
La classe di Dado Moroni è inconfondibile: con le sue preziose melodie incanta il pubblico, trascinandolo in un mondo dove musica, gioia ed emozioni regnano sovrane. È un musicista colto, ma non c’è traccia di manierismo nelle sue composizioni anzi, comunica costantemente con il pubblico e lo avvolge in quella che è una sua naturale attitudine passionale.
In ottemperanza alla normativa anti-Covid in vigore, per poter accedere alla sala è necessario essere in possesso del SUPER GREEN PASS ed è d’obbligo l’utilizzo della mascherina tipo FFp2.
Redazione
da synpress44 | 13/Ott/2021 | Comunicati stampa
Sabato 16 ottobre 2021
ore 18.00
Ca’ del Garda
Frazione Loppio
Mori (TN)
MICHELE SPERANDIO JAZZ QUARTET
Michele Sperandio batteria,
Ludovico Carmenati contrabbasso,
Simone Maggio pianoforte
Massimo Morganti trombone.
info, prenotazioni: 328 6324447
ore 21.00
Distilleria Marzadro
Via Per Brancolino, 10
Nogaredo (TN)
Tel.:+39 0464 304554
MONK DUET
Tino Tracanna sassofoni
Francesco Saiu chitarra elettrica
ore 20.00: Visita guidata con degustazione itinerante
ore 21.00: concerto
Biglietto: 10 € (pagamento all’ingresso)
Prenotazione obbligatoria tramite e-mail o telefono:
eventi.marzadro@gmail.com / Tel. 0464 304554
greenpass obbligatorio
Sabato 16 ottobre doppio concerto per Jazz & Wine/Suono di-vino, il ciclo di eventi del TrentinoInJazz 2021 legato al jazz e alla degustazione di vini in cantine prestigiose, promosso nel circuito nazionale jazz&wine in collaborazione con il Circolo Controtempo.
Alle 18.00 a Mori (TN) appuntamento con il Michele Sperandio Jazz Quartet, presenza ideale a Cà del Garda dove suonerà in mezzo al vino e alle opere d’arte nel nuovo spazio espositivo inaugurato da pochi mesi. Cà del Garda offrirà gratuitamente un aperitivo e una degustazione di vino. Il progetto del batterista marchigiano si ispira al jazz modale degli anni ’60: brani di Miles Davis, Herbie Hancock, Joe Henderson, Wayne Shorter e altri vengono adattati alle influenze musicali odierne. Un lavoro legato alla tradizione ma con una forte componente contemporanea; gli arrangiamenti di Sperandio valorizzano l’impatto ritmico della musica e la ricchezza timbrica del quartetto.
Alle 21.00 alla Distllleria Marzadro, dopo la degustazione itinerante, torna al TrentinoInJazz uno dei giganti del jazz italiano, il grande Tino Tracanna. Il fiatista sarà sul palco con il chitarrista Francesco Saiu in un progetto speciale dedicato a Thelonious Monk intitolato Monk Duet. Tracanna e Saiu si confrontano con il suo affascinante repertorio, consapevoli di dover fare i conti con una musica caratterizzata da armonie complesse, dense di progressioni cromatiche e fraseggi frastagliati su idee ritmiche originalissime, talvolta imprevedibili. Le sue composizioni diventano il punto di partenza: «Un laboratorio permanente di ricerca musicale dove esplorare con grande libertà espressiva un personale mondo sonoro, in un continuo dialogo tra le parti».















 Francesco Cusa, Giorgia Santoro – “The Black Shoes” – Dodicilune
Francesco Cusa, Giorgia Santoro – “The Black Shoes” – Dodicilune Franco D’Andrea, DJ Rocca – “Franco D’Andrea Meets DJ Rocca” – Parco della Musica Records 3 CD
Franco D’Andrea, DJ Rocca – “Franco D’Andrea Meets DJ Rocca” – Parco della Musica Records 3 CD Giovanni Falzone, Glauco Venier – “Dialogo espressivo” – Parco della Musica Records
Giovanni Falzone, Glauco Venier – “Dialogo espressivo” – Parco della Musica Records Biagio Marino, Zeno De Rossi – “Break Seal Gently” – Fonterossa
Biagio Marino, Zeno De Rossi – “Break Seal Gently” – Fonterossa Roberto Ottaviano, Alexander Hawkins – “Charlie’s Blue Skylight” – Dodicilune
Roberto Ottaviano, Alexander Hawkins – “Charlie’s Blue Skylight” – Dodicilune Barre Phillips, György Kurtag jr. – “Face à Face” – ECM
Barre Phillips, György Kurtag jr. – “Face à Face” – ECM In “Confluence”, registrato live nella Sala accademica del Conservatorio Santa Cecilia, a Roma, il primo marzo del 2020 il contrabbassista statunitense si trova a collaborare con un altro contrabbassista, Daniele Roccato, musicista che da anni si dedica all’interazione fra più contrabbassi, essendo tra l’altro il fondatore dell’ensemble Ludus Gravis, un gruppo di soli contrabbassisti (spesso nove) che si è affermato nel mono della musica moderna eseguendo partiture, fra gli altri, di Hans Werner Henze, Sofia Gubaidulina, Terry Riley, Gavin Bryars, Stefano Scodanibbio. Come evidenziato in apertura, i due contrabbassisti si incontrano sul terreno dell’improvvisazione libera e dal convergere di questi due percorsi musicali, totalmente diversi, emergono nuovi paesaggi che siamo sicuri saranno ancora nuovi e diversi se i due avranno modo di incidere un altro album. Insomma un’immersione totale in una sorta di università sonora per chi ama questo strumento. Un’ultima notazione: davvero belle le foto che accompagnano l’album.
In “Confluence”, registrato live nella Sala accademica del Conservatorio Santa Cecilia, a Roma, il primo marzo del 2020 il contrabbassista statunitense si trova a collaborare con un altro contrabbassista, Daniele Roccato, musicista che da anni si dedica all’interazione fra più contrabbassi, essendo tra l’altro il fondatore dell’ensemble Ludus Gravis, un gruppo di soli contrabbassisti (spesso nove) che si è affermato nel mono della musica moderna eseguendo partiture, fra gli altri, di Hans Werner Henze, Sofia Gubaidulina, Terry Riley, Gavin Bryars, Stefano Scodanibbio. Come evidenziato in apertura, i due contrabbassisti si incontrano sul terreno dell’improvvisazione libera e dal convergere di questi due percorsi musicali, totalmente diversi, emergono nuovi paesaggi che siamo sicuri saranno ancora nuovi e diversi se i due avranno modo di incidere un altro album. Insomma un’immersione totale in una sorta di università sonora per chi ama questo strumento. Un’ultima notazione: davvero belle le foto che accompagnano l’album. Enrico Rava, Fred Hersch – “The song s You” – ECM
Enrico Rava, Fred Hersch – “The song s You” – ECM
 Il 13, sempre alla Cavea, appuntamento con una vera e propria leggenda del jazz: Herbie Hancock. Spesso si adopera la parola “leggenda” in modo esagerato ma nel caso in questione non v’è dubbio alcuno che il termine sia più che appropriato. Non è questa la sede adatta per sintetizzare un curriculum assolutamente straordinario; basti solo dire che l’artista di Chicago, oggi ottantunenne, ha attraversato, sempre da protagonista, generi e mode come performer, compositore, arrangiatore, produttore, scopritore di talenti, inventore di nuove tendenze, senza mai perdere una coerenza di fondo. A Roma si è presentato alla testa di una band eccezionale completata da Terence Blanchard alla tromba, Lionel Loueke (chitarra), James Genus (basso) e Justin Tyson (batteria). Ascoltare un concerto di Hancock è come rivivere, in sintesi, buona parte della storia del jazz dal momento che questo artista ha sviluppato un’estetica giocata sempre su una sorta di doppio binario: da un canto virtuoso pianista del jazz acustico, dall’altro estimatore se non fondatore del funky elettronico. E questi due aspetti della sua personalità sono apparsi evidenti anche nel concerto romano; così in una prima parte abbiamo ascoltato alcuni classici del jazz come il sempre verde “Footprints” di Wayne Shorter, un altro giovanotto di 89 anni, omaggiato da Hancock che si alternava al piano e alle tastiere non disdegnando un ricorso mai esagerato al vocoder (ma che comunque se non ci fosse stato nulla avrebbe tolto alla validità del concerto). Nella seconda parte Hancock si richiamava al suo coté più funky e chiudeva il concerto con “Chameleon” brano tratto dal celebre album “Head Hunters” del 1973, scatenando l’entusiasmo del pubblico che si è accalcato a ballare sotto il palco.
Il 13, sempre alla Cavea, appuntamento con una vera e propria leggenda del jazz: Herbie Hancock. Spesso si adopera la parola “leggenda” in modo esagerato ma nel caso in questione non v’è dubbio alcuno che il termine sia più che appropriato. Non è questa la sede adatta per sintetizzare un curriculum assolutamente straordinario; basti solo dire che l’artista di Chicago, oggi ottantunenne, ha attraversato, sempre da protagonista, generi e mode come performer, compositore, arrangiatore, produttore, scopritore di talenti, inventore di nuove tendenze, senza mai perdere una coerenza di fondo. A Roma si è presentato alla testa di una band eccezionale completata da Terence Blanchard alla tromba, Lionel Loueke (chitarra), James Genus (basso) e Justin Tyson (batteria). Ascoltare un concerto di Hancock è come rivivere, in sintesi, buona parte della storia del jazz dal momento che questo artista ha sviluppato un’estetica giocata sempre su una sorta di doppio binario: da un canto virtuoso pianista del jazz acustico, dall’altro estimatore se non fondatore del funky elettronico. E questi due aspetti della sua personalità sono apparsi evidenti anche nel concerto romano; così in una prima parte abbiamo ascoltato alcuni classici del jazz come il sempre verde “Footprints” di Wayne Shorter, un altro giovanotto di 89 anni, omaggiato da Hancock che si alternava al piano e alle tastiere non disdegnando un ricorso mai esagerato al vocoder (ma che comunque se non ci fosse stato nulla avrebbe tolto alla validità del concerto). Nella seconda parte Hancock si richiamava al suo coté più funky e chiudeva il concerto con “Chameleon” brano tratto dal celebre album “Head Hunters” del 1973, scatenando l’entusiasmo del pubblico che si è accalcato a ballare sotto il palco. Il 12 luglio una vecchia e cara conoscenza del pubblico romano: John Scofield. Il chitarrista può a ben ragione essere considerato una delle massime espressioni della chitarra jazz degli ultimi decenni. Musicista eclettico, voglioso sempre di sperimentare strade nuove, questa volta si è presentato con un progetto del tutto nuovo, “Yankee Go Home”, con cui torna alle radici del rock americano, riscoprendo classici fra il folk e il rock’n’roll. Accanto a lui Jon Cowherd (pianoforte e tastiere), Vicente Archer (contrabbasso)e Josh Dion (batteria). E’ lo stesso Scofield a illustrare il senso di questo nuovo progetto, non senza elogiare i suoi compagni di viaggio: “L’idea –afferma Scofield – è di coprire successi americani/rock e canzoni folk jazz, più alcuni dei miei brani originali scritti in quel modo. Mi sto riconnettendo con molte delle mie radici Rock ‘n Roll da adolescente, naturalmente colorate dai miei 50 anni di pratica Jazz…. Questi ragazzi sono straordinariamente versatili, altrettanto bravi quando si tratta di suonare in modo interattivo e creativo. Stiamo esplorando rock, funk, country, jazz e musica libera e ci divertiamo moltissimo. Sono entusiasta di questa collaborazione”. Risultato raggiunto? Assolutamente sì; il repertorio, comprendente brani tra gli altri di Bob Dylan, Neil Young, Grateful Dead, B.B. King, Buddy Holly, viene declinato attraverso quella maestria strumentale che ben conosciamo oramai da tanti anni. Scofield è sempre lì a tessere le fila del discorso, con un solismo preciso, elegante, raffinato mai soverchiante cosicché tutti i suoi compagni di viaggio hanno la possibilità di mettersi in luce. I vari pezzi vengono riletti alla luce di quelle esperienze cui lo stesso Scofield faceva riferimento ridando loro una sorta di nuova linfa e il pubblico dimostra di apprezzare con lunghi appalusi a scena aperta. Immancabile il bis: un coinvolgente blues che evidenzia come Scofield rimanga solidamente ancorato anche alle radici della musica afro-americana.
Il 12 luglio una vecchia e cara conoscenza del pubblico romano: John Scofield. Il chitarrista può a ben ragione essere considerato una delle massime espressioni della chitarra jazz degli ultimi decenni. Musicista eclettico, voglioso sempre di sperimentare strade nuove, questa volta si è presentato con un progetto del tutto nuovo, “Yankee Go Home”, con cui torna alle radici del rock americano, riscoprendo classici fra il folk e il rock’n’roll. Accanto a lui Jon Cowherd (pianoforte e tastiere), Vicente Archer (contrabbasso)e Josh Dion (batteria). E’ lo stesso Scofield a illustrare il senso di questo nuovo progetto, non senza elogiare i suoi compagni di viaggio: “L’idea –afferma Scofield – è di coprire successi americani/rock e canzoni folk jazz, più alcuni dei miei brani originali scritti in quel modo. Mi sto riconnettendo con molte delle mie radici Rock ‘n Roll da adolescente, naturalmente colorate dai miei 50 anni di pratica Jazz…. Questi ragazzi sono straordinariamente versatili, altrettanto bravi quando si tratta di suonare in modo interattivo e creativo. Stiamo esplorando rock, funk, country, jazz e musica libera e ci divertiamo moltissimo. Sono entusiasta di questa collaborazione”. Risultato raggiunto? Assolutamente sì; il repertorio, comprendente brani tra gli altri di Bob Dylan, Neil Young, Grateful Dead, B.B. King, Buddy Holly, viene declinato attraverso quella maestria strumentale che ben conosciamo oramai da tanti anni. Scofield è sempre lì a tessere le fila del discorso, con un solismo preciso, elegante, raffinato mai soverchiante cosicché tutti i suoi compagni di viaggio hanno la possibilità di mettersi in luce. I vari pezzi vengono riletti alla luce di quelle esperienze cui lo stesso Scofield faceva riferimento ridando loro una sorta di nuova linfa e il pubblico dimostra di apprezzare con lunghi appalusi a scena aperta. Immancabile il bis: un coinvolgente blues che evidenzia come Scofield rimanga solidamente ancorato anche alle radici della musica afro-americana. La band inizia a suonare senza presentare alcunché; McCraven è uomo di poche parole, e non si concede quasi mai pause, tranne una ogni tre pezzi circa per presentare e ringraziare la sua band e per annunciare – qualche volta – il nome del prossimo pezzo. Per il resto è stata una serata di pura musica ed energia: non solo di McCraven, il cui vigore era pari alla sua abilità – mai sentito un batterista che suonasse per circa un’ora e mezza, senza mai smettere di percuotere pelli e piatti con tanta ininterrotta energia – ma anche di tutti gli altri musicisti, che durante il concerto si cimentavano con diversi tipi di percussioni. Altra nota di merito va alla varietà di brani suonati: si passa da pezzi ormai diventati standard del jazz, come “Autumn in New York”, Frank’s Tune” di Frank Strzier o “A Slice of the Top” a pezzi originali di McCraven, come “In These Times”, “The Bounce!” e un inedito tratto dal suo prossimo album in uscita a settembre.
La band inizia a suonare senza presentare alcunché; McCraven è uomo di poche parole, e non si concede quasi mai pause, tranne una ogni tre pezzi circa per presentare e ringraziare la sua band e per annunciare – qualche volta – il nome del prossimo pezzo. Per il resto è stata una serata di pura musica ed energia: non solo di McCraven, il cui vigore era pari alla sua abilità – mai sentito un batterista che suonasse per circa un’ora e mezza, senza mai smettere di percuotere pelli e piatti con tanta ininterrotta energia – ma anche di tutti gli altri musicisti, che durante il concerto si cimentavano con diversi tipi di percussioni. Altra nota di merito va alla varietà di brani suonati: si passa da pezzi ormai diventati standard del jazz, come “Autumn in New York”, Frank’s Tune” di Frank Strzier o “A Slice of the Top” a pezzi originali di McCraven, come “In These Times”, “The Bounce!” e un inedito tratto dal suo prossimo album in uscita a settembre. Il 23 la Casa de Jazz proponeva un quesito intrigante: può la sofisticata poetica di un Pieranunzi coniugarsi con l’incredibile carica energetica di Antonello Salis? In altri termini possono coesistere due musicisti stilisticamente quasi all’opposto, uniti solo dalla grande passione e dedizione alla musica? Ciò perché il concerto in programma prevedeva per l’appunto un duo di piano composto da questi due artisti che mai avevano avuto modo di incontrarsi sul palco. Grande attesa, quindi, e non a caso grande affluenza di pubblico…ripagato da un concerto sicuramente interessante. Seduti l’uno di fronte all’altro i due hanno suonato per circa un’ora e mezza sciorinando un’intesa che non era facile prevedere. Spesso si partiva da un tema che veniva sviluppato, esaminato, sviscerato fin nelle sue più intime pieghe e quindi riproposto in una veste totalmente diversa che traeva nelle capacità improvvisative dei due nuova linfa vitale. E questa volta non si può dire che l’uno si sia piegato alle esigenze dell’altro in quanto ambedue hanno sviluppato appieno le proprie tematiche che finivano con l’incontrarsi su un terreno ben frequentato sia da Enrico sia da Antonello: l’improvvisazione pura o forse meglio la capacità di creare musica strada facendo. In effetti, oltre che partire da un dato tema, i due si sono spesso avventurati anche sul foglio bianco, vale a dire cominciando a suonare senza conoscere il punto di approdo, con una maestria che solo pochi posseggono.
Il 23 la Casa de Jazz proponeva un quesito intrigante: può la sofisticata poetica di un Pieranunzi coniugarsi con l’incredibile carica energetica di Antonello Salis? In altri termini possono coesistere due musicisti stilisticamente quasi all’opposto, uniti solo dalla grande passione e dedizione alla musica? Ciò perché il concerto in programma prevedeva per l’appunto un duo di piano composto da questi due artisti che mai avevano avuto modo di incontrarsi sul palco. Grande attesa, quindi, e non a caso grande affluenza di pubblico…ripagato da un concerto sicuramente interessante. Seduti l’uno di fronte all’altro i due hanno suonato per circa un’ora e mezza sciorinando un’intesa che non era facile prevedere. Spesso si partiva da un tema che veniva sviluppato, esaminato, sviscerato fin nelle sue più intime pieghe e quindi riproposto in una veste totalmente diversa che traeva nelle capacità improvvisative dei due nuova linfa vitale. E questa volta non si può dire che l’uno si sia piegato alle esigenze dell’altro in quanto ambedue hanno sviluppato appieno le proprie tematiche che finivano con l’incontrarsi su un terreno ben frequentato sia da Enrico sia da Antonello: l’improvvisazione pura o forse meglio la capacità di creare musica strada facendo. In effetti, oltre che partire da un dato tema, i due si sono spesso avventurati anche sul foglio bianco, vale a dire cominciando a suonare senza conoscere il punto di approdo, con una maestria che solo pochi posseggono. Guidati dal funambolico sassofonista Shabaka Hutchings, il quartetto (completato dal basso tuba di Theon Cross e ben due batterie nelle mani di Eddie Hick e della giovanissima e bravissima Jas Keyser in sostituzione di Tom Skinner in tour con Thom Yorke) ha sciorinato una musica di grande intensità, basata sul fitto tappeto ritmico intessuto dalle due batterie su cui svolgevano i loro interventi i due fiati. In particolare il sax del leader, spesso effettato con delay o reverberi, non disegnava lunghe linee melodiche ma intonava frasi ritmiche e frammenti melodici ripetuti più volte mentre il basso tuba contribuiva in maniera determinante a completare il tessuto ritmico delle due batterie. Il tutto ‘condito’ da un volume molto, molto elevato a creare una musica che raggiungesse l’obiettivo di portare al massimo l’eccitazione dell’uditorio e di coinvolgerlo in una sorta di rito collettivo in cui i richiami all’Africa erano ben evidenti. Si tenga presente che il concerto si è sviluppato su una linea di continuità ininterrotta tranne due momenti in cui Shabaka Hutchings ha imbracciato un flauto di legno per intonare una splendida melodia di origine africana e il tubista si è espresso in solitudine. Obiettivo raggiunto? Quanto al coinvolgimento direi proprio di sì… anche se non al cento per cento. Nel senso che, ad esempio, il vostro cronista non si è sentito coinvolto dalla musica dei Sons of Kemet. Ed il perché non è difficile da spiegare: avendo avuto la fortuna di ascoltare anche dal vivo alcuni dei più grandi musicisti – per intenderci quelli che hanno scritto davvero la storia del jazz – non è facile lasciarsi impressionare da qualcuno che pur suonando bene non raggiunge quei vertici cui prima si faceva riferimento. Quanto ai messaggi che questa musica così aggressiva intende veicolare, ci viene in soccorso lo stesso Shabaka Hutchings affermando che “Black to the Future (ultimo album del gruppo) è un poema sonoro di invocazione del potere, del ricordo e della guarigione. Raffigura un movimento, quello della ridefinizione e riaffermazione di cosa significa lottare per il black power”. Ma anche sotto questo aspetto non riusciamo a vedere una grande novità dal momento che il jazz come musica di protesta non è certo cosa di oggi.
Guidati dal funambolico sassofonista Shabaka Hutchings, il quartetto (completato dal basso tuba di Theon Cross e ben due batterie nelle mani di Eddie Hick e della giovanissima e bravissima Jas Keyser in sostituzione di Tom Skinner in tour con Thom Yorke) ha sciorinato una musica di grande intensità, basata sul fitto tappeto ritmico intessuto dalle due batterie su cui svolgevano i loro interventi i due fiati. In particolare il sax del leader, spesso effettato con delay o reverberi, non disegnava lunghe linee melodiche ma intonava frasi ritmiche e frammenti melodici ripetuti più volte mentre il basso tuba contribuiva in maniera determinante a completare il tessuto ritmico delle due batterie. Il tutto ‘condito’ da un volume molto, molto elevato a creare una musica che raggiungesse l’obiettivo di portare al massimo l’eccitazione dell’uditorio e di coinvolgerlo in una sorta di rito collettivo in cui i richiami all’Africa erano ben evidenti. Si tenga presente che il concerto si è sviluppato su una linea di continuità ininterrotta tranne due momenti in cui Shabaka Hutchings ha imbracciato un flauto di legno per intonare una splendida melodia di origine africana e il tubista si è espresso in solitudine. Obiettivo raggiunto? Quanto al coinvolgimento direi proprio di sì… anche se non al cento per cento. Nel senso che, ad esempio, il vostro cronista non si è sentito coinvolto dalla musica dei Sons of Kemet. Ed il perché non è difficile da spiegare: avendo avuto la fortuna di ascoltare anche dal vivo alcuni dei più grandi musicisti – per intenderci quelli che hanno scritto davvero la storia del jazz – non è facile lasciarsi impressionare da qualcuno che pur suonando bene non raggiunge quei vertici cui prima si faceva riferimento. Quanto ai messaggi che questa musica così aggressiva intende veicolare, ci viene in soccorso lo stesso Shabaka Hutchings affermando che “Black to the Future (ultimo album del gruppo) è un poema sonoro di invocazione del potere, del ricordo e della guarigione. Raffigura un movimento, quello della ridefinizione e riaffermazione di cosa significa lottare per il black power”. Ma anche sotto questo aspetto non riusciamo a vedere una grande novità dal momento che il jazz come musica di protesta non è certo cosa di oggi. Smaltita la sbornia dell’“Afrofuturism” (così viene definita la musica di Sons of Kemet da chi se ne intende), ecco il 27 sempre alla Casa del Jazz, la giovane e brava sassofonista Nubya Garcia, reduce dallo straordinario successo ottenuto dal suo primo album “Source” su etichetta Concord. Bel concerto questo con una musica sì proiettata verso il futuro ma sempre memore di ciò che il jazz ha rappresentato fino ad oggi. Anche la Garcia viene fuori dalla tumultuosa scena londinese di questi ultimi anni affermandosi passo dopo passo come una delle strumentiste più preparate e fantasiose del pur vasto panorama. In effetti Nubya frequenta il sax da tanti anni riuscendo così a raggiungere una tecnica tutt’altro che banale, una tecnica comunque sempre messa al servizio dell’espressività e di una concezione musicale fortemente inclusiva dal momento che nelle sue performances sono ben riscontrabili echi di jazz spirituale, dub, reggae, ritmi latini e suoni africani. Così il concerto si è sviluppato lungo modalità contrassegnate da notevoli assolo non solo della leader ma anche del pianista-tastierista Alastair MacSween mentre la sezione ritmica (Daniel Casimir contrabbasso e Sam Jones batteria) forniva un supporto sempre preciso, puntuale, propositivo. E a proposito di ritmo, da sottolineare la sensualità dei ritmi colombiani rinverdita dalla Nubya nella riproposizione di uno dei brani più riusciti dell’intera serata, “La Cumbia Me Está Llamando”, scritta con il trio colombiano al femminile “La Perla”.
Smaltita la sbornia dell’“Afrofuturism” (così viene definita la musica di Sons of Kemet da chi se ne intende), ecco il 27 sempre alla Casa del Jazz, la giovane e brava sassofonista Nubya Garcia, reduce dallo straordinario successo ottenuto dal suo primo album “Source” su etichetta Concord. Bel concerto questo con una musica sì proiettata verso il futuro ma sempre memore di ciò che il jazz ha rappresentato fino ad oggi. Anche la Garcia viene fuori dalla tumultuosa scena londinese di questi ultimi anni affermandosi passo dopo passo come una delle strumentiste più preparate e fantasiose del pur vasto panorama. In effetti Nubya frequenta il sax da tanti anni riuscendo così a raggiungere una tecnica tutt’altro che banale, una tecnica comunque sempre messa al servizio dell’espressività e di una concezione musicale fortemente inclusiva dal momento che nelle sue performances sono ben riscontrabili echi di jazz spirituale, dub, reggae, ritmi latini e suoni africani. Così il concerto si è sviluppato lungo modalità contrassegnate da notevoli assolo non solo della leader ma anche del pianista-tastierista Alastair MacSween mentre la sezione ritmica (Daniel Casimir contrabbasso e Sam Jones batteria) forniva un supporto sempre preciso, puntuale, propositivo. E a proposito di ritmo, da sottolineare la sensualità dei ritmi colombiani rinverdita dalla Nubya nella riproposizione di uno dei brani più riusciti dell’intera serata, “La Cumbia Me Está Llamando”, scritta con il trio colombiano al femminile “La Perla”.
 Jon Balke Siwan – “Hafla” – ECM
Jon Balke Siwan – “Hafla” – ECM Flavio Boltro, Fabio Giachino – “Things to Say” – Cam Jazz
Flavio Boltro, Fabio Giachino – “Things to Say” – Cam Jazz Avishai Cohen – “Naked Truth” – ECM
Avishai Cohen – “Naked Truth” – ECM Claudio Cojaniz – “Orfani” – Caligola
Claudio Cojaniz – “Orfani” – Caligola Lorenzo De Finti Quartet – “Mysterium Lunae” – Losen
Lorenzo De Finti Quartet – “Mysterium Lunae” – Losen Joey DeFrancesco – “More Music” – Mack Avenue
Joey DeFrancesco – “More Music” – Mack Avenue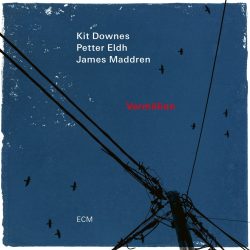 Kit Downes – “Vermillion” – ECM
Kit Downes – “Vermillion” – ECM Mathias Eick – “When We Leave” – ECM
Mathias Eick – “When We Leave” – ECM Antonio Flinta – “Secrets of a Kiri Tree” – Autoprod.
Antonio Flinta – “Secrets of a Kiri Tree” – Autoprod. Tord Gustavsen – “Opening” – ECM
Tord Gustavsen – “Opening” – ECM Roberto Laneri – “Musica finta / Blue Prints” – Da Vinci Classics
Roberto Laneri – “Musica finta / Blue Prints” – Da Vinci Classics “South of No Border” (come si diceva registrato tra il 2014 e il 2018 ma anch’esso pubblicato poche settimane fa) vede Roberto Laneri (clarinetto, clarinetto basso, sax sopranino, sax soprano e alto, didjeridoo, shruti box, voce e percussioni) alla testa di un gruppo comprendente Giuppi Paone voce, Raffaela Siniscalchi voce, Eleonora Vulpiani chitarra, Luigi Polsini contrabbasso e Laugi Marino zarb. Contrariamente al primo album, in questo caso il repertorio è come una sorta di finestra affacciata sulle musiche del mondo. Ecco, quindi, dopo l’apertura affidata alle melodie orientaleggianti di “Malia” (scritta da Laneri), il choro brasiliano “Tico-Tico no fubá” (scritto da Zequinha de Abreu nel 1917, accanto al bolero cubano “Contigo En La Distancia” scritto dal cantautore César Portillo de la Luz quando aveva 24 anni nel 1946, il tutto impreziosito da 4 original del leader. A confronto con un tale repertorio, Laneri dà ancora una volta prova non solo della sua indiscussa preparazione tecnica ma anche della profonda conoscenza del panorama musicale internazionale. Le sue interpretazioni risultano, quindi, assolutamente pertinenti: traendo feconda ispirazione da svariate tradizioni, riesce a produrre una sintesi che non conosce confini geografici grazie ad una concezione visionaria della musica senza barriere. Insomma un disco originale nella concezione e nell’esecuzione.
“South of No Border” (come si diceva registrato tra il 2014 e il 2018 ma anch’esso pubblicato poche settimane fa) vede Roberto Laneri (clarinetto, clarinetto basso, sax sopranino, sax soprano e alto, didjeridoo, shruti box, voce e percussioni) alla testa di un gruppo comprendente Giuppi Paone voce, Raffaela Siniscalchi voce, Eleonora Vulpiani chitarra, Luigi Polsini contrabbasso e Laugi Marino zarb. Contrariamente al primo album, in questo caso il repertorio è come una sorta di finestra affacciata sulle musiche del mondo. Ecco, quindi, dopo l’apertura affidata alle melodie orientaleggianti di “Malia” (scritta da Laneri), il choro brasiliano “Tico-Tico no fubá” (scritto da Zequinha de Abreu nel 1917, accanto al bolero cubano “Contigo En La Distancia” scritto dal cantautore César Portillo de la Luz quando aveva 24 anni nel 1946, il tutto impreziosito da 4 original del leader. A confronto con un tale repertorio, Laneri dà ancora una volta prova non solo della sua indiscussa preparazione tecnica ma anche della profonda conoscenza del panorama musicale internazionale. Le sue interpretazioni risultano, quindi, assolutamente pertinenti: traendo feconda ispirazione da svariate tradizioni, riesce a produrre una sintesi che non conosce confini geografici grazie ad una concezione visionaria della musica senza barriere. Insomma un disco originale nella concezione e nell’esecuzione. Roberto Magris – “Match Point” – JMood / Roberto Magris – “Duo & Trio” – JMood
Roberto Magris – “Match Point” – JMood / Roberto Magris – “Duo & Trio” – JMood Dino & Franco Piana Ensemble – “Reflections” –Alfa Music
Dino & Franco Piana Ensemble – “Reflections” –Alfa Music Valentina Ranalli, Enrico Pieranunzi – “Cantare Pieranunzi” – Alfa Music
Valentina Ranalli, Enrico Pieranunzi – “Cantare Pieranunzi” – Alfa Music Completamente diverso il secondo album – “The Extra Something” – registrato live il 13 e 14 gennaio 2016 al Village Vanguard da un quintetto che vedeva il pianista romano in compagnia di Diego Urcola tromba e trombone (semplicemente straordinario nella title tracke), Seamus Blake sax tenore (particolarmente convincente in “Atoms”), Ben Street basso e Adam Cruz batteria. E per quanti seguono il jazz non c’è bisogno di altre parole per sottolineare il valore assoluto della band. Valore assoluto che si evidenzia in tutto il repertorio, sette brani tutti composti dal pianista. Pieranunzi, come spesso gli capita, è in uno stato di grazie e conduce il gruppo con mano sicura, del tutto consapevole dell’intesa che ha raggiunto con i compagni di viaggio. Dal punto di vista compositivo non scopriamo certo oggi il suo senso della struttura che mai l’abbandona, per cui se consideriamo tutti questi elementi si capisce bene perché il ben noto Brian Morton abbia incluso Enrico tra “i più significativi musicisti contemporanei”. Nelle note di copertina Pieranunzi dedica espressamente questo terzo CD Live at The Village Vanguard a Lorraine Gordon in memoriam, senza la quale né questo né i precedenti due si sarebbero potuti realizzare. Ricordiamo per inciso che il pianista romano è forse l’unico musicista italiano nella veste di leader ed uno dei pochissimi europei ad aver suonato nel leggendario jazz club a forma di diamante aperto da Max Gordon nel 1935 al 178 Seventh Avenue South di Manhattan.
Completamente diverso il secondo album – “The Extra Something” – registrato live il 13 e 14 gennaio 2016 al Village Vanguard da un quintetto che vedeva il pianista romano in compagnia di Diego Urcola tromba e trombone (semplicemente straordinario nella title tracke), Seamus Blake sax tenore (particolarmente convincente in “Atoms”), Ben Street basso e Adam Cruz batteria. E per quanti seguono il jazz non c’è bisogno di altre parole per sottolineare il valore assoluto della band. Valore assoluto che si evidenzia in tutto il repertorio, sette brani tutti composti dal pianista. Pieranunzi, come spesso gli capita, è in uno stato di grazie e conduce il gruppo con mano sicura, del tutto consapevole dell’intesa che ha raggiunto con i compagni di viaggio. Dal punto di vista compositivo non scopriamo certo oggi il suo senso della struttura che mai l’abbandona, per cui se consideriamo tutti questi elementi si capisce bene perché il ben noto Brian Morton abbia incluso Enrico tra “i più significativi musicisti contemporanei”. Nelle note di copertina Pieranunzi dedica espressamente questo terzo CD Live at The Village Vanguard a Lorraine Gordon in memoriam, senza la quale né questo né i precedenti due si sarebbero potuti realizzare. Ricordiamo per inciso che il pianista romano è forse l’unico musicista italiano nella veste di leader ed uno dei pochissimi europei ad aver suonato nel leggendario jazz club a forma di diamante aperto da Max Gordon nel 1935 al 178 Seventh Avenue South di Manhattan. Serena Spedicato – “Io che amo solo te” – Dodicilune
Serena Spedicato – “Io che amo solo te” – Dodicilune Andrés Thor – Hereby – Losen
Andrés Thor – Hereby – Losen Mark Turner – “Return From The Stars” – ECM
Mark Turner – “Return From The Stars” – ECM Cristina Zavalloni – “Parlami di me” – Egea
Cristina Zavalloni – “Parlami di me” – Egea




