da Gerlando Gatto | 05/Ago/2023 | Fotoreportage, I nostri Eventi, News, Primo piano, Recensioni
Dopo aver assistito alle ultime giornate di Udine Jazz 2023 mi sono vieppiù radicato nel convincimento che il Festival friulano, che vede da 33 anni alla direzione artistica Giancarlo Velliscig, sia oggi uno dei pochi ad aver veramente diritto di cittadinanza nell’universo festivaliero che oramai da anni accompagna l’estate degli italiani dalle Alpi alla Sicilia.
I perché sono molteplici: innanzitutto il giusto peso dato ai musicisti italiani e friulani in particolare; in secondo luogo, il tentativo, spesso riuscito, di allargare i confini del discorso oltre i limiti strettamente musicali per approdare a tematiche di carattere sociale che interessano anche chi di musica poco si occupa. E’ stato questo, ad esempio, il caso della mattinata dedicata al problema del rapporto tra jazz e donna approdato rapidamente alla più larga tematica del rapporto tra donna e mondo del lavoro.
Ciò, ovviamente, senza alcunché togliere alla qualità della musica che si è mantenuta su livelli più che buoni con punte di assoluta eccellenza. Tra queste punte va annoverato senza dubbio alcuno il concerto del quintetto ‘Eternal Love’ di Roberto Ottaviano al sax soprano con Marco Colonna ai clarinetti, Alexander Hawkins al pianoforte, Giovanni Majer al contrabbasso e Zeno De Rossi alla batteria. L’occasione mi è particolarmente gradita per ribadire un concetto che porto avanti oramai da tanti anni: Ottaviano è uno dei più grandi musicisti che il panorama jazzistico internazionale possa oggi vantare e che quindi non ha raccolto tutto ciò che effettivamente merita.
-

-
Ottaviano Eternal Love 5et – U&J 2023 – ph.A.Salvin
-

-
Ottaviano Eternal Love 5et – U&J 2023 – ph.A.Salvin
-

-
Ottaviano Eternal Love 5et – U&J 2023 – ph.A.Salvin
-

-
Ottaviano Eternal Love 5et – U&J 2023 – ph.A.Salvin
-

-
Ottaviano Eternal Love 5et – U&J 2023 – ph.A.Salvin
-

-
Ottaviano Eternal Love 5et – U&J 2023 – ph.A.Salvin
-

-
Ottaviano Eternal Love 5et – U&J 2023 – ph.A.Salvin
-

-
Ottaviano Eternal Love 5et – U&J 2023 – ph.A.Salvin
-

-
Ottaviano Eternal Love 5et – U&J 2023 – ph.A.Salvin
Quest’ultimo lavoro, presentato anche a Udine, lo conferma appieno: Ottaviano, prendendo spunto dalla spaventosa realtà che ci circonda, caratterizzata da intolleranza, flussi migratori che non si fermano, guerre assurde si rivolge alla musica e alla sua capacità di accomunare anziché dividere, per innalzare un sentito omaggio alla spiritualità africana e lo fa rileggendo con autentica passione le musiche di Don Cherry, Charlie Haden, John Coltrane e Dewey Redman. Ma attenzione, nelle interpretazioni di Ottaviano, nulla c’è di calligrafico: il musicista pugliese è in grado di rileggere queste storiche partiture facendole proprie e quindi rivitalizzandole alla luce di un’esperienza di molti, molti anni, in ciò perfettamente coadiuvato da un gruppo che funziona magnificamente, in cui ogni segmento sonoro si incastra alla perfezione nel puzzle magnificamente ideato dal leader.
Le positive sensazioni lasciatemi dal concerto di Ottaviano sono state ribadite, ma con alcuni distinguo, poche ore più tardi dal concerto di Matteo Mancuso in trio con Stefano India al basso elettrico e Giuseppe Bruno alla batteria. Siciliano, classe 1996, figlio d’arte, Matteo è considerato l’enfant prodige della chitarra jazz italiana ed in effetti presenta una tecnica davvero straordinaria. Ma ovviamente ciò non basta per fare di un buon musicista, un vero artista: ci vuole ben altro. Ed in effetti l’inizio del concerto non mi aveva convinto dato l’impianto sonoro più vicino ai concerti pop-rock che non a quelli jazz. Poi il giovane chitarrista ha rotto gli indugi ed ha presentato una bellissima versione di ‘Black Market’ che ha spinto gli astanti a tributargli una vera e propria ovazione.
-

-
Matteo Mancuso U&J 2023 – ph. A.Salvin
-

-
Matteo Mancuso U&J 2023 – ph. A.Salvin
-

-
Matteo Mancuso U&J 2023 – ph. A.Salvin
-

-
Matteo Mancuso U&J 2023 – ph. A.Salvin
-

-
Matteo Mancuso U&J 2023 – ph. A.Salvin
-

-
Matteo Mancuso U&J 2023 – ph. A.Salvin
-

-
Matteo Mancuso U&J 2023 – ph. A.Salvin
-

-
Matteo Mancuso U&J 2023 – ph. A.Salvin
-

-
Matteo Mancuso U&J 2023 – ph. A.Salvin
Ora, come si diceva, Mancuso è sostanzialmente agli inizi ma le premesse sono più che buone: adesso dovrà dimostrare non solo di avere una digitazione velocissima, ma soprattutto di far muovere quelle dite secondo idee ben precise (come in “Black Market”) e di essere capace di scrivere e arrangiare in maniera acconcia. Insomma, lo aspettiamo con curiosità a prove più impegnative.
Il giorno dopo di scena un altro artista siciliano ma oramai udinese d’azione: il pianista Dario Carnovale con Lorenzo Conte al contrabbasso, Sasha Mashin alla batteria e Flavio Boltro alla tromba. L’incontro tra uno dei migliori trombettisti italiani ed un pianista eclettico, talentuoso, prorompente come Carnovale prometteva scintille… e così è stato. Alternando pezzi originali a brani ben conosciuti il gruppo ha entusiasmato il numeroso pubblico presente.
-

-
Dario Carnovale feat Flavio Boltro – U&J 2023 – ph.A.Salvin
-

-
Dario Carnovale feat Flavio Boltro – U&J 2023 – ph.A.Salvin
-

-
Dario Carnovale feat Flavio Boltro – U&J 2023 – ph.A.Salvin
-

-
Dario Carnovale feat Flavio Boltro – U&J 2023 – ph.A.Salvin
-

-
Dario Carnovale feat Flavio Boltro – U&J 2023 – ph.A.Salvin
-

-
Il direttore di A Proposito di Jazz, Gerlando Gatto a U&J 2023 – ph.A.Salvin
Definire il loro stile non è impresa facile, ammesso poi che sia così importante. Comunque, per dare solo un’idea anche a chi non ha visto il concerto, si potrebbe dire che la loro musica si inserisce nell’alveo di un moderno main stream ora ricco di lirismo ora carico di coinvolgente energia. Ovviamente merito della bella riuscita del concerto è sicuramente dei due leader…ma anche della sezione ritmica con un Conte cha ha fatto capire a tutti perché ha suonato accanto a mostri sacri quali Art Farmer, Bob Sheppard e Enrico Rava mentre il batterista russo Sasha Mashin si è confermato uno dei musicisti più interessanti a livello europeo.
In serata tutti al Castello per la serata brasiliana accolta, more solito, con favore dal numeroso pubblico e preceduta in mattinata da una dotta conversazione sulla musica brasiliana guidata da Max De Tomassi, conduttore di Radio1RAi e vero esperto della materia. Due gli appuntamenti in programma. Dapprima si presenta sul palco per l’atteso solo-piano Amaro Freitas indossando un improbabile completino da spiaggia che avrebbe fatto invidia ai miei amici di Capalbio. Comunque, abbigliamento a parte, Freitas ha confermato le attese di quanti vedono in lui il nuovo esponente dell’odierno jazz brasiliano. Dotato di un’energia prorompente, che comunque riesce a dosare grazie ad un approfondito studio sullo strumento, Freitas si lascia andare ad una serie di improvvisazioni, molto giocate sul lato percussivo, che catturano l’attenzione dell’ascoltatore, preso per mano e condotto alla scoperta della storia e della filosofia della gente brasiliana attraverso la musica. In effetti obiettivo del nuovo lavoro del pianista – “Sankofa” – presentato a Udine è proprio quello – per esplicita ammissione dello stesso Freitas – di “capire i miei antenati, il mio posto, la mia storia come uomo di colore”.
-

-
Amaro Freitas U&J 2023 ph.A.Salvin
-

-
Amaro Freitas U&J 2023 ph.A.Salvin
-

-
Amaro Freitas U&J 2023 ph.A.Salvin
-

-
Amaro Freitas U&J 2023 ph.A.Salvin
-

-
Amaro Freitas U&J 2023 ph.A.Salvin
-

-
Amaro Freitas U&J 2023 ph.A.Salvin
-

-
Amaro Freitas U&J 2023 ph.A.Salvin
C’è riuscito? Onestamente non posso dirlo in questa sede ma se avremo occasione di intervistarlo glielo chiederò; quel che è certo è che Freitas continua ad evolversi stilisticamente parlando e a rendere il suo discorso sempre più convincente e coinvolgente. A quest’ultimo proposito bella la conclusione del concerto con un brano dolce dedicato alla mamma che è stato supportato dal coro di tutto il pubblico.
Completamente diverso il discorso sul secondo concerto che vedeva sul palco una vera e propria icona non solo della musica brasiliana ma della musica in generale: Eliane Elias pianoforte e voce con accanto il compagno di vita nonché personaggio di assoluto rilievo nel mondo del jazz, Marc Johnson al contrabbasso, Leandro Pellegrino alla chitarra e Rafael Barata alla batteria. Per introdurre la Elias a quei pochi che ancora non la conoscessero, basti dire che nel 2022 ha vinto il Grammy come Miglior Album Latin Jazz con “Mirror Mirror” straordinario album di duetti con Chick Corea e Chucho Valdes. A Udine la Elias ha sciorinato solo una piccolissima parte del suo vastissimo repertorio facendo intendere come l’appellativo di “The Bossa Queen” sia ancora oggi più che meritato.
-

-
Eliane Elias U&J 2023 – ph. A.Salvin
-

-
Eliane Elias U&J 2023 – ph. A.Salvin
-

-
Eliane Elias U&J 2023 – ph. A.Salvin
-

-
Eliane Elias U&J 2023 – ph. A.Salvin
-

-
Eliane Elias U&J 2023 – ph. A.Salvin
-

-
Eliane Elias U&J 2023 – ph. A.Salvin
La classe esecutiva rimane cristallina mentre il vocale denuncia qualche piccola crepa che non inficia la bontà della performance impreziosita anche dall’altissimo livello degli altri componenti il quartetto. Tra questi assolutamente strabiliante il batterista Rafael Barata con la Elias da oltre dieci anni ma anche con Dianne Reeves e Jaques Morelenbaum. Barata è davvero fenomenale per come riesce a tenere in mano le redini del flusso ritmico che rimane costante per tutta la durata del concerto senza un attimo di stanca, senza che mai si avverta una qualche sensazione di vuoto o di scansione men che perfetta. Risultato: alla fine del concerto pubblico in piedi e meritatissima ovazione.
Il 16 al Giangio Garden Parco Brun esibizione del “Green Tea in Fusion” al secolo Franco Fabris Fender Rhodes e synth, Gianni Iardino sax alto e soprano, flauto, synth, Maurizio Fabris percussioni e vocale e Pietro Liut basso elettrico. Il quartetto, costituito nel 2022, ha già al suo attivo ben due CD e a quanto ci risulta è già in lavorazione il terzo. Il gruppo sta assumendo sempre più visibilità e consensi grazie ad una proposta musicale di livello caratterizzata da una raffinata ricerca melodica e da un impianto ritmico tutt’altro che banale.
-

-
GreenTea inFusion+ Massimiliano Gosparini U&J 2023 – ph. A.Salvin
-

-
GreenTea inFusion+ Massimiliano Gosparini U&J 2023 – ph. A.Salvin
-

-
GreenTea inFusion+ Massimiliano Gosparini U&J 2023 – ph. A.Salvin
-

-
GreenTea inFusion+ Massimiliano Gosparini U&J 2023 – ph. A.Salvin
-

-
GreenTea inFusion+ Massimiliano Gosparini U&J 2023 – ph. A.Salvin
-

-
GreenTea inFusion+ Massimiliano Gosparini U&J 2023 – ph. A.Salvin
Questi elementi assumono ancora maggior forza ove si tenga conto che il repertorio è composto unicamente da pezzi originali che ben arrangiati danno la possibilità ai singoli (tutti musicisti esperti eccezion fatta per il giovane ma bravissimo bassista) di evidenziare le proprie potenzialità. Con specifico riferimento al concerto di Udine, la musica è entrata in connessione con la performance di action painting dell’artista Massimiliano Gosparini che ha prodotto una bella tela donata al gruppo alla fine del concerto.
In serata, in piazza della Libertà, quella che io considero la più bella sorpresa del Festival: organizzata da Cinemazero, la proiezione del film muto “The Freshman – Viva lo sport” diretto da Sam Taylor e Fred Newmeyer, con Harold Lloyd e la colonna sonora eseguita dal vivo dalla Zerorchestra. Per quanto mi riguarda è stato sinceramente emozionante vedere scorrere sullo schermo le immagini di un bel film magnificamente commentate da una splendida orchestra tutta costituita da musicisti del Triveneto, tra cui Mirko Cisilino tromba e trombone, Francesco Bearzatti sax tenore, Luca Colussi batteria, Juri Dal Dan piano, Luca Grizzo percussioni.
-

-
Zerorchestra – U&J 2023 – ph. A.Salvin
-

-
Zerorchestra – U&J 2023 – ph. A.Salvin
-

-
Zerorchestra – U&J 2023 – ph. A.Salvin
-

-
Zerorchestra – U&J 2023 – ph. A.Salvin
-

-
Zerorchestra – U&J 2023 – ph. A.Salvin
-

-
Zerorchestra – U&J 2023 – ph. A.Salvin
La Zerorchestra nasce su iniziativa di Cinamezero, in occasione del centenario della nascita del cinema, come laboratorio per la scrittura di nuove partiture musicali per quelle pellicole che rappresentano il repertorio del cinema muto spesso ignorate dal grande pubblico. Io non so se il risultato è sempre pari a questo di Udine, non so se sia meglio l’orchestra nascosta agli occhi del pubblico o viceversa…quel che so è che a Udine la serata è stata davvero unica, magnifica, merito, a mio avviso, soprattutto dell’orchestra che ha saputo cogliere come meglio non si potrebbe gli stati d’animo dei personaggi. Di qui interventi solistici sempre acconci, misurati, pertinenti mentre i pieni orchestrali suggellano alcuni dei passaggi più significativi del film.
Il 17 luglio si apre, a Casa Cavazzini Museo di Arte Moderna, con un duo di improvvisazione totale costituito da Massimo De Mattia al flauto e Giorgio Pacorig al pianoforte. Devo confessare che la musica totalmente improvvisata non è di certo in cima ai miei gusti ma, ciononostante, Massimo De Mattia rientra tra i miei musicisti preferiti. Il perché non è facilissimo da spiegare: la sua musica mi soddisfa, ogni volta che la ascolto sento come se il flusso della vita moderna con le sue insidie, le sue mille sfaccettature, i suoi dolori, le sue gioie fossero racchiuse nelle note emesse dal suo flauto il cui discorso rimane sempre intellegibile a chi sappia ascoltare.
-

-
De Mattia/Pacorig U&J 2023 – ph.A.Salvin
-

-
De Mattia/Pacorig U&J 2023 – ph.A.Salvin
-

-
De Mattia/Pacorig U&J 2023 – ph.A.Salvin
-

-
De Mattia/Pacorig U&J 2023 – ph.A.Salvin
-

-
De Mattia/Pacorig U&J 2023 – ph.A.Salvin
-

-
De Mattia/Pacorig U&J 2023 – ph.A.Salvin
Ricordo qualche anno fa, sempre a Udine, che, mentre De Mattia stava suonando all’aperto, cominciarono a sentirsi distintamente il suono di campane e il cinguettio di uccelli. Bene, il flautista fu talmente bravo da inserire questi elementi nella sua musica ottenendo degli effetti semplicemente straordinari a dimostrare che la musica può essere fatta di moltissimi elementi. A Udine, in quest’ultimo concerto, ha dimostrato ancora una volta tutte le sue potenzialità duettando egregiamente con Pacorig, altro esponente di rilievo dell’area improvvisativa. Non a caso flauto e pianoforte si sono integrati alla perfezione con un gioco di rimandi, suggestioni, tensioni e distensioni che denotano quanto profonda sia la conoscenza della musica da parte di questi due artisti.
In serata altro evento clou del Festival: il concerto della sassofonista Lakecia Benjamin. Devo dire immediatamente che l’artista ha entusiasmato i numerosi spettatori grazie ad una performance caratterizzata da straordinaria energia, da un sound alle volte “sporco” a richiamare i più grandi esponenti del soul, e da un repertorio che ha toccato da molto vicino i grandi nomi del jazz. Ecco, quindi, l’immortale “A Love Supreme” riproposto con sincera partecipazione anche se, ovviamente, nessuna interpretazione può raggiungere il pathos, la drammatizzazione, l’aspirazione verso il divino così ben rappresentata da Coltrane. A Udine l’alto sassofonista ha presentato il suo ultimo lavoro – “Phoenix” – che racchiude una doppia metafora: da un lato racconta le cadute e le risalite di New York città in cui è cresciuta, dall’altro si riferisce ad una sua esperienza personale vissuta nel 2021 quando sfuggì miracolosamente alla morte dopo un grave incidente stradale.
-

-
Lakecia Benjamin U&J 2023 – ph.A.Salvin
-

-
Lakecia Benjamin U&J 2023 – ph.A.Salvin
-

-
Lakecia Benjamin U&J 2023 – ph.A.Salvin
-

-
Lakecia Benjamin U&J 2023 – ph.A.Salvin
-

-
Lakecia Benjamin U&J 2023 – ph.A.Salvin
-

-
Lakecia Benjamin U&J 2023 – ph.A.Salvin
-

-
Lakecia Benjamin U&J 2023 – ph.A.Salvin
A proposito del concerto, qualche commentatore ha posto l’accento sulla mise dell’artista lodandone l’indubbia eleganza. Apriti cielo! Sui social si è scatenata una dura polemica e qualche musicista (o forse pseudo tale) si è spinta fino ad ipotizzare che la scelta di presentarsi sul palco ben vestiti sia vetero borghese se non addirittura “fascio” (questa la parola usata). E poi ci meravigliamo perché tanti giovani che nulla capiscono di musica, che non sanno intonare neppure due note di seguito riescono ad avere un vasto pubblico: basta vestirsi da straccioni, parlare un italiano approssimato e il gioco è fatto.
Martedì 18 luglio ultima giornata funestata da una breve tempesta di vento sufficiente, comunque, a mandare per aria tutte le sedie già approntate nello spiazzale del Castello per il concerto finale di Pat Metheny. Fortunatamente il tempo è volto al meglio e quindi il concerto si è potuto svolgere regolarmente seppure iniziato con un’oretta di ritardo. E personalmente ho ritrovato il Metheny che negli ultimi anni avevo smesso di seguire data l’involuzione stilistica che a mio avviso aveva caratterizzato le ultime produzioni del chitarrista.
-

-
Pat Metheny U&J 2023 – ph.A.Salvin
-

-
Pat Metheny U&J 2023 – ph.A.Salvin
-

-
Pat Metheny U&J 2023 – ph.A.Salvin
-

-
Pat Metheny U&J 2023 – ph.A.Salvin
-

-
Pat Metheny U&J 2023 – ph.A.Salvin
-

-
Pat Metheny U&J 2023 – ph.A.Salvin
-

-
Pat Metheny U&J 2023 – ph.A.Salvin
-

-
Pat Metheny U&J 2023 – ph.A.Salvin
-

-
Pat Metheny U&J 2023 – ph.A.Salvin
A Udine Pat è tornato sui suoi passi e perfettamente coadiuvato da giovani musicisti, quali Chris Fishman al pianoforte e Joe Dyson alla batteria a costituire il “Side-Eye Trio”, ha riproposto alcuni dei suoi pezzi storici quali “Bright Size Life”, “Better Days Ahead” e “Timeline” lasciando perdere complicati meccanismi e riproponendo quel sound nutrito da tanta tecnica, tanto studio ma anche tanta sincerità d’ispirazione, che l’aveva contraddistinto negli anni scorsi. Entusiasta la reazione del pubblico che ha calorosamente applaudito ogni brano e che dopo l’ultimo bis ha regalato all’artista una più che meritata standing ovation.
Gerlando Gatto
da Gerlando Gatto | 11/Mar/2023 | I nostri CD, Primo piano, Recensioni
Dopo le numerose escursioni di Amedeo Furfaro intorno al jazz italiano, questa volta soffermiamo la nostra attenzione sulle novità che arrivano dall’estero.
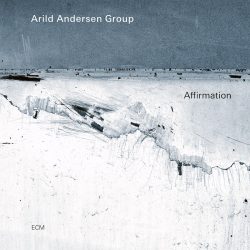 Arild Andersen Group – “Affirmation” – ECM
Arild Andersen Group – “Affirmation” – ECM
Arild Andersen, contrabbassista norvegese, è uno di quei rari musicisti che non sbaglia un colpo. Ogni suo album è frutto di lunga meditazione quindi di sicura riuscita…almeno dal punto di vista artistico, ché come sappiamo il gradimento del pubblico è altra cosa. Ad accompagnarlo in questa nuova impresa musicisti quasi tutti molto più giovani: il pianista quarantasettenne Helge Lien, l’altro quarantasettenne Hakon Mjaset Johansen alla batteria e il trentaseienne Marius Neset al sax. Il repertorio è suddiviso in due parti, ciascuna delle quali comprende alcuni momenti numerati – quattro per la Part I e tre per la Part II; a chiudere l’unica composizione “scritta” dallo stesso Andersen, “Short Story”. A questo punto avrete già capito che l’album si basa su una lunga improvvisazione di gruppo che, però, nulla ha a che vedere con le infocate sedute del free storico. Qui l’atmosfera è completamente diversa, intimista, meditativa con i quattro musicisti che dimostrano di conoscersi assai bene, districandosi come meglio non potrebbero nelle pieghe di una tessitura tanto lieve quanto complessa, in cui le pause, il silenzio hanno un loro perché. L’ultimo brano, “Short Story”, si basa su una melodia splendidamente scritta dal leader e altrettanto splendidamente eseguita dai quattro, con sassofonista e pianista in primissimo piano.
 Onur Aymergen Quintet – “Lunar” – Losen
Onur Aymergen Quintet – “Lunar” – Losen
E’ con vero piacere che vi presentiamo questo gruppo proveniente dalla Turchia e composto da Onur Aymergen leader alla chitarra, Can Çankaya piano, Tolga Bilgin tromba, Apostolos Sideris contrabbasso, Turgut Alp Bekoğlu batteria. Anche se ancora poco noto nel nostro Paese, Onur Aymergen può già vantare una solida preparazione: ha cominciato a studiare chitarra classica con Özhan Gölebatmaz approfondendo anche il flamenco classico con Suat Demirkıran, fino a quando ha deciso di convogliare i suoi interessi verso il rock, il funk e il jazz. In questo suo album d’esordio, Onur dimostra di avere le carte in regola per un futuro luminoso: intendiamoci, nulla di trascendentale, ma un musicista che conosce assai bene lo strumento, il linguaggio che adopera, il patrimonio musicale del suo Paese che ogni tanto fa capolino dalle linee esposte dal gruppo. E non a caso si è citato il gruppo in quanto, nei suoi sapidi arrangiamenti, il leader ha lasciato ad ogni compagno d’avventura lo spazio per porsi in evidenza. E quanto sin qui detto appare evidente sin dal primo brano in programma, “Yeditepe”, scritto, così come gli altri sette pezzi in repertorio, dal leader che evidenzia, in tal modo, una notevolissima capacità di scrittura.
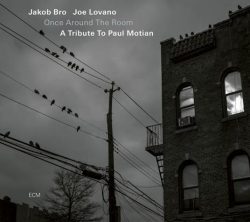 Jakob Bro, Joe Lovano –“Once Around The Room” – A Tribute to Paul Motian” – ECM
Jakob Bro, Joe Lovano –“Once Around The Room” – A Tribute to Paul Motian” – ECM
Il chitarrista Jakob Bro e il tenorsassofonista Joe Lovano sono i cofirmatari di questo album esplicitamente dedicato a Paul Motian, già loro compagno in tante avventure. Ad assecondare i due, i contrabbassisti Larry Grenadier e Thomas Morgan, Anders Christensen al basso elettrico e i due batteristi Joey Baron e Jorge Rossi. Un organico anomalo, quindi, per una musica che di anomalo nulla propone data la maestria dei singoli e quindi dell’intera formazione. Lovano e Motian hanno collaborato per una decina d’anni e personalmente ricordiamo di averli ascoltati, tra l’altro, a Stavanger in Norvegia nei primissimi anni ’80. E ciò potrebbe spiegare assai bene il perché di questo album. Quanto poi all’immediata ricerca del drumming di Motian nella musica dell’album, si tratta di operazione, come al solito, assai difficile anche perché soprattutto Lovano non ha alcuna intenzione di scrivere una pagina calligrafica. Anzi! Ed è lo stesso sassofonista a spiegare cosa per lui significhi questo album: “Con Motian suonavamo degli standard ma cercavamo in ogni modo di farli nostri. Ecco noi suonavamo con fiducia con attitudine, con un approccio che potesse rendere al massimo le nostre intenzioni. Ecco è proprio questo stesso feeling che ho tenuto durante la registrazione dell’album”. Diverso l’atteggiamento di Jakob Bro che ha scritto due brani di sapore quasi opposto in cui si avverte chiaramente una profonda malinconia, una tristezza di fondo per la scomparsa di Motian. Qui il gruppo abbandona lo spirito improvvisativo che ha caratterizzato i primi tre pezzi, per immergersi nella scrittura di Bro che trova sia in “Song To An Old Friend” sia in “Pause” una dolce melodia. Chitarra e sassofono dialogano soavemente ben sostenuti da bassi e batterie. Nel brano conclusivo particolarmente apprezzabile il lavoro del chitarrista che disegna con delicatezza una splendida e toccante linea melodica. Ad intervallare i due brani, l’unica composizione di Paul Motian, “Drum Music”, caratterizzata da una lunga intro disegnata dai due batteristi che lasciano il posto a sax e chitarra, quest’ultima con una sonorità assi vicina a quella del sax per effetto dell’elettronica.
 Eik Trio – “Eik Trio” – Losen
Eik Trio – “Eik Trio” – Losen
Sempre prodotto dalla norvegese “Losen” ecco questo nuovo trio composto dal pianista Ole Fredrik Norbye, dalla vocalist Elisabeth Karsten e dal contrabbassista John Børge Askeland, cui si aggiungono alcuni dei migliori jazzisti norvegesi ed europei quali il sassofonista Bendik Hofseth al sax tenore in tre brani, il trombettista Nils Petter Molvaer nel celeberrimo “I Love Paris” e il fisarmonicista Heine Bugge in “For Once in My Life”, mentre quasi tutti gli arrangiamenti sono curati da Fredrik Norbye. Dai titoli citati avrete forse già capito che tutto l’album è incentrato sulla riproposizione di standard, dieci pezzi che davvero hanno fatto la storia della musica che ci piace, interpretati senza alcuna voglia di sperimentalismo ma con il massimo del rispetto che meritano. Ferma restando la capacità della cantante di rendere al massimo ogni linea melodica, ogni più piccolo risvolto di queste immortali melodie, tra i brani siamo rimasti particolarmente colpito dal già citato “I Love Paris” per il fraseggio del pianista Ole Fredrik Norbye e il maiuscolo apporto di Nils Petter Molvaer
 Mette Henriette – “Drifting” – ECM
Mette Henriette – “Drifting” – ECM
Trio di grande spessore quello che si ascolta in “Drifting”: a guidarlo è la sassofonista Mette Henriette coadiuvata da Johan Lindvall al pianoforte e Judith Hamann al violoncello. In repertorio quindici brani tutti scritti dalla sassofonista (l’ultimo in collaborazione con Lindvall). Dopo l’album d’esordio, registrato sempre per ECM nel 2013 ma pubblicato due anni dopo, la sassofonista norvegese torna sempre in compagnia del pianista ma con l’aggiunta della validissima violoncellista Judith Hamman. L’atmosfera è quanto mai rarefatta con i tre che letteralmente distillano ogni singola nota che acquista così un peso specifico. I brani si susseguono legati da un filo ben preciso che si snoda attraverso le sapienti mani dei tre musicisti. Così se l’impianto melodico è spesso affidato alla leader, il pianoforte si incarica di sottolinearne le parti salienti con il violoncello impegnato in una non facile operazione di ricucitura. Il tutto a disegnare un quadro difficilmente classificabile: certo non si tratta di jazz nell’accezione più usata del termine, né di musica classica tout court…piuttosto di una sorta di esplorazione sonora che induce anche l’ascoltare a guardarsi dentro, a lasciarsi andare alle sensazioni che la musica gli propone. Senza preoccuparsi di capire dove la pagina scritta lascia il posto all’improvvisazione. E se anche chi ci legge seguirà questa metodologia, siamo sicuri che l’album risulterà di notevole interesse.
 Anders Jormin, Lena Willemark – “Pasado en claro” – ECM
Anders Jormin, Lena Willemark – “Pasado en claro” – ECM
Album molto impegnativo questo “Pasado en claro” in cui il contrabbassista svedese Anders Jormin, in collaborazione con la vocalist, violinista e violista Lena Willemark guida un quartetto completato da Karin Nakagawa al koto e Jon Fält alla batteria, già con il leader nel trio di Bobo Stenson. La complessità di cui in apertura è determinata dal fatto che il leader ha voluto trarre ispirazione da una serie di poeti tra i più diversi della letteratura mondiale: ecco quindi testi da antiche fonti cinesi e giapponesi, accanto a poeti scandinavi contemporanei, senza per questo trascurare lo scrittore messicano Octavio Paz (dalla cui opera è tratto il titolo dell’album) e il “nostro” Francesco Petrarca. Insomma un panorama di riferimento da far apparire impossibile una qualsivoglia unità dell’album E invece il quartetto ci riesce grazie soprattutto all’interpretazione della vocalist. Su un tappeto costituito da una valida struttura sonora ben scritta e altrettanto ben arrangiata, ricca di nuances, Lena Willemark si produce in una prova di grande maturità alternando l’uso della voce all’altro strumento a sua disposizione (il violino); esemplare al riguardo “Tho Woman of the Long Ice” musica e testo della stessa Willemark . Insomma è come se nella voce di Lena si ritrovasse allo stesso tempo, il passato, il presente e il futuro di una musica il cui flusso mai si interrompe.
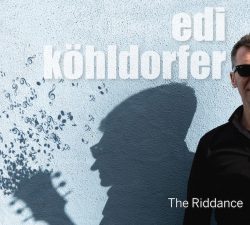 Edi Köhldorfer – “The Riddance” – Ats Records
Edi Köhldorfer – “The Riddance” – Ats Records
Personaggio sicuramente interessante questo chitarrista austriaco Edi Köhldorfer il quale, dopo aver studiato chitarra classica, ha intrapreso la strada del musicista professionista suonando nei contesti più vari, dalle orchestre classiche al folk, dal funk al pop…fino al jazz collaborando con alcuni artisti di fama mondiale come Biréli Lagrène, Dee Dee Bridgewater, Stephane Grappelli. Di qui una personalità compiuta non solo a livello musicale, esplicitata appieno in questo album che risponde ad una grande esigenza di fondo: evidenziare quanto può accadere quando musicisti di provenienza diversa si riuniscono per un comune progetto, e soprattutto liberarsi dalla schiavitù di una pandemia che ha costretto all’immobilismo moltissimi artisti. Per raggiungere questo obbiettivo, Edi ha contattato 26 musicisti di 4 continenti e nessuno si è tirato indietro dando vita ad una produzione assai particolare. Ascoltando l’album, in effetti, non si può non rilevare la gioia, la forza, l’entusiasmo il dinamismo che promana da questi brani cosicché è davvero arduo sceglierne qualcuno in particolare. Tuttavia dobbiamo ammettere che ci hanno particolarmente colpiio “Goodbye Armando” un sentito omaggio a Chick Corea con un fantastico assolo del pianista Ui Datler richiamante “La Fiesta” e “Midwest” impreziosito da un lungo e centrato assolo del bassista colombiano Juan Garcia-Herreros meglio noto come “The Snow Owl”, che suona un basso elettrico personalizzato a sei corde; all’età di 37 anni, Juan ha ottenuto una nomination, per il Latin Grammy Award nella categoria Best Latin Jazz Album, per il suo terzo CD intitolato “Normas”.
 Benjamin Lackner – “Last decade” – ECM
Benjamin Lackner – “Last decade” – ECM
Probabilmente il pianista tedesco Benjamin Lackner non è molto noto al pubblico italiano anche se può già vantare un’invidiabile carriera che lo porta ad esordire oggi in casa ECM. Lackner è tornato da poco a Berlino, dopo un lungo periodo trascorso negli Stati Uniti dove ha avuto modo di studiare con “maestri” quali Charlie Haden e Brad Mehldau. Per questo album il pianista è affiancato da tre grandi artisti: il trombettista Mathias Eick, il batterista Manu Katché e il contrabbassista Jérôme Regard, già con Lackner dal 2006. Il risultato c’è ed è a tutto tondo. In effetti appare chiaro sin dalla primissime note come l’intendimento principale del trio sia quello di proporre una musica caratterizzata dalla ricerca della linea melodica. Una linea che risulti dolce, fors’anche accattivante, ma non per questo banale o scontata. Di qui un repertorio di nove brani (tutti composti dal leader ad eccezione di “Emile” scritta da Jérôme Regard) in cui la musica scorre in perenne equilibrio fra i quattro, con nessuna voglia particolare del leader di mettersi in luce ché anzi molto spesso ascoltiamo in primo piano la bella voce della tromba di Eick sempre sorretta da una sezione ritmica assolutamente funzionale all’intento del leader. Tra i brani particolarmente suggestivo e sofisticato è “Hang Up on That Ghost” tutto giocato su un fitto dialogo tra pianoforte, batteria e contrabbasso mentre Mathias alterna la sua voce a quella della tromba con effetti di estrema delicatezza.
 Ieremy Lirola – “Mock the Borders” –
Ieremy Lirola – “Mock the Borders” –
Dopo “Uptown Desire” il contrabbassista francese si ripresenta al pubblico con questo “Mock the Borders” in cui è possibile ascoltare anche il piano di Maxime Sanchez, il sax di Denis Guivarc’h e la batteria di Nicolas Larmignat, questi ultimi due già presenti nel citato lavoro “Uptown Desire”.
Il titolo è quanto mai esplicativo: “Ridicolizza il confine” appare come una sorta di manifesto programmatico che dovrebbe informare il senso dell’album. Ma è davvero così? Francamente non ci sembra che l’artista abbia voluto andare oltre la lezione di Coleman; piuttosto la sua idea, conclamata in musica, è quella di una libertà che prescinda dalle etichette, dalle mode, per dare pieno diritto di cittadinanza ad ogni forma espressiva. Insomma per Lirola la musica tonale può coesistere con escursioni nel mondo del free. Di qui un album dai colori cangianti, dalle atmosfere variegate in cui si avverte l’urgenza di nulla trascurare delle passate esperienze: guadare avanti non significa necessariamente trascurare ciò che c’è stato e che continua ad esserci. Insomma una visione oserei dire filosofica e non solo musicale che informa questo interessante lavoro. Tra i vari brani eccellente l’apertura con “Mock the lines” impreziosito dal lavoro del sassofonista. Ma nello svolgimento dell’album il leader lascia ampio spazio ai compagni d’avventura che hanno così modo di esprimere appieno le proprie potenzialità.
 Stephan Micus – “Thunder” – ECM
Stephan Micus – “Thunder” – ECM
Nessuna sorpresa per questo ennesimo ottimo album di Stephan Micus, un vero ricercatore di note che abbiamo imparato ad ammirare oramai nel corso di lunghi anni. Questa volta il suo interesse si focalizza, come da lui stesso sottolineato, sulla musica dei monasteri tibetani, meta di molte visite da parte del musicista. Stephan rimane particolarmente colpito dal particolare strumento che si usa in queste cerimonie, il dung-chen, una sorta di tromba lunga circa quattro metri, cui affianca il ki kun ki, uno strumento a fiato – ci spiega lo stesso Micus – molto semplice, costruito con un unico stelo ligneo che cresce in alcune foreste siberiane del lontano Oriente e il nahkan, una specie di flauto di provenienza giapponese. Mescolate questi straordinari elementi e la ricetta è pronta: una musica ancora una volta affascinante, dai suoni allo stesso tempo primordiali e di attualità che ci trasportano in un mondo virtuale apparentemente alla nostra portata ma che mai riusciamo ad abbracciare davvero. E credo sia questo il segreto di Micus: sintetizzare gli universi musicali più disparati per ricondurli ad una unità senza spazio, senza tempo ove solo il suo credo ha diritto di cittadinanza. Per tornare al contenuto dell’album è comunque lo stesso Micus a fornirci una chiave di lettura ove afferma che l’album è dedicato alla grande famiglia delle divinità dei tuoni cui hanno creduto intere popolazioni con la speranza che il loro distruttivo potere possa in qualche modo essere placato dalla musica.
 Arvo Pärt – “Tintinnabuli” – Billant Corners
Arvo Pärt – “Tintinnabuli” – Billant Corners
Con il termine “Tintinnabuli” ci si intende riferire allo stile compositivo creato dal compositore estone Arvo Pärt, introdotto nella sua “Für Alina” (1976) e riutilizzato in “Spiegel im Spiegel” (1978). Caratteristiche che ritroviamo appieno in questo splendido album che vede come protagonisti Jeroen van Veen al piano, Joachim Eijlander al violoncello e in un brano la moglie di Jeroen, Sandra van Veen, anch’essa pianista. L’album è una sorta di summa delle caratteristiche che hanno sempre connotato la musica di Arvo Pärt, vale a dire la quiete estatica e il saper racchiudere lo spirito dei tempi grazie anche alle esperienze mistiche con la musica dei canti religiosi. Risultato: composizioni senza tempo che appaiono in egual misura antiche e contemporanee, religiose e profane, non immuni da una marcata influenza da parte del movimento minimalista. L’album si apre con “Fratres” cui fa immediatamente seguito uno dei brani più importanti di Arvo, quel “Für Alina” cui si è già fatto cenno. “Ukuaru Valss” ci fa conoscere un lato più “leggero” della personalità di Pärt mentre il conclusivo lungo “Partomania” è preceduto da “Spiegel im Spiegel” anch’esso citato in precedenza quale pietra miliare nel percorso compositivo dell’artista estone: ascoltandolo ancora oggi, dopo tanto tempo, impressiona il modo in cui le note sono letteralmente distillate una dopo l’altra a conferma di una maestria compositiva difficilmente eguagliabile.
 Sebastian Rochford, Kit Downes – “A Short Diary” – ECM
Sebastian Rochford, Kit Downes – “A Short Diary” – ECM
Ecco un album non facile da recensire in quanto gli usuali strumenti che si adoperano per illustrare una produzione discografica, in questo caso non sono sufficienti. In ballo ci sono, infatti, motivazioni che vanno ben al di là del fatto musicale e che coinvolgono direttamente i sentimenti più profondi di Rochford, non a caso compositore di tutti i brani in programma. In effetti l’album è una appassionata e sentita dedica che il cinquantenne batterista scozzese rivolge al padre, Gerard Rochford, grande poeta morto nel 2019. Alla luce di questa realtà, la musica assume una valenza tutta particolare. E’ facile immaginare come l’autore, nello scrivere, si sia lasciato andare ai ricordi della sua infanzia, degli anni trascorsi con il padre e di ciò che questo ha voluto dire per la sua crescita. Di qui l’originalità di un discorso che ha una sua compiutezza dall’inizio alla fine, ben sorretto dal partner di Rochford, ovvero Kit Downes che in precedenti occasioni aveva evidenziato tutto il suo talento. Talento che qui si manifesta nell’aver saputo mirabilmente arrangiare il tutto costruendo un coinvolgente percorso melodico-armonico in cui non esageriamo affermando che sotto alcuni aspetti ascoltare questo album è come sfogliare un album le cui pagine sono costituite dai ricordi dolcemente custodite da Sebastian. Quanto ai brani particolarmente significativo “Our Time Is Still”: un pezzo essenziale, scarnificato fino al limite massimo, tutto giocato sulla sottrazione ma con una carica di tristezza, di emozionalità, di sentimento davvero toccante.
 Rubber Soul Quartet – “Something” – Losen
Rubber Soul Quartet – “Something” – Losen
E’ ancora possibile eseguire in chiave jazzistica un repertorio ‘beatlesiano’ senza scadere nel già sentito, nello scontato? Certo che sì, ma si tratta sicuramente di un’impresa estremamente complessa dato che i brani dei Beatles oramai da molti anni sono entrati nel repertorio di grandi jazzisti. A provarci, adesso, sono quattro musicisti norvegesi, Bård Helgerud chitarra e vocale, Håvard Fossum sax, flauto, clarinetto, Andreas Dreier contrabbasso e e vocale, Torstein Ellingsen batteria e percussioni. In cartellone, come già accenato, undici composizioni dei Beatles per un viaggio all’indietro che si preannuncia tanto entusiasmante quanto colmo di insidie. Il quartetto cerca di evitare gli scogli proponendo una chiave di lettura originale: combinare le melodie ben note con arrangiamenti che si rifanno espressamente alla lezione dei grandi jazzisti made in USA, il tutto condito da una forte carica di swing e una buona dose di improvvisazione. Obiettivo raggiunto? Francamente non del tutto in quanto, indipendentemente dall’arrangiamento, la carica melodica dei brani è troppo forte cosicché resta lì, a farla da padrona e quindi a spedire in secondo piano esecuzione e arrangiamento, a meno che non si tratti davvero di grandi musicisti quali, tanto per fare due soli nomi, Brad Mehldau e Sarah Vaughan
 Salon Odjilà – “TangoRomaBalkanJazz” – ATS Records
Salon Odjilà – “TangoRomaBalkanJazz” – ATS Records
Un’elegante mistura di oriente e occidente, di jazz e folk, di euforia e malinconia definisce il clima di questo album interpretato da un quartetto di assoluto livello: Wolfgang e Werner Weissengruber sono multistrumentisti che oramai da anni si dedicano con passione al jazz, Manuela Kloibmüller è fisarmonicista che frequenta con assiduità sia i terreni classici sia quelli jazz nonché vocalist di riconosciuto spessore, Matthias Eglseer è batterista fantasioso e preciso (lo si ascolti, ad esempio, in “Cetvorno Sopsko Horo”). In repertorio tre classici di Piazzolla, un originale di Wolfgang Weissengruber e sei ‘traditional’. Ciò premesso la musica rispetta perfettamente le premesse contenute nel titolo vale a dire un tango ma con quel forte imprinting che caratterizza la musica balcanica. Ciò grazie ad arrangiamenti particolarmente indovinati che riescono a valorizzare appieno l’originalità del gruppo anche quando si avventura su pezzi non sempre consigliabili. E’ il caso dei tre brani di Piazzolla e in particolare di “Libertango” il brano forse più celebre del compositore argentino: introdotto dal contrabbasso, il brano prende man mano spessore con la Kloibmüller che si produce in un vibrante assolo ben sostenuta da tutto il gruppo per una interpretazione convincente.
 Solis String Quartet & Sarah Jane Morris – “All You Need Is Love” – Irma
Solis String Quartet & Sarah Jane Morris – “All You Need Is Love” – Irma
E dopo il cd del Rubber Soul Quartet ecco un altro album interamente dedicato ai Beatles. Ad interpretare le melodie di John Lennon e Paul McCartney è però questa volta una delle voci, a nostro avviso, più belle e convincenti dell’intero panorama vocale internazionale. Oramai sulla cresta dell’onda da molti anni, la Morris mai delude; chi scrive l’ha sentita in concerto svariate volte e ha sempre trovato un’artista straordinariamente generosa, capace di interpretare ogni brano alla sua maniera andando a visitare anche le più intime pieghe delle melodie senza trascurarne la valenza ritmica. E la stessa cosa accade anche questa volta: la vocalist affronta ogni tema con gande rispetto ma allo stesso tempo con la sicurezza che le deriva da tanti anni di carriera. Di qui interpretazioni che senza alcunché togliere all’originale fascino, rivestono i brani di una veste originale. Il che, non sarebbe stato possibile, se la vocalist non fosse stata adeguatamente supportata da uno straordinario Solis String Quartet, al secolo Vincenzo Di Donna e Luigi De Maio, violini, Gerardo Morrone viola e Antonio Di Francia cello e chitarra, con quest’ultimo impegnato in una preziosa opera di ri-arrangiamento che non ha fatto sentire la mancanza di quella sezione ritmica, viceversa tanto importante nella produzione originale. Tra i brani particolarmente riuscita la versione di “The Fool on The Hill” che resta una delle più belle composizioni dei Beatles.
Gerlando Gatto
da Flaviano Bosco | 04/Ago/2022 | News, Primo piano, Recensioni
Dopo la triennale parentesi balneare di Grado, è tornata nella sua sede naturale di Udine la storica manifestazione Udin&Jazz che ha dimostrato, con la sua 32 edizione, di essere uno dei punti di riferimento per il jazz non solo a livello italiano.

Lo ha ribadito autorevolmente con una serie di straordinari eventi musicali ma anche con tutta una serie di attività culturali collaterali che da sempre sono parte integrante di un modo di intendere la musica non solo come intrattenimento ma prima di tutto come rivendicazione di istanze democratiche e libertarie che considerano le blue note in tutte le loro sfumature come strumento di conoscenza, condivisione e rispetto di diritti inalienabili nei confronti dei nostri fratelli meno fortunati e di tutti.
Il jazz può essere inteso in molti modi: può essere un modo un po’ esotico e snob di estraniarsi dalla realtà per qualche ottusa élite oppure il grido di dolore che si alza dai campi dell’ingiustizia e della discriminazione che scuote il potere con l’intento di abbatterlo a colpi di note. Non a caso la rassegna si è aperta con il film “Gli Stati Uniti vs Billie Holiday” di Lee Daniels (Usa 2021) che a modo suo ricostruisce la persecuzione giudiziaria che subì la grande cantante per aver denunciato attraverso la propria arte gli orrori dei linciaggi contro gli afroamericani in “Strange Fruit”.
Il Jazz è uno strano frutto che penzola dall’albero dell’ingiustizia sociale ma che non muore mai continuando a scalciare contro ogni sopruso senza che nessuno possa mai far tacere la sua voce di denuncia e di protesta.
L’associazione Euritmica con il suo patron Giancarlo Velliscig, che da sempre organizza il festival, lo sa bene e da sempre si batte per gli alti valori in cui crede e professa. Il motto della manifestazione di quest’anno lo diceva chiaramente: “Play Jazz, Not War” semplice e diretto ma per nulla scontato in un momento nel quale stiamo assistendo ad una nuova pericolosa corsa al riarmo generale, mentre i soliti mentecatti credono che solo dotandosi di missili più potenti si possa “vincere la pace”. Stiamo passando dalle tragicomiche “missioni di pace” a suon di bombardamenti a tappeto (Iraq, Afghanistan, Siria ecc.) alle “Operazioni speciali di difesa democratica” con i droni telecomandati e con i lanciamissili portatili. Gli imperialisti sono sempre gli altri così come molti di noi dicono: “Sono pacifista ma…”, affermano tranquillamente anche “Non sono razzista ma…”come in una canzone, tristemente ironica, di Willie Peyote.
Di seguito daremo conto brevemente degli eventi principali del festival, solo una piccola parte di tanta meraviglia che per essere davvero compresa ha bisogno di essere vissuta personalmente, per questo si considerino le righe che seguono solo come un’indicazione e un invito a partecipare alla prossima edizione.
Gianpaolo Rinaldi con il suo rodato trio è in grado di affascinare e divertire in qualunque situazione anche la più improbabile. Udin&Jazz quest’anno più che mai ha voluto sperimentare nuovi angoli della città per alcune delle proprie esibizioni in cartellone. Come preambolo al festival ha creato un’apposita sezione chiamata semplicemente : “Aspettando Udin&Jazz”. A Rinaldi e ai suoi è toccato un bel giardino nel pieno centro cittadino perfettamente attrezzato con aree giochi per bambini e un fornitissimo chiosco per quelli che bambini non lo sono più da un pezzo e possono annegare negli spritz tutti i rimpianti e le nostalgie mentre i loro bambini fanno il diavolo a quattro su altalene, tappeto elastico e cavallucci a molla. Non è facile suonare in un luogo del genere ma è davvero affascinante, vivo, reale; non si può contare sulle liturgie della sala da concerto e nemmeno sulla dimensione intima del club, è stato vero jazz in plein air con i bambini che scorrazzavano e il vociare delle famiglie al parco mentre i tanti intervenuti per il concerto si godevano i suoni meravigliosi della vita reale che si univano dinamicamente in perfetta sinergia a quelli dei musicisti.
-

-
Giampaolo Rinaldi
-

-
Matteo Sgobino Lune Troublante
-

-
Armando Battiston
L’ultima ambiziosa incisione del trio con composizioni originali di Rinaldi, “Sapiens doesen’t mean Sapiens” è stata ispirata al best seller Sapiens, da animali a dei di Yuval Noah Harari e, almeno nelle intenzioni, vuole tracciare un arcobaleno di note tra la scimmia che eravamo e i quadrumani che diventiamo mano a mano che pervertiamo le nostre esigenze di esseri umani. E’ un fatto ormai acclarato che tanta abilità e adattamento evolutivo non hanno portato solamente a miglioramenti nella nostra esistenza; la catastrofe ecologica che abbiamo provocato su scala planetaria ci dimostra chiaramente che di certo siamo Homo ma che sul Sapiens si può discutere. Rinaldi traduce impeccabilmente questo discorso in musica dal proprio punto di vista di pianista talentuoso alle prese con un mondo difficile da capire ma che la musica può aiutarci a comprendere.
Il tutto è suggerito da Rinaldi in modo lieve ma per nulla superficiale, il linguaggio della sua musica è alto ma perfettamente comprensibile a tutti. Nel trio si distingue anche il batterista Marco D’Orlando dalla grande fantasia poliritmica che usa anche gli stridii delle bacchette sui piatti e altri bizzarri rumori per esprimere al meglio inquietudini e illuminazioni. Ottima la calibratura dell’insieme attraverso il contrabbasso di Mattia Magatelli.
Armando Battiston è uno dei decani del pianismo jazz friulano e si è esibito per “Aspettando Udin&Jazz” in duo con il proprio storico batterista Daniele Comuzzi al Caffè Caucigh, uno dei luoghi storici della buona musica udinese con un cartellone fitto di eventi, jam sessions e readings.
La versatilità del pianista, la lunghissima esperienza gli permettono di guardare avanti e progettare futuri imperscrutabili e inauditi. Per l’occasione ha sfoggiato la sua conoscenza e predisposizione verso il Latin Jazz con una certa vena tangheira. Moltissimi anche gli standard più classici interpretati dalla sua particolarissima sensibilità e dal suo gusto che va dalle più spericolate sperimentazioni free form al jazz main stream e confidenziale venato dalla tradizione della canzone italiana melodica. E’ davvero un gran piacere ascoltarlo; la sua musica è un vero balsamo vivificante, la sua fluviale esibizione in perfetto interscambio ed equilibrio con il batterista Comuzzi in uno degli angoli più suggestivi della città medievale ha respirato al ritmo della serata estiva e dei suoi incanti.
La manifestazione è entrata nel vivo spostando i propri eventi centrali al Teatro Palamostre. Tra i primi ad esibirsi in quella sede il pianista Emanuele Filippi che presentava per l’occasione il suo nuovo lavoro, fresco di stampa, in duo con Seamus Blake: “Heart Chant”. Il sassofonista inglese, purtroppo non ha potuto essere presente a Udine perché impegnato nella tournée americana di Roger Waters, d’altronde un nome come “Seamus” deve ricordare sicuramente qualcosa al fondatore dei Pink Floyd (Meddle, 1971). Solo da questo, che non è per nulla un particolare irrilevante, possiamo capire la rilevanza internazionale di Blake e il conseguente alto valore del sodalizio con il giovane pianista friulano. Il lavoro discografico che ne è scaturito è di una bellezza meditativa e sospesa. A sostituire il musicista inglese per il concerto udinese, Ben van Gelder da Amsterdam, giovane di talento e di grandi prospettive ma comprensibilmente, non proprio allo stesso livello.
La musica è sembrata molto solida dal punto di vista compositivo ma fin troppo sorvegliata per quanto riguarda il Pathos. Di certo, almeno dal vivo, il cambio di partner all’ultimo momento non ha giovato al risultato finale che comunque ha regalato alcuni momenti di grande intensità.
-

-
Emanuele Filippi, Ben van Gelder- ph Luca A. d’Agostino/Phocus Agency © 2022
-

-
Fabrizio Bosso 4et – ph Luca A. d’Agostino/Phocus Agency © 2022
-

-
Fabrizio Bosso 4et – ph Angelo Salvin © 2022
A seguire, in una serata dal doppio concerto, il quartetto del funambolico trombettista Fabrizio Bosso che ha trascinato il pubblico in un’atmosfera gioiosa di divertimento dai suoni scintillanti e preziosi fatti di grandissimo virtuosismo ma anche di tanta emozione elegante. Bosso non è mai eccessivo e non vuole stupire il pubblico a tutti i costi con equilibrismi trombettistici fine a se stessi così come i suoi musicisti che pur lanciati a folli velocità da ritmi prodigiosi mantengono sempre la barra a dritta. Nessuno di loro vuole fare il “fenomeno”. Fin da subito hanno saputo creare un’atmosfera piacevole, senza tensioni eccessive o liturgie narcisistiche, solo tanta buona musica che lascia Good Vibrations e che fa sognare ad occhi aperti. Ogni tanto ci vuole proprio.
Udin&Jazz presentava anche una personale dedicata della pittrice Ivana Burello dal significativo titolo “I colori del Jazz”. Nel ridotto del Palamostre, dedicato a Carmelo Bene e ricavato sotto una delle scalinate dell’auditorium, erano esposti alcuni ritratti di grandi icone del jazz, (Sonny Rollins, John Coltrane, Miles Davis, Billie Holiday) frutto di varie tecniche pittoriche soprattutto relative all’espressionismo astratto e all’action painting. L’effetto era quello di un’improvvisazione musicale per spatole e pennelli non del tutto inedita o assolutamente originale ma sicuramente di grande impatto.
-

-
I COLORI DEL JAZZ – IVANA BURELLO – ph Luca A. d’Agostino/Phocus Agency © 2022
-

-
Flavio Massarutto – Mingus – ph Luca A. d’Agostino
-

-
Flavio Massarutto – Mingus – ph Luca A. d’Agostino
Nel corso della manifestazione è stata anche presentata quella che ormai è giustamente diventata la migliore e più venduta graphic novel di Jazz nel nostro paese: Mingus di Flavio Massarutto e Pasquale Todisco “Squaz” dal quale, per concludere questa prima parte della recensione, rubiamo impunemente l’explicit che può davvero servirci come nuovo inizio per future riflessioni: Mingus “è la storia di un intellettuale autodidatta in lotta perenne con una società che lo vorrebbe marginale e subalterno. La storia di un Martin Eden meticcio, la si potrebbe definire anche una biografia apocrifa. Come ebbe a scrivere Ingeborg Bachmann – Lo scrittore apocrifo non gioca con la storia, non divaga con i destini, non costruisce biografie: prende una vita umana, consegnata all’erbario delle storie dell’arte, della poesia e della filosofia, e la provoca, la smaschera, la interroga: le fa rivelare sorprendenti segreti, fantasie più vere della realtà, che fanno esplodere tutte le storie e tutti i cimiteri, riconsegnando alla vita quanto di una vita è stato immaginato vivente.”
(continua)
Flaviano Bosco
da Amedeo Furfaro | 05/Mag/2020 | I nostri CD, Recensioni

Daniele Di Bonaventura, Michele Di Toro – “Vola Vola” – Caligola Records.
 Nel jazz la coppia scoppia … di salute. È il caso di “Vola Vola”, l’album, edito da Caligola Records, in cui il bandoneon di Daniele Di Bonaventura sposa il pianoforte di Michele Di Toro nel mettere le ali a dieci brani esemplari dell’estetica musicale della partnership. Diceva Horacio Ferrer che “il bandoneon è una fatalità del tango”. Non solo tango, verrebbe da aggiungere ascoltando questo lavoro intitolato ad una delle canzoni abruzzesi più famose reinterpretata, fra le altre, su arrangiamento dello stesso bandoneonista. Perché un tale strumento dal suono struggente, se accostato ad una tastiera ispirata, anche quando fuoriesce dal ventre latino, amplia la gamma di possibilità espressive, per aprirsi ad una varietà sconfinata di opzioni.
Nel jazz la coppia scoppia … di salute. È il caso di “Vola Vola”, l’album, edito da Caligola Records, in cui il bandoneon di Daniele Di Bonaventura sposa il pianoforte di Michele Di Toro nel mettere le ali a dieci brani esemplari dell’estetica musicale della partnership. Diceva Horacio Ferrer che “il bandoneon è una fatalità del tango”. Non solo tango, verrebbe da aggiungere ascoltando questo lavoro intitolato ad una delle canzoni abruzzesi più famose reinterpretata, fra le altre, su arrangiamento dello stesso bandoneonista. Perché un tale strumento dal suono struggente, se accostato ad una tastiera ispirata, anche quando fuoriesce dal ventre latino, amplia la gamma di possibilità espressive, per aprirsi ad una varietà sconfinata di opzioni.
Con Di Bonaventura e Di Toro la musica “trasvola”, scivola via in modo aeriforme, non imbocca false piste né infila uscite tortuose. E se può sembrare che il giusto grembo per quelle note sia il Piazzolla di “Jeanne y Paul” e i Gardel-Le Pera di “Soledad” e “Sus Ojos se cerraron”, la eccentricità del duo risalta quando è alle prese con “Blossom” di Keith Jarrett. Non c’è, intendiamoci, nessuna “slatinizzazione” del repertorio semmai si è all’approdo verso nuovi mondi sonori. Sono quelli per cui i due musicisti si fanno attori di spirali armoniche, propulsori di sintesi calde fra dimensioni tecnica ed artistica, addensatori colto-popular in pezzi quali “Touch Her Soft Lips And Part” di William Turner Walton. I due solisti si destreggiano inoltre in partiture proprie – Di Bonaventura in “Sogno di primavera”, Di Toro in “Corale” e in “Ninna nanna” – e quando si cimentano con la poesia insita in un brano altrui tipo “One Day I’ll Fly Away” applicano al meglio i propri elegiaci modi al lirismo vibrante di questa intensa composizione di Nils Landgren e Joe Sampler.
Alice Ricciardi, Pietro Lussu –“Catch A Falling Star” – Gibigiana Records.
 Come zumare insomma inquadrare dei soggetti musicali tramite la macchina da presa uditiva? Facciamo l’esempio del canto femminile: qual è il contesto strumentale più idoneo a focalizzarne le doti? La soluzione proposta con il disco “Catch A Falling Star” della vocalist Alice Ricciardi col pianista Pietro Lussu è più che idonea: la voce, semplicemente cruda, affidata alla “cura” della tastiera, elettrica in questo caso. Beninteso la materia prima, quella canora, ed il contorno armonico della tastiera devono essere di prim’ordine perché il risultato sia adeguato alle aspettative.
Come zumare insomma inquadrare dei soggetti musicali tramite la macchina da presa uditiva? Facciamo l’esempio del canto femminile: qual è il contesto strumentale più idoneo a focalizzarne le doti? La soluzione proposta con il disco “Catch A Falling Star” della vocalist Alice Ricciardi col pianista Pietro Lussu è più che idonea: la voce, semplicemente cruda, affidata alla “cura” della tastiera, elettrica in questo caso. Beninteso la materia prima, quella canora, ed il contorno armonico della tastiera devono essere di prim’ordine perché il risultato sia adeguato alle aspettative.
Ed è quanto avviene con la Ricciardi, artista di stile e raffinatezza non comuni, che propone nell’album tredici brani sia di propria scrittura (fra cui spiccano “Clues Blues” a firma anche del pianista e”Y-Am”con i testi di Eva Macali) che standards di Berlin, Vance (vedansi il titolo del cd), Rodgers-Hammerstein, Gershwin, Van Heusen, Porter, Ellington ed una originale immersione nel pop d’annata con “Good Vibrations” dei Beach Boys. La forza del lavoro sta ulteriormente nella capacità di Lussu di inseguire in punta di piedi le di lei giravolte sui registri più acuti, nell’orchestrarla di ornamenti ed arabeschi, nell’abilità di rarefarne le atmosfere swing, nella discrezione nel defilarsi al momento opportuno e lasciare che la cantante segua il proprio filo d’Arianna, jazzisticamente proteso, con l’orientamento deciso che le è proprio.
Josh Deutsch, Nico Soffiato – “Redshift” – Nusica.org
 Sembra alquanto inusuale la struttura binomica del piccolo gruppo formato dal trombettista John Deutsch – Grammy Award 2019 per il miglior album latin jazz – con Nico Soffiato alla chitarra baritona. Il duo, artisticamente nato a Boston, nel terzo disco, Redshift appena edito da Nusica.org, si arricchisce di loop, sinth e sovratracce, e si “rinforza” in diversi brani grazie alla presenza “extra” di due batteristi come Allison Miller alternato a Dan Weiss. Dunque un duo plus se si considera il featuring degli ospiti citati che vanno a ben incidere sulla tenuta ritmico-percussiva delle esecuzioni senza per questo minimizzare la validità del costrutto sonoro impastato dalla coppia leader. Il sodalizio ultradecennale di Josh e Nico si basa su una “bilancia” musicale, in bilico fra acustica ed elettronica, su due creste, estetica jazz/rock/pop ed anima classica (“44.2” è un riarrangiamento da Robert Schumann mentre “John My Beloved” è la nota cover di Sufjan Stevens laddove con “Paul” siamo nell’indie rock degli statunitensi Big Thief). Le composizioni di Soffiato si distinguono per scelta sussequenziale di accordi funzionali allo sviluppo melodico ed ad impro contenute (“Endnote”, “Remember”) con qualche deviazione funky (“Tooch Taach”). Dal canto suo il Deutsch autore si caratterizza per l’ondeggiare gravitazionale della tromba che va ad illuminare di rossastro gli antri sonori di “Time Lapse” o le luci basse di “Arrival” mentre in “Triad Tune” e nella stessa “Consolation Prize”, scritta a quattro mani col chitarrista, dà sfogo ad un eloquio modulato e intenso, istintivo e profondo, per rimanere a descrizioni “dual”. Il tutto viene shakerato avendo sullo sfondo la skyline di New York, metropoli in cui i nostri eroi si sono da tempo trasferiti assorbendone in pieno lo spirito innovativo. Da precisare che Redshift, oltre ad essere il nome della storica band inglese fondata da Mark Shreeve, sta ad indicare la maggiore lunghezza d’onda di un qualcosa che si allontana. Da qui il richiamo subliminale al gioco più/meno di frequenze del duo in questione.
Sembra alquanto inusuale la struttura binomica del piccolo gruppo formato dal trombettista John Deutsch – Grammy Award 2019 per il miglior album latin jazz – con Nico Soffiato alla chitarra baritona. Il duo, artisticamente nato a Boston, nel terzo disco, Redshift appena edito da Nusica.org, si arricchisce di loop, sinth e sovratracce, e si “rinforza” in diversi brani grazie alla presenza “extra” di due batteristi come Allison Miller alternato a Dan Weiss. Dunque un duo plus se si considera il featuring degli ospiti citati che vanno a ben incidere sulla tenuta ritmico-percussiva delle esecuzioni senza per questo minimizzare la validità del costrutto sonoro impastato dalla coppia leader. Il sodalizio ultradecennale di Josh e Nico si basa su una “bilancia” musicale, in bilico fra acustica ed elettronica, su due creste, estetica jazz/rock/pop ed anima classica (“44.2” è un riarrangiamento da Robert Schumann mentre “John My Beloved” è la nota cover di Sufjan Stevens laddove con “Paul” siamo nell’indie rock degli statunitensi Big Thief). Le composizioni di Soffiato si distinguono per scelta sussequenziale di accordi funzionali allo sviluppo melodico ed ad impro contenute (“Endnote”, “Remember”) con qualche deviazione funky (“Tooch Taach”). Dal canto suo il Deutsch autore si caratterizza per l’ondeggiare gravitazionale della tromba che va ad illuminare di rossastro gli antri sonori di “Time Lapse” o le luci basse di “Arrival” mentre in “Triad Tune” e nella stessa “Consolation Prize”, scritta a quattro mani col chitarrista, dà sfogo ad un eloquio modulato e intenso, istintivo e profondo, per rimanere a descrizioni “dual”. Il tutto viene shakerato avendo sullo sfondo la skyline di New York, metropoli in cui i nostri eroi si sono da tempo trasferiti assorbendone in pieno lo spirito innovativo. Da precisare che Redshift, oltre ad essere il nome della storica band inglese fondata da Mark Shreeve, sta ad indicare la maggiore lunghezza d’onda di un qualcosa che si allontana. Da qui il richiamo subliminale al gioco più/meno di frequenze del duo in questione.
da Gerlando Gatto | 29/Apr/2019 | News, Primo piano

Un’altra stella del jazz è andata a brillare lassù nel cielo: il 22 aprile si è spento a New York City, dopo una lunga malattia, il vibrafonista e percussionista Dave Samuels. Aveva 70 anni.
Nato a Waukegan, nello Stato dell’Illinois, il 9 ottobre 1948, Dave Samuels ha legato il suo nome al celebre gruppo fusion “Spyro Gyra” con cui ha suonato per molti anni.
Ma, ovviamente, la sua storia di musicista comincia molto prima, e precisamente nel 1954 quando, a soli sei anni, inizia a prendere lezioni di batteria e pianoforte influenzato dai due fratelli maggiori che suonano, rispettivamente, sassofono e pianoforte. Successivamente, negli anni dell’università a Boston, passa al vibrafono e alla marimba studiando, tra gli altri, con Gary Burton e frequentando il Berkley College of Music.
Non ancora trentenne, nel 1974, si trasferisce a New York dove viene immediatamente, chiamato a suonare in occasione del celebre concerto alla Carnegie Hall del 24 novembre dello stesso anno per la reunion tra Gerry Mulligan e Chet Baker, concerto che per fortuna possiamo riascoltare grazie al doppio LP registrato dal vivo e pubblicato dalla CTI.
Più o meno dello stesso periodo è l’altra prestigiosa collaborazione con Carla Bley, e poi con Frank Zappa (lo si ascolta nell’album “Zappa in New York” del ’77), Paul McCandless e David Friedman, suo insegnante a Boston e con il quale crea il duo Double Image e incide due album, nel 1977 e nel 1994.
Nel 1977 inizia la sua lunga e fruttuosa collaborazione con “Spyro Gyra”, di cui diventa membro effettivo e stabile solo in occasione dell’album del 1983 “City Kids”; grazie all’apporto di Samuels, “Spyro Gyra” viene nominato dalla rivista Billboard come miglior gruppo di jazz contemporaneo degli anni ’80.
Ma gli interessi di Samuels non si limitano alla fusion essendo egli un grande estimatore della musica caraibica; eccolo, quindi, nel 1993 dare vita al “Caribbean Jazz Project” con Paquito D’Rivera e Andy Narell specialista di steel pan, che diventa ben presto la sua creatura preferita, lanciandolo definitivamente nell’olimpo dei grandi. Così nel 2005 lascia “Spyro Gyra” e si dedica al nuovo progetto declinato attraverso la ricerca dei molti stili che animano il jazz latino e afro-caraibico. E che la ricerca abbia dato fruttosi succosi è dimostrato dal fatto che il gruppo vince un Grammy per il Miglior Latin Jazz Album (“The Gathering” del 2002) e un Latin Grammy nella stessa categoria (“Afro Bop Alliance” del 2008).
A fianco di queste prestigiose realizzazioni, Samuels prosegue la sua carriera da solista: nel 1980 incide, con un gruppo di musicisti italiani (Furio Di Castri, Tullio De Piscopo, Giorgio Baiocco), “One Step Ahead” il primo di dieci album da leader.
Samules è stato anche un valido didatta avendo insegnato al Berklee e al New England Conservatory of Music; ha scritto anche due volumi didattici “Mallet Keyboard Musicianship” nel 1988 e “Contemporary Vibraphone Technique” nel 1992.
Insomma con Samuels se n’è andato un grande artista che traeva le sue motivazioni da tutti gli aspetti dell’essere musicista: la composizione, l’arrangiamento, il solismo…senza trascurare il desiderio di trasmettere ai più giovani il suo sapere.
Gerlando Gatto
da Fabio Ciminiera | 03/Apr/2019 | Comunicati stampa
Giovedì 4 aprile 2019, il Rossini Jazz Club di Faenza ospita il concerto di The Latin Quarters, formazione composta da Luca Gardini al sax contralto, Mario Accardo al pianoforte, Filippo Lucchi al basso elettrico e Gianluca Berardi alla batteria. La rassegna diretta da Michele Francesconi si presenta in questa stagione con due cambiamenti sostanziali: il Bistrò Rossini di Piazza del Popolo è il nuovo “teatro” per i concerti che si terranno di giovedì. Resta immutato l’orario di inizio alle 22. Il concerto è ad ingresso libero.
The Latin Quarters è un progetto avviato nel 2008 come laboratorio di musiche folkloriche dell’America Latina e isole caraibiche diretto da Filippo Lucchi, insegnante di chitarra e tres cubano, all’interno delle attività didattiche della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli. In seguito, il progetto si è sviluppato come formazione stabile che utilizza l’incontro delle armonie e del linguaggio del jazz con il folklore latinoamericano, come tratto caratteristico.
Filippo Lucchi, in veste di bassista elettrico, si è avvalso della collaborazione di musicisti come il pianista Mario Accardo, il batterista Gianluca Berardi e il sassofonista Luca Gardini per proporre alcune rivisitazioni dei brani più celebri presenti nel repertorio di artisti del panorama attuale del latin jazz, come Paquito D’ Rivera, Claudio Roditi, Ray Barretto o Michel Camilo, e di temi classici di compositori come Ernesto Lecuona o Chano Pozo.
I ritmi provenienti da Cuba, Brasile, Puerto Rico e isole caraibiche sono perciò gli ingredienti delle esibizioni di The Latin Quarters e permettono al quartetto di condurre gli ascoltatori in un viaggio attraverso un mondo sonoro vasto e ricco di sfumature.
La rassegna musicale diretta da Michele Francesconi, dopo oltre dieci anni, cambia sede e si sposta al Bistrò Rossini che diventerà, ogni giovedì, il Rossini Jazz Club: la seconda importante novità riguarda proprio il giorno della settimana, si passa appunto al giovedì come giorno “assegnato” ai concerti. Resta invece immutato lo spirito che anima l’intero progetto: al direttore artistico Michele Francesconi e all’organizzazione generale di Gigi Zaccarini si unisce, da quest’anno, la passione e l’accoglienza dello staff del Bistrò Rossini e l’intenzione di offrire all’appassionato e competente pubblico faentino una stagione di concerti coerente con quanto proposto in passato.
Giovedì 11 aprile 2019, la stagione del Rossini Jazz Club si conclude con l’appuntamento affidato agli Allievi dei Corsi di Jazz della Scuola Sarti di Faenza.
Il Bistrò Rossini è a Faenza, in Piazza del Popolo, 22.








































































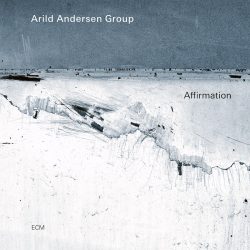 Arild Andersen Group – “Affirmation” – ECM
Arild Andersen Group – “Affirmation” – ECM Onur Aymergen Quintet – “Lunar” – Losen
Onur Aymergen Quintet – “Lunar” – Losen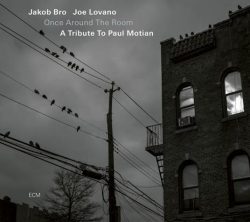 Jakob Bro, Joe Lovano –“Once Around The Room” – A Tribute to Paul Motian” – ECM
Jakob Bro, Joe Lovano –“Once Around The Room” – A Tribute to Paul Motian” – ECM Eik Trio – “Eik Trio” – Losen
Eik Trio – “Eik Trio” – Losen Mette Henriette – “Drifting” – ECM
Mette Henriette – “Drifting” – ECM Anders Jormin, Lena Willemark – “Pasado en claro” – ECM
Anders Jormin, Lena Willemark – “Pasado en claro” – ECM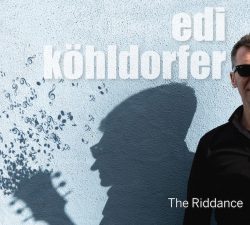 Edi Köhldorfer – “The Riddance” – Ats Records
Edi Köhldorfer – “The Riddance” – Ats Records Benjamin Lackner – “Last decade” – ECM
Benjamin Lackner – “Last decade” – ECM Ieremy Lirola – “Mock the Borders” –
Ieremy Lirola – “Mock the Borders” –  Stephan Micus – “Thunder” – ECM
Stephan Micus – “Thunder” – ECM Arvo Pärt – “Tintinnabuli” – Billant Corners
Arvo Pärt – “Tintinnabuli” – Billant Corners Sebastian Rochford, Kit Downes – “A Short Diary” – ECM
Sebastian Rochford, Kit Downes – “A Short Diary” – ECM Rubber Soul Quartet – “Something” – Losen
Rubber Soul Quartet – “Something” – Losen Salon Odjilà – “TangoRomaBalkanJazz” – ATS Records
Salon Odjilà – “TangoRomaBalkanJazz” – ATS Records Solis String Quartet & Sarah Jane Morris – “All You Need Is Love” – Irma
Solis String Quartet & Sarah Jane Morris – “All You Need Is Love” – Irma










 Nel jazz la coppia scoppia … di salute. È il caso di “Vola Vola”, l’album, edito da Caligola Records, in cui il bandoneon di Daniele Di Bonaventura sposa il pianoforte di Michele Di Toro nel mettere le ali a dieci brani esemplari dell’estetica musicale della partnership. Diceva Horacio Ferrer che “il bandoneon è una fatalità del tango”. Non solo tango, verrebbe da aggiungere ascoltando questo lavoro intitolato ad una delle canzoni abruzzesi più famose reinterpretata, fra le altre, su arrangiamento dello stesso bandoneonista. Perché un tale strumento dal suono struggente, se accostato ad una tastiera ispirata, anche quando fuoriesce dal ventre latino, amplia la gamma di possibilità espressive, per aprirsi ad una varietà sconfinata di opzioni.
Nel jazz la coppia scoppia … di salute. È il caso di “Vola Vola”, l’album, edito da Caligola Records, in cui il bandoneon di Daniele Di Bonaventura sposa il pianoforte di Michele Di Toro nel mettere le ali a dieci brani esemplari dell’estetica musicale della partnership. Diceva Horacio Ferrer che “il bandoneon è una fatalità del tango”. Non solo tango, verrebbe da aggiungere ascoltando questo lavoro intitolato ad una delle canzoni abruzzesi più famose reinterpretata, fra le altre, su arrangiamento dello stesso bandoneonista. Perché un tale strumento dal suono struggente, se accostato ad una tastiera ispirata, anche quando fuoriesce dal ventre latino, amplia la gamma di possibilità espressive, per aprirsi ad una varietà sconfinata di opzioni. Come zumare insomma inquadrare dei soggetti musicali tramite la macchina da presa uditiva? Facciamo l’esempio del canto femminile: qual è il contesto strumentale più idoneo a focalizzarne le doti? La soluzione proposta con il disco “Catch A Falling Star” della vocalist Alice Ricciardi col pianista Pietro Lussu è più che idonea: la voce, semplicemente cruda, affidata alla “cura” della tastiera, elettrica in questo caso. Beninteso la materia prima, quella canora, ed il contorno armonico della tastiera devono essere di prim’ordine perché il risultato sia adeguato alle aspettative.
Come zumare insomma inquadrare dei soggetti musicali tramite la macchina da presa uditiva? Facciamo l’esempio del canto femminile: qual è il contesto strumentale più idoneo a focalizzarne le doti? La soluzione proposta con il disco “Catch A Falling Star” della vocalist Alice Ricciardi col pianista Pietro Lussu è più che idonea: la voce, semplicemente cruda, affidata alla “cura” della tastiera, elettrica in questo caso. Beninteso la materia prima, quella canora, ed il contorno armonico della tastiera devono essere di prim’ordine perché il risultato sia adeguato alle aspettative. Sembra alquanto inusuale la struttura binomica del piccolo gruppo formato dal trombettista John Deutsch – Grammy Award 2019 per il miglior album latin jazz – con Nico Soffiato alla chitarra baritona. Il duo, artisticamente nato a Boston, nel terzo disco, Redshift appena edito da Nusica.org, si arricchisce di loop, sinth e sovratracce, e si “rinforza” in diversi brani grazie alla presenza “extra” di due batteristi come Allison Miller alternato a Dan Weiss. Dunque un duo plus se si considera il featuring degli ospiti citati che vanno a ben incidere sulla tenuta ritmico-percussiva delle esecuzioni senza per questo minimizzare la validità del costrutto sonoro impastato dalla coppia leader. Il sodalizio ultradecennale di Josh e Nico si basa su una “bilancia” musicale, in bilico fra acustica ed elettronica, su due creste, estetica jazz/rock/pop ed anima classica (“44.2” è un riarrangiamento da Robert Schumann mentre “John My Beloved” è la nota cover di Sufjan Stevens laddove con “Paul” siamo nell’indie rock degli statunitensi Big Thief). Le composizioni di Soffiato si distinguono per scelta sussequenziale di accordi funzionali allo sviluppo melodico ed ad impro contenute (“Endnote”, “Remember”) con qualche deviazione funky (“Tooch Taach”). Dal canto suo il Deutsch autore si caratterizza per l’ondeggiare gravitazionale della tromba che va ad illuminare di rossastro gli antri sonori di “Time Lapse” o le luci basse di “Arrival” mentre in “Triad Tune” e nella stessa “Consolation Prize”, scritta a quattro mani col chitarrista, dà sfogo ad un eloquio modulato e intenso, istintivo e profondo, per rimanere a descrizioni “dual”. Il tutto viene shakerato avendo sullo sfondo la skyline di New York, metropoli in cui i nostri eroi si sono da tempo trasferiti assorbendone in pieno lo spirito innovativo. Da precisare che Redshift, oltre ad essere il nome della storica band inglese fondata da Mark Shreeve, sta ad indicare la maggiore lunghezza d’onda di un qualcosa che si allontana. Da qui il richiamo subliminale al gioco più/meno di frequenze del duo in questione.
Sembra alquanto inusuale la struttura binomica del piccolo gruppo formato dal trombettista John Deutsch – Grammy Award 2019 per il miglior album latin jazz – con Nico Soffiato alla chitarra baritona. Il duo, artisticamente nato a Boston, nel terzo disco, Redshift appena edito da Nusica.org, si arricchisce di loop, sinth e sovratracce, e si “rinforza” in diversi brani grazie alla presenza “extra” di due batteristi come Allison Miller alternato a Dan Weiss. Dunque un duo plus se si considera il featuring degli ospiti citati che vanno a ben incidere sulla tenuta ritmico-percussiva delle esecuzioni senza per questo minimizzare la validità del costrutto sonoro impastato dalla coppia leader. Il sodalizio ultradecennale di Josh e Nico si basa su una “bilancia” musicale, in bilico fra acustica ed elettronica, su due creste, estetica jazz/rock/pop ed anima classica (“44.2” è un riarrangiamento da Robert Schumann mentre “John My Beloved” è la nota cover di Sufjan Stevens laddove con “Paul” siamo nell’indie rock degli statunitensi Big Thief). Le composizioni di Soffiato si distinguono per scelta sussequenziale di accordi funzionali allo sviluppo melodico ed ad impro contenute (“Endnote”, “Remember”) con qualche deviazione funky (“Tooch Taach”). Dal canto suo il Deutsch autore si caratterizza per l’ondeggiare gravitazionale della tromba che va ad illuminare di rossastro gli antri sonori di “Time Lapse” o le luci basse di “Arrival” mentre in “Triad Tune” e nella stessa “Consolation Prize”, scritta a quattro mani col chitarrista, dà sfogo ad un eloquio modulato e intenso, istintivo e profondo, per rimanere a descrizioni “dual”. Il tutto viene shakerato avendo sullo sfondo la skyline di New York, metropoli in cui i nostri eroi si sono da tempo trasferiti assorbendone in pieno lo spirito innovativo. Da precisare che Redshift, oltre ad essere il nome della storica band inglese fondata da Mark Shreeve, sta ad indicare la maggiore lunghezza d’onda di un qualcosa che si allontana. Da qui il richiamo subliminale al gioco più/meno di frequenze del duo in questione.




