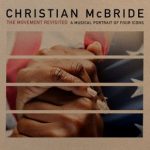da Gerlando Gatto | 21/Mag/2020 | I nostri CD, Primo piano, Recensioni

Massimo Barbiero – “Woland – Omaggio a ‘Il maestro e Margherita’” – Autoprodotto
 Massimo Barbiero, batterista e percussionista, è senza dubbio uno dei musicisti italiani più coerenti e originali, senza che, a tutt’oggi, abbia ottenuto i riconoscimenti che merita. Anche questo suo ultimo album si inserisce nell’ambito di quelle produzioni di qualità cui l’artista ci ha abituati oramai da molti anni. L’organico è un trio con Eloisa Manera al violino ed al violino elettrico a cinque corde e Emanuele Sartoris al pianoforte. In repertorio dieci brani che sostanziano un omaggio a “Il maestro e Margherita” di Bulgakov, uno dei più importanti lavori del Novecento letterario, e “Woland” è uno dei nomi germanici del Diavolo, ed è anche il nome (in russo Воланд) di uno dei personaggi chiave di questo romanzo. Quindi un concept album in cui la sapienza compositiva di Barbiero trova ancora una volta il modo di esplicarsi appieno, anche se questa volta il carico compositivo è ripartito egualmente fra i tre artisti. Ammesso e non concesso che sia ancora importante definire ciò che si ascolta, incasellarlo in una cornice predeterminata, ebbene con la musica di questo album tutto ciò non è possibile. Non è jazz propriamente detto, non è musica colta nell’accezione del termine ma una sorta di percorso tra culture musicali diverse, alle volte molto diverse. E sta proprio qui la bravura dei musicisti che nulla concedono al facile ascolto riuscendo comunque a conquistare l’attenzione dell’ascoltatore sin dal brano d’apertura, “Abadonna” di Massimo Barbiero, in cui violino e pianoforte quasi si inseguono su un terreno accidentato che taluni hanno voluto accostare ad atmosfere impressioniste. In “Margherita”, sempre di Massimo Barbiero, è soprattutto il violino, ben supportato dal tappeto ritmico disegnato dal leader, a dettare le atmosfere del brano, questa volta più leggibili e narrative, in cui si avvertono echi sia di Vivaldi sia di Paganini. Di livello anche la suite in tre parti, di undici minuti, “Suite dei tre demoni” di Eloisa Manera, sempre in bilico fra scrittura ed improvvisazione, come del resto l’intero disco. La conclusione è affidata ad una composizione di Sartoris, “Pilato, potere temporale”, in cui il pianismo dell’autore si evidenzia in tutta la sua essenzialità, ben lontana da qualsivoglia esibizionismo.
Massimo Barbiero, batterista e percussionista, è senza dubbio uno dei musicisti italiani più coerenti e originali, senza che, a tutt’oggi, abbia ottenuto i riconoscimenti che merita. Anche questo suo ultimo album si inserisce nell’ambito di quelle produzioni di qualità cui l’artista ci ha abituati oramai da molti anni. L’organico è un trio con Eloisa Manera al violino ed al violino elettrico a cinque corde e Emanuele Sartoris al pianoforte. In repertorio dieci brani che sostanziano un omaggio a “Il maestro e Margherita” di Bulgakov, uno dei più importanti lavori del Novecento letterario, e “Woland” è uno dei nomi germanici del Diavolo, ed è anche il nome (in russo Воланд) di uno dei personaggi chiave di questo romanzo. Quindi un concept album in cui la sapienza compositiva di Barbiero trova ancora una volta il modo di esplicarsi appieno, anche se questa volta il carico compositivo è ripartito egualmente fra i tre artisti. Ammesso e non concesso che sia ancora importante definire ciò che si ascolta, incasellarlo in una cornice predeterminata, ebbene con la musica di questo album tutto ciò non è possibile. Non è jazz propriamente detto, non è musica colta nell’accezione del termine ma una sorta di percorso tra culture musicali diverse, alle volte molto diverse. E sta proprio qui la bravura dei musicisti che nulla concedono al facile ascolto riuscendo comunque a conquistare l’attenzione dell’ascoltatore sin dal brano d’apertura, “Abadonna” di Massimo Barbiero, in cui violino e pianoforte quasi si inseguono su un terreno accidentato che taluni hanno voluto accostare ad atmosfere impressioniste. In “Margherita”, sempre di Massimo Barbiero, è soprattutto il violino, ben supportato dal tappeto ritmico disegnato dal leader, a dettare le atmosfere del brano, questa volta più leggibili e narrative, in cui si avvertono echi sia di Vivaldi sia di Paganini. Di livello anche la suite in tre parti, di undici minuti, “Suite dei tre demoni” di Eloisa Manera, sempre in bilico fra scrittura ed improvvisazione, come del resto l’intero disco. La conclusione è affidata ad una composizione di Sartoris, “Pilato, potere temporale”, in cui il pianismo dell’autore si evidenzia in tutta la sua essenzialità, ben lontana da qualsivoglia esibizionismo.
Francesco Bearzatti / Carmine Ioanna – “Favolando” – artesuono 186
 Carmine Ioanna, fisarmonicista d’origine irpina, e Francesco Bearzatti, sassofonista e clarinettista cresciuto nella provincia friulana, sono i “responsabili” di questo godibile album. Il titolo riflette la predilezione dei due artisti per raccontare, attraverso la musica, storie, in questo caso specifico ‘favole’. Il sodalizio nasce due anni or sono sulla base della comune volontà di improvvisare divertendosi e questa caratteristica si coglie appieno ascoltando l’album, declinato attraverso composizioni dei due artisti, un brano tratto dalla tradizione dell’Azerbaijan e tre improvvisazioni espressamente dichiarate come tali. Neppure per un attimo si avverte la sensazione che l’uno voglia prevaricare l’altro ma, sottolinea Ioanna, – siamo “due persone che si amano, si completano, non si sovrappongono mai perché vanno nella stessa direzione”. “Soprattutto c’è, secondo me, – ribadisce Bearzatti – una bella mescolanza di ego, nel senso che non c’è nessuno che sovrasta l’altro”. Una musica, quindi, che ci consegna due artisti in grado di improvvisare costantemente, mai perdendo il bandolo della matassa, anzi continuando a sviluppare un discorso sempre coerente e con tale intensità da non far rimpiangere la mancanza degli altri strumenti. Sassofono e fisarmonica, nella mani dei due artisti, riescono a produrre una massa sonora spesso di tipo orchestrale che si inserisce in una atmosfera davvero magica, “da favola” per riportarci al titolo dell’album, in cui si avvertono echi della musica popolare così come del jazz, della musica contemporanea, della world music. Il tutto, sottolinea ancora Bearzatti, per aprire delle piccole brecce, non già per fare musica di massa, e per puntare al grande pubblico.
Carmine Ioanna, fisarmonicista d’origine irpina, e Francesco Bearzatti, sassofonista e clarinettista cresciuto nella provincia friulana, sono i “responsabili” di questo godibile album. Il titolo riflette la predilezione dei due artisti per raccontare, attraverso la musica, storie, in questo caso specifico ‘favole’. Il sodalizio nasce due anni or sono sulla base della comune volontà di improvvisare divertendosi e questa caratteristica si coglie appieno ascoltando l’album, declinato attraverso composizioni dei due artisti, un brano tratto dalla tradizione dell’Azerbaijan e tre improvvisazioni espressamente dichiarate come tali. Neppure per un attimo si avverte la sensazione che l’uno voglia prevaricare l’altro ma, sottolinea Ioanna, – siamo “due persone che si amano, si completano, non si sovrappongono mai perché vanno nella stessa direzione”. “Soprattutto c’è, secondo me, – ribadisce Bearzatti – una bella mescolanza di ego, nel senso che non c’è nessuno che sovrasta l’altro”. Una musica, quindi, che ci consegna due artisti in grado di improvvisare costantemente, mai perdendo il bandolo della matassa, anzi continuando a sviluppare un discorso sempre coerente e con tale intensità da non far rimpiangere la mancanza degli altri strumenti. Sassofono e fisarmonica, nella mani dei due artisti, riescono a produrre una massa sonora spesso di tipo orchestrale che si inserisce in una atmosfera davvero magica, “da favola” per riportarci al titolo dell’album, in cui si avvertono echi della musica popolare così come del jazz, della musica contemporanea, della world music. Il tutto, sottolinea ancora Bearzatti, per aprire delle piccole brecce, non già per fare musica di massa, e per puntare al grande pubblico.
Black Coffee & Martine Thomas – “Once Upon A Time” – Caligola 2273
 Ecco un album raffinato, oserei dire in alcuni momenti sofisticato, in cui si privilegia senza remora alcuna la ricerca della bella melodia. Di qui un repertorio che spazia da alcuni temi cari agli appassionati di jazz (uno per tutti “My Favorite Things”), alla canzone francese, rappresentata da ben quattro titoli (“Et maintenant” di Gilbert Bécaud, “Ne me quitte pas” di Jacques Brel, “L’hymne à l’amour” di Edith Piaf e “La Bohème” di Charles Aznavour), dalla black music (“I Can’t Help It” di Stevie Wonder e Susaye Greene) ad esplicite reminiscenze blues (“Butterfly” di Herbie Hancock)… alle atmosfere vagamente brasiliane di “The Island” di Ivan Lins, Marilyn e Alan Bergman,… con l’aggiunta di due intermezzi strumentali “End of Chapter One e Two”. A cucinare questa gustosa ricetta sono la cantante americana di origini haitiane Martine Thomas che attualmente vive a Zara, coadiuvata dai Black Coffee, il trio croato costituito da Renato Švorinić, bassista e leader, dal pianista Ivan Ivić e dal batterista Jadran Dučić, cui si aggiungono come special guests Daniele di Bonaventura, bandoneon, presente solo in “Et maintenant”, e Massimo Donà, la cui tromba si ascolta in quattro tracce. Vista la varietà dei brani si potrebbe temere una certa disomogeneità dell’album. Invece “Once Upon A Time” mantiene una sua intrinseca coerenza derivante dal come il gruppo approccia la materia: innanzitutto la ferma volontà di rispettare le linee melodiche dei vari pezzi cui si aggiungono i sapidi arrangiamenti di Renato Švorinić e Ivan Ivić. E il discorso appare quanto mai evidente soprattutto nei quattro pezzi francesi interpretati con gusto ed eleganza dalla Thomas e impreziositi da arrangiamenti mai banali. In questo senso particolarmente apprezzabile è anche la versione di “I Can’t Help It” con un centrato assolo di Ivić al piano elettrico.
Ecco un album raffinato, oserei dire in alcuni momenti sofisticato, in cui si privilegia senza remora alcuna la ricerca della bella melodia. Di qui un repertorio che spazia da alcuni temi cari agli appassionati di jazz (uno per tutti “My Favorite Things”), alla canzone francese, rappresentata da ben quattro titoli (“Et maintenant” di Gilbert Bécaud, “Ne me quitte pas” di Jacques Brel, “L’hymne à l’amour” di Edith Piaf e “La Bohème” di Charles Aznavour), dalla black music (“I Can’t Help It” di Stevie Wonder e Susaye Greene) ad esplicite reminiscenze blues (“Butterfly” di Herbie Hancock)… alle atmosfere vagamente brasiliane di “The Island” di Ivan Lins, Marilyn e Alan Bergman,… con l’aggiunta di due intermezzi strumentali “End of Chapter One e Two”. A cucinare questa gustosa ricetta sono la cantante americana di origini haitiane Martine Thomas che attualmente vive a Zara, coadiuvata dai Black Coffee, il trio croato costituito da Renato Švorinić, bassista e leader, dal pianista Ivan Ivić e dal batterista Jadran Dučić, cui si aggiungono come special guests Daniele di Bonaventura, bandoneon, presente solo in “Et maintenant”, e Massimo Donà, la cui tromba si ascolta in quattro tracce. Vista la varietà dei brani si potrebbe temere una certa disomogeneità dell’album. Invece “Once Upon A Time” mantiene una sua intrinseca coerenza derivante dal come il gruppo approccia la materia: innanzitutto la ferma volontà di rispettare le linee melodiche dei vari pezzi cui si aggiungono i sapidi arrangiamenti di Renato Švorinić e Ivan Ivić. E il discorso appare quanto mai evidente soprattutto nei quattro pezzi francesi interpretati con gusto ed eleganza dalla Thomas e impreziositi da arrangiamenti mai banali. In questo senso particolarmente apprezzabile è anche la versione di “I Can’t Help It” con un centrato assolo di Ivić al piano elettrico.
Felice Clemente – “Solo” – Crocevia di suoni 018
 Affrontare la registrazione di un album per sole ance è impresa quanto mai difficile da cui sono usciti indenni solo alcuni grandissimi personaggi quali Sonny Rollins, Steve Lacy, Lee Konitz, Anthony Braxton. In questo album ascoltiamo un artista italiano, Felice Clemente, che usa sax tenore, sax soprano e clarinetto, in una registrazione effettuata nella chiesa settecentesca di Montecalvo Versiggia il 15 e 16 novembre del 2019. La scelta della location non è stata casuale o indifferente: in effetti, come acutamente sottolinea Paolo Fresu nelle note che accompagnano l’album, la dimensione armonica di un solo di sax e clarinetto si esplica nella magia dei rimandi di echi e riverberi, che traggono spunto dalla navata e dalle arcate di una chiesa o di una basilica. Quasi a dimostrare quanto il fitto dialogo tra gli strumenti e il luogo che li accoglie sia frutto di un “antico matrimonio che appartiene alla storia dell’uomo”. Ecco quindi come, grazie anche ad una presa di suono eccellente, sia possibile apprezzare in tutta la loro bellezza queste architravi sonore rette da echi, riverberi che solo in un ambiente come quello di una chiesa (ovviamente con caratteristiche particolari) sarebbe stato possibile ottenere. Ma tutto ciò non sarebbe stato possibile se non ci fosse stata anche e soprattutto la valentia di Felice Clemente compositore, arrangiatore, esecutore di grande raffinatezza che ha voluto disegnare un percorso non facile attraverso un repertorio che parte da un classico del jazz, “Harlem Nocturne” di Hearle Hagen per concludersi con una libera improvvisazione, passando attraverso tre sue composizioni originali, e brani di Branford Marsalis, Godard, Morricone, Nuzzolese, Di Gregorio, Javier Perz Forte e Bach.
Affrontare la registrazione di un album per sole ance è impresa quanto mai difficile da cui sono usciti indenni solo alcuni grandissimi personaggi quali Sonny Rollins, Steve Lacy, Lee Konitz, Anthony Braxton. In questo album ascoltiamo un artista italiano, Felice Clemente, che usa sax tenore, sax soprano e clarinetto, in una registrazione effettuata nella chiesa settecentesca di Montecalvo Versiggia il 15 e 16 novembre del 2019. La scelta della location non è stata casuale o indifferente: in effetti, come acutamente sottolinea Paolo Fresu nelle note che accompagnano l’album, la dimensione armonica di un solo di sax e clarinetto si esplica nella magia dei rimandi di echi e riverberi, che traggono spunto dalla navata e dalle arcate di una chiesa o di una basilica. Quasi a dimostrare quanto il fitto dialogo tra gli strumenti e il luogo che li accoglie sia frutto di un “antico matrimonio che appartiene alla storia dell’uomo”. Ecco quindi come, grazie anche ad una presa di suono eccellente, sia possibile apprezzare in tutta la loro bellezza queste architravi sonore rette da echi, riverberi che solo in un ambiente come quello di una chiesa (ovviamente con caratteristiche particolari) sarebbe stato possibile ottenere. Ma tutto ciò non sarebbe stato possibile se non ci fosse stata anche e soprattutto la valentia di Felice Clemente compositore, arrangiatore, esecutore di grande raffinatezza che ha voluto disegnare un percorso non facile attraverso un repertorio che parte da un classico del jazz, “Harlem Nocturne” di Hearle Hagen per concludersi con una libera improvvisazione, passando attraverso tre sue composizioni originali, e brani di Branford Marsalis, Godard, Morricone, Nuzzolese, Di Gregorio, Javier Perz Forte e Bach.
Cordoba Reunion – “Sì” – abeat 214
 Ecco un altro gradevole album firmato Cordoba Reunion, ovvero il prestigioso quartetto costituito da musicisti tutti nativi della stessa città, Cordoba, ma residenti in paesi diversi (Francia, Italia e Argentina): Javier Girotto ai sassofoni, Gerardo Di Giusto al piano, Gabriel “Minino” Garay percussioni e batteria e Carlos “El Tero” Buschini basso e guembri. Registrato a Milano nel marzo del 2019, l’album contiene undici tracce di cui nove firmate dagli stessi membri del gruppo e due da Julien Lourau un sassofonista francese classe 1970. Come già nei precedenti album, “Argentina Jazz” del 2004 e “Sin lugar a dudas” del 2008, il gruppo si muove su direttrici molto ben individuabili: uno straordinario mix tra tanghi, milonghe e chacareras da un lato, jazz, improvvisazione, sperimentazione dall’altro. Evidentemente una impresa così difficile può essere intrapresa con un minimo di possibilità di successo solo se ad affrontarla sono musicisti che coniugano una spiccata personalità individuale con una capacità di rapportarsi ai compagni d’avventura. Ebbene i quattro musicisti in oggetto possiedono ambedue queste doti essendo tecnicamente molto ferrati ma allo stesso tempo capaci di condurre il discorso musicale sulla base di una profonda empatia. Risultato: un latin-jazz assolutamente coinvolgente che risponde ad un progetto musicale in cui la ricchezza ritmica della musica argentina, seppur ancorata al ricco patrimonio folklorico del Paese, dimostra come la stessa non sia solo tango e milonga, ma molto, molto di più.
Ecco un altro gradevole album firmato Cordoba Reunion, ovvero il prestigioso quartetto costituito da musicisti tutti nativi della stessa città, Cordoba, ma residenti in paesi diversi (Francia, Italia e Argentina): Javier Girotto ai sassofoni, Gerardo Di Giusto al piano, Gabriel “Minino” Garay percussioni e batteria e Carlos “El Tero” Buschini basso e guembri. Registrato a Milano nel marzo del 2019, l’album contiene undici tracce di cui nove firmate dagli stessi membri del gruppo e due da Julien Lourau un sassofonista francese classe 1970. Come già nei precedenti album, “Argentina Jazz” del 2004 e “Sin lugar a dudas” del 2008, il gruppo si muove su direttrici molto ben individuabili: uno straordinario mix tra tanghi, milonghe e chacareras da un lato, jazz, improvvisazione, sperimentazione dall’altro. Evidentemente una impresa così difficile può essere intrapresa con un minimo di possibilità di successo solo se ad affrontarla sono musicisti che coniugano una spiccata personalità individuale con una capacità di rapportarsi ai compagni d’avventura. Ebbene i quattro musicisti in oggetto possiedono ambedue queste doti essendo tecnicamente molto ferrati ma allo stesso tempo capaci di condurre il discorso musicale sulla base di una profonda empatia. Risultato: un latin-jazz assolutamente coinvolgente che risponde ad un progetto musicale in cui la ricchezza ritmica della musica argentina, seppur ancorata al ricco patrimonio folklorico del Paese, dimostra come la stessa non sia solo tango e milonga, ma molto, molto di più.
Fausto Ferraiuolo – “Il dono” – abeat 212
 La genesi di questo album viene esplicitata dallo stesso leader laddove afferma da un canto che il progetto è nato dall’incontro con Jeff Ballard conosciuto molti anni addietro durante una masterclass a Siena, dall’altro che “Il dono” è per lui quello dell’incontro, per cui “donare o ricevere sono due aspetti dello stesso gesto”. Gesto che si concretizza in questo album in cui il musicista napoletano, ben sostenuto da Aldo Vigorito al basso, suo ‘storico’ compagno d’avventure musicali, e dal già citato Jeff Ballard alla batteria (particolarmente importante la sua militanza nel trio di Brad Meldhau), presenta undici brani tutti di sua composizione, eccezion fatta per “O Impro Mio” (Ferraiuolo-Vigorito-Ballard), “Improtune” (Ferraiuolo-Vigorito-Ballard) e “Somebody Loves Me” (George Gershwin). I pezzi originali, per esplicita ammissione dello stesso pianista, sono dedicati alle persone a lui più care. La caratura dell’album appare evidente sin dal primo brano, “Fire Island”: i tre si muovono su un piano di assoluta parità ritagliandosi spazi appropriati (ad esempio in questo brano possiamo già gustare un preciso e gustoso assolo di Aldo Vigorito). Nasce da qui una musica che si inscrive nell’alveo del jazz canonico, con improvvisazioni serrate (particolarmente azzeccata quella sulla falsa riga di “O sole mio” trasformato in “O impro mio”), scambi trascinanti, ricerca di suadenti linee melodiche (particolarmente apprezzate da chi scrive quelle di “4 Septembre” e “C’est tout”) mentre in “Baires” specie nella parte finale si avverte una certa influenza ‘tanguera”. Infine “Improtune” si avventura su terreni contigui al free per tornare ad atmosfere più consuete con la convincente interpretazione del gershwiano “Somebody Loves Me”.
La genesi di questo album viene esplicitata dallo stesso leader laddove afferma da un canto che il progetto è nato dall’incontro con Jeff Ballard conosciuto molti anni addietro durante una masterclass a Siena, dall’altro che “Il dono” è per lui quello dell’incontro, per cui “donare o ricevere sono due aspetti dello stesso gesto”. Gesto che si concretizza in questo album in cui il musicista napoletano, ben sostenuto da Aldo Vigorito al basso, suo ‘storico’ compagno d’avventure musicali, e dal già citato Jeff Ballard alla batteria (particolarmente importante la sua militanza nel trio di Brad Meldhau), presenta undici brani tutti di sua composizione, eccezion fatta per “O Impro Mio” (Ferraiuolo-Vigorito-Ballard), “Improtune” (Ferraiuolo-Vigorito-Ballard) e “Somebody Loves Me” (George Gershwin). I pezzi originali, per esplicita ammissione dello stesso pianista, sono dedicati alle persone a lui più care. La caratura dell’album appare evidente sin dal primo brano, “Fire Island”: i tre si muovono su un piano di assoluta parità ritagliandosi spazi appropriati (ad esempio in questo brano possiamo già gustare un preciso e gustoso assolo di Aldo Vigorito). Nasce da qui una musica che si inscrive nell’alveo del jazz canonico, con improvvisazioni serrate (particolarmente azzeccata quella sulla falsa riga di “O sole mio” trasformato in “O impro mio”), scambi trascinanti, ricerca di suadenti linee melodiche (particolarmente apprezzate da chi scrive quelle di “4 Septembre” e “C’est tout”) mentre in “Baires” specie nella parte finale si avverte una certa influenza ‘tanguera”. Infine “Improtune” si avventura su terreni contigui al free per tornare ad atmosfere più consuete con la convincente interpretazione del gershwiano “Somebody Loves Me”.
Tommaso Gambini – “The Machine Stops” – Workin’ Label 37
 Ecco un’altra prima discografica: protagonista il chitarrista Tommaso Gambini torinese ma newyorkese di adozione, alla testa di un gruppo ad organico variabile composto dai suoi abituali collaboratori Manuel Schmiedel al pianoforte, Ben Tiberio al contrabbasso e Adam Arruda alla batteria cui si aggiungono l’alto sassofonista olandese Ben Van Gelder, il tenor sassofonista e compositore americano Dayna Stephens, il clarinettista Jacopo Albini e la flautista Anggie Obin. In scaletta sette brani tutti firmati dal chitarrista, e riferiti al racconto omonimo dello scrittore inglese Edward Morgan Forster del 1909, racconto che paradossalmente sembra avere molti punti di contatto con la tragica realtà di oggi. Forster parla di una Macchina inventata dall’uomo che prende il sopravvento sulla nostra stessa volontà; sostituite i termini Macchina con Virus e il gioco è fatto. Quindi, almeno sulla carta, si tratta di un concept album. Ma, come al solito in questi casi si pone l’interrogativo: è riuscita la musica a tradurre in suoni tali concetti? Francamente non del tutto; non ho sentito quel clima, cupo, drammatico che forse meglio si sarebbe attagliato alla situazione di cui sopra. Ad onor del vero, il brano d’apertura, anche grazie all’inserto parlato tratto dal volume in oggetto, riflette bene il clima dello stesso ma nei brani successivi è come se l’atmosfera si addolcisse e quindi la tensione si allentasse. Comunque, onestamente, non ho letto il racconto per cui potrebbe darsi che anche i successivi pezzi riflettano in qualche modo i contenuti dello scritto. Ma tutto ciò è abbastanza irrilevante in quanto poco toglie alla valenza dell’album che risulta apprezzabile: Gambini scrive bene, arrangia altrettanto bene e come chitarrista si è fatto ampiamente conoscere collaborando con jazzisti quali Antonio Sanchez, George Garzone, Miguel Zenon e non si lavora con personaggi del genere se non sei più che bravo.
Ecco un’altra prima discografica: protagonista il chitarrista Tommaso Gambini torinese ma newyorkese di adozione, alla testa di un gruppo ad organico variabile composto dai suoi abituali collaboratori Manuel Schmiedel al pianoforte, Ben Tiberio al contrabbasso e Adam Arruda alla batteria cui si aggiungono l’alto sassofonista olandese Ben Van Gelder, il tenor sassofonista e compositore americano Dayna Stephens, il clarinettista Jacopo Albini e la flautista Anggie Obin. In scaletta sette brani tutti firmati dal chitarrista, e riferiti al racconto omonimo dello scrittore inglese Edward Morgan Forster del 1909, racconto che paradossalmente sembra avere molti punti di contatto con la tragica realtà di oggi. Forster parla di una Macchina inventata dall’uomo che prende il sopravvento sulla nostra stessa volontà; sostituite i termini Macchina con Virus e il gioco è fatto. Quindi, almeno sulla carta, si tratta di un concept album. Ma, come al solito in questi casi si pone l’interrogativo: è riuscita la musica a tradurre in suoni tali concetti? Francamente non del tutto; non ho sentito quel clima, cupo, drammatico che forse meglio si sarebbe attagliato alla situazione di cui sopra. Ad onor del vero, il brano d’apertura, anche grazie all’inserto parlato tratto dal volume in oggetto, riflette bene il clima dello stesso ma nei brani successivi è come se l’atmosfera si addolcisse e quindi la tensione si allentasse. Comunque, onestamente, non ho letto il racconto per cui potrebbe darsi che anche i successivi pezzi riflettano in qualche modo i contenuti dello scritto. Ma tutto ciò è abbastanza irrilevante in quanto poco toglie alla valenza dell’album che risulta apprezzabile: Gambini scrive bene, arrangia altrettanto bene e come chitarrista si è fatto ampiamente conoscere collaborando con jazzisti quali Antonio Sanchez, George Garzone, Miguel Zenon e non si lavora con personaggi del genere se non sei più che bravo.
Erroll Garner – “Octave” – Mack Avenue 02
 Erroll Garner è sicuramente uno dei giganti della musica jazz. La “Octave Remastered Series”, prodotta da Peter Lockhart e Steve Rosenthal, continua a riproporre alcune delle perle di questo straordinario pianista. Questo ultimo album include nove pezzi tratti da tre album “That’s My Kick” registrato nel 1967 con Milt Hinton basso, Herbert Lovelle e George Jenkins batteria, José Mangual e Johnny Pacheco congas, Wally Richardson e Art Ryerson chitarra; “Up In Erroll’s Room” del novembre dello stesso 1967 con Ike Isaacs basso, Jimmie Smith batteria, Jose Mangual congas featuring “The Brass Bed”; e “Feeling Is Believing” del 1969 con Wally Richardson chitarra, Joe Cocuzzo, Jimmie Smith e Charlie Persip batteria, Jose Mangual congas, Jerry Jemmott e George Duvivier basso. Per chi conosce il jazz, credo bastino solo queste note per comprendere come si tratti di musica di assoluta livello, registrata quando il pianista di Pittsburgh stava vivendo uno dei suoi tanti momenti positivi. In particolare i brani contenuti nell’album ci mostrano un Garner alla testa di formazioni diverse ma che sempre sono in grado di seguire con partecipazione le idee del leader, il cui pianismo, smagliante, mai conosce un attimo di stasi, di indecisione. E siamo sicuri che anche l’ascolto di questo album aprirà una dialettica, a mio avviso del tutto inutile, tra chi considera Garner un assoluto genio musicale (ed io sono tra questi) e chi invece lo valuta pianista di eccellente tecnica ma troppo dedito a inutili virtuosismi.
Erroll Garner è sicuramente uno dei giganti della musica jazz. La “Octave Remastered Series”, prodotta da Peter Lockhart e Steve Rosenthal, continua a riproporre alcune delle perle di questo straordinario pianista. Questo ultimo album include nove pezzi tratti da tre album “That’s My Kick” registrato nel 1967 con Milt Hinton basso, Herbert Lovelle e George Jenkins batteria, José Mangual e Johnny Pacheco congas, Wally Richardson e Art Ryerson chitarra; “Up In Erroll’s Room” del novembre dello stesso 1967 con Ike Isaacs basso, Jimmie Smith batteria, Jose Mangual congas featuring “The Brass Bed”; e “Feeling Is Believing” del 1969 con Wally Richardson chitarra, Joe Cocuzzo, Jimmie Smith e Charlie Persip batteria, Jose Mangual congas, Jerry Jemmott e George Duvivier basso. Per chi conosce il jazz, credo bastino solo queste note per comprendere come si tratti di musica di assoluta livello, registrata quando il pianista di Pittsburgh stava vivendo uno dei suoi tanti momenti positivi. In particolare i brani contenuti nell’album ci mostrano un Garner alla testa di formazioni diverse ma che sempre sono in grado di seguire con partecipazione le idee del leader, il cui pianismo, smagliante, mai conosce un attimo di stasi, di indecisione. E siamo sicuri che anche l’ascolto di questo album aprirà una dialettica, a mio avviso del tutto inutile, tra chi considera Garner un assoluto genio musicale (ed io sono tra questi) e chi invece lo valuta pianista di eccellente tecnica ma troppo dedito a inutili virtuosismi.
Giulio Gentile / Emanuela Di Benedetto – “There’s no Place Like Home” – artesuono 192
 Album d’esordio per il pianista Giulio Gentile e la vocalist Emanuela Di Benedetto che da giovani appassionati di musica Jazz, hanno poi studiato al dipartimento Jazz del Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara. Il duo nasce nel 2012 e si fortifica attraverso la partecipazione a numerosi festival, tra cui “MuntagninJazz”, “La Settimana Mozartiana”, il “Castelbuono Jazz Festival”, la rassegna “Sabato in Concerto Jazz” per “Archivi Sonori”. Presto arrivano anche i primi riconoscimenti come il Premio “BEST BAND” al “Bucharest International Jazz Competition 2016”, l’affermazione al “Premio Marco Tamburini 2016” per la sezione band mentre nel 2017 sono vincitori del “Premio Nazionale delle Arti” sezione Jazz tenutosi a Milano Logico, quindi, che si giungesse a questo primo album il cui organico è completato dal batterista Marcello Di Leonardo, dal bassista Luca Bulgarelli, dal sassofonista Manuel Trabucco e dal flicornista Jorge Ro. In repertorio otto brani con musica di Gentile e testi della vocalist. Tenendo conto che si tratta di una ‘prima’ assoluta, l’album presenta note positive riscontrabili soprattutto nella bella intesa tra voce e pianoforte, nella delicatezza dei temi proposti, nella eleganza con cui si manifesta l’amore per la musica e nell’attenzione con cui si guarda alla realtà di oggi. Ecco quindi un omaggio alla città di New York da parte di una giovane donna, una dichiarazione d’amore verso una natura che si vorrebbe più tutelata, un grido di dolore per la lontananza dell’amato/a, un ritratto dell’emigrazione ricco di poesia.
Album d’esordio per il pianista Giulio Gentile e la vocalist Emanuela Di Benedetto che da giovani appassionati di musica Jazz, hanno poi studiato al dipartimento Jazz del Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara. Il duo nasce nel 2012 e si fortifica attraverso la partecipazione a numerosi festival, tra cui “MuntagninJazz”, “La Settimana Mozartiana”, il “Castelbuono Jazz Festival”, la rassegna “Sabato in Concerto Jazz” per “Archivi Sonori”. Presto arrivano anche i primi riconoscimenti come il Premio “BEST BAND” al “Bucharest International Jazz Competition 2016”, l’affermazione al “Premio Marco Tamburini 2016” per la sezione band mentre nel 2017 sono vincitori del “Premio Nazionale delle Arti” sezione Jazz tenutosi a Milano Logico, quindi, che si giungesse a questo primo album il cui organico è completato dal batterista Marcello Di Leonardo, dal bassista Luca Bulgarelli, dal sassofonista Manuel Trabucco e dal flicornista Jorge Ro. In repertorio otto brani con musica di Gentile e testi della vocalist. Tenendo conto che si tratta di una ‘prima’ assoluta, l’album presenta note positive riscontrabili soprattutto nella bella intesa tra voce e pianoforte, nella delicatezza dei temi proposti, nella eleganza con cui si manifesta l’amore per la musica e nell’attenzione con cui si guarda alla realtà di oggi. Ecco quindi un omaggio alla città di New York da parte di una giovane donna, una dichiarazione d’amore verso una natura che si vorrebbe più tutelata, un grido di dolore per la lontananza dell’amato/a, un ritratto dell’emigrazione ricco di poesia.
Dimitri Grechi Espinoza – “The Spiritual Way” – ponderosa 147
 Nel panorama musicale internazionale Dimitri Grechi Espinoza si è oramai ritagliato uno spazio ben preciso grazie alla sua ricerca che conduce oramai da tempo e che si sostanzia nel progetto Oreb, il monte dove Mosé incontrò Dio. E credo basti questo solo elemento per capire la dimensione in cui opera il sassofonista. Anche questo suo ultimo lavoro, intitolato “The Spiritual Way” per la Ponderosa Music Records, si inserisce, dunque, in quella ricerca che attraverso la musica conduce all’estasi. In particolare in questo terzo volume di Oreb, Dimitri affronta il tema delle virtù spirituali, dando eco e risonanza a uno scritto della tradizione cinese che delinea un percorso di ascesi interiore. Il tutto espresso, ovviamente, attraverso una musica la cui particolarità può essere facilmente percepita se solo la si ascolti con un minimo di attenzione e cuore aperto. In compagnia del suo fido sax tenore, Dimitri ha inciso questo album nel febbraio del 2019 in una località del tutto particolare come il Battistero di Pisa di San Giovanni in Piazza dei Miracoli, un luogo che data la sua particolare acustica è risultato fondamentale per la riuscita dell’impresa. Ed in effetti l‘artista pone a base della sua ricerca anche il rapporto fra suono e spazio-sonoro e il suo significato spirituale. Il suono del sax si staglia stentoreo, preciso, nitido, straordinariamente coinvolgente, ricco di riverberi, che richiama altri grandi del passato primo fra tutti il John Coltrane nella versione più intimista e spirituale. Così il sassofonista ci trascina in un mondo “altro”, un mondo in cui noi tutti avremmo forse voglia di rifugiarci dato il terribile momento che stiamo attraversando.
Nel panorama musicale internazionale Dimitri Grechi Espinoza si è oramai ritagliato uno spazio ben preciso grazie alla sua ricerca che conduce oramai da tempo e che si sostanzia nel progetto Oreb, il monte dove Mosé incontrò Dio. E credo basti questo solo elemento per capire la dimensione in cui opera il sassofonista. Anche questo suo ultimo lavoro, intitolato “The Spiritual Way” per la Ponderosa Music Records, si inserisce, dunque, in quella ricerca che attraverso la musica conduce all’estasi. In particolare in questo terzo volume di Oreb, Dimitri affronta il tema delle virtù spirituali, dando eco e risonanza a uno scritto della tradizione cinese che delinea un percorso di ascesi interiore. Il tutto espresso, ovviamente, attraverso una musica la cui particolarità può essere facilmente percepita se solo la si ascolti con un minimo di attenzione e cuore aperto. In compagnia del suo fido sax tenore, Dimitri ha inciso questo album nel febbraio del 2019 in una località del tutto particolare come il Battistero di Pisa di San Giovanni in Piazza dei Miracoli, un luogo che data la sua particolare acustica è risultato fondamentale per la riuscita dell’impresa. Ed in effetti l‘artista pone a base della sua ricerca anche il rapporto fra suono e spazio-sonoro e il suo significato spirituale. Il suono del sax si staglia stentoreo, preciso, nitido, straordinariamente coinvolgente, ricco di riverberi, che richiama altri grandi del passato primo fra tutti il John Coltrane nella versione più intimista e spirituale. Così il sassofonista ci trascina in un mondo “altro”, un mondo in cui noi tutti avremmo forse voglia di rifugiarci dato il terribile momento che stiamo attraversando.
Hiromi – “Spectrum” – Telarc 0081
 Vulcanica, tecnicamente fortissima, semplicemente straordinaria: questi gli apprezzamenti che critici e pubblici di tutto il mondo hanno rivolto a Hiromi Uehara una delle più talentuose protagoniste della nuova scena jazz internazionale. La pianista giapponese (classe 1979) si è messa in luce già da bambina e durante tutti questi anni non ha fatto altro che studiare, suonare, studiare e suonare affinando una tecnica davvero strepitosa e migliorando notevolmente anche l’interpretazione. Queste doti vengono tutte in luce in questo album per solo piano registrato in Giappone nel settembre del 2019. E’ interessante sottolineare come questo sia solo il secondo CD registrato dalla Hiromi per piano solo dopo “Place to Be” del 2009 a conferma di quanto l’artista sia attenta a misurare le proprie capacità. E così “Spectrum” si segnala come una delle migliori prove della pianista che si conferma non solo strumentista in possesso di una conoscenza profonda della tastiera, capace di padroneggiare diversi linguaggi, ma anche interprete raffinata, attenta ad ogni aspetto della sua performance. Hiromi accarezza letteralmente ogni tasto dello strumento, dando a ciascuna nota un suo peso specifico cosicché l’esecuzione raggiunge livelli di profondità non facilmente eguagliabili. Cosa che si nota sia nei brani originali, sia nei pezzi già famosi come “Blackbird” di Lennon-McCartney, “Rhapsody in Various Shades of Blue” ovvero “Rhapsody in blue” corredata da varie interpolazioni, alcune originali altre tratte da “Blue Train” di John Coltrane e “Behind Blue Eyes” di Pete Townshend. Splendida la chiusura affidata ad un melodico “Sepia Effect”.
Vulcanica, tecnicamente fortissima, semplicemente straordinaria: questi gli apprezzamenti che critici e pubblici di tutto il mondo hanno rivolto a Hiromi Uehara una delle più talentuose protagoniste della nuova scena jazz internazionale. La pianista giapponese (classe 1979) si è messa in luce già da bambina e durante tutti questi anni non ha fatto altro che studiare, suonare, studiare e suonare affinando una tecnica davvero strepitosa e migliorando notevolmente anche l’interpretazione. Queste doti vengono tutte in luce in questo album per solo piano registrato in Giappone nel settembre del 2019. E’ interessante sottolineare come questo sia solo il secondo CD registrato dalla Hiromi per piano solo dopo “Place to Be” del 2009 a conferma di quanto l’artista sia attenta a misurare le proprie capacità. E così “Spectrum” si segnala come una delle migliori prove della pianista che si conferma non solo strumentista in possesso di una conoscenza profonda della tastiera, capace di padroneggiare diversi linguaggi, ma anche interprete raffinata, attenta ad ogni aspetto della sua performance. Hiromi accarezza letteralmente ogni tasto dello strumento, dando a ciascuna nota un suo peso specifico cosicché l’esecuzione raggiunge livelli di profondità non facilmente eguagliabili. Cosa che si nota sia nei brani originali, sia nei pezzi già famosi come “Blackbird” di Lennon-McCartney, “Rhapsody in Various Shades of Blue” ovvero “Rhapsody in blue” corredata da varie interpolazioni, alcune originali altre tratte da “Blue Train” di John Coltrane e “Behind Blue Eyes” di Pete Townshend. Splendida la chiusura affidata ad un melodico “Sepia Effect”.
Karabà – “Viola” – emme record 1916
 “Viola” è il secondo album dei Karabà, al secolo Alessandro Casciaro al pianoforte e compositore dei brani, Alberto Stefanizzi alla batteria e Stefano Rielli al contrabbasso.
“Viola” è il secondo album dei Karabà, al secolo Alessandro Casciaro al pianoforte e compositore dei brani, Alberto Stefanizzi alla batteria e Stefano Rielli al contrabbasso.
Il gruppo si muove con grande intesa cementata dal fatto che i tre suonano assieme dal 2016 essendo riusciti, cosa non sempre scontata, a fondere le proprie forti personalità in un unicum assolutamente credibile. Anche perché Karabà si tiene ben lontano da sterili sperimentazioni muovendosi su terreni prettamente jazzistici, senza se e senza ma, un jazz indubbiamente moderno ma che nulla dimentica degli insegnamenti del passato. Il tutto agevolato, se non determinato, dalla buona penna di Alessandro Casciaro compositore di otto brani (su nove); l’unico pezzo non originale è “Tonight Tonight” che chiude il disco; si tratta di un riarrangiamento per piano solo del celebre brano degli Smashing Pumpkins che grazie all’estro di Alessandro Casciaro prende nuovo lustro, senza nulla perdere dell’originario fascino. Tornando alle composizioni di Casciaro, le stesse se da un canto esaltano la forza del collettivo, dall’altro offrono ad ognuno dei musicisti la possibilità di esporre appieno le proprie potenzialità. Così, sulla scorta di melodie ben disegnate e di armonizzazioni ricercate, Casciaro ha modo di esporre il suo pianismo sempre essenziale, ben sostenuto da una sezione ritmica affiatata, precisa e, come già detto, capace di prendere in mano il filo del discorso. I brani sono tutti gradevoli anche se personalmente ho preferito “Parco bello luogo” per gli espliciti richiami al bebop grazie soprattutto ad un poderoso assolo di Stefano Rielli e “Primavera 19” per la delicatezza della linea melodica.
Riccardo Morpurgo- “Kaleidoscopic” – artesuono 184
Morpurgo, Maier, Ricci – “ ” – Palomar records 58
” – Palomar records 58
Il pianista Riccardo Morpurgo è presente in due titoli usciti di recente.
Nel primo è alla guida del Mandala Trio completato da Alessandro Turchet al contrabbasso e Luca Colussi alla batteria, vale a dire una delle più affiatate e valide sezioni ritmiche che il jazz italiano possa vantare. Il nome del gruppo è di per sé indicativo: il termine “mandala” si riferisce alle culture buddiste e induiste, e si tratta di immagini geometriche usate per trovare l’equilibrio, l’essenza del proprio essere. Ecco, partendo da queste premesse il trio si avventura in un percorso piuttosto accidentato, declinato attraverso dieci composizioni dello stesso Morpurgo. L’intento è quello di trovare un equilibrio tra pagina scritta e improvvisazione dal momento che, per esplicita ammissione dello stesso pianista, i tre alternano momenti di assoluta coerenza ad una struttura data a momenti in cui si svincolano da qualsivoglia legame e si lanciano in improvvisazioni totali. Evidentemente i momenti più interessanti sono proprio questi in cui Morpurgo e compagni si lasciano andare con risultati eccellenti sia per la bravura del leader sia per quella compattezza ed intesa batteria-contrabbasso cui prima si faceva riferimento. Quindi un disco non facile ma di sicuro interesse.
*****
 Nel secondo album – “Mesmer” – Morpurgo è ancora in trio ma con Giovanni Maier al contrabbasso e Pietro Ricci alla batteria; l’album esce per la ‘Palomar records’ una piccola etichetta fondata e curata da Giovanni Maier, che lavora esclusivamente in autoproduzione e con tirature limitate. Questo “Mesmer” è dedicato quasi totalmente alle musiche di Paul Motian in quanto sei delle composizioni presentate sono del batterista (la settima è invece di Charlie Haden). Il risultato è più che eccellente data da un canto la valenza delle composizioni che lumeggiano al meglio la capacità di scrittura di Motian spesso non adeguatamente valorizzata, dall’altro la capacità del trio di renderle proprie e quindi di reinterpretarle in modo personale ma pertinente. Si parte con “Psalm” title track dell’omonimo album registrato nel dicembre 1981 dal gruppo comprendente Paul Motian, Bill Frisell alla chitarra, Joe Lovano al sax tenore, Billy Drewes ai sax tenore e alto, Ed Schuller al basso e si chiude con “Mesmer” tratto dall’album “Garden of Eden” del 2004. Per tutta la durata dell’album i tra si muovono quasi con cautela, rifuggendo da qualsivoglia esibizione di bravura tecnica e affidandosi molto all’interpretazione. Di qui una musica suggestiva, misurata, spesso eseguita per sottrazione senza che però venga compressa l’abilità individuale. Si ascolti ad esempio il magnifico duetto basso batteria in “Morpion” tratto dall’album “One Time Out” (Blue Note 1987).
Nel secondo album – “Mesmer” – Morpurgo è ancora in trio ma con Giovanni Maier al contrabbasso e Pietro Ricci alla batteria; l’album esce per la ‘Palomar records’ una piccola etichetta fondata e curata da Giovanni Maier, che lavora esclusivamente in autoproduzione e con tirature limitate. Questo “Mesmer” è dedicato quasi totalmente alle musiche di Paul Motian in quanto sei delle composizioni presentate sono del batterista (la settima è invece di Charlie Haden). Il risultato è più che eccellente data da un canto la valenza delle composizioni che lumeggiano al meglio la capacità di scrittura di Motian spesso non adeguatamente valorizzata, dall’altro la capacità del trio di renderle proprie e quindi di reinterpretarle in modo personale ma pertinente. Si parte con “Psalm” title track dell’omonimo album registrato nel dicembre 1981 dal gruppo comprendente Paul Motian, Bill Frisell alla chitarra, Joe Lovano al sax tenore, Billy Drewes ai sax tenore e alto, Ed Schuller al basso e si chiude con “Mesmer” tratto dall’album “Garden of Eden” del 2004. Per tutta la durata dell’album i tra si muovono quasi con cautela, rifuggendo da qualsivoglia esibizione di bravura tecnica e affidandosi molto all’interpretazione. Di qui una musica suggestiva, misurata, spesso eseguita per sottrazione senza che però venga compressa l’abilità individuale. Si ascolti ad esempio il magnifico duetto basso batteria in “Morpion” tratto dall’album “One Time Out” (Blue Note 1987).
Marius Neset, London Sinfonietta – “Viaduct” – ACT 9048-2
 Il sassofonista norvegese Marius Neset (Bergen 1985) si ripresenta al pubblico del jazz alla testa del suo gruppo anglo-scandinavo (Ivo Neame piano, Jim Hart vibrafono, marimba e percussioni, Petter Eldh basso, Anton Eger batteria e percussioni) con il robusto supporto della London Sinfonietta, complesso di ben 19 elementi diretta da Geoffrey Paterson con cui Neset, sempre per la ACT, aveva già inciso nel 2016 l’album “Snowmelt”. Neset è a ben ragione considerato uno dei migliori jazzisti delle nuove generazioni tanto che la rivista Downbeat lo considera non solo uno dei più eccitanti artisti jazz del momento ma anche un musicista di straordinaria preparazione tecnica dotato altresì di una felice vena compositiva. Doti, queste, che risaltano evidenti anche da quest’ultimo album, contenente un paio di suite intitolate rispettivamente “Viaduct part 1” in 6 capitoli e “Viaduct part.2” in 4 elementi. Originariamente commissionata per il concerto d’apertura del Kongsberg Jazz Festival nel 2018, “Viaduct” ha offerto a Neset la fantastica opportunità di mostrare le molteplici facce del suo stile, così composito, ricco di richiami, colorito e soprattutto capace di convogliare numerosi input provenienti da fonti diverse. Il suo sassofono è sempre preciso, con un sound potente sia al tenore sia al soprano, che richiama sia il migliore Brecker sia il grandissimo Garbarek, capace di dettare le atmosfere che si respirano per tutta la durata dell’album. Certo, la bravura di Neset come sassofonista è indubbia, ma non sarebbe stata sufficiente a determinare la bontà dell’album se non fosse stata declinata attraverso le dieci composizioni originali dello stesso Neset che riescono a coniugare il jazz propriamente inteso, ricco quindi anche di improvvisazione, con la musica classica contemporanea.
Il sassofonista norvegese Marius Neset (Bergen 1985) si ripresenta al pubblico del jazz alla testa del suo gruppo anglo-scandinavo (Ivo Neame piano, Jim Hart vibrafono, marimba e percussioni, Petter Eldh basso, Anton Eger batteria e percussioni) con il robusto supporto della London Sinfonietta, complesso di ben 19 elementi diretta da Geoffrey Paterson con cui Neset, sempre per la ACT, aveva già inciso nel 2016 l’album “Snowmelt”. Neset è a ben ragione considerato uno dei migliori jazzisti delle nuove generazioni tanto che la rivista Downbeat lo considera non solo uno dei più eccitanti artisti jazz del momento ma anche un musicista di straordinaria preparazione tecnica dotato altresì di una felice vena compositiva. Doti, queste, che risaltano evidenti anche da quest’ultimo album, contenente un paio di suite intitolate rispettivamente “Viaduct part 1” in 6 capitoli e “Viaduct part.2” in 4 elementi. Originariamente commissionata per il concerto d’apertura del Kongsberg Jazz Festival nel 2018, “Viaduct” ha offerto a Neset la fantastica opportunità di mostrare le molteplici facce del suo stile, così composito, ricco di richiami, colorito e soprattutto capace di convogliare numerosi input provenienti da fonti diverse. Il suo sassofono è sempre preciso, con un sound potente sia al tenore sia al soprano, che richiama sia il migliore Brecker sia il grandissimo Garbarek, capace di dettare le atmosfere che si respirano per tutta la durata dell’album. Certo, la bravura di Neset come sassofonista è indubbia, ma non sarebbe stata sufficiente a determinare la bontà dell’album se non fosse stata declinata attraverso le dieci composizioni originali dello stesso Neset che riescono a coniugare il jazz propriamente inteso, ricco quindi anche di improvvisazione, con la musica classica contemporanea.
Enrico Pieranunzi – “Frame” – Cam J 7955 2
 Enrico Pieranunzi è musicista colto e in quanto tale ‘aperto’ verso tutte le altre forme artistiche. Nel passato, anche recente, ne abbiamo avuto prova evidente riscontrando la sua profonda predilezione per il cinema e le colonne sonore. Si ricordi, ad esempio, il concerto organizzato il 20 febbraio scorso dall’Ambasciata d’Italia e dall’Istituto di Cultura Italiana a Washington in occasione del centenario della nascita di Federico Fellini, con Enrico Pieranunzi, accompagnato da Luca Bulgarelli al basso e da Mauro Beggio alla batteria, impegnato in un repertorio interamente dedicato alle colonne sonore del maestro romagnolo. In questo album l’interesse del pianista romano è rivolto alle arti figurative: immaginatevi una galleria d’arte in cui sono esposti i capolavori di Pollock, Hopper, Picasso, Paul Klee, Rothko, Matisse e Mondrian; Enrico si sofferma dinnanzi ad ogni quadro e disegna, in splendida solitudine, con le note del pianoforte o alla celesta, un affresco da inserire in una ipotetica ‘cornice’, “Frame” per l’appunto. L’effetto è quanto meno intrigante: Pieranunzi non si smentisce e la sua arte pianistica rifulge sempre luminosa sia che si avventuri in stupefacenti e trascinanti avventure magari con illustri partner d’oltre oceano, sia, come in questo caso, che si rivolga di più al suo coté intimista regalandoci una serie di bozzetti che illustrano meglio di mille parole le sue riflessioni determinate dai pittori sopra citati. Un’ultima considerazione: capita sempre più spesso che la data di pubblicazione di un disco sia di molto posteriore alla sua incisione; ad esempio questo album è stato registrato nel 2012 ma pubblicato solo nel febbraio di questo non felicissimo 2020.
Enrico Pieranunzi è musicista colto e in quanto tale ‘aperto’ verso tutte le altre forme artistiche. Nel passato, anche recente, ne abbiamo avuto prova evidente riscontrando la sua profonda predilezione per il cinema e le colonne sonore. Si ricordi, ad esempio, il concerto organizzato il 20 febbraio scorso dall’Ambasciata d’Italia e dall’Istituto di Cultura Italiana a Washington in occasione del centenario della nascita di Federico Fellini, con Enrico Pieranunzi, accompagnato da Luca Bulgarelli al basso e da Mauro Beggio alla batteria, impegnato in un repertorio interamente dedicato alle colonne sonore del maestro romagnolo. In questo album l’interesse del pianista romano è rivolto alle arti figurative: immaginatevi una galleria d’arte in cui sono esposti i capolavori di Pollock, Hopper, Picasso, Paul Klee, Rothko, Matisse e Mondrian; Enrico si sofferma dinnanzi ad ogni quadro e disegna, in splendida solitudine, con le note del pianoforte o alla celesta, un affresco da inserire in una ipotetica ‘cornice’, “Frame” per l’appunto. L’effetto è quanto meno intrigante: Pieranunzi non si smentisce e la sua arte pianistica rifulge sempre luminosa sia che si avventuri in stupefacenti e trascinanti avventure magari con illustri partner d’oltre oceano, sia, come in questo caso, che si rivolga di più al suo coté intimista regalandoci una serie di bozzetti che illustrano meglio di mille parole le sue riflessioni determinate dai pittori sopra citati. Un’ultima considerazione: capita sempre più spesso che la data di pubblicazione di un disco sia di molto posteriore alla sua incisione; ad esempio questo album è stato registrato nel 2012 ma pubblicato solo nel febbraio di questo non felicissimo 2020.
Andreas Schaerer, Hildegard Lernt Fliegen – “The Waves Are Rising, Dear!
 Già altre volte, questa testata si è occupata di Andreas Schaerer sottolineandone le innumerevoli virtù e la capacità di interpretare più parti in commedia dal momento che la sua arte gli consente di fare non solo ciò che hanno fatto i più grandi vocalist del jazz, ma di esibirsi come “beatboxer”, di imitare vari strumenti e di improvvisare con uno scat inventivo e trascinante. Questa volta lo svizzero di Berna si presenta alla testa del suo gruppo “Hildegard Lernt Fliegen” il più creativo e originale progetto musicale che la Svizzera abbia potuto offrire in questi ultimi anni. In effetti una performance del gruppo è sempre qualcosa di straordinario dal momento che è difficile stabilire se si tratti di un concerto jazz, rock, rap, di cabaret, di musica da circo (si ascolti, ad esempio il brano d’apertura “Dripping Pint”) con incursioni sempre misurate anche nel mondo dell’elettronica. Ad assecondare le acrobazie vocali di Andreas cinque solisti di eccellenza quali il trombonista e tubista Andreas Tschopp, i sassofonisti Matthias Wenger e Benedikt Reising (che si ascoltano rispettivamente anche al flauto e al clarinetto basso), il bassista Marco Muller e Christoph Steiner alla batteria e alla marimba. Il tutto rinforzato, purtroppo in un solo brano “Embraced By The Earth” dalla presenza del celebrato fisarmonicista francese Vincent Peirani e dalla intensa voce di Jessana Némitz. Così la musica scorre impetuosa, tutt’altro che banale, lontana da qualsivoglia piacevolezza superficiale in cui l’ascoltatore è coinvolto nella sua totalità, mente e corpo, emozione e intelletto. Da questo punto di vista è difficile scegliere in particolare qualche brano anche se personalmente ho maggiormente apprezzato il già citato pezzo in cui si ascoltano anche Peirani e la Némitz e il brano di chiusura “Love Warrior: Part I-IV” che si muove su coordinate più spiccatamente jazzistiche.
Già altre volte, questa testata si è occupata di Andreas Schaerer sottolineandone le innumerevoli virtù e la capacità di interpretare più parti in commedia dal momento che la sua arte gli consente di fare non solo ciò che hanno fatto i più grandi vocalist del jazz, ma di esibirsi come “beatboxer”, di imitare vari strumenti e di improvvisare con uno scat inventivo e trascinante. Questa volta lo svizzero di Berna si presenta alla testa del suo gruppo “Hildegard Lernt Fliegen” il più creativo e originale progetto musicale che la Svizzera abbia potuto offrire in questi ultimi anni. In effetti una performance del gruppo è sempre qualcosa di straordinario dal momento che è difficile stabilire se si tratti di un concerto jazz, rock, rap, di cabaret, di musica da circo (si ascolti, ad esempio il brano d’apertura “Dripping Pint”) con incursioni sempre misurate anche nel mondo dell’elettronica. Ad assecondare le acrobazie vocali di Andreas cinque solisti di eccellenza quali il trombonista e tubista Andreas Tschopp, i sassofonisti Matthias Wenger e Benedikt Reising (che si ascoltano rispettivamente anche al flauto e al clarinetto basso), il bassista Marco Muller e Christoph Steiner alla batteria e alla marimba. Il tutto rinforzato, purtroppo in un solo brano “Embraced By The Earth” dalla presenza del celebrato fisarmonicista francese Vincent Peirani e dalla intensa voce di Jessana Némitz. Così la musica scorre impetuosa, tutt’altro che banale, lontana da qualsivoglia piacevolezza superficiale in cui l’ascoltatore è coinvolto nella sua totalità, mente e corpo, emozione e intelletto. Da questo punto di vista è difficile scegliere in particolare qualche brano anche se personalmente ho maggiormente apprezzato il già citato pezzo in cui si ascoltano anche Peirani e la Némitz e il brano di chiusura “Love Warrior: Part I-IV” che si muove su coordinate più spiccatamente jazzistiche.
Ian Shaw – “Integrity” – abeat 01
 Il cantante, pianista e songwriter inglese Ian Shaw è considerato, insieme a Mark Murphy e Kurt Elling, uno dei migliori cantanti jazz di sesso maschile di tutto il mondo. Lo evidenziano i tanti riconoscimenti ottenuti in questi anni: miglior Vocalist Jazz ai BBC Jazz Awards nel 2007 e nel 2004, e nomination nella categoria Miglior Vocalist del Regno Unito ai JazzFM Awards nel 2013… In questo album Ian è accompagnato da un trio italiano composto da Alessandro Di Liberto al piano, Tommaso Scannapieco al basso ed Enzo Zirilli alla batteria. In programma accanto ad alcuni grandi classici ‘leggeri’ come “People”, cavallo di battaglia di Barbara Streisand dal film “Funny girl” del 1964 (arrangiato per l’occasione da Di Liberto), e “Smile” di Charlie Chaplin arrangiata da Enzo Zirilli, ecco alcuni standards del jazz tra i meno battuti come “Use me” di Bill Withers che chiude l’intero disco. In tutti i brani risalta evidente il ruolo svolto dagli strumentisti che riescono a intessere un tappeto ritmico-armonico in cui si inserisce con assoluta pertinenza la voce di Ian Shaw che, dal canto suo, evidenzia una maturità espressiva non comune. Di solito quando si ascolta un disco il cui leader è un cantante (indipendentemente dal sesso) la formula è quella del vocalist con accompagnamento. In questo caso la situazione è completamente diversa in quanto il gruppo appare perfettamente coeso e si muove all’unisono dando ad ognuno la possibilità di mettersi in evidenza. Certo, Ian Shaw è la stella dell’album e la sua prestazione è assolutamente all’altezza dei suoi precedenti album che hanno giustificato, nel tempo, i riconoscimenti cui in apertura si faceva riferimento. I brani sono tutti notevoli con una preferenza, del tutto personale, per il celeberrimo “Smile” di Charlie Chaplin.
Il cantante, pianista e songwriter inglese Ian Shaw è considerato, insieme a Mark Murphy e Kurt Elling, uno dei migliori cantanti jazz di sesso maschile di tutto il mondo. Lo evidenziano i tanti riconoscimenti ottenuti in questi anni: miglior Vocalist Jazz ai BBC Jazz Awards nel 2007 e nel 2004, e nomination nella categoria Miglior Vocalist del Regno Unito ai JazzFM Awards nel 2013… In questo album Ian è accompagnato da un trio italiano composto da Alessandro Di Liberto al piano, Tommaso Scannapieco al basso ed Enzo Zirilli alla batteria. In programma accanto ad alcuni grandi classici ‘leggeri’ come “People”, cavallo di battaglia di Barbara Streisand dal film “Funny girl” del 1964 (arrangiato per l’occasione da Di Liberto), e “Smile” di Charlie Chaplin arrangiata da Enzo Zirilli, ecco alcuni standards del jazz tra i meno battuti come “Use me” di Bill Withers che chiude l’intero disco. In tutti i brani risalta evidente il ruolo svolto dagli strumentisti che riescono a intessere un tappeto ritmico-armonico in cui si inserisce con assoluta pertinenza la voce di Ian Shaw che, dal canto suo, evidenzia una maturità espressiva non comune. Di solito quando si ascolta un disco il cui leader è un cantante (indipendentemente dal sesso) la formula è quella del vocalist con accompagnamento. In questo caso la situazione è completamente diversa in quanto il gruppo appare perfettamente coeso e si muove all’unisono dando ad ognuno la possibilità di mettersi in evidenza. Certo, Ian Shaw è la stella dell’album e la sua prestazione è assolutamente all’altezza dei suoi precedenti album che hanno giustificato, nel tempo, i riconoscimenti cui in apertura si faceva riferimento. I brani sono tutti notevoli con una preferenza, del tutto personale, per il celeberrimo “Smile” di Charlie Chaplin.
Djime Sissoko, Djama Djigui – “Kabako” – Caligola 2272
 Tutti conosciamo Baba Sissoko; ebbene Djime è il di lui nipote che vive a Bamako in Mali. Come si dice buon sangue non mente e anche questo artista è degno della massima attenzione. Si badi bene, però: la sua musica non è quella sorta di jazz fortemente contaminato dall’Africa che ha reso famoso Baba; qui siamo sul terreno della musica africana, meglio maliana, lontana da qualsivoglia contaminazione e proprio per questo di grande fascino. Djime si presenta alla testa del suo gruppo, “Djama Djigui” una formazione assolutamente particolare in quanto composta da fratelli, cugini, vicini che sono cresciuti assieme, discendenti della grande famiglia dei Griot Sissoko, tra cui ovviamente il più volte citato Baba. L’album, oltre della maestria del leader al ngoni (strumento a corda proprio dell’Africa occidentale) e al tama (strumento a percussione sempre dell’Africa occidentale) e dello straordinario affiatamento del gruppo, si avvale della splendida voce della moglie di Djime, Aichata Bah. Oltre a quella di Aichata, si possono altresì ascoltare le voci di Baba in “Ma Kono Djarabi” e in “Djumara Djeli”, di Sadibuou Kanté in “Djuku Ya Magnie” e di Samba Tourè in “Anka Miri”, tutti in veste di ospiti. Particolarmente significativo il brano che chiude l’album,”Tama solo”, in cui Djime Sissoko evidenzia tutto il suo virtuosismo per l’appunto al tama. “Kabako”, oramai l’avrete già capito, ci conduce in un meraviglioso viaggio attraverso il Mali grazie alla sua musica che affonda le proprie radici nella tradizione di quella terra.
Tutti conosciamo Baba Sissoko; ebbene Djime è il di lui nipote che vive a Bamako in Mali. Come si dice buon sangue non mente e anche questo artista è degno della massima attenzione. Si badi bene, però: la sua musica non è quella sorta di jazz fortemente contaminato dall’Africa che ha reso famoso Baba; qui siamo sul terreno della musica africana, meglio maliana, lontana da qualsivoglia contaminazione e proprio per questo di grande fascino. Djime si presenta alla testa del suo gruppo, “Djama Djigui” una formazione assolutamente particolare in quanto composta da fratelli, cugini, vicini che sono cresciuti assieme, discendenti della grande famiglia dei Griot Sissoko, tra cui ovviamente il più volte citato Baba. L’album, oltre della maestria del leader al ngoni (strumento a corda proprio dell’Africa occidentale) e al tama (strumento a percussione sempre dell’Africa occidentale) e dello straordinario affiatamento del gruppo, si avvale della splendida voce della moglie di Djime, Aichata Bah. Oltre a quella di Aichata, si possono altresì ascoltare le voci di Baba in “Ma Kono Djarabi” e in “Djumara Djeli”, di Sadibuou Kanté in “Djuku Ya Magnie” e di Samba Tourè in “Anka Miri”, tutti in veste di ospiti. Particolarmente significativo il brano che chiude l’album,”Tama solo”, in cui Djime Sissoko evidenzia tutto il suo virtuosismo per l’appunto al tama. “Kabako”, oramai l’avrete già capito, ci conduce in un meraviglioso viaggio attraverso il Mali grazie alla sua musica che affonda le proprie radici nella tradizione di quella terra.
Warren Wolf – “Reincarnation” – Mack Avenue1169
 L’ afroamericano Warren Wolf, anche attraverso i suoi quattro precedenti album pubblicati per la Mack Avenue tra il 2005 e il 2016, si è affermato come uno dei migliori vibrafonisti degli ultimi anni e in questa nuova incisione ha chiamato accanto a sé giovani sideman e alcuni veterani. Con lui ecco quindi Brett Williams al Fender Rhodes ed al pianoforte, Richie Godds al basso elettrico e su “Livin’ the Good Life” al contrabbasso, Mark Whitfeld su due brani alla chitarra, Carroll “CV” Dashell III alla batteria ed alle percussioni e due cantanti che si alternano: Imani-Grace Cooper e Marcellus “bassman” Shepard. L’album è sostanzialmente incentrato sul R&B, sul soul e su una fusion di qualità, mentre dal punto di vista dell’ispirazione, il fattore dominante è l’amore declinato attraverso le sue mille sfaccettature; è lo stesso Wolf a chiarirlo: “Questo è un album sull’amore e la musica che mi fa stare bene – spiega Wolf – A questo punto della mia carriera, volevo solo dimostrare che posso essere versatile ed esprimermi in molti stili diversi”. Così ad esempio “For Ma” è dedicato alla madre, Celeste Wolf, deceduta nel 2015, “Sebastian e Zoë” è un delicato omaggio ai suoi due bambini più piccoli, mentre “Come And Dance With Me” è stata scritta per la moglie che è una ballerina. Da quanto sin qui detto, risulta evidente come l’album riuscirà particolarmente gradito a quanti amano la black music nella sua accezione più ampia. Tuttavia, ad opinione del vostro recensore, uno dei pezzi meglio riusciti è “Sebastian and Zoe” in cui Shepard , con espliciti riferimenti a Barry White, dialoga con Imani-Grace Cooper facendo rivivere quelle atmosfere che hanno segnato per molti di noi gli anni ’70.
L’ afroamericano Warren Wolf, anche attraverso i suoi quattro precedenti album pubblicati per la Mack Avenue tra il 2005 e il 2016, si è affermato come uno dei migliori vibrafonisti degli ultimi anni e in questa nuova incisione ha chiamato accanto a sé giovani sideman e alcuni veterani. Con lui ecco quindi Brett Williams al Fender Rhodes ed al pianoforte, Richie Godds al basso elettrico e su “Livin’ the Good Life” al contrabbasso, Mark Whitfeld su due brani alla chitarra, Carroll “CV” Dashell III alla batteria ed alle percussioni e due cantanti che si alternano: Imani-Grace Cooper e Marcellus “bassman” Shepard. L’album è sostanzialmente incentrato sul R&B, sul soul e su una fusion di qualità, mentre dal punto di vista dell’ispirazione, il fattore dominante è l’amore declinato attraverso le sue mille sfaccettature; è lo stesso Wolf a chiarirlo: “Questo è un album sull’amore e la musica che mi fa stare bene – spiega Wolf – A questo punto della mia carriera, volevo solo dimostrare che posso essere versatile ed esprimermi in molti stili diversi”. Così ad esempio “For Ma” è dedicato alla madre, Celeste Wolf, deceduta nel 2015, “Sebastian e Zoë” è un delicato omaggio ai suoi due bambini più piccoli, mentre “Come And Dance With Me” è stata scritta per la moglie che è una ballerina. Da quanto sin qui detto, risulta evidente come l’album riuscirà particolarmente gradito a quanti amano la black music nella sua accezione più ampia. Tuttavia, ad opinione del vostro recensore, uno dei pezzi meglio riusciti è “Sebastian and Zoe” in cui Shepard , con espliciti riferimenti a Barry White, dialoga con Imani-Grace Cooper facendo rivivere quelle atmosfere che hanno segnato per molti di noi gli anni ’70.
da Gerlando Gatto | 21/Mar/2020 | I nostri CD, Primo piano, Recensioni

Carla Bley – “Life Goes On”- ECM 2669
 Carla Bley con il fido Steve Swallow al basso e Andy Sheppard ai sax tenore e soprano sono i protagonisti di questo nuovo album registrato nel maggio del 2019 a Lugano. In repertorio tre suite intitolate rispettivamente “Life Goes On”, “Beautiful Telephones” e “Copycat” tutte composte dalla stessa Bley. Chi ha seguito negli anni la Bley, sa bene come ad onta dei suoi ottantaquattro anni, l’artista di Oakland conservi intatta la sua straordinaria vena creativa e una stupefacente capacità di arrangiare e presentare in forme sempre originali le sue composizioni. Altro dato che si può ricavare dall’ascolto di questo suo ultimo lavoro, è la consapevolezza raggiunta dall’artista di poter finalmente trarre le fila di un discorso portato avanti oramai da molti anni. In effetti la musica che si ascolta soprattutto nella prima suite rappresenta un po’ la cifra stilistica della Bley in cui il blues viene coniugato con una certa malinconia di fondo che ben si affianca a quella carica iconoclasta e ironica che nel passato aveva caratterizzato molte composizioni della pianista. Ed ecco infatti la seconda suite che nel polemico titolo “Beautiful Telephones” richiama quella assurda espressione del presidente Trump che installandosi nello studio ovale della Casa Bianca, fu colpito soprattutto dai telefoni che definì “i più bei telefoni che abbia mai visto in vita mia”. Comunque, al di là di tutto, la musica di Carla Bley convince ancora una volta per la straordinaria carica di eleganza, modernità, coerenza in essa contenuta nonché per aver creato un jazz cameristico – se mi consentite il termine – che dovrebbe mettere d’accordo gli amanti del jazz e quelli della musica “colta” dati gli espliciti riferimenti a quel coté artistico che la Bley spesso mette in campo. Ovviamente la bella riuscita dell’album è dovuta anche alla personalità artistica dei due compagni di viaggio. Steve collabora con la Bley oramai da venticinque anni e la loro intesa è parte integrante di ogni loro album dato il peso specifico che il bassista riesca ogni volta ad assumere (lo si ascolti soprattutto nel primo movimento della “Beautiful Telephones”); dal canto suo Andy Sheppard è in grado di inserirsi autorevolmente e coerentemente nel fitto dialogo pianoforte-basso.
Carla Bley con il fido Steve Swallow al basso e Andy Sheppard ai sax tenore e soprano sono i protagonisti di questo nuovo album registrato nel maggio del 2019 a Lugano. In repertorio tre suite intitolate rispettivamente “Life Goes On”, “Beautiful Telephones” e “Copycat” tutte composte dalla stessa Bley. Chi ha seguito negli anni la Bley, sa bene come ad onta dei suoi ottantaquattro anni, l’artista di Oakland conservi intatta la sua straordinaria vena creativa e una stupefacente capacità di arrangiare e presentare in forme sempre originali le sue composizioni. Altro dato che si può ricavare dall’ascolto di questo suo ultimo lavoro, è la consapevolezza raggiunta dall’artista di poter finalmente trarre le fila di un discorso portato avanti oramai da molti anni. In effetti la musica che si ascolta soprattutto nella prima suite rappresenta un po’ la cifra stilistica della Bley in cui il blues viene coniugato con una certa malinconia di fondo che ben si affianca a quella carica iconoclasta e ironica che nel passato aveva caratterizzato molte composizioni della pianista. Ed ecco infatti la seconda suite che nel polemico titolo “Beautiful Telephones” richiama quella assurda espressione del presidente Trump che installandosi nello studio ovale della Casa Bianca, fu colpito soprattutto dai telefoni che definì “i più bei telefoni che abbia mai visto in vita mia”. Comunque, al di là di tutto, la musica di Carla Bley convince ancora una volta per la straordinaria carica di eleganza, modernità, coerenza in essa contenuta nonché per aver creato un jazz cameristico – se mi consentite il termine – che dovrebbe mettere d’accordo gli amanti del jazz e quelli della musica “colta” dati gli espliciti riferimenti a quel coté artistico che la Bley spesso mette in campo. Ovviamente la bella riuscita dell’album è dovuta anche alla personalità artistica dei due compagni di viaggio. Steve collabora con la Bley oramai da venticinque anni e la loro intesa è parte integrante di ogni loro album dato il peso specifico che il bassista riesca ogni volta ad assumere (lo si ascolti soprattutto nel primo movimento della “Beautiful Telephones”); dal canto suo Andy Sheppard è in grado di inserirsi autorevolmente e coerentemente nel fitto dialogo pianoforte-basso.
Paolo Damiani – “Silenzi luterani” – Alfa Music 214
 Due i riferimenti colti esplicitati dallo stesso Damiani nelle note che accompagnano il CD: da un lato la Riforma di Martin Lutero che nel 1517 si staccò dalla Santa Sede romana introducendo il canto in chiesa di tutti i fedeli e componendo egli stesso musica, dall’altro l’evocazione nel titolo del CD… e non solo, delle “Lettere Luterane” di Pier Paolo Pasolini, articoli scritti nel 1975 e pubblicati sul Corriere della Sera. Ambedue, Lutero e Pasolini, si scagliavano contro i mali della società ovviamente delle rispettive epoche: ebbene, Damiani con la sua musica intende protestare contro uno stato di cose per cui l’indignazione non basta più. Di qui una musica a tratti sghemba, difficile, ma di sicuro fascino, impreziosita dal fatto che viene liberamente interpolata con frammenti melodici scritti da Lutero e testi di Pasolini. Ancora una volta Damiani evidenzia la sua ottima conoscenza del mondo musicale, inteso nell’accezione più ampia del termine, riuscendo così a far convivere nella stessa espressione artistica echi di mondi assai lontani con suggestioni derivate dal presente, in un gioco di incastri, di rimandi che disegnano un universo davvero senza confini. Insomma un’operazione tutt’altro che banale per la cui riuscita era necessaria una perfetta intesa degli esecutori. Ecco quindi la formazione posta in campo da Damiani, formata dai migliori ex allievi del dipartimento jazz del conservatorio di Santa Cecilia, dipartimento fondato e guidato dallo stesso Damiani fino al 2018: quattro voci capitanate da Daniela Troilo (in questa sede anche arrangiatrice), Erica Scheri al violino, Lewis Saccocci al pianoforte, Francesco Merenda alla batteria cui si aggiunge, in veste di ospite, Daniele Tittarelli ai sassofoni. In repertorio sette brani, tutti composti dal leader, registrati in occasione di due concerti tenuti presso la Sala Accademia del Conservatorio di Santa Cecilia di Roma e la Sala Concerti della casa del Jazz di Roma, nel 2017.
Due i riferimenti colti esplicitati dallo stesso Damiani nelle note che accompagnano il CD: da un lato la Riforma di Martin Lutero che nel 1517 si staccò dalla Santa Sede romana introducendo il canto in chiesa di tutti i fedeli e componendo egli stesso musica, dall’altro l’evocazione nel titolo del CD… e non solo, delle “Lettere Luterane” di Pier Paolo Pasolini, articoli scritti nel 1975 e pubblicati sul Corriere della Sera. Ambedue, Lutero e Pasolini, si scagliavano contro i mali della società ovviamente delle rispettive epoche: ebbene, Damiani con la sua musica intende protestare contro uno stato di cose per cui l’indignazione non basta più. Di qui una musica a tratti sghemba, difficile, ma di sicuro fascino, impreziosita dal fatto che viene liberamente interpolata con frammenti melodici scritti da Lutero e testi di Pasolini. Ancora una volta Damiani evidenzia la sua ottima conoscenza del mondo musicale, inteso nell’accezione più ampia del termine, riuscendo così a far convivere nella stessa espressione artistica echi di mondi assai lontani con suggestioni derivate dal presente, in un gioco di incastri, di rimandi che disegnano un universo davvero senza confini. Insomma un’operazione tutt’altro che banale per la cui riuscita era necessaria una perfetta intesa degli esecutori. Ecco quindi la formazione posta in campo da Damiani, formata dai migliori ex allievi del dipartimento jazz del conservatorio di Santa Cecilia, dipartimento fondato e guidato dallo stesso Damiani fino al 2018: quattro voci capitanate da Daniela Troilo (in questa sede anche arrangiatrice), Erica Scheri al violino, Lewis Saccocci al pianoforte, Francesco Merenda alla batteria cui si aggiunge, in veste di ospite, Daniele Tittarelli ai sassofoni. In repertorio sette brani, tutti composti dal leader, registrati in occasione di due concerti tenuti presso la Sala Accademia del Conservatorio di Santa Cecilia di Roma e la Sala Concerti della casa del Jazz di Roma, nel 2017.
Vittorio De Angelis – “Believe Not Belong” – Creusarte Records
 Una delle strade maestre su cui oramai si è indirizzato il jazz è quella di far confluire in un unico linguaggio input derivanti da varie fonti, soprattutto jazz mainstream, soul e funk. Certo, se la strada è la stessa, il modo di percorrerla è diverso ed è proprio su questo parametro che si può valutare oggi la valenza di una esecuzione. Da questo punto di vista, l’album in oggetto si lascia ascoltare non tanto per l’originalità delle composizioni (7 brani tutti composti dal leader sassofonista, flautista e compositore napoletano) quanto per il particolare organico. De Angelis ha infatti scelto di puntare sul “double trio” vale a dire due batterie, due tastiere, due fiati; manca il bassista in quattro dei sette brani sostituito dai due tastieristi (Domenico Sanna al basso sinth e Sebi Burgio al piano basso Rhodes). Insomma due trio indipendenti che suonano assieme e che proprio per questo producono una sonorità particolare, pregio principale di queste registrazioni. E non è poco ove si tenga conto che si tratta del primo album di Vittorio De Angelis leader, il quale, tra l’altro ha avuto l’intelligenza di chiamare accanto a sé musicisti di livello tra cui Domenico Sanna pianista di Gaeta, classe 1984, che ha già collaborato con musicisti di livello internazionale quali Steve Grossman, Rick Margitza, Dave Liebman, JD Allen, Greg Hutchinson; Seby Burgio, altro talentuoso tastierista (Siracusa 1989 ) che può vantare collaborazioni con, tra gli altri, Larry James Ray, Tony Arco, Michael Rosen, Alfredo Paixao; Francesco Fratini uno dei più promettenti trombettisti italiani e Takuya Kuroda trombettista e arrangiatore giapponese, classe 1980, che incide per la Blue Note e ha già al suo attivo cinque album sotto suo nome.
Una delle strade maestre su cui oramai si è indirizzato il jazz è quella di far confluire in un unico linguaggio input derivanti da varie fonti, soprattutto jazz mainstream, soul e funk. Certo, se la strada è la stessa, il modo di percorrerla è diverso ed è proprio su questo parametro che si può valutare oggi la valenza di una esecuzione. Da questo punto di vista, l’album in oggetto si lascia ascoltare non tanto per l’originalità delle composizioni (7 brani tutti composti dal leader sassofonista, flautista e compositore napoletano) quanto per il particolare organico. De Angelis ha infatti scelto di puntare sul “double trio” vale a dire due batterie, due tastiere, due fiati; manca il bassista in quattro dei sette brani sostituito dai due tastieristi (Domenico Sanna al basso sinth e Sebi Burgio al piano basso Rhodes). Insomma due trio indipendenti che suonano assieme e che proprio per questo producono una sonorità particolare, pregio principale di queste registrazioni. E non è poco ove si tenga conto che si tratta del primo album di Vittorio De Angelis leader, il quale, tra l’altro ha avuto l’intelligenza di chiamare accanto a sé musicisti di livello tra cui Domenico Sanna pianista di Gaeta, classe 1984, che ha già collaborato con musicisti di livello internazionale quali Steve Grossman, Rick Margitza, Dave Liebman, JD Allen, Greg Hutchinson; Seby Burgio, altro talentuoso tastierista (Siracusa 1989 ) che può vantare collaborazioni con, tra gli altri, Larry James Ray, Tony Arco, Michael Rosen, Alfredo Paixao; Francesco Fratini uno dei più promettenti trombettisti italiani e Takuya Kuroda trombettista e arrangiatore giapponese, classe 1980, che incide per la Blue Note e ha già al suo attivo cinque album sotto suo nome.
e.s.t. – “Live in Gothenburg” – ACT 9046 2
 Ascoltando queste registrazioni effettuate live il 10 Ottobre del 2001 alla Concert Hall di Gothenburg si rinnova il rimpianto per aver perso troppo presto e in maniera davvero assurda un talento come Esbjörn Svensson qui accompagnato dai fidi partner Dan Berglund al basso e Magnus Ostrom alla batteria. Siamo negli anni in cui il trio sta consolidando il proprio essere gruppo omogeneo, compatto in grado di dire qualcosa di nuovo nel pur affollato panorama dei trii piano-basso-batteria. Ciò ovviamente per merito di tutti e tre i musicisti ma in modo particolare, del leader, il pianista Esbjörn Svensson affermatosi in brevissimo tempo come uno dei più fulgidi talenti del piano jazz a livello internazionale. In questo concerto, poi riportato sul doppio CD in oggetto, il trio rivisita alcuni dei brani contenuti nei due album già usciti in quel periodo, vale a dire “From Gagarin´s Point of View” del 1999 e “Good Morning Susie Soho” del 2000. E si è trattato di una performance davvero molto rilevante se lo stesso Svensson aveva più volte dichiarato di considerare questo concerto uno dei migliori della sua carriera. E come dargli torto? La musica è assolutamente ben costruita, ben arrangiata e altrettanto ben eseguita con i tre artisti che si ascoltano e interagiscono con immediatezza e pertinenza. Ascoltando in sequenza tutti e gli undici brani dei due CD è davvero difficile, se non impossibile, capire quando i tre improvvisano e quando seguono qualcosa di stabilito in precedenza. E non credo di esagerare affermando che dopo i mitici trii di Bill Evans, che hanno rivoluzionato il modo di concepire il combo piano-batteria-contrabbasso, questa di Svensson e compagni sia stato la formazione che più di altre è riuscita a dire qualcosa di nuovo e originale in materia.
Ascoltando queste registrazioni effettuate live il 10 Ottobre del 2001 alla Concert Hall di Gothenburg si rinnova il rimpianto per aver perso troppo presto e in maniera davvero assurda un talento come Esbjörn Svensson qui accompagnato dai fidi partner Dan Berglund al basso e Magnus Ostrom alla batteria. Siamo negli anni in cui il trio sta consolidando il proprio essere gruppo omogeneo, compatto in grado di dire qualcosa di nuovo nel pur affollato panorama dei trii piano-basso-batteria. Ciò ovviamente per merito di tutti e tre i musicisti ma in modo particolare, del leader, il pianista Esbjörn Svensson affermatosi in brevissimo tempo come uno dei più fulgidi talenti del piano jazz a livello internazionale. In questo concerto, poi riportato sul doppio CD in oggetto, il trio rivisita alcuni dei brani contenuti nei due album già usciti in quel periodo, vale a dire “From Gagarin´s Point of View” del 1999 e “Good Morning Susie Soho” del 2000. E si è trattato di una performance davvero molto rilevante se lo stesso Svensson aveva più volte dichiarato di considerare questo concerto uno dei migliori della sua carriera. E come dargli torto? La musica è assolutamente ben costruita, ben arrangiata e altrettanto ben eseguita con i tre artisti che si ascoltano e interagiscono con immediatezza e pertinenza. Ascoltando in sequenza tutti e gli undici brani dei due CD è davvero difficile, se non impossibile, capire quando i tre improvvisano e quando seguono qualcosa di stabilito in precedenza. E non credo di esagerare affermando che dopo i mitici trii di Bill Evans, che hanno rivoluzionato il modo di concepire il combo piano-batteria-contrabbasso, questa di Svensson e compagni sia stato la formazione che più di altre è riuscita a dire qualcosa di nuovo e originale in materia.
Giovanni Falzone – “L’albero delle fate” – Parco della Musica
 Il trombettista Giovanni Falzone, il pianista Enrico Zanisi, il contrabbassista Jacopo Ferrazza e il batterista Alessandro Rossi sono i protagonisti di questo album registrato nel febbraio del 2019 all’Auditorium Parco della Musica di Roma. La musica è di segno naturistico, se mi consentite l’espressione, in quanto Giovanni per comporla si è ispirato ai sentieri, ai grandi sassi, agli alberi, agli animali, ai colori, alle fonti d’acqua che vivificano il lago di Endine, in provincia di Bergamo, dove il trombettista ama trascorrere parte del suo tempo libero. Di qui nove brani che lo stesso Falzone definisce “cartoline sonore”; ma attenzione, quanto fin qui detto non tragga in inganno ché quella di Falzone resta una musica ben lontana dal New Age e viceversa ben ancorata alle grandi tradizioni del jazz. Così nel suo linguaggio è possibile riscontrare echi di Armstrong così come, per venire a tempi a noi più vicini, di Kenny Wheeler, di Enrico Rava (al quale in occasione dell’ottantesimo compleanno il 20 agosto scorso ha dedicato una intensa ballad), di Miles Davis (ma quale trombettista non è stato influenzato da Miles?). Quindi un jazz ora vigoroso (“Il mondo di Wendy”), ora più intimista (“Capelli d’argento”) ma sempre splendidamente suonato e arrangiato. Frutto evidente dell’intesa che si respira nel gruppo in cui tutti si esprimono al meglio delle rispettive possibilità.
Il trombettista Giovanni Falzone, il pianista Enrico Zanisi, il contrabbassista Jacopo Ferrazza e il batterista Alessandro Rossi sono i protagonisti di questo album registrato nel febbraio del 2019 all’Auditorium Parco della Musica di Roma. La musica è di segno naturistico, se mi consentite l’espressione, in quanto Giovanni per comporla si è ispirato ai sentieri, ai grandi sassi, agli alberi, agli animali, ai colori, alle fonti d’acqua che vivificano il lago di Endine, in provincia di Bergamo, dove il trombettista ama trascorrere parte del suo tempo libero. Di qui nove brani che lo stesso Falzone definisce “cartoline sonore”; ma attenzione, quanto fin qui detto non tragga in inganno ché quella di Falzone resta una musica ben lontana dal New Age e viceversa ben ancorata alle grandi tradizioni del jazz. Così nel suo linguaggio è possibile riscontrare echi di Armstrong così come, per venire a tempi a noi più vicini, di Kenny Wheeler, di Enrico Rava (al quale in occasione dell’ottantesimo compleanno il 20 agosto scorso ha dedicato una intensa ballad), di Miles Davis (ma quale trombettista non è stato influenzato da Miles?). Quindi un jazz ora vigoroso (“Il mondo di Wendy”), ora più intimista (“Capelli d’argento”) ma sempre splendidamente suonato e arrangiato. Frutto evidente dell’intesa che si respira nel gruppo in cui tutti si esprimono al meglio delle rispettive possibilità.
Claudio Fasoli – “The Brooklyn Option” – abeat 206
 Questo album è in realtà la riedizione di un CD pubblicato nel 2015; quindi, dal punto di vista del contenuto musicale, nessuna novità; cambia, invece, la copertina adesso rappresentata da una bella foto scattata dallo stesso Fasoli. Il sassofonista è reduce da una serie di brillanti riconoscimenti: nel 2018 ha vinto il Top Jazz come musicista dell’anno mentre nel 2017 il suo album “Selfie” sul mercato francese è stato votato dalla rivista “JazzMagazine” come “disco shock” del mese. In questa occasione è alla testa di un quintetto all stars comprendente Ralph Alessi alla tromba, Matt Mitchell al pianoforte, Drew Gress al contrabbasso e Nasheet Waits alla batteria. Fasoli è in forma smagliante sia come compositore sia come esecutore. In effetti tutti e tredici i brani contenuti nell’album sono da lui stesso firmati e ci mostrano un musicista maturo, assolutamente consapevole dei propri mezzi ed in grado di scrivere musica a tratti coinvolgente, sempre, comunque, interessante e ben lontana dal ‘già sentito’. Ovviamente almeno parte di queste positive valutazioni dipende anche dall’esecuzione: ebbene al riguardo occorre sottolineare come il gruppo funzioni a meraviglia, con un altissimo grado di interplay che consente ai musicisti di muoversi in assoluta libertà, certo che il compagno di strada saprà quasi percepire in anticipo le sue proposte e sarà quindi in grado di condurle alle finalità desiderate. Straordinario, al riguardo, il modo in cui tromba e sassofono dialogano e suonano anche all’unisono sul filo di un idem sentire non facilissimo da raggiungere. Ancora una volta Alessi si qualifica come una delle più belle e originali voci trombettistiche degli ultimi anni. E non c’è un solo momento nel disco che non si percepisca questa intesa, questa gioia di suonare assieme. Tali caratteristiche si colgono sin dall’inizio, vale a dire dai tre movimenti che compongono la suite “Brooklyn Bridge”, aperta da una esposizione del tema armonizzata dai fiati che lasciano quindi spazio alla sezione ritmica con Mitchell, Gress e Waits a dimostrare quanto sia meritata la fama raggiunta nel corso degli ultimi anni.
Questo album è in realtà la riedizione di un CD pubblicato nel 2015; quindi, dal punto di vista del contenuto musicale, nessuna novità; cambia, invece, la copertina adesso rappresentata da una bella foto scattata dallo stesso Fasoli. Il sassofonista è reduce da una serie di brillanti riconoscimenti: nel 2018 ha vinto il Top Jazz come musicista dell’anno mentre nel 2017 il suo album “Selfie” sul mercato francese è stato votato dalla rivista “JazzMagazine” come “disco shock” del mese. In questa occasione è alla testa di un quintetto all stars comprendente Ralph Alessi alla tromba, Matt Mitchell al pianoforte, Drew Gress al contrabbasso e Nasheet Waits alla batteria. Fasoli è in forma smagliante sia come compositore sia come esecutore. In effetti tutti e tredici i brani contenuti nell’album sono da lui stesso firmati e ci mostrano un musicista maturo, assolutamente consapevole dei propri mezzi ed in grado di scrivere musica a tratti coinvolgente, sempre, comunque, interessante e ben lontana dal ‘già sentito’. Ovviamente almeno parte di queste positive valutazioni dipende anche dall’esecuzione: ebbene al riguardo occorre sottolineare come il gruppo funzioni a meraviglia, con un altissimo grado di interplay che consente ai musicisti di muoversi in assoluta libertà, certo che il compagno di strada saprà quasi percepire in anticipo le sue proposte e sarà quindi in grado di condurle alle finalità desiderate. Straordinario, al riguardo, il modo in cui tromba e sassofono dialogano e suonano anche all’unisono sul filo di un idem sentire non facilissimo da raggiungere. Ancora una volta Alessi si qualifica come una delle più belle e originali voci trombettistiche degli ultimi anni. E non c’è un solo momento nel disco che non si percepisca questa intesa, questa gioia di suonare assieme. Tali caratteristiche si colgono sin dall’inizio, vale a dire dai tre movimenti che compongono la suite “Brooklyn Bridge”, aperta da una esposizione del tema armonizzata dai fiati che lasciano quindi spazio alla sezione ritmica con Mitchell, Gress e Waits a dimostrare quanto sia meritata la fama raggiunta nel corso degli ultimi anni.
Luca Flores – “Innocence” – Auand 2 cd
 Ascoltare un inedito di Luca Flores è sempre emozionante e non solo per le vicende umane legate alla prematura scomparsa dell’artista, quanto perché la sua musica è come una sorta di scrigno contenente delle perle rare e preziose. Ovviamente anche quest’ultimo doppio album non sfugge alla regola: sedici tracce inedite incise da Luca Flores tra il 1994 e il 1995 di grande livello. Ma prima di spendere qualche parola sul contenuto artistico di “Innocence” vorrei ringraziare, a nome di tutti gli appassionati di jazz, l’amico Luigi Bozzolan, anch’egli valente pianista, il quale da tempo si sta adoperando per illustrare al meglio il lavoro di Flores, Stefano Lugli, il sound engineer che aveva curato quelle registrazioni, e Michelle Bobko, che ne aveva conservate delle copie, per aver ritrovato questo materiale e averlo regalato all’ascolto di noi tutti. E un doveroso riconoscimento va anche al pianista Alessandro Galati che ha curato selezione e mastering dell’opera. Il titolo di questo doppio cd è quello che Luca aveva indicato al produttore Peppo Spagnoli della Splasc(H) per quello che sarebbe stato il suo nuovo lavoro, un disco dedicato alla sua infanzia in Mozambico e che prevedeva un organico allargato con violoncello, percussioni, vibrafono e armonica, nonché la voce di Miriam Makeba. Data la complessità del progetto, dai costi piuttosto elevati, si decise di pubblicare un piano solo (“For Those I Never Knew”, edito da Splasch Records), con l’aggiunta di nuove tracce registrate il 19 marzo 1995; il pianista sarebbe scomparso dieci giorni dopo cosicché l’album uscì postumo. Tornando a “Innocence” i due CD si differenziano per un particolare non secondario: il primo è dedicato a brani mai incisi mentre il secondo presenta versioni alternative di pezzi già registrati. Ovviamente ciò nulla toglie all’omogeneità delle registrazioni che ci restituiscono ancora una volta un musicista straordinario dal punto di vista sia tecnico sia interpretativo. Il suo pianismo è sempre lucido, fluido, mai teso a stupire l’ascoltatore ma sempre rivolto ad esprimere il proprio io, la propria anima. Di qui una capacità di scavare all’interno di ogni singolo brano che solo i grandi possiedono. Si ascolti al riguardo come sia riuscito a fondere in un unicum “Broken Wing” e “Lush Life” e come dimostri di saper padroneggiare diversi stili, dal bop di “Work” di Thelonious Monk e “Donna Lee” di Charlie Parker, allo swing di “Strictly Confidential” fino ad un pianismo di marca intimista in “Kaleidoscopic Beams” impreziosito da un unisono piano/voce prima e dopo il lungo assolo e “Silent Brother” che chiude degnamente il cd.
Ascoltare un inedito di Luca Flores è sempre emozionante e non solo per le vicende umane legate alla prematura scomparsa dell’artista, quanto perché la sua musica è come una sorta di scrigno contenente delle perle rare e preziose. Ovviamente anche quest’ultimo doppio album non sfugge alla regola: sedici tracce inedite incise da Luca Flores tra il 1994 e il 1995 di grande livello. Ma prima di spendere qualche parola sul contenuto artistico di “Innocence” vorrei ringraziare, a nome di tutti gli appassionati di jazz, l’amico Luigi Bozzolan, anch’egli valente pianista, il quale da tempo si sta adoperando per illustrare al meglio il lavoro di Flores, Stefano Lugli, il sound engineer che aveva curato quelle registrazioni, e Michelle Bobko, che ne aveva conservate delle copie, per aver ritrovato questo materiale e averlo regalato all’ascolto di noi tutti. E un doveroso riconoscimento va anche al pianista Alessandro Galati che ha curato selezione e mastering dell’opera. Il titolo di questo doppio cd è quello che Luca aveva indicato al produttore Peppo Spagnoli della Splasc(H) per quello che sarebbe stato il suo nuovo lavoro, un disco dedicato alla sua infanzia in Mozambico e che prevedeva un organico allargato con violoncello, percussioni, vibrafono e armonica, nonché la voce di Miriam Makeba. Data la complessità del progetto, dai costi piuttosto elevati, si decise di pubblicare un piano solo (“For Those I Never Knew”, edito da Splasch Records), con l’aggiunta di nuove tracce registrate il 19 marzo 1995; il pianista sarebbe scomparso dieci giorni dopo cosicché l’album uscì postumo. Tornando a “Innocence” i due CD si differenziano per un particolare non secondario: il primo è dedicato a brani mai incisi mentre il secondo presenta versioni alternative di pezzi già registrati. Ovviamente ciò nulla toglie all’omogeneità delle registrazioni che ci restituiscono ancora una volta un musicista straordinario dal punto di vista sia tecnico sia interpretativo. Il suo pianismo è sempre lucido, fluido, mai teso a stupire l’ascoltatore ma sempre rivolto ad esprimere il proprio io, la propria anima. Di qui una capacità di scavare all’interno di ogni singolo brano che solo i grandi possiedono. Si ascolti al riguardo come sia riuscito a fondere in un unicum “Broken Wing” e “Lush Life” e come dimostri di saper padroneggiare diversi stili, dal bop di “Work” di Thelonious Monk e “Donna Lee” di Charlie Parker, allo swing di “Strictly Confidential” fino ad un pianismo di marca intimista in “Kaleidoscopic Beams” impreziosito da un unisono piano/voce prima e dopo il lungo assolo e “Silent Brother” che chiude degnamente il cd.
Jan Garbarek, The Hilliard Ensemble – “Remember me, my dear” – ECM New Series 2625
 Ho conosciuto personalmente Jan Garbarek nel 1982 quando abitavo in Norvegia; in quella occasione l’ho trovato persona squisita, cortese, sensibile…oltre che straordinario musicista. E questa valutazione sull’artista nel corso degli anni non è mutata di una virgola…anzi. Quest’ultimo album mi conferma vieppiù nel considerare Jan Garbarek uno dei musicisti più originali, maturi, straordinari degli ultimi decenni. Ancora una volta accanto all’Hilliard Ensemble (questo è il quinto album da loro inciso nel corso degli ultimi ventisei anni), il sassofonista norvegese ci regala un’altra rara perla, una musica assolutamente inconsueta che affascina chi mantiene mente e cuore aperti. Qui non c’è più la distinzione tra generi: non si tratta di jazz, di musica classica, di folk, di musica religiosa ma di una straordinaria miscela di suoni, ricca di pathos, che ci trasporta in una dimensione trascendente l’attualità per instaurare un colloquio diretto con l’anima di chi ascolta. Ecco quindi un repertorio che abbraccia un lunghissimo arco di tempo, con quattordici brani di cui due firmati rispettivamente da Christ Komitas e Nikolai N. Kedrov autori a cavallo tra Otto e Novecento, cinque di autore anonimo, uno a testa per Guillaume le Rouge, maestro Pérotin, Hildegard von Bingen, Antoine Brumel tutti databili da 1098 al 1500,lo splendido “Most Holy Mother of God” di Arvo Pärt, più due composizioni originali dello stesso Garbarek. L’apertura è affidata a “Ov zarmanali” inno battista del religioso armeno Christ Komitas, interpretato da Garbarek in solitudine ed è questo il brano in cui si ascolta maggiormente il sax soprano del musicista norvegese, dal momento che negli altri pezzi a prevalere sono sostanzialmente le voci. Particolarmente degna di nota l’”Alleluia Nativitas” del Maestro Perotino. Un’ultima notazione: la registrazione, effettuata nella Chiesa della Collegiata dei SS.Pietro e Stefano di Bellinzona risale all’ottobre del 2014; come mai è stata pubblicata solo adesso?
Ho conosciuto personalmente Jan Garbarek nel 1982 quando abitavo in Norvegia; in quella occasione l’ho trovato persona squisita, cortese, sensibile…oltre che straordinario musicista. E questa valutazione sull’artista nel corso degli anni non è mutata di una virgola…anzi. Quest’ultimo album mi conferma vieppiù nel considerare Jan Garbarek uno dei musicisti più originali, maturi, straordinari degli ultimi decenni. Ancora una volta accanto all’Hilliard Ensemble (questo è il quinto album da loro inciso nel corso degli ultimi ventisei anni), il sassofonista norvegese ci regala un’altra rara perla, una musica assolutamente inconsueta che affascina chi mantiene mente e cuore aperti. Qui non c’è più la distinzione tra generi: non si tratta di jazz, di musica classica, di folk, di musica religiosa ma di una straordinaria miscela di suoni, ricca di pathos, che ci trasporta in una dimensione trascendente l’attualità per instaurare un colloquio diretto con l’anima di chi ascolta. Ecco quindi un repertorio che abbraccia un lunghissimo arco di tempo, con quattordici brani di cui due firmati rispettivamente da Christ Komitas e Nikolai N. Kedrov autori a cavallo tra Otto e Novecento, cinque di autore anonimo, uno a testa per Guillaume le Rouge, maestro Pérotin, Hildegard von Bingen, Antoine Brumel tutti databili da 1098 al 1500,lo splendido “Most Holy Mother of God” di Arvo Pärt, più due composizioni originali dello stesso Garbarek. L’apertura è affidata a “Ov zarmanali” inno battista del religioso armeno Christ Komitas, interpretato da Garbarek in solitudine ed è questo il brano in cui si ascolta maggiormente il sax soprano del musicista norvegese, dal momento che negli altri pezzi a prevalere sono sostanzialmente le voci. Particolarmente degna di nota l’”Alleluia Nativitas” del Maestro Perotino. Un’ultima notazione: la registrazione, effettuata nella Chiesa della Collegiata dei SS.Pietro e Stefano di Bellinzona risale all’ottobre del 2014; come mai è stata pubblicata solo adesso?
Ghost Horse – “Trojan” – Auand 9090
 Ecco la nuova formazione posta in essere sulle orme del precedente gruppo “Hobby Horse” dal sassofonista Dan Kinzelman con Filippo Vignato al trombone, Gabrio Baldacci alla chitarra baritona, Joe Rehmer al basso elettrico, Stefano Tamborrino alla batteria e Glauco Benedetti all’eufonio e alla tuba. Come si nota un organico piuttosto insolito così come insolita è la musica proposta. Una musica che trae spunti dal jazz, dal rock, dalla psichedelia cui si riferisce la frequente reiterazione di brevi frasi musicali che finiscono per ottenere un effetto in bilico tra l’onirico e l’ipnotico. Il tutto impreziosito da una intelligente ricerca sul suono, sulla timbrica e sulla dinamica particolarmente evidente nel brano di chiusura “Pyre” di Kinzelman (autore di cinque degli otto brani in repertorio) caratterizzato sul finire da quella reiterazione cui prima si faceva riferimento. Ma è l’intero album che si fa ascoltare con interesse dal primo all’ultimo minuto. Così, tanto per citare qualche altro titolo, la title track che apre l’album evidenzia la volontà del gruppo di non fermarsi su terreni particolarmente frequentati e di ricercare da un canto una propria specificità con frasi oblique, sghembe, tutt’altro che scontate, dall’altro una dimensione quasi orchestrale con un crescendo in cui tutti i componenti il sestetto hanno modo di mettersi in luce. In “Il bisonte” è in primo piano il sound così particolare della tuba utilizzata in un ruolo tutt’altro che coloristico. Convincente l’impianto narrativo di “Five Civilized Tribes” con in primo piano Gabrio Baldacci e Stefano Tamborrino autore del brano. Più legato a stilemi tradizionali, ma non per questo meno affascinante, “Hydraulic Empire” con un Vignato in grande spolvero mentre in “Dancing Rabbit” è in primo piano la sezione ritmica di Tamborrino e Rehmer. Per chiudere una menzione la merita anche la crepuscolare “Forest For The Trees” (di Kinzelman) in cui si avverte forse più che altrove quel fine lavoro di cesello cui si dedicano i fiati.
Ecco la nuova formazione posta in essere sulle orme del precedente gruppo “Hobby Horse” dal sassofonista Dan Kinzelman con Filippo Vignato al trombone, Gabrio Baldacci alla chitarra baritona, Joe Rehmer al basso elettrico, Stefano Tamborrino alla batteria e Glauco Benedetti all’eufonio e alla tuba. Come si nota un organico piuttosto insolito così come insolita è la musica proposta. Una musica che trae spunti dal jazz, dal rock, dalla psichedelia cui si riferisce la frequente reiterazione di brevi frasi musicali che finiscono per ottenere un effetto in bilico tra l’onirico e l’ipnotico. Il tutto impreziosito da una intelligente ricerca sul suono, sulla timbrica e sulla dinamica particolarmente evidente nel brano di chiusura “Pyre” di Kinzelman (autore di cinque degli otto brani in repertorio) caratterizzato sul finire da quella reiterazione cui prima si faceva riferimento. Ma è l’intero album che si fa ascoltare con interesse dal primo all’ultimo minuto. Così, tanto per citare qualche altro titolo, la title track che apre l’album evidenzia la volontà del gruppo di non fermarsi su terreni particolarmente frequentati e di ricercare da un canto una propria specificità con frasi oblique, sghembe, tutt’altro che scontate, dall’altro una dimensione quasi orchestrale con un crescendo in cui tutti i componenti il sestetto hanno modo di mettersi in luce. In “Il bisonte” è in primo piano il sound così particolare della tuba utilizzata in un ruolo tutt’altro che coloristico. Convincente l’impianto narrativo di “Five Civilized Tribes” con in primo piano Gabrio Baldacci e Stefano Tamborrino autore del brano. Più legato a stilemi tradizionali, ma non per questo meno affascinante, “Hydraulic Empire” con un Vignato in grande spolvero mentre in “Dancing Rabbit” è in primo piano la sezione ritmica di Tamborrino e Rehmer. Per chiudere una menzione la merita anche la crepuscolare “Forest For The Trees” (di Kinzelman) in cui si avverte forse più che altrove quel fine lavoro di cesello cui si dedicano i fiati.
Rosario Giuliani – “Love in Translation” – VVJ 133
 Una sezione ritmica tra le migliori del jazz non solo italiano (Dario Deidda basso e Roberto Gatto batteria; li si ascolti in “Hidden force of love”) e una front line costituita da due grandi performer quali Rosario Giuliani ai sax alto e soprano e Joe Locke al vibrafono: ecco in poche righe spiegati i motivi del perché questo album si percepisce con grande piacere. Come solo i grandi musicisti sanno fare, i brani si susseguono con scioltezza e si ha l’impressione che tutto sia facile anche quando, ascoltando più attentamente, si scopre che le cose non stanno proprio così. In effetti gli arrangiamenti sono tutt’altro che banali e il modo di interloquire vibrafono-sax è il frutto di un’intesa assai solida, cementificata da un ventennio di collaborazione che i due intendono festeggiare proprio con l’uscita di questo album. Il repertorio è quanto mai variegato passando da classici del jazz (“Duke Ellington’s Sound of Love” di Charles Mingus, o “Everything I Love” di Cole Porter”) a hit della musica pop quali “I Wish You Love”, versione inglese della celeberrima “Que reste-t-il de nos amours?” di Charles Trenet o quel “Can’t Help Falling In Love” di Peretti-Creatore-Weiss che inopinatamente troveremo anche nel CD di Oded Tzur di cui si parla più in basso; a questi si aggiungono alcuni original quali “Raise Heaven” dedicato da Joe Locke a Roy Hargrove e “Tamburo” di Rosario Giuliani per l’amico Marco Tamburini. Come prima sottolineato, tutti e dieci i brani in repertorio si ascoltano con molta piacevolezza, tuttavia mi ha particolarmente impressionato il dialogo di sax e vibrafono in “Can’t Help Falling In Love” e le modalità con cui il gruppo nella sua interezza ha approcciato un brano non facile come il mingusiano “Duke Ellington’s Sound of Love”.
Una sezione ritmica tra le migliori del jazz non solo italiano (Dario Deidda basso e Roberto Gatto batteria; li si ascolti in “Hidden force of love”) e una front line costituita da due grandi performer quali Rosario Giuliani ai sax alto e soprano e Joe Locke al vibrafono: ecco in poche righe spiegati i motivi del perché questo album si percepisce con grande piacere. Come solo i grandi musicisti sanno fare, i brani si susseguono con scioltezza e si ha l’impressione che tutto sia facile anche quando, ascoltando più attentamente, si scopre che le cose non stanno proprio così. In effetti gli arrangiamenti sono tutt’altro che banali e il modo di interloquire vibrafono-sax è il frutto di un’intesa assai solida, cementificata da un ventennio di collaborazione che i due intendono festeggiare proprio con l’uscita di questo album. Il repertorio è quanto mai variegato passando da classici del jazz (“Duke Ellington’s Sound of Love” di Charles Mingus, o “Everything I Love” di Cole Porter”) a hit della musica pop quali “I Wish You Love”, versione inglese della celeberrima “Que reste-t-il de nos amours?” di Charles Trenet o quel “Can’t Help Falling In Love” di Peretti-Creatore-Weiss che inopinatamente troveremo anche nel CD di Oded Tzur di cui si parla più in basso; a questi si aggiungono alcuni original quali “Raise Heaven” dedicato da Joe Locke a Roy Hargrove e “Tamburo” di Rosario Giuliani per l’amico Marco Tamburini. Come prima sottolineato, tutti e dieci i brani in repertorio si ascoltano con molta piacevolezza, tuttavia mi ha particolarmente impressionato il dialogo di sax e vibrafono in “Can’t Help Falling In Love” e le modalità con cui il gruppo nella sua interezza ha approcciato un brano non facile come il mingusiano “Duke Ellington’s Sound of Love”.
Wolfgang Haffner – “Kind of Tango” – ACT 9899-2
 Ad alcuni sembrerà forse strano che dei musicisti nordeuropei si interessino di tango, ma si tratta di una impressione totalmente errata. In effetti il Paese dove il tango è più frequentato, ascoltato, ballato – ovviamente al di fuori dell’Argentina – è un Paese del Nord Europa e precisamente la Finlandia. Chiarito questo equivoco, con questo album siamo in terra di Germania dove il batterista Wolfgang Haffner ha costituito un gruppo di stelle a livello internazionale per affrontare un repertorio piuttosto impegnativo dal momento che sotto l’insegna del tango si ascoltano sia brani di compositori celebri come Astor Piazzolla, Gerardo Matos Rodriguez sia original dei componenti il sestetto. Ecco quindi uno accanto all’altro il già citato Haffner, gli altri tedeschi Christopher Dell al vibrafono e Simon Oslender al piano, il francese Vincent Peirani all’accordion, gli svedesi Lars Danielsson al basso e cello e Ulf Wakenius alla chitarra, “rinforzati” dalla presenza in alcuni brani dei tedeschi Alma Naidu vocalist e Sebastian Studnitzky trombettista, dello svedese Lars Nilsson flicorno e del sassofonista statunitense Bill Evans. E c’è un altro equivoco da chiarire. In questo caso non si tratta della m era riproposizione delle atmosfere tipiche del tango, quanto di un’operazione un tantino più complessa e ben illustrata dallo stesso batterista quando afferma che per lui ascoltare e scrivere un tango non è una semplice traduzione in musica di ciò che ha sentito ma l’assorbire e l’adattare degli input ricevuti in un processo da cui può scaturire qualcosa di nuovo e contemporaneo. Ed in effetti ascoltando la riproposizione dei tanghi più celebri da tutti conosciuti quali “La Cumparista”, “Libertango” e “Chiquilin de Bachin” da un lato non c’è quel pathos che caratterizza le esecuzioni di un Astor Piazzolla, dall’altro si avverte la volontà di distaccarsi dai modelli originari per giungere su spiagge inesplorate. Tentativo riuscito? A mio avviso sì, ma ascoltate e giudicate.
Ad alcuni sembrerà forse strano che dei musicisti nordeuropei si interessino di tango, ma si tratta di una impressione totalmente errata. In effetti il Paese dove il tango è più frequentato, ascoltato, ballato – ovviamente al di fuori dell’Argentina – è un Paese del Nord Europa e precisamente la Finlandia. Chiarito questo equivoco, con questo album siamo in terra di Germania dove il batterista Wolfgang Haffner ha costituito un gruppo di stelle a livello internazionale per affrontare un repertorio piuttosto impegnativo dal momento che sotto l’insegna del tango si ascoltano sia brani di compositori celebri come Astor Piazzolla, Gerardo Matos Rodriguez sia original dei componenti il sestetto. Ecco quindi uno accanto all’altro il già citato Haffner, gli altri tedeschi Christopher Dell al vibrafono e Simon Oslender al piano, il francese Vincent Peirani all’accordion, gli svedesi Lars Danielsson al basso e cello e Ulf Wakenius alla chitarra, “rinforzati” dalla presenza in alcuni brani dei tedeschi Alma Naidu vocalist e Sebastian Studnitzky trombettista, dello svedese Lars Nilsson flicorno e del sassofonista statunitense Bill Evans. E c’è un altro equivoco da chiarire. In questo caso non si tratta della m era riproposizione delle atmosfere tipiche del tango, quanto di un’operazione un tantino più complessa e ben illustrata dallo stesso batterista quando afferma che per lui ascoltare e scrivere un tango non è una semplice traduzione in musica di ciò che ha sentito ma l’assorbire e l’adattare degli input ricevuti in un processo da cui può scaturire qualcosa di nuovo e contemporaneo. Ed in effetti ascoltando la riproposizione dei tanghi più celebri da tutti conosciuti quali “La Cumparista”, “Libertango” e “Chiquilin de Bachin” da un lato non c’è quel pathos che caratterizza le esecuzioni di un Astor Piazzolla, dall’altro si avverte la volontà di distaccarsi dai modelli originari per giungere su spiagge inesplorate. Tentativo riuscito? A mio avviso sì, ma ascoltate e giudicate.
Ayler’s Mood “Combat joy” e Pasquale Innarella “Go Dex”Quartet– aut records 051, 053
 Due cd dedicati a due giganti del sax: il Trio Ayler’s Mood, costituito da Pasquale Innarella al sax, Danilo Gallo al basso elettrico e Ermanno Baron alla batteria sono i protagonisti di “Combat Joy”, dedicato ad Albert Ayler, e Pasquale Innarella e “Go Dex Quartet” dedicato a Dexter Gordon. Una sfida molto, molto difficile, quella con i mondi sonori di due grandi sassofonisti molto diversi tra di loro e quindi impossibili da ricondurre ad un unicum. Di qui l’intelligenza poetica – mi si passi il termine – di questi due gruppi e di Innarella che, come sassofonista, ben lungi dal voler imitare l’inimitabile, ha voluto con i suoi compagni di viaggio, piuttosto, rileggere le esperienze dei due grandi artisti. In particolare nel primo album, “Ayler’s Mood”, registrato live durante un concerto a “Jazz in Cantina”, zona Quarto Miglio, Roma, il 22 dicembre del 2018, Innarella (nell’occasione anche al sax soprano) coadiuvato da due eccellenti partner quali Danilo Gallo al basso e Ermanno Baron alla batteria, si rivolge all’universo di Albert Ayler (1936-1970) considerato a ben ragione uno dei massimi esponenti del free anni sessanta; lo stile del musicista di Cleveland era caratterizzato da un vibrato molto aggressivo e da un linguaggio che destrutturava gli elementi fondativi della musica, vale a dire melodia, armonia e timbro. Come affrontare quindi, tale musica senza ricorrere a sterile imitazioni? Lasciandosi andare ad una improvvisazione pura, estemporanea (come sottolineato nella presentazione dell’album) è stata la risposta di Innarella e compagni. Un flusso sonoro di circa un’ora che coinvolge l’ascoltatore in una sorta di viaggio senza meta, assolutamente coinvolgente. I tre suonano liberamente ma con estrema lucidità, in un quadro in cui nessuno ha la prevalenza sull’altro e in cui la musica di Ayler rivive in tutta la sua drammatica attualità con lacerti di free che si alternano con accenni di calypso o di R&B…senza trascurare alcune citazioni ben riconoscibili.
Due cd dedicati a due giganti del sax: il Trio Ayler’s Mood, costituito da Pasquale Innarella al sax, Danilo Gallo al basso elettrico e Ermanno Baron alla batteria sono i protagonisti di “Combat Joy”, dedicato ad Albert Ayler, e Pasquale Innarella e “Go Dex Quartet” dedicato a Dexter Gordon. Una sfida molto, molto difficile, quella con i mondi sonori di due grandi sassofonisti molto diversi tra di loro e quindi impossibili da ricondurre ad un unicum. Di qui l’intelligenza poetica – mi si passi il termine – di questi due gruppi e di Innarella che, come sassofonista, ben lungi dal voler imitare l’inimitabile, ha voluto con i suoi compagni di viaggio, piuttosto, rileggere le esperienze dei due grandi artisti. In particolare nel primo album, “Ayler’s Mood”, registrato live durante un concerto a “Jazz in Cantina”, zona Quarto Miglio, Roma, il 22 dicembre del 2018, Innarella (nell’occasione anche al sax soprano) coadiuvato da due eccellenti partner quali Danilo Gallo al basso e Ermanno Baron alla batteria, si rivolge all’universo di Albert Ayler (1936-1970) considerato a ben ragione uno dei massimi esponenti del free anni sessanta; lo stile del musicista di Cleveland era caratterizzato da un vibrato molto aggressivo e da un linguaggio che destrutturava gli elementi fondativi della musica, vale a dire melodia, armonia e timbro. Come affrontare quindi, tale musica senza ricorrere a sterile imitazioni? Lasciandosi andare ad una improvvisazione pura, estemporanea (come sottolineato nella presentazione dell’album) è stata la risposta di Innarella e compagni. Un flusso sonoro di circa un’ora che coinvolge l’ascoltatore in una sorta di viaggio senza meta, assolutamente coinvolgente. I tre suonano liberamente ma con estrema lucidità, in un quadro in cui nessuno ha la prevalenza sull’altro e in cui la musica di Ayler rivive in tutta la sua drammatica attualità con lacerti di free che si alternano con accenni di calypso o di R&B…senza trascurare alcune citazioni ben riconoscibili.
Nel secondo CD, “Go Dex”, Innarella è in quartetto con Paolo Cintio al piano, Leonardo De Rose al contrabbasso e Giampiero Silvestri alla batteria. In questo caso il discorso è completamente diverso e non potrebbe essere altrimenti dato che Dexter Gordon (1923-1990) è stato uno degli alfieri del bebop, un artista straordinario di recente ricordato in un bel volume della EDT di cui ci si occuperà quanto prima. Nell’album Innarella esegue sette composizioni di Dexter Gordon con l’aggiunta di un celeberrimo standard, “Misty” di Errol Garner. Ma è già nel termine “Go Dex” che si vuole omaggiare il sassofonista di Los Angeles dal momento che “Go” è il titolo che lo stesso Dexter volle dare ad un suo album registrato nell’agosto del 1962 con Sonny Clark piano, Butch Warren basso e Billy Higgins batteria. Ma Pasquale non si è fermato qui: Gordon ha scritto pochi brani e Innarella ha voluto, quindi, riproporne almeno una parte tenendosi però ben lontano da una pedissequa imitazione. Quindi non un linguaggio boppistico ma un jazz moderno, attuale, che non disdegna incursioni nel mondo del free. Ecco le prime battute dell’album eseguite secondo stilemi molto vicini al free accanto ad una convincente e canonica interpretazione di “Misty” con sonorità più legate alla tradizione; ecco “Soy Califa” dall’andamento funkeggiante, illuminato da uno splendido assolo di Paolo Cintio accanto al conclusivo “Sticky Wichet” che ci riconduce ad atmosfere molto accese… il tutto senza perdere di vista, in alcun momento, quelli che erano i principi ispiratori di Gordon e che ritroviamo intatti in questo pregevole album.
Keith Jarrett – “Munich 2016” – ECM 2667/68
 Passano gli anni ma è sempre un’esperienza appagante ascoltare Keith Jarrett specie su disco (ché dal vivo alcune intemperanze sono francamente insopportabili). In questo doppio CD, registrato alla Philarmonic Hall di Berlino il 16 luglio del 2016, ultima sera di un tour europeo, Jarrett, in totale solitudine, ci presenta una suite in dodici parti dal titolo “Munich” totalmente improvvisata e tre bis, “Answer Me, My Love” (versione inglese della canzone tedesca del 1953, “Mütterlein”), “It’s A Lonesome Old Town” e “Somewhere Over The Rainbow”. Com’è facile immaginare, il Jarrett migliore lo si trova nella prima parte, e soprattutto nel primo movimento dove, in circa quindici minuti di musica magmatica e complessa, il pianista improvvisa liberamente mescolando gli input che oramai da tempo costituiscono gli ingredienti fondamentali della sua cifra stilistica, vale a dire jazz, blues, gospel, folk, musica colta. Ed è davvero un bel sentire: gli intricati percorsi disegnati da Jarrett confluiscono sempre laddove l’artista vuole arrivare, nonostante le spericolate armonizzazioni e la velocissima diteggiatura che alle volte non consentano all’ascoltatore, seppur attento, di immaginare il percorso immaginato dall’artista. E seppur meno intense anche i successivi momenti della suite mantengono davvero alto lo standard esecutivo ed improvvisativo di Jarrett. Leggermente diverso il discorso per i tre brani. Jarrett sembra essersi relativamente placato fino a regalarci una splendida versione del celeberrimo “Over The Rainbow” che da solo vale l’acquisto dell’album.
Passano gli anni ma è sempre un’esperienza appagante ascoltare Keith Jarrett specie su disco (ché dal vivo alcune intemperanze sono francamente insopportabili). In questo doppio CD, registrato alla Philarmonic Hall di Berlino il 16 luglio del 2016, ultima sera di un tour europeo, Jarrett, in totale solitudine, ci presenta una suite in dodici parti dal titolo “Munich” totalmente improvvisata e tre bis, “Answer Me, My Love” (versione inglese della canzone tedesca del 1953, “Mütterlein”), “It’s A Lonesome Old Town” e “Somewhere Over The Rainbow”. Com’è facile immaginare, il Jarrett migliore lo si trova nella prima parte, e soprattutto nel primo movimento dove, in circa quindici minuti di musica magmatica e complessa, il pianista improvvisa liberamente mescolando gli input che oramai da tempo costituiscono gli ingredienti fondamentali della sua cifra stilistica, vale a dire jazz, blues, gospel, folk, musica colta. Ed è davvero un bel sentire: gli intricati percorsi disegnati da Jarrett confluiscono sempre laddove l’artista vuole arrivare, nonostante le spericolate armonizzazioni e la velocissima diteggiatura che alle volte non consentano all’ascoltatore, seppur attento, di immaginare il percorso immaginato dall’artista. E seppur meno intense anche i successivi momenti della suite mantengono davvero alto lo standard esecutivo ed improvvisativo di Jarrett. Leggermente diverso il discorso per i tre brani. Jarrett sembra essersi relativamente placato fino a regalarci una splendida versione del celeberrimo “Over The Rainbow” che da solo vale l’acquisto dell’album.
Lydian Sound Orchestra – “Mare 1519” – Parco della Musica Records
 Oramai da tempo la Lydian Sound Orchestra viene a ben ragione considerata una delle migliori big band a livello internazionale e ciò per alcuni validi motivi; innanzitutto la bontà dell’organico che prevede artisti tutti di assoluto spessore quali i sassofonisti Robert Bonisolo, Rossano Emili e Mauro Negri anche al clarinetto, Gianluca Carollo alla tromba e flicorno, Roberto Rossi al trombone, Giovanni Hoffer al corno francese, Glauco Benedetti alla tuba, Paolo Birro al piano e al Fender Rhodes, Marc Abrams al basso e Mauro Beggio alla batteria, Riccardo Brazzale piano e direzione, Bruno Grotto electronics e Vivian Grillo voce. In secondo luogo il grande lavoro svolto da Riccardo Brazzale che è stato capace di mettere assieme una compagine di tutto rispetto e di scrivere per essa arrangiamenti coinvolgenti che non a caso sono stati interpretati dall’orchestra con estrema compattezza. A ciò si aggiunga una sempre lucida scelta del repertorio che anche questa volta è composto sia da composizioni originali del leader sia da composizioni di alcuni grandi della musica come Ellington, Monk, Shorter, Miles Davis, Paul Simon. In più questo album è una sorta di concept dal momento che, come spiegato nelle note, due numeri, 1 e 9, accompagnano nel corso dei secoli i viaggi e i viaggiatori, a partire dall’impresa di Magellano del 1519 ( considerata l’inizio dell’era moderna ) per finire al 2019 quando il mar Mediterraneo continua a raccontare di nascite e di morti; insomma questa volta Brazzale vuole prendere per mano l’ascoltatore e condurlo attraverso quel mar Mediterraneo, testimone delle più importanti vicende dell’umanità, per un viaggio che metaforicamente riproduce alcune fasi della storia del jazz. Di qui una musica immaginifica, travolgente a tratti, sempre improntata alla commistione di più elementi, dal jazz al folk alla musica classica, il tutto impreziosito da una originalità di linguaggio vivificata dal grande livello dei vari solisti cui prima si faceva riferimento.
Oramai da tempo la Lydian Sound Orchestra viene a ben ragione considerata una delle migliori big band a livello internazionale e ciò per alcuni validi motivi; innanzitutto la bontà dell’organico che prevede artisti tutti di assoluto spessore quali i sassofonisti Robert Bonisolo, Rossano Emili e Mauro Negri anche al clarinetto, Gianluca Carollo alla tromba e flicorno, Roberto Rossi al trombone, Giovanni Hoffer al corno francese, Glauco Benedetti alla tuba, Paolo Birro al piano e al Fender Rhodes, Marc Abrams al basso e Mauro Beggio alla batteria, Riccardo Brazzale piano e direzione, Bruno Grotto electronics e Vivian Grillo voce. In secondo luogo il grande lavoro svolto da Riccardo Brazzale che è stato capace di mettere assieme una compagine di tutto rispetto e di scrivere per essa arrangiamenti coinvolgenti che non a caso sono stati interpretati dall’orchestra con estrema compattezza. A ciò si aggiunga una sempre lucida scelta del repertorio che anche questa volta è composto sia da composizioni originali del leader sia da composizioni di alcuni grandi della musica come Ellington, Monk, Shorter, Miles Davis, Paul Simon. In più questo album è una sorta di concept dal momento che, come spiegato nelle note, due numeri, 1 e 9, accompagnano nel corso dei secoli i viaggi e i viaggiatori, a partire dall’impresa di Magellano del 1519 ( considerata l’inizio dell’era moderna ) per finire al 2019 quando il mar Mediterraneo continua a raccontare di nascite e di morti; insomma questa volta Brazzale vuole prendere per mano l’ascoltatore e condurlo attraverso quel mar Mediterraneo, testimone delle più importanti vicende dell’umanità, per un viaggio che metaforicamente riproduce alcune fasi della storia del jazz. Di qui una musica immaginifica, travolgente a tratti, sempre improntata alla commistione di più elementi, dal jazz al folk alla musica classica, il tutto impreziosito da una originalità di linguaggio vivificata dal grande livello dei vari solisti cui prima si faceva riferimento.
Christian McBride – “The Movement Revisited” – Mack Avenue 1082
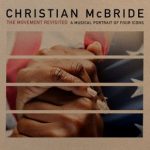 “The Movement Revisited: A Musical Portrait of Four Icons” è esplicitamente dedicato a quattro figure chiave del movimento per i diritti civili degli afro-americani: Rev. Dr. Martin Luther King Jr., Malcolm X, Rosa Parks e Muhammad Ali. In realtà questa monumentale opera ha una storia piuttosto complessa che ha origine nel 1998 quando, su commissione della Portland Arts Society, McBride scrisse una composizione per quartetto e coro gospel che rappresenta, per l’appunto, la prima versione di “The Movement Revisited”. Nel 2008 la L.A. Philharmonic chiese a McBride di farne una versione orchestrale e così “The Movement Revisited” diventò una suite in quattro parti per big band jazz, piccolo gruppo jazz, coro gospel e quattro narratori. In questa registrazione, effettuata nel 2013, è stato aggiunto un quinto movimento, “Apotheosis”, dedicato all’elezione di Barack Obama come primo presidente afroamericano degli Stati Uniti. Evidente, quindi, l’intento di Christian McBride (contrabbassista, compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra, poeta, vincitore di due Grammy con “The Good Feeling” nel 2011 e “Bringin ‘It” nel 2017) di presentare un album che andasse ben al di là del fattore squisitamente musicale riallacciandosi direttamente alla lotta per una effettiva eguaglianza tra bianchi e neri, ancora ben lungi dall’essere raggiunta negli States. La suite è eseguita da una big band di 18 elementi, con coro gospel e narratori, questi ultimi nelle persone di Sonia Sanchez, Vondie Curtis-Hall, Dion Graham, e Wendell Pierce. E come accade alle volte, è impossibile scindere il mero valore artistico dal valore sociale, politico, culturale che questa musica veicola. Non a caso l’album ha ottenuto i più sinceri riconoscimenti da parte di accreditati critici statunitensi. In effetti ascoltando il CD è come se ci si muovesse in un contesto teatrale con i quattro attori che riportano stralci dei discorsi dei protagonisti e un sound che è una sorta di summa di tutta la musica nera, quindi jazz, soul, funk, gospel, spiritual…Insomma una musica che è allo stesso tempo un grido di dolore per quanto accaduto e un segno di speranza per un futuro che non può essere disgiunto dal passato in quanto, come nota lo stesso McBride, “ci sono oggi nuove battaglie che stiamo combattendo, ma sento che queste nuove battaglie cadono sotto l’ombrello di uguaglianza, equità e diritti umani – e questa è una vecchia battaglia». Particolarmente emozionante, al riguardo, riascoltare “I Have a Dream”, un discorso che credo tutti dovremmo, ancora oggi, apprezzare nei suoi profondi significati.
“The Movement Revisited: A Musical Portrait of Four Icons” è esplicitamente dedicato a quattro figure chiave del movimento per i diritti civili degli afro-americani: Rev. Dr. Martin Luther King Jr., Malcolm X, Rosa Parks e Muhammad Ali. In realtà questa monumentale opera ha una storia piuttosto complessa che ha origine nel 1998 quando, su commissione della Portland Arts Society, McBride scrisse una composizione per quartetto e coro gospel che rappresenta, per l’appunto, la prima versione di “The Movement Revisited”. Nel 2008 la L.A. Philharmonic chiese a McBride di farne una versione orchestrale e così “The Movement Revisited” diventò una suite in quattro parti per big band jazz, piccolo gruppo jazz, coro gospel e quattro narratori. In questa registrazione, effettuata nel 2013, è stato aggiunto un quinto movimento, “Apotheosis”, dedicato all’elezione di Barack Obama come primo presidente afroamericano degli Stati Uniti. Evidente, quindi, l’intento di Christian McBride (contrabbassista, compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra, poeta, vincitore di due Grammy con “The Good Feeling” nel 2011 e “Bringin ‘It” nel 2017) di presentare un album che andasse ben al di là del fattore squisitamente musicale riallacciandosi direttamente alla lotta per una effettiva eguaglianza tra bianchi e neri, ancora ben lungi dall’essere raggiunta negli States. La suite è eseguita da una big band di 18 elementi, con coro gospel e narratori, questi ultimi nelle persone di Sonia Sanchez, Vondie Curtis-Hall, Dion Graham, e Wendell Pierce. E come accade alle volte, è impossibile scindere il mero valore artistico dal valore sociale, politico, culturale che questa musica veicola. Non a caso l’album ha ottenuto i più sinceri riconoscimenti da parte di accreditati critici statunitensi. In effetti ascoltando il CD è come se ci si muovesse in un contesto teatrale con i quattro attori che riportano stralci dei discorsi dei protagonisti e un sound che è una sorta di summa di tutta la musica nera, quindi jazz, soul, funk, gospel, spiritual…Insomma una musica che è allo stesso tempo un grido di dolore per quanto accaduto e un segno di speranza per un futuro che non può essere disgiunto dal passato in quanto, come nota lo stesso McBride, “ci sono oggi nuove battaglie che stiamo combattendo, ma sento che queste nuove battaglie cadono sotto l’ombrello di uguaglianza, equità e diritti umani – e questa è una vecchia battaglia». Particolarmente emozionante, al riguardo, riascoltare “I Have a Dream”, un discorso che credo tutti dovremmo, ancora oggi, apprezzare nei suoi profondi significati.
Dino e Franco Piana – “Open Spaces” – Alfa Music
 Conosco Dino e Franco Piana oramai da tanti anni e mi ha sempre stupito la straordinaria intesa tra padre e figlio che ha portato questi due personaggi ad attraversare l’oceano del jazz con signorilità, competenza e pochi ma significativi album. In effetti i due (il primo nella veste di trombonista dalla classe eccelsa, il secondo nella quadruplice funzione di compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra e flicornista) entrano in sala di incisione solo quando sentono di avere qualcosa di nuovo da dire. Di qui gli ultimi tre album particolarmente significativi, tutti registrati per l’Alfa Music, “Seven” (2012), “Seasons” (2015), e adesso questo “Open Spaces” il cui organico è sostanzialmente lo stesso dell’album precedente cui si aggiungono i cinque archi della Bim Orchestra. Quindi, oltre a Dino e Franco Piana, si possono ascoltare Fabrizio Bosso alla tromba, Max Ionata al sax tenore, Ferruccio Corsi al sax alto, Lorenzo Corsi al flauto, Enrico Pieranunzi al piano, Giuseppe Bassi al basso e Roberto Gatto alla batteria. In repertorio due suite, “Open Spaces” e “Sketch of Colours”, articolate la prima su una Introduzione e tre Variazioni, la seconda su una Introduzione e due Movimenti, ed in più altri tre brani “Dreaming”, “Sunshine” e “Blue Blues”, tutti composti e arrangiati da Franco Piana eccezion fatta per “Sketch of Colours” scritto da Franco Piana e Lorenzo Corsi. L’album è davvero di assoluto livello e per più di un motivo. Innanzitutto la scrittura di Franco che, accoppiata ad una evidente bravura nell’arrangiamento, riesce a ricreare una sonorità caratterizzata da timbri e colori assolutamente originali, rimanendo fedele ad un linguaggio prettamente jazzistico. In secondo luogo l’affiatamento dell’orchestra che pur essendo composta da grandi personalità ha trovato una sua cifra di coesione che l’accompagna in tutte le esecuzioni. In terzo luogo la caratura dei vari assolo che vedono protagonisti tutti i componenti della band. A questo punto non resta che auguravi buon ascolto!
Conosco Dino e Franco Piana oramai da tanti anni e mi ha sempre stupito la straordinaria intesa tra padre e figlio che ha portato questi due personaggi ad attraversare l’oceano del jazz con signorilità, competenza e pochi ma significativi album. In effetti i due (il primo nella veste di trombonista dalla classe eccelsa, il secondo nella quadruplice funzione di compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra e flicornista) entrano in sala di incisione solo quando sentono di avere qualcosa di nuovo da dire. Di qui gli ultimi tre album particolarmente significativi, tutti registrati per l’Alfa Music, “Seven” (2012), “Seasons” (2015), e adesso questo “Open Spaces” il cui organico è sostanzialmente lo stesso dell’album precedente cui si aggiungono i cinque archi della Bim Orchestra. Quindi, oltre a Dino e Franco Piana, si possono ascoltare Fabrizio Bosso alla tromba, Max Ionata al sax tenore, Ferruccio Corsi al sax alto, Lorenzo Corsi al flauto, Enrico Pieranunzi al piano, Giuseppe Bassi al basso e Roberto Gatto alla batteria. In repertorio due suite, “Open Spaces” e “Sketch of Colours”, articolate la prima su una Introduzione e tre Variazioni, la seconda su una Introduzione e due Movimenti, ed in più altri tre brani “Dreaming”, “Sunshine” e “Blue Blues”, tutti composti e arrangiati da Franco Piana eccezion fatta per “Sketch of Colours” scritto da Franco Piana e Lorenzo Corsi. L’album è davvero di assoluto livello e per più di un motivo. Innanzitutto la scrittura di Franco che, accoppiata ad una evidente bravura nell’arrangiamento, riesce a ricreare una sonorità caratterizzata da timbri e colori assolutamente originali, rimanendo fedele ad un linguaggio prettamente jazzistico. In secondo luogo l’affiatamento dell’orchestra che pur essendo composta da grandi personalità ha trovato una sua cifra di coesione che l’accompagna in tutte le esecuzioni. In terzo luogo la caratura dei vari assolo che vedono protagonisti tutti i componenti della band. A questo punto non resta che auguravi buon ascolto!
Stefania Tallini – “Uneven” – Alfa Music 226
 Ebbene lo confesso: sono un grande amico di Stefania Tallini che ammiro non solo come pianista e compositrice ma anche come persona gentile, equilibrata, mai sopra le righe e soprattutto affettuosa, che si è sempre mantenuta con i piedi per terra nonostante gli innumerevoli successi a livello internazionale. Ecco, questo album inciso in trio con Matteo Bortone valente contrabbassista che ha suonato tra gli altri con Kurt Rosenwinkel, Ben Wendel, Tigran Hamasyan, Ralph Alessi, e Gregory Hutchinson statunitense a ben ragione considerato uno dei migliori batteristi di questi ultimi anni, è probabilmente uno degli album più significativi registrati dalla pianista. La filosofia dell’album è racchiusa nello stesso titolo, “Uneven” ovvero “Irregolare”: in effetti, spiega la stessa Tallini, “questa parola inglese è l’espressione di qualcosa di inatteso, di inaspettato, che rimanda ad un carattere di imprevedibilità, appunto, che è proprio ciò che amo nella musica e nella vita.” E per esplicitare al meglio queste sue posizioni, Stefania ha voluto fortemente accanto a sé i due musicisti cui prima si faceva riferimento. I risultati le danno ragione. L’album è convincente in ogni suo aspetto: intelligente la scelta del repertorio che accanto a dieci composizioni originali della pianista annovera “Inùtìl Paisagem” di Antonio Carlos Jobim e lo standard “The Nearness of You” di Hoagy Carmichael eseguito in solo; assolutamente ben strutturata la scrittura in cui ricerca della linea melodica e armonizzazione si equilibrano in un linguaggio che non consente espliciti punti di riferimento. Tra i vari brani una menzione particolare, a mio avviso, per il brano di Jobim proposto con grande partecipazione e delicatezza, impreziosito anche dagli assolo dei compagni di viaggio, e l’original “Triotango” che ben cattura l’essenza di questo genere musicale.
Ebbene lo confesso: sono un grande amico di Stefania Tallini che ammiro non solo come pianista e compositrice ma anche come persona gentile, equilibrata, mai sopra le righe e soprattutto affettuosa, che si è sempre mantenuta con i piedi per terra nonostante gli innumerevoli successi a livello internazionale. Ecco, questo album inciso in trio con Matteo Bortone valente contrabbassista che ha suonato tra gli altri con Kurt Rosenwinkel, Ben Wendel, Tigran Hamasyan, Ralph Alessi, e Gregory Hutchinson statunitense a ben ragione considerato uno dei migliori batteristi di questi ultimi anni, è probabilmente uno degli album più significativi registrati dalla pianista. La filosofia dell’album è racchiusa nello stesso titolo, “Uneven” ovvero “Irregolare”: in effetti, spiega la stessa Tallini, “questa parola inglese è l’espressione di qualcosa di inatteso, di inaspettato, che rimanda ad un carattere di imprevedibilità, appunto, che è proprio ciò che amo nella musica e nella vita.” E per esplicitare al meglio queste sue posizioni, Stefania ha voluto fortemente accanto a sé i due musicisti cui prima si faceva riferimento. I risultati le danno ragione. L’album è convincente in ogni suo aspetto: intelligente la scelta del repertorio che accanto a dieci composizioni originali della pianista annovera “Inùtìl Paisagem” di Antonio Carlos Jobim e lo standard “The Nearness of You” di Hoagy Carmichael eseguito in solo; assolutamente ben strutturata la scrittura in cui ricerca della linea melodica e armonizzazione si equilibrano in un linguaggio che non consente espliciti punti di riferimento. Tra i vari brani una menzione particolare, a mio avviso, per il brano di Jobim proposto con grande partecipazione e delicatezza, impreziosito anche dagli assolo dei compagni di viaggio, e l’original “Triotango” che ben cattura l’essenza di questo genere musicale.
Oded Tzur – “Here Be Dragons” – ECM 2676
 Questo “Here Be Dragons” è l’album d’esordio in casa ECM per il sassofonista israeliano, ma da tempo residente a New York, Oded Tzur. Accanto a lui Nitai Hershkovits al pianoforte, Petros Klampanis al contrabbasso e Johnathan Blake alla batteria, quindi una piccola internazionale del jazz dal momento che se Hershkovits è anch’egli israeliano, il bassista è greco di Zakynthos e il batterista statunitense di Filadelfia. Registrato nel giugno del 2019 presso l’Auditorio Stelio Molo in Lugano, l’album presenta in repertorio otto brani di cui ben sette scritti dallo stesso sassofonista cui si aggiunge “Can’t Help Falling In Love” di Peretti-Creatore-Weiss, portato al successo nientemeno che da Elvis Presley. Fatte queste premesse, anche per inquadrare il personaggio ancora non molto noto presso il pubblico italiano, occorre sottolineare la valenza della musica proposta. Una musica che sottende una particolare bravura di Tzur sia nell’esecuzione sia ancora – e forse di più – nella scrittura, sempre fluida, facile da assorbire seppure non banale e soprattutto frutto di una straordinaria capacità di introiettare input provenienti da mondi i più diversi. In effetti egli, israeliano di nascita, ha dedicato molta parte del suo tempo a studiare la musica classica indiana considerata, come egli stesso afferma, “un laboratorio di suoni”. Ecco quindi stagliarsi in modo del tutto originale il suono del suo sassofono chiaramente influenzato dagli studi con il maestro di bansuri (flauto traverso tipico della musica classica indiana) Hariprasad Chaurasia, iniziati nel 2007. Ed è proprio la particolarità del sound che a mio avviso caratterizza tutto l’album, con i quattro musicisti che si intendono a meraviglia pronti a supportarsi in qualsivoglia momento. I brani sono tutti ben scritti e arrangiati con una prevalenza, per quanto mi riguarda, per “20 Years” la cui linea melodica viene splendidamente disegnata da Hershkovits altrettanto splendidamente sostenuto da Blake il cui lavoro alle spazzole andrebbe fatto studiare ai giovani batteristi.
Questo “Here Be Dragons” è l’album d’esordio in casa ECM per il sassofonista israeliano, ma da tempo residente a New York, Oded Tzur. Accanto a lui Nitai Hershkovits al pianoforte, Petros Klampanis al contrabbasso e Johnathan Blake alla batteria, quindi una piccola internazionale del jazz dal momento che se Hershkovits è anch’egli israeliano, il bassista è greco di Zakynthos e il batterista statunitense di Filadelfia. Registrato nel giugno del 2019 presso l’Auditorio Stelio Molo in Lugano, l’album presenta in repertorio otto brani di cui ben sette scritti dallo stesso sassofonista cui si aggiunge “Can’t Help Falling In Love” di Peretti-Creatore-Weiss, portato al successo nientemeno che da Elvis Presley. Fatte queste premesse, anche per inquadrare il personaggio ancora non molto noto presso il pubblico italiano, occorre sottolineare la valenza della musica proposta. Una musica che sottende una particolare bravura di Tzur sia nell’esecuzione sia ancora – e forse di più – nella scrittura, sempre fluida, facile da assorbire seppure non banale e soprattutto frutto di una straordinaria capacità di introiettare input provenienti da mondi i più diversi. In effetti egli, israeliano di nascita, ha dedicato molta parte del suo tempo a studiare la musica classica indiana considerata, come egli stesso afferma, “un laboratorio di suoni”. Ecco quindi stagliarsi in modo del tutto originale il suono del suo sassofono chiaramente influenzato dagli studi con il maestro di bansuri (flauto traverso tipico della musica classica indiana) Hariprasad Chaurasia, iniziati nel 2007. Ed è proprio la particolarità del sound che a mio avviso caratterizza tutto l’album, con i quattro musicisti che si intendono a meraviglia pronti a supportarsi in qualsivoglia momento. I brani sono tutti ben scritti e arrangiati con una prevalenza, per quanto mi riguarda, per “20 Years” la cui linea melodica viene splendidamente disegnata da Hershkovits altrettanto splendidamente sostenuto da Blake il cui lavoro alle spazzole andrebbe fatto studiare ai giovani batteristi.
Kadri Voorand – In duo with Mihkel Mälgand – ACT 9739-2
 Ecco un album che sicuramente susciterà l’interesse e la curiosità degli appassionati italiani: protagonisti due artisti estoni, la cantante, pianista e compositrice Kadri Voorand e il bassista Mihkel Mälgand. Kadri da piccola cantava nel gruppo di musica popolare di sua madre, avvicinandosi successivamente al pianoforte classico e quindi al jazz nelle accademie di Tallinn e Stoccolma. Oggi viene considerata una stella nel proprio Paese grazie ad uno stile versatile che le consente di mescolare jazz contemporaneo, folk estone, rhythm & blues e ritmi latino-americani. Non a caso nel 2017 è stata insignita del premio musicale estone per la miglior artista ed è stata premiata per il miglior album jazz dell’anno (“Armupurjus”). Mihkel Mälgand è uno dei bassisti estoni di maggior successo, avendo lavorato, tra gli altri, con musicisti come Nils Landgren, Dave Liebman e Randy Brecker. In questo album si presentano nella rischiosa formula del duo con la vocalist che suona anche kalimba e violino mentre Mihkel si cimenta anche con bass guitar, bass drum, cello e percussioni. In un brano ai due si aggiunge come special guest Noep. In repertorio 12 brani scritti in massima parte dalla Voorand e cantati in inglese eccezion fatta per due nella sua lingua madre (due splendide song tratte dal patrimonio folcloristico estone). L’album è notevole ed è stato apprezzato anche al di fuori dell’Estonia: Europe Jazz Network, la rete europea di operatori del settore jazz, che stila la Europe Jazz Media Chart, una selezione mensile dei migliori titoli usciti curata da un pool di giornalisti specializzati, ha incluso “Kadri Voorand – In duo with Mihkel Mälgand” tra le migliori registrazioni del marzo 2020. La musica scorre fluida ed evidenzia appieno la valenza dei due musicisti che si muovono con maestria ben supportati da un tappeto intessuto dagli effetti elettronici padroneggiati con misura ed euqilibrio. La voce della Voorand è fresca, e affronta il difficile repertorio con disinvoltura non scevro da una certa dose di ironia. Dal canto suo Mälgand non si limita ad accompagnare la vocalist ma ci mette del suo prendendo spesso in mano il pallino dell’esecuzione sempre con pertinenza.
Ecco un album che sicuramente susciterà l’interesse e la curiosità degli appassionati italiani: protagonisti due artisti estoni, la cantante, pianista e compositrice Kadri Voorand e il bassista Mihkel Mälgand. Kadri da piccola cantava nel gruppo di musica popolare di sua madre, avvicinandosi successivamente al pianoforte classico e quindi al jazz nelle accademie di Tallinn e Stoccolma. Oggi viene considerata una stella nel proprio Paese grazie ad uno stile versatile che le consente di mescolare jazz contemporaneo, folk estone, rhythm & blues e ritmi latino-americani. Non a caso nel 2017 è stata insignita del premio musicale estone per la miglior artista ed è stata premiata per il miglior album jazz dell’anno (“Armupurjus”). Mihkel Mälgand è uno dei bassisti estoni di maggior successo, avendo lavorato, tra gli altri, con musicisti come Nils Landgren, Dave Liebman e Randy Brecker. In questo album si presentano nella rischiosa formula del duo con la vocalist che suona anche kalimba e violino mentre Mihkel si cimenta anche con bass guitar, bass drum, cello e percussioni. In un brano ai due si aggiunge come special guest Noep. In repertorio 12 brani scritti in massima parte dalla Voorand e cantati in inglese eccezion fatta per due nella sua lingua madre (due splendide song tratte dal patrimonio folcloristico estone). L’album è notevole ed è stato apprezzato anche al di fuori dell’Estonia: Europe Jazz Network, la rete europea di operatori del settore jazz, che stila la Europe Jazz Media Chart, una selezione mensile dei migliori titoli usciti curata da un pool di giornalisti specializzati, ha incluso “Kadri Voorand – In duo with Mihkel Mälgand” tra le migliori registrazioni del marzo 2020. La musica scorre fluida ed evidenzia appieno la valenza dei due musicisti che si muovono con maestria ben supportati da un tappeto intessuto dagli effetti elettronici padroneggiati con misura ed euqilibrio. La voce della Voorand è fresca, e affronta il difficile repertorio con disinvoltura non scevro da una certa dose di ironia. Dal canto suo Mälgand non si limita ad accompagnare la vocalist ma ci mette del suo prendendo spesso in mano il pallino dell’esecuzione sempre con pertinenza.
da Gerlando Gatto | 30/Gen/2020 | I nostri CD, Primo piano, Recensioni

Stefano Bagnoli We Kids Trio – “Dalì” – Tuk 036
 Dopo il progetto dedicato ad Arthur Rimbaud, Stefano Bagnoli si cimenta con un altro concept album esaminando la figura di Salvador Dalì. Accanto al celebre e celebrato batterista, Giuseppe Vitale al pianoforte e Stefano Zambon al contrabbasso, due giovani talenti, rispettivamente di 19 e 20 anni, solidamente ancorati al jazz tradizionale ma nello stesso tempo capaci di misurarsi con successo su terreni più moderni e attuali. L’album consta di 14 composizioni originali a firma del leader e rappresenta una sorta di punto di svolta nella poetica di Bagnoli. In effetti è lo stesso batterista ad affermare che il suo We Kids Trio “sino ad oggi volutamente legato a quella tradizione jazzistica alla quale sono profondamente e visceralmente devoto, viceversa in questo nuovo lavoro lascia spazio alla creatività sonora più ampia e sperimentale”. Di qui una musica aperta, senza confini, a tratti irriverente come la pittura di Dalì, in cui pagina scritta e improvvisazione convivono, in cui la ricerca melodica pur nella sua onnipresenza sconfina spesso nell’imprevisto senza che ciò arrechi un minimo problema all’omogeneità dell’album globalmente inteso. In un tale contesto, certo non banale, Vitale e Zambon evidenziano tutta la loro bravura e sotto la regia del leader dimostrano di sapersi egregiamente districare nel puzzle così ben congegnato e disegnato da Stefano Bagnoli. Un’ultima considerazione perfettamente in linea con l’argomento trattato: la copertina è opera del grafico e illustratore Oscar Diodoro, le cui opere sono state esposte a Roma, Milano, Treviso, Verona, Los Angeles, Parigi e Pechino.
Dopo il progetto dedicato ad Arthur Rimbaud, Stefano Bagnoli si cimenta con un altro concept album esaminando la figura di Salvador Dalì. Accanto al celebre e celebrato batterista, Giuseppe Vitale al pianoforte e Stefano Zambon al contrabbasso, due giovani talenti, rispettivamente di 19 e 20 anni, solidamente ancorati al jazz tradizionale ma nello stesso tempo capaci di misurarsi con successo su terreni più moderni e attuali. L’album consta di 14 composizioni originali a firma del leader e rappresenta una sorta di punto di svolta nella poetica di Bagnoli. In effetti è lo stesso batterista ad affermare che il suo We Kids Trio “sino ad oggi volutamente legato a quella tradizione jazzistica alla quale sono profondamente e visceralmente devoto, viceversa in questo nuovo lavoro lascia spazio alla creatività sonora più ampia e sperimentale”. Di qui una musica aperta, senza confini, a tratti irriverente come la pittura di Dalì, in cui pagina scritta e improvvisazione convivono, in cui la ricerca melodica pur nella sua onnipresenza sconfina spesso nell’imprevisto senza che ciò arrechi un minimo problema all’omogeneità dell’album globalmente inteso. In un tale contesto, certo non banale, Vitale e Zambon evidenziano tutta la loro bravura e sotto la regia del leader dimostrano di sapersi egregiamente districare nel puzzle così ben congegnato e disegnato da Stefano Bagnoli. Un’ultima considerazione perfettamente in linea con l’argomento trattato: la copertina è opera del grafico e illustratore Oscar Diodoro, le cui opere sono state esposte a Roma, Milano, Treviso, Verona, Los Angeles, Parigi e Pechino.
Cuneman – “Tension And Relief” – UR
 Questo è il secondo capitolo del progetto posto in essere da Cuneman, un gruppo che si sta facendo conoscere in tutta Italia. Nel 2018 venne pubblicato il loro primo lavoro dal titolo “Cuneman” sempre per l’etichetta milanese UR Records; per “Tension And Relief” all’originaria formazione (Fabio Della Cuna sax tenore e composizione, Jorge Ro tromba e flicorno, Giuseppe Lubatti contrabbasso, Luca Di Battista batteria) si aggiungono Francesco Di Giulio trombone e in otto pezzi il prezioso sousaphone di Mauro Ottolini. Ciò detto resta da sottolineare come la cifra stilistica sia rimasta coerentemente la stessa, vale a dire la costante ricerca di un perfetto equilibrio tra composizione e improvvisazione; il tutto basato sull’interplay che deve necessariamente caratterizzare l’operato di jazzisti di tal fatta. E il risultato è notevole: il gruppo si muove su coordinate ben precise, mettendo in luce qualità sia dei singoli sia del collettivo. E, a mio avviso, i momenti più significativi e convincenti dell’album si hanno quando i sei si muovono contemporaneamente a disegnare un quadro tutt’altro che banale, reso ancora più complesso dalla mancanza di uno strumento armonico. Un’ultima notazione che evidenzia ancor più la valenza dell’album e del gruppo: il repertorio è declinato attraverso undici composizioni tutte scritte da Fabio Della Cuna, il quale passa con estrema disinvoltura e competenza da riferimenti classici, per la precisione a Poulenc nella title track, al jazz più canonico come l’esplicito omaggio a Lee Konitz “Self Conscious-Lee”, fino ad inclinazioni più moderniste come nel caso di “War and Violence” in ambedue le sue parti.
Questo è il secondo capitolo del progetto posto in essere da Cuneman, un gruppo che si sta facendo conoscere in tutta Italia. Nel 2018 venne pubblicato il loro primo lavoro dal titolo “Cuneman” sempre per l’etichetta milanese UR Records; per “Tension And Relief” all’originaria formazione (Fabio Della Cuna sax tenore e composizione, Jorge Ro tromba e flicorno, Giuseppe Lubatti contrabbasso, Luca Di Battista batteria) si aggiungono Francesco Di Giulio trombone e in otto pezzi il prezioso sousaphone di Mauro Ottolini. Ciò detto resta da sottolineare come la cifra stilistica sia rimasta coerentemente la stessa, vale a dire la costante ricerca di un perfetto equilibrio tra composizione e improvvisazione; il tutto basato sull’interplay che deve necessariamente caratterizzare l’operato di jazzisti di tal fatta. E il risultato è notevole: il gruppo si muove su coordinate ben precise, mettendo in luce qualità sia dei singoli sia del collettivo. E, a mio avviso, i momenti più significativi e convincenti dell’album si hanno quando i sei si muovono contemporaneamente a disegnare un quadro tutt’altro che banale, reso ancora più complesso dalla mancanza di uno strumento armonico. Un’ultima notazione che evidenzia ancor più la valenza dell’album e del gruppo: il repertorio è declinato attraverso undici composizioni tutte scritte da Fabio Della Cuna, il quale passa con estrema disinvoltura e competenza da riferimenti classici, per la precisione a Poulenc nella title track, al jazz più canonico come l’esplicito omaggio a Lee Konitz “Self Conscious-Lee”, fino ad inclinazioni più moderniste come nel caso di “War and Violence” in ambedue le sue parti.
Francesco Fratini – “The Best Of All Possible Worlds” – VVJ 132
 Il trombettista Francesco Fratini è il leader di un quartetto completato da Domenico Sanna piano, Luca Fattorini contrabbasso e Matteo Bultrini batteria, cui si aggiungono in alcuni brani Charlotte Wassy voce, Daniele Tittarelli al sax alto, e i rapper Karnival Kid e Kala and The Lost Tribe, con cui ha inciso questo album. I quattro si conoscono e frequentano da diverso tempo ma non avevano, finora, avuto l’occasione di incidere assieme anche perché hanno percorso strade diverse. In particolare Fratini nel settembre 2010 si trasferisce a New York dove frequenta, grazie ad una borsa di studio quadriennale, i corsi della New School For Jazz and Contemporary Music. A New York si ferma per 5 anni avendo così l’opportunità di studiare con insegnanti quali Reggie Workman, George Cables, Aaron Goldberg, Jimmy Owens, Ambrose Akimounsire, Avishai Cohen… tra gli altri. Tornato in Italia nel 2016 costituisce il quartetto di cui parliamo in questa sede e con cui si presenta all’attenzione del pubblico italiano. E se il buongiorno si vede dal mattino non v’è dubbio che di questo gruppo e del suo leader in particolare sentiremo parlare molto a lungo. I quattro si muovono lungo dieci brani tutti scritti dallo stesso Fratini eccezion fatta per ”163 Humboldt Street” di Domenico Sanna e “Buffalo Wings” di Tom Harrell. Scorrendo l’organico, la presenza dei rapper evidenzia al meglio come Fratini sia rimasto legato alla realtà degli States e di come intenda riproporla nella sua musica. Di qui un jazz robusto, solido, impreziosito dalle spiccate individualità di tutti i musicisti
Il trombettista Francesco Fratini è il leader di un quartetto completato da Domenico Sanna piano, Luca Fattorini contrabbasso e Matteo Bultrini batteria, cui si aggiungono in alcuni brani Charlotte Wassy voce, Daniele Tittarelli al sax alto, e i rapper Karnival Kid e Kala and The Lost Tribe, con cui ha inciso questo album. I quattro si conoscono e frequentano da diverso tempo ma non avevano, finora, avuto l’occasione di incidere assieme anche perché hanno percorso strade diverse. In particolare Fratini nel settembre 2010 si trasferisce a New York dove frequenta, grazie ad una borsa di studio quadriennale, i corsi della New School For Jazz and Contemporary Music. A New York si ferma per 5 anni avendo così l’opportunità di studiare con insegnanti quali Reggie Workman, George Cables, Aaron Goldberg, Jimmy Owens, Ambrose Akimounsire, Avishai Cohen… tra gli altri. Tornato in Italia nel 2016 costituisce il quartetto di cui parliamo in questa sede e con cui si presenta all’attenzione del pubblico italiano. E se il buongiorno si vede dal mattino non v’è dubbio che di questo gruppo e del suo leader in particolare sentiremo parlare molto a lungo. I quattro si muovono lungo dieci brani tutti scritti dallo stesso Fratini eccezion fatta per ”163 Humboldt Street” di Domenico Sanna e “Buffalo Wings” di Tom Harrell. Scorrendo l’organico, la presenza dei rapper evidenzia al meglio come Fratini sia rimasto legato alla realtà degli States e di come intenda riproporla nella sua musica. Di qui un jazz robusto, solido, impreziosito dalle spiccate individualità di tutti i musicisti
Paolo Fresu, Daniele Di Bonaventura – “Altissima luce. Laudario di Cortona” – Tuk 032

Conosco Paolo Fresu oramai da qualche decennio eppure questo artista riesce ancora a sorprendermi per la straordinaria musicalità che sa infondere in ogni progetto. E’ il caso di questo album concepito e realizzato in collaborazione con il bandoneonista Daniele Di Bonaventura cui si affiancano Marco Bardoscia al contrabbasso, Michele Rabbia alla batteria e percussioni, l’Orchestra da Camera di Perugia e il gruppo vocale “Armonioso incanto” diretto da Franco Radicchia, album impreziosito da una eccellente qualità del suono. In programma la rivisitazione del Laudario di Cortona ovvero una preziosa raccolta di 66 laude (di cui solo 46 canti devozionali) con testo in lingua volgare e su notazione quadrata risalente alla seconda metà del XIII secolo che dovrebbe essere stato copiato fra gli anni 1270 e 1297. Materiale difficile da maneggiare e posso dirlo a ragion veduta dal momento che per ben cinque anni ho seguito mio figlio che studiava e cantava musica sacra. Comunque, a prescindere da queste notazioni personali, l’album è davvero un piccolo gioiello di inventiva e capacità di arrangiare e attualizzare, per giunta in chiave jazzistica, una musica così distante dall’oggi. Dai suddetti 46 canti sono stati estrapolate 13 composizioni (a cui se ne è aggiunta un’altra, quella finale “Laudar Vollio Per Amore”, tratta dal più tardo e similare Laudario Magliabechiano 18). Nel CD in oggetto ogni elemento è al posto giusto: il coro che s’incarica di trasmetterci il misticismo dei canti originari, Fresu e Di Bonaventura che incarnano le due anime di questa musica quella colta e quella popolare, l ‘Orchestra che trasmette una narrazione più ampia, vasta nel cui ambito si rimescolano linguaggi e sonorità che abbracciano non solo la tradizione europea ma anche la cultura araba. Insomma un album da gustare con attenzione in tutte le sue mille sfaccettature.
Roberto Magris – “Sun Stone” – Jmoodrecords – 017
 Ancora un eccellente album del pianista triestino Roberto Magris che questa volta si presenta alla testa di un sestetto di caratura internazionale con Ira Sullivan al flauto ed ai sax alto e soprano, Shareef Clayton alla tromba, Mark Colby al sax tenore, Jamie Ousley al contrabbasso e Rodolfo Zuniga alla batteria. In programma sei composizioni originali dello stesso Magris con l’aggiunta di “Innamorati a Milano” di Memo Remigi già entrato nel repertorio di alcuni jazzisti quali Stefano Benini, Marco Gotti, Mario Piacentini…insomma una sorta di standard italiano. Quasi superfluo affermare che Magris ne dà un’interpretazione assolutamente convincente, swingante, senza che venga persa un’oncia dell’originaria linea melodica, il tutto impreziosito dagli assolo dei tre fiati. Ma è tutto l’album che si fa apprezzare per la qualità della musica composta da Magris e la valenza degli esecutori. Il jazz che si ascolta non può considerarsi sperimentale ma proprio per questo acquisisce ancora maggior valore: in un momento in cui il cosiddetto mainstream è additato come qualcosa che si avvicina all’inconcepibile, Magris dimostra come si possa ancora fare non della buona ma dell’ottima musica senza discostarsi troppo dagli insegnamenti del passato. Certo ci vogliono classe, fantasia, capacità compositiva, grande padronanza strumentale, raffinate capacità interpretative, doti non facili da trovare tutte assieme ma che di sicuro fanno parte del bagaglio sia di Magris sia degli altri componenti questo fantastico gruppo. Tra le sette composizioni una menzione particolare la merita “Look at the Stars”, il brano più lungo dell’album, in cui dopo un’intro affidata a pianoforte e sezione ritmica si ascoltano in successione gli assolo dello stesso Magris, del sempre grande Ira Sullivan (classe 1931) al sax soprano, Shareef Clayton alla tromba, Mark Colby al sax tenore e di nuovo Magris prima della ripresa finale che vede la front line esprimersi all’unisono ben sostenuta dalla sezione ritmica.
Ancora un eccellente album del pianista triestino Roberto Magris che questa volta si presenta alla testa di un sestetto di caratura internazionale con Ira Sullivan al flauto ed ai sax alto e soprano, Shareef Clayton alla tromba, Mark Colby al sax tenore, Jamie Ousley al contrabbasso e Rodolfo Zuniga alla batteria. In programma sei composizioni originali dello stesso Magris con l’aggiunta di “Innamorati a Milano” di Memo Remigi già entrato nel repertorio di alcuni jazzisti quali Stefano Benini, Marco Gotti, Mario Piacentini…insomma una sorta di standard italiano. Quasi superfluo affermare che Magris ne dà un’interpretazione assolutamente convincente, swingante, senza che venga persa un’oncia dell’originaria linea melodica, il tutto impreziosito dagli assolo dei tre fiati. Ma è tutto l’album che si fa apprezzare per la qualità della musica composta da Magris e la valenza degli esecutori. Il jazz che si ascolta non può considerarsi sperimentale ma proprio per questo acquisisce ancora maggior valore: in un momento in cui il cosiddetto mainstream è additato come qualcosa che si avvicina all’inconcepibile, Magris dimostra come si possa ancora fare non della buona ma dell’ottima musica senza discostarsi troppo dagli insegnamenti del passato. Certo ci vogliono classe, fantasia, capacità compositiva, grande padronanza strumentale, raffinate capacità interpretative, doti non facili da trovare tutte assieme ma che di sicuro fanno parte del bagaglio sia di Magris sia degli altri componenti questo fantastico gruppo. Tra le sette composizioni una menzione particolare la merita “Look at the Stars”, il brano più lungo dell’album, in cui dopo un’intro affidata a pianoforte e sezione ritmica si ascoltano in successione gli assolo dello stesso Magris, del sempre grande Ira Sullivan (classe 1931) al sax soprano, Shareef Clayton alla tromba, Mark Colby al sax tenore e di nuovo Magris prima della ripresa finale che vede la front line esprimersi all’unisono ben sostenuta dalla sezione ritmica.
Francesco Mascio, Alberto La Neve – “I Thàlassa Mas” – Manitù Records
 Il chitarrista Francesco Mascio e il sassofonista (soprano) Alberto La Neve sono i protagonisti di questo album in cui si richiama un tema oggi di strettissima attualità: il significato di uno spazio, quale il Mar Mediterraneo, che collega e sotto certi aspetti, accomuna civiltà e tradizioni di più Paesi. Come viene illustrato nelle brevi note di copertina, “I Thàlassa Mas” è il nome con cui i greci chiamavano il Mediterraneo, ma i turchi lo chiamavano in altro modo così come gli arabi, gli albanesi… Questo per sottolineare come luoghi con culture diverse siano uniti dalle onde del medesimo mare. Di qui la partenza per un viaggio non solo musicale ma anche spirituale alla riscoperta di ciò che ci unisce; di qui la creazione di una musica che, prendendo spunto dalle molteplici sonorità dei diversi territori toccati dal Mediterraneo, arrivia ad un unicum di grande fascino; di qui la collaborazione, importante, che a questo intento hanno fornito le voci di Jali Babou Saho (anche suonatore di Kora) artista africano di lingua mandinga, Esharef Ali Mhagag di origine libica e Fabiana Dota di origine napoletana.
Il chitarrista Francesco Mascio e il sassofonista (soprano) Alberto La Neve sono i protagonisti di questo album in cui si richiama un tema oggi di strettissima attualità: il significato di uno spazio, quale il Mar Mediterraneo, che collega e sotto certi aspetti, accomuna civiltà e tradizioni di più Paesi. Come viene illustrato nelle brevi note di copertina, “I Thàlassa Mas” è il nome con cui i greci chiamavano il Mediterraneo, ma i turchi lo chiamavano in altro modo così come gli arabi, gli albanesi… Questo per sottolineare come luoghi con culture diverse siano uniti dalle onde del medesimo mare. Di qui la partenza per un viaggio non solo musicale ma anche spirituale alla riscoperta di ciò che ci unisce; di qui la creazione di una musica che, prendendo spunto dalle molteplici sonorità dei diversi territori toccati dal Mediterraneo, arrivia ad un unicum di grande fascino; di qui la collaborazione, importante, che a questo intento hanno fornito le voci di Jali Babou Saho (anche suonatore di Kora) artista africano di lingua mandinga, Esharef Ali Mhagag di origine libica e Fabiana Dota di origine napoletana.
Insomma una sorta di jazz etnico che tocca diversi generi musicali (dal francese all’andaluso, dal balcanico al nordafricano, dall’italiano al vicino oriente) declinato attraverso nove composizioni, di cui due a firma di La Neve e sei di Mascio. La terza traccia (“Cano”) è frutto della collaborazione tra Mascio e il già citato Jali Babou Saho. Tutto il repertorio si ispira alle linee sopra illustrate, eccezion fatta per “Soul in September” di Francesco Mascio che si richiama ad un linguaggio jazzistico più tradizionale e mainstream.
Enrica Rava, Joe Lovano – “Roma” – ECM 2654
 Ecco uno degli album più interessanti dell’anno: protagonisti due dei più autorevoli jazzisti oggi in esercizio – il trombettista Enrico Rava e il sassofonista Joe Lovano – coadiuvati da una sezione ritmica letteralmente stellare composta da Giovanni Guidi al pianoforte, Dezron Douglas al contrabbasso e Gerald Cleaver alla batteria. E vi assicuro che è davvero motivo d’orgoglio per chi, come lo scrivente, segue il jazz da qualche decennio constatare colme oggi i musicisti italiani siano in grado di misurarsi alla pari con gli artisti d’oltre Oceano. Questo album ne è l’ennesima riprova: registrato live durante un concerto del gruppo all’Auditorium Parco della Musica di Roma il 10 novembre del 2018, “Roma” è stato classificato primo nell’annuale referendum “Top Jazz” nella categoria “disco italiano dell’anno” e contemporaneamente Enrico Rava è stato ancora una volta giudicato “musicista italiano dell’anno” Un doppio riconoscimento che la dice lunga sui meriti dell’album e del musicista. Ad onor del vero non è che i referendum, da chiunque indetti, fotografino sempre al meglio i valori in campo, ma in questo caso i riconoscimenti sono assolutamente meritati. Ad onta della sua non verdissima età (ad agosto ha compiuto 80 anni), Rava, nell’occasione al flicorno soprano, suona bene, come al solito senza eccedere nei virtuosismi ma con una sensibilità, un trasporto, una visione d’assieme che gli fanno onore. Ovviamente non è da meno un altro leone del jazz quale Joe Lovano (classe 1952) che sfodera un linguaggio sassofonistico sempre attuale nonostante si rifaccia alle più genuine tradizioni del jazz. Il tutto declinato attraverso un repertorio che vede ancora in primo piano i due grandi maestri: così l’album si apre con le due composizioni di Rava “Interiors” e “Secrets”, cui fanno seguito i tre brani del sassofonista “Fort Worth”, “Divine Timing” e “Drum Song”, unico episodio in cui Lovano suona il tarogato, che apre la medley di chiusura completata dal coltraniano “Spiritual” e da un “Over the Rainbow” per solo piano. E proprio quest’ultimo brano mi offre l’occasione per sottolineare come la bella riuscita dell’album si deve anche al pianismo sempre raffinato e ben calibrato di Giovanni Guidi, e all’esemplare supporto di Douglas e Cleaver sempre propositivi.
Ecco uno degli album più interessanti dell’anno: protagonisti due dei più autorevoli jazzisti oggi in esercizio – il trombettista Enrico Rava e il sassofonista Joe Lovano – coadiuvati da una sezione ritmica letteralmente stellare composta da Giovanni Guidi al pianoforte, Dezron Douglas al contrabbasso e Gerald Cleaver alla batteria. E vi assicuro che è davvero motivo d’orgoglio per chi, come lo scrivente, segue il jazz da qualche decennio constatare colme oggi i musicisti italiani siano in grado di misurarsi alla pari con gli artisti d’oltre Oceano. Questo album ne è l’ennesima riprova: registrato live durante un concerto del gruppo all’Auditorium Parco della Musica di Roma il 10 novembre del 2018, “Roma” è stato classificato primo nell’annuale referendum “Top Jazz” nella categoria “disco italiano dell’anno” e contemporaneamente Enrico Rava è stato ancora una volta giudicato “musicista italiano dell’anno” Un doppio riconoscimento che la dice lunga sui meriti dell’album e del musicista. Ad onor del vero non è che i referendum, da chiunque indetti, fotografino sempre al meglio i valori in campo, ma in questo caso i riconoscimenti sono assolutamente meritati. Ad onta della sua non verdissima età (ad agosto ha compiuto 80 anni), Rava, nell’occasione al flicorno soprano, suona bene, come al solito senza eccedere nei virtuosismi ma con una sensibilità, un trasporto, una visione d’assieme che gli fanno onore. Ovviamente non è da meno un altro leone del jazz quale Joe Lovano (classe 1952) che sfodera un linguaggio sassofonistico sempre attuale nonostante si rifaccia alle più genuine tradizioni del jazz. Il tutto declinato attraverso un repertorio che vede ancora in primo piano i due grandi maestri: così l’album si apre con le due composizioni di Rava “Interiors” e “Secrets”, cui fanno seguito i tre brani del sassofonista “Fort Worth”, “Divine Timing” e “Drum Song”, unico episodio in cui Lovano suona il tarogato, che apre la medley di chiusura completata dal coltraniano “Spiritual” e da un “Over the Rainbow” per solo piano. E proprio quest’ultimo brano mi offre l’occasione per sottolineare come la bella riuscita dell’album si deve anche al pianismo sempre raffinato e ben calibrato di Giovanni Guidi, e all’esemplare supporto di Douglas e Cleaver sempre propositivi.
Tower Jazz Composers Orchestra – “Tower Jazz Composers Orchestra”
 Questo album, che segna il debutto discografico della Tower Jazz Composers Orchestra, merita una segnalazione particolare per più di un motivo. Innanzitutto evidenzia come l’intesa tra più soggetti possa portare a risultati positivi. L’orchestra è diretta emanazione del Jazz Club Ferrara e il nome Tower si riferisce alla sede storica del club, il rinascimentale Torrione San Giovanni. Ma l’uscita dell’album in oggetto non sarebbe stata possibile senza la collaborazione tra il Jazz Club Ferrara, Bologna Jazz Festival, Regione Emilia Romagna (“Legge Musica L.R 2/18, art. 8”) e Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna. A produrlo la neonata Over Studio Records, etichetta emanazione dell’omonimo studio discografico che si è occupato della registrazione del disco a fine settembre al Teatro De Micheli di Copparo (FE). In secondo luogo è l’ennesima dimostrazione di come il jazz orchestrale conservi un suo fascino particolare ed una sua precisa ragion d’essere…specie se la band segue strade poco battute. In effetti il nome è ispirato alla storica Jazz Composer’s Orchestra di Carla Bley e Michael Mantler e l’intento rimane quello, assai impegnativo, di mettere assieme alcuni compositori-improvvisatori in grado di offrire qualcosa di nuovo. Obiettivo perfettamente raggiunto: nell’organico, composto da musicisti dell’area emiliano-veneta, figurano musicisti di estrazione diversa tra cui figurano nomi ben noti come quelli di Piero Bittolo Bon e Alfonso Santimone che dirigono l’orchestra e della vocalist Marta Raviglia, accanto a giovani di sicuro talento come il trombettista Mirko Cisilino che abbiamo imparato a conoscere a Udine Jazz e la sassofonista Giulia Barba che ho avuto il piacere di intervistare nel 2014 in occasione dell’uscita del suo primo album “The Angry St. Bernard”. Le atmosfere proposte dalla big band sono assai variegate essendo molteplici i punti di riferimento (free jazz, musica latina, musica classica, mainstream orchestrale) ma in tutte si avverte una sapiente scrittura ed un costante equilibrio tra composizione e improvvisazione, una particolare ricerca timbrica, un sapiente uso della dinamica, il ricorso a soluzioni ritmiche inusuali, il tutto supportato dal talento dei musicisti.
Questo album, che segna il debutto discografico della Tower Jazz Composers Orchestra, merita una segnalazione particolare per più di un motivo. Innanzitutto evidenzia come l’intesa tra più soggetti possa portare a risultati positivi. L’orchestra è diretta emanazione del Jazz Club Ferrara e il nome Tower si riferisce alla sede storica del club, il rinascimentale Torrione San Giovanni. Ma l’uscita dell’album in oggetto non sarebbe stata possibile senza la collaborazione tra il Jazz Club Ferrara, Bologna Jazz Festival, Regione Emilia Romagna (“Legge Musica L.R 2/18, art. 8”) e Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna. A produrlo la neonata Over Studio Records, etichetta emanazione dell’omonimo studio discografico che si è occupato della registrazione del disco a fine settembre al Teatro De Micheli di Copparo (FE). In secondo luogo è l’ennesima dimostrazione di come il jazz orchestrale conservi un suo fascino particolare ed una sua precisa ragion d’essere…specie se la band segue strade poco battute. In effetti il nome è ispirato alla storica Jazz Composer’s Orchestra di Carla Bley e Michael Mantler e l’intento rimane quello, assai impegnativo, di mettere assieme alcuni compositori-improvvisatori in grado di offrire qualcosa di nuovo. Obiettivo perfettamente raggiunto: nell’organico, composto da musicisti dell’area emiliano-veneta, figurano musicisti di estrazione diversa tra cui figurano nomi ben noti come quelli di Piero Bittolo Bon e Alfonso Santimone che dirigono l’orchestra e della vocalist Marta Raviglia, accanto a giovani di sicuro talento come il trombettista Mirko Cisilino che abbiamo imparato a conoscere a Udine Jazz e la sassofonista Giulia Barba che ho avuto il piacere di intervistare nel 2014 in occasione dell’uscita del suo primo album “The Angry St. Bernard”. Le atmosfere proposte dalla big band sono assai variegate essendo molteplici i punti di riferimento (free jazz, musica latina, musica classica, mainstream orchestrale) ma in tutte si avverte una sapiente scrittura ed un costante equilibrio tra composizione e improvvisazione, una particolare ricerca timbrica, un sapiente uso della dinamica, il ricorso a soluzioni ritmiche inusuali, il tutto supportato dal talento dei musicisti.
Gianluigi Trovesi, Gianni Coscia – “La misteriosa musica della Regina Loana” – ECM 2652
 E’ con vero piacere che vi presento questo album in quanto i protagonisti sono, oltre che due grandissimi musicisti, due affettuosi amici che conosco da tempo e che incontro ogni volta con sincero affetto. Ad onor del vero non vedo Gianluigi da circa due anni mentre con Gianni Coscia ci siamo incontrati nello scorso settembre a Castelfidardo per l’annuale edizione del premio internazionale della fisarmonica. In questa occasione Coscia, presentando in concerto un suo brano, omaggiò l’amico di sempre, Umberto Eco. E proprio al grande scrittore e semiologo è dedicato l’album in oggetto che trae ispirazione dal suo «La misteriosa fiamma della regina Loana» del 2004, romanzo illustrato sulla natura della memoria. E così Trovesi al clarinetto piccolo e alto e Gianni Coscia alla fisarmonica imbastiscono un repertorio tutto giocato sul filo dei ricordi, con i due che non nascondono il piacere di suonare assieme e di improvvisare con la solita classe e competenza. L’album si apre con “Interludio”, brano composto da Coscia quando aveva quattordici anni e di cui Eco scrisse i testi, cui fanno seguito una serie di pezzi assai conosciuti che svariano dal jazz, al folk, alla musica popolare italiana come tre frammenti tratti dalla composizione di Leoš Janáček “Nella nebbia”, “Basin Street Blues”, “Pippo non lo sa”, “As Time Goes By”, “Fischia il vento” libera elaborazione di “Bella Ciao”, “Gragnola”, “L’inno dei sommergibili”, una gustosa suite di brani EIAR, per chiudere con “Moonlight Serenade”. Certo l’improvvisazione c’è, lo swing pure, la maestria strumentale quanta ne volete… i virtuosismi strumentali fine a se stessi, il percorrere terreni ai confini del jazz, lo sperimentalismo sui suoni, beh questi elementi non ci sono. Ma siamo sicuri che sia poi così importante?
E’ con vero piacere che vi presento questo album in quanto i protagonisti sono, oltre che due grandissimi musicisti, due affettuosi amici che conosco da tempo e che incontro ogni volta con sincero affetto. Ad onor del vero non vedo Gianluigi da circa due anni mentre con Gianni Coscia ci siamo incontrati nello scorso settembre a Castelfidardo per l’annuale edizione del premio internazionale della fisarmonica. In questa occasione Coscia, presentando in concerto un suo brano, omaggiò l’amico di sempre, Umberto Eco. E proprio al grande scrittore e semiologo è dedicato l’album in oggetto che trae ispirazione dal suo «La misteriosa fiamma della regina Loana» del 2004, romanzo illustrato sulla natura della memoria. E così Trovesi al clarinetto piccolo e alto e Gianni Coscia alla fisarmonica imbastiscono un repertorio tutto giocato sul filo dei ricordi, con i due che non nascondono il piacere di suonare assieme e di improvvisare con la solita classe e competenza. L’album si apre con “Interludio”, brano composto da Coscia quando aveva quattordici anni e di cui Eco scrisse i testi, cui fanno seguito una serie di pezzi assai conosciuti che svariano dal jazz, al folk, alla musica popolare italiana come tre frammenti tratti dalla composizione di Leoš Janáček “Nella nebbia”, “Basin Street Blues”, “Pippo non lo sa”, “As Time Goes By”, “Fischia il vento” libera elaborazione di “Bella Ciao”, “Gragnola”, “L’inno dei sommergibili”, una gustosa suite di brani EIAR, per chiudere con “Moonlight Serenade”. Certo l’improvvisazione c’è, lo swing pure, la maestria strumentale quanta ne volete… i virtuosismi strumentali fine a se stessi, il percorrere terreni ai confini del jazz, lo sperimentalismo sui suoni, beh questi elementi non ci sono. Ma siamo sicuri che sia poi così importante?
Gianluca Vigliar – “Plastic Estrogenus” – A.M.A. Records 019
 Questo è il secondo album del sassofonista e compositore Gianluca Vigliar in quintetto con Andrea Biondi al vibrafono, Francesco Fratini alla tromba, Luca Fattorini al contrabbasso e Marco Valeri alla batteria, questi ultimi tre presenti anche nel precedente album di Vigliar “Fragia” (2018). Quando ci si accinge ad ascoltare un album di un artista non ancora conosciutissimo bisogna ben chiarire quali sono le aspettative. Se ci si attende di scoprire il novello John Coltrane fatalmente si resterà delusi; viceversa se l’idea è quella di incontrare un musicista di talento ci sono molte più probabilità che le nostre attese non vadano disattese. E’ questo il caso di Gianluca Vigliar, un musicista romano (classe 1979) che pur in possesso di una solida preparazione di base e ad onta delle numerose e prestigiose collaborazioni (Greg Hutchinson, Javier Girotto, Israel Varela, Pino Jodice, Mark White , Paolo Fresu, Pietro Jodice, Giovanni Tommaso… tra gli altri) non ha ancora avuto i riconoscimenti che merita. Questo “Plastic Estrogenus” è una sorta di concept album in cui Vigliar denuncia i danni che la plastica produce all’ambiente e quindi a noi stessi. Come in tutti gli album a tesi è veramente difficile che la musica corrisponda all’assunto per cui è meglio prescindere da questo elemento. Ciò detto bisogna riconoscere a Vigliar da un canto la facilità e la bravura nello scrivere (sei brani su sette sono sue composizioni), dall’altro la capacità di ben arrangiare i brani caratterizzandoli sia con una efficace ricerca timbrica sia con un convincente alternarsi tra “pieni” di buon effetto ed interventi solistici sempre pertinenti.
Questo è il secondo album del sassofonista e compositore Gianluca Vigliar in quintetto con Andrea Biondi al vibrafono, Francesco Fratini alla tromba, Luca Fattorini al contrabbasso e Marco Valeri alla batteria, questi ultimi tre presenti anche nel precedente album di Vigliar “Fragia” (2018). Quando ci si accinge ad ascoltare un album di un artista non ancora conosciutissimo bisogna ben chiarire quali sono le aspettative. Se ci si attende di scoprire il novello John Coltrane fatalmente si resterà delusi; viceversa se l’idea è quella di incontrare un musicista di talento ci sono molte più probabilità che le nostre attese non vadano disattese. E’ questo il caso di Gianluca Vigliar, un musicista romano (classe 1979) che pur in possesso di una solida preparazione di base e ad onta delle numerose e prestigiose collaborazioni (Greg Hutchinson, Javier Girotto, Israel Varela, Pino Jodice, Mark White , Paolo Fresu, Pietro Jodice, Giovanni Tommaso… tra gli altri) non ha ancora avuto i riconoscimenti che merita. Questo “Plastic Estrogenus” è una sorta di concept album in cui Vigliar denuncia i danni che la plastica produce all’ambiente e quindi a noi stessi. Come in tutti gli album a tesi è veramente difficile che la musica corrisponda all’assunto per cui è meglio prescindere da questo elemento. Ciò detto bisogna riconoscere a Vigliar da un canto la facilità e la bravura nello scrivere (sei brani su sette sono sue composizioni), dall’altro la capacità di ben arrangiare i brani caratterizzandoli sia con una efficace ricerca timbrica sia con un convincente alternarsi tra “pieni” di buon effetto ed interventi solistici sempre pertinenti.
*****
Joe Bonamassa – “Live At The Sydney Opera House” – Mascot/Provogue
 Iniziamo questa seconda parte della rubrica dedicata alle novità internazionali con un chitarrista bianco che fa musica nera: si tratta del newyorchese Joe Bonamassa (classe 1977). Dopo aver studiato musica classica, Joe, ancora ragazzino, scopre il blues ed è a questo genere che si dedica con tutte le forze esordendo professionalmente nel 2000 e divenendo in breve tempo uno dei migliori esponenti del rock-blues. E quanto tale stima sia meritata viene confermata dagli album che si succedono nel tempo; in particolare dopo i tre CD pubblicati nel 2018, ecco il CD in oggetto registrato dal vivo nel 2016 per l’appunto nella Sydney Opera House, durante il tour di “Blues Of Desperation”. Non a caso molti sono i brani tratti da “Blues Of Desperation”. L’impianto è quello caro al leader vale a dire un rock-blues piuttosto aggressivo, giocato su ritmi veloci e su dinamiche sempre alte. Quindi un linguaggio che potrebbe stancare se non ci fossero anche momenti di maggiore raffinatezza in cui si nota un approccio più jazzistico: è il caso di “Drive” impreziosito da un notevole assolo di Reese Wynans alle tastiere. Tra gli altri pezzi particolarmente convincente la riproposizione di una cover, “Florida Mainiline” tratta da “461 Ocean Boulevard” di Eric Clapton, con un Bonamassa in gran spolvero. E la menzione di Wynans mi offre il destro per sottolineare come il chitarrista presenti in questa occasione una band piuttosto nutrita completata da Anton Fig alle percussioni, Michael Rhodes al basso, Lee Thornburg alla tromba, Paulie Cerra al sax e Mahalia Barnes, Juanita Tippins, Gary Pinto ai backing vocals.
Iniziamo questa seconda parte della rubrica dedicata alle novità internazionali con un chitarrista bianco che fa musica nera: si tratta del newyorchese Joe Bonamassa (classe 1977). Dopo aver studiato musica classica, Joe, ancora ragazzino, scopre il blues ed è a questo genere che si dedica con tutte le forze esordendo professionalmente nel 2000 e divenendo in breve tempo uno dei migliori esponenti del rock-blues. E quanto tale stima sia meritata viene confermata dagli album che si succedono nel tempo; in particolare dopo i tre CD pubblicati nel 2018, ecco il CD in oggetto registrato dal vivo nel 2016 per l’appunto nella Sydney Opera House, durante il tour di “Blues Of Desperation”. Non a caso molti sono i brani tratti da “Blues Of Desperation”. L’impianto è quello caro al leader vale a dire un rock-blues piuttosto aggressivo, giocato su ritmi veloci e su dinamiche sempre alte. Quindi un linguaggio che potrebbe stancare se non ci fossero anche momenti di maggiore raffinatezza in cui si nota un approccio più jazzistico: è il caso di “Drive” impreziosito da un notevole assolo di Reese Wynans alle tastiere. Tra gli altri pezzi particolarmente convincente la riproposizione di una cover, “Florida Mainiline” tratta da “461 Ocean Boulevard” di Eric Clapton, con un Bonamassa in gran spolvero. E la menzione di Wynans mi offre il destro per sottolineare come il chitarrista presenti in questa occasione una band piuttosto nutrita completata da Anton Fig alle percussioni, Michael Rhodes al basso, Lee Thornburg alla tromba, Paulie Cerra al sax e Mahalia Barnes, Juanita Tippins, Gary Pinto ai backing vocals.
Edmar Castaneda, Grégoire Maret – “Harp vs. Harp” – ACT9044-2
 Nonostante la presenza di un’eccellente arpista jazz come Marcella Carboni, sono ancora in molti nel nostro Paese a ritenere che con l’arpa non si possa suonare del buon jazz. Ebbene, a questi scettici consiglio caldamente l’ascolto di questo bell’album in cui si confrontano un grande esponente dell’arpa quale Edmar Castaneda e un eccellente armonicista quale Grégoire Maret, coadiuvati in alcuni brani da Béla Flack al banjo e Andrea Tierra voce. Svizzero l’uno (Maret), colombiano l’altro (Castaneda) hanno in comune alcuni tratti particolarmente significativi: l’aver deciso di abbandonare il proprio Paese per stabilirsi a New York e l’aver cercato e trovato una nuova strada per il proprio strumento. Di qui l’autorevolezza di cui i due godono nel panorama jazzistico internazionale; tanto per citare qualche elemento Maret ha vinto nel 2006 il Grammy Award for Best Contemporary Jazz Album grazie a “The Way Up” con il gruppo di Pat Meteny mentre Castaneda è unanimemente considerato uno dei massimi esponenti dell’arpa jazz, come d’altro canto testimoniato dalle collaborazioni con alcuni giganti del jazz attuale come Paquito D’Rivera, Giovanni Hidalgo, Joe Locke, Wynton Marsalis, John Patitucci, John Scofield, Hiromi. Poco tempo fa i due si sono incontrati al Montecarlo Jazz Festival e hanno deciso di creare un duo; così nel settembre del 2018, hanno radunato a New York il quartetto di cui in apertura dando vita all’album in oggetto. Album che sicuramente non va incontro alle esigenze di sperimentazione presenti in molti appassionati, ma altrettanto sicuramente soddisferà i palati di quanti anche nel jazz continuano a cercare belle melodie e arrangiamenti non particolarmente cervellotici anche se non banali. Ecco, tutto ciò è presente in abbondanza nell’album declinato attraverso otto brani di cui un paio originali (“Blueserinho” di Maret e”No Fear” di Castaneda) e gli altri sei di sapore prevalentemente sudamericano tra cui spiccano, a mio avviso, “Romance de Barrio” di Annibal Troilo e Homero Manzi e “Manhã de Carnaval” di Luiz Bonfá.
Nonostante la presenza di un’eccellente arpista jazz come Marcella Carboni, sono ancora in molti nel nostro Paese a ritenere che con l’arpa non si possa suonare del buon jazz. Ebbene, a questi scettici consiglio caldamente l’ascolto di questo bell’album in cui si confrontano un grande esponente dell’arpa quale Edmar Castaneda e un eccellente armonicista quale Grégoire Maret, coadiuvati in alcuni brani da Béla Flack al banjo e Andrea Tierra voce. Svizzero l’uno (Maret), colombiano l’altro (Castaneda) hanno in comune alcuni tratti particolarmente significativi: l’aver deciso di abbandonare il proprio Paese per stabilirsi a New York e l’aver cercato e trovato una nuova strada per il proprio strumento. Di qui l’autorevolezza di cui i due godono nel panorama jazzistico internazionale; tanto per citare qualche elemento Maret ha vinto nel 2006 il Grammy Award for Best Contemporary Jazz Album grazie a “The Way Up” con il gruppo di Pat Meteny mentre Castaneda è unanimemente considerato uno dei massimi esponenti dell’arpa jazz, come d’altro canto testimoniato dalle collaborazioni con alcuni giganti del jazz attuale come Paquito D’Rivera, Giovanni Hidalgo, Joe Locke, Wynton Marsalis, John Patitucci, John Scofield, Hiromi. Poco tempo fa i due si sono incontrati al Montecarlo Jazz Festival e hanno deciso di creare un duo; così nel settembre del 2018, hanno radunato a New York il quartetto di cui in apertura dando vita all’album in oggetto. Album che sicuramente non va incontro alle esigenze di sperimentazione presenti in molti appassionati, ma altrettanto sicuramente soddisferà i palati di quanti anche nel jazz continuano a cercare belle melodie e arrangiamenti non particolarmente cervellotici anche se non banali. Ecco, tutto ciò è presente in abbondanza nell’album declinato attraverso otto brani di cui un paio originali (“Blueserinho” di Maret e”No Fear” di Castaneda) e gli altri sei di sapore prevalentemente sudamericano tra cui spiccano, a mio avviso, “Romance de Barrio” di Annibal Troilo e Homero Manzi e “Manhã de Carnaval” di Luiz Bonfá.
Avishai Cohen, Yonathan Avishai – “Playing The Room” – ECM 2641
 I duo tromba-piano non sono frequentissimi nel mondo del jazz anche perché la formula è particolarmente insidiosa: manca del tutto il supporto ritmico e il pianoforte deve assumersi il duplice compito di sostenere melodia e armonia. Certo, occorrono musicisti che non solo siano straordinariamente bravi e sensibili ma anche che si conoscano assai bene per poter liberamente interagire. Ebbene queste due condizioni sono del tutto soddisfatte nell’album in oggetto dal momento che il pianista Avishai Cohen e il trombettista Yonathan Avishai si conoscono da circa vent’anni. E tale intesa si avverte sin dalle primissime note disegnate dal pianoforte che introduce il primo pezzo per oltre un minuto prima di ascoltare anche la tromba di Yonathan. Il clima del CD è, quindi, immediatamente riconoscibile: una approfondita ricerca melodica che bandisce qualsivoglia tentazione virtuosistica per far ricorso, unitamente, a quella sincerità d’espressione che da sempre caratterizza questi due artisti. E il repertorio scelto tocca tutti gli aspetti del jazz, eccezion fatta per le più accese sperimentazioni. Ecco quindi, oltre ai due brani di apertura dovuti rispettivamente ad Avishai Cohen e Yonathan Avishai, “Azalea” di Duke Ellington, “Kofifi Blue” di Abdullah Ibrahim, “Crescent” di John Coltrane, “Dee Dee” di Ornette Coleman fino al blues di Milt Jackson, “Ralph’s New Blues”, inciso per la prima volta dal Modern Jazz Quartet nel 1955 e a “Sir Duke”, brano di Stevie Wonder che ha superato gli ancor ristretti confini del jazz, magnificamente intonato dal pianoforte di Cohen sottilmente contrappuntato dalla tromba di Avishai..
I duo tromba-piano non sono frequentissimi nel mondo del jazz anche perché la formula è particolarmente insidiosa: manca del tutto il supporto ritmico e il pianoforte deve assumersi il duplice compito di sostenere melodia e armonia. Certo, occorrono musicisti che non solo siano straordinariamente bravi e sensibili ma anche che si conoscano assai bene per poter liberamente interagire. Ebbene queste due condizioni sono del tutto soddisfatte nell’album in oggetto dal momento che il pianista Avishai Cohen e il trombettista Yonathan Avishai si conoscono da circa vent’anni. E tale intesa si avverte sin dalle primissime note disegnate dal pianoforte che introduce il primo pezzo per oltre un minuto prima di ascoltare anche la tromba di Yonathan. Il clima del CD è, quindi, immediatamente riconoscibile: una approfondita ricerca melodica che bandisce qualsivoglia tentazione virtuosistica per far ricorso, unitamente, a quella sincerità d’espressione che da sempre caratterizza questi due artisti. E il repertorio scelto tocca tutti gli aspetti del jazz, eccezion fatta per le più accese sperimentazioni. Ecco quindi, oltre ai due brani di apertura dovuti rispettivamente ad Avishai Cohen e Yonathan Avishai, “Azalea” di Duke Ellington, “Kofifi Blue” di Abdullah Ibrahim, “Crescent” di John Coltrane, “Dee Dee” di Ornette Coleman fino al blues di Milt Jackson, “Ralph’s New Blues”, inciso per la prima volta dal Modern Jazz Quartet nel 1955 e a “Sir Duke”, brano di Stevie Wonder che ha superato gli ancor ristretti confini del jazz, magnificamente intonato dal pianoforte di Cohen sottilmente contrappuntato dalla tromba di Avishai..
Chick Corea Trio – “Trilogy 2” – Concord 00183 2 CD
 Eccoci all’Università del jazz ad ascoltare la lezione di uno dei più grandi pianisti della storia del jazz, il pianista settantottenne di origini italiane Chick Corea, con i suoi assistenti, il batterista Brian Blade e il contrabbassista Christian McBride. Ed in effetti ascoltando questi due straordinari CD con sedici tracce (che non caso si è classificato sesto nell’annuale “Top Jazz” nella categoria “disco internazionale dell’anno”) non si può non restare ammirati di fronte ad un artista che non solo non conosce l’usura del tempo ma che anzi riesce a dare nuova linfa, nuova vitalità ad una formula usata ed abusata qual è quella del piano trio con batteria e contrabbasso. In queste due ore di musica non c’è un solo passaggio che suoni scontato, un solo frammento in cui si avverta un minimo di stasi, di ricorso a cliché: la musica è fresca, trascinante, godibile dal primo all’ultimo istante. Il tutto con un repertorio quanto mai impegnativo in cui figurano, tra l’altro, due brani di Thelonious Monk, “Work” e “Crepuscule With Nellie”, di cui il trio fornisce interpretazioni da antologia…per non parlare degli evergreen di Chick Corea quali “500 Miles High” registrato per la prima volta nel 1972 e impreziosito in quest’ultimo album da un poderoso assolo di Brian Blade, il celeberrimo “La Fiesta” e “Now He Sings, Now He Sobs”. Il titolo dell’album prende le mosse dal precedente cd “Trilogy” del 2014, che ottenne ben due Grammy Awards (Best Jazz Instrumental Album e Best Improvised Jazz Solo per “Fingerprints”) e da cui sono stati ripescati per questo nuovo doppio disco solo due brani, “How Deep Is the Ocean” di Irving Berlin, proposto in apertura, e del già citato “Work”. Come il precedente, anche questo “Trilogy 2” comprende esecuzioni provenienti da anni e luoghi diversi: in questo caso Oakland e Tokio nel 2010, Bologna e Zurigo nel 2012, Ottawa, Minneapolis, St. Louis, Rockport, Rochester nel 2016.
Eccoci all’Università del jazz ad ascoltare la lezione di uno dei più grandi pianisti della storia del jazz, il pianista settantottenne di origini italiane Chick Corea, con i suoi assistenti, il batterista Brian Blade e il contrabbassista Christian McBride. Ed in effetti ascoltando questi due straordinari CD con sedici tracce (che non caso si è classificato sesto nell’annuale “Top Jazz” nella categoria “disco internazionale dell’anno”) non si può non restare ammirati di fronte ad un artista che non solo non conosce l’usura del tempo ma che anzi riesce a dare nuova linfa, nuova vitalità ad una formula usata ed abusata qual è quella del piano trio con batteria e contrabbasso. In queste due ore di musica non c’è un solo passaggio che suoni scontato, un solo frammento in cui si avverta un minimo di stasi, di ricorso a cliché: la musica è fresca, trascinante, godibile dal primo all’ultimo istante. Il tutto con un repertorio quanto mai impegnativo in cui figurano, tra l’altro, due brani di Thelonious Monk, “Work” e “Crepuscule With Nellie”, di cui il trio fornisce interpretazioni da antologia…per non parlare degli evergreen di Chick Corea quali “500 Miles High” registrato per la prima volta nel 1972 e impreziosito in quest’ultimo album da un poderoso assolo di Brian Blade, il celeberrimo “La Fiesta” e “Now He Sings, Now He Sobs”. Il titolo dell’album prende le mosse dal precedente cd “Trilogy” del 2014, che ottenne ben due Grammy Awards (Best Jazz Instrumental Album e Best Improvised Jazz Solo per “Fingerprints”) e da cui sono stati ripescati per questo nuovo doppio disco solo due brani, “How Deep Is the Ocean” di Irving Berlin, proposto in apertura, e del già citato “Work”. Come il precedente, anche questo “Trilogy 2” comprende esecuzioni provenienti da anni e luoghi diversi: in questo caso Oakland e Tokio nel 2010, Bologna e Zurigo nel 2012, Ottawa, Minneapolis, St. Louis, Rockport, Rochester nel 2016.
Pablo Corradini – “Alma de viejo” –
 Compositore polistrumentista argentino che risiede in Italia da 25 anni, Pablo Corradini ha studiato flauto traverso diplomandosi successivamente in piano jazz. Parallelamente si è dedicato allo studio costante del bandoneon, attività che ha affinato confrontandosi spesso con i grandi maestri bandoneonisti del paese natio. Dopo “Betango” ecco la sua nuova produzione caratterizzata ancora una volta dalla riproposizione in chiave jazzistica dei ritmi tradizionali argentini. Per questa nuova impresa, Corradini ha chiamato accanto a se musicisti di vaglia quali Marco Postacchini al sax tenore e soprano e al flauto, Simone Maggio al piano, Roberto Gazzani al contrabbasso e Gianluca Nanni batteria e percussioni cui si aggiungono come special guests Javier Girotto al quena flute (flauto diritto andino) in “Tempo Atras” e un trio d’archi nella title track (Carlo Celsi violino, Fabio Cappella viola, Giuseppe Franchellucci cello). In repertorio undici brani tutti scritti dal leader che propongono un repertorio assai variegato in cui figurano diversi ritmi del folclore argentino come la zamba, la chacarera ed il tango, declinati però attraverso un linguaggio prettamente jazzistico in cui l’improvvisazione non è certo secondaria. Tra i diversi brani particolarmente significativi i due citati in precedenza in cui figurano gli ospiti, ambedue caratterizzati da una dolce linea melodica ben interpretata rispettivamente da Javier Girotto e dal trio d’archi. Dal canto suo il leader conferma appieno quanto di buono aveva già messo in mostra nei precedenti lavori vale a dire una assoluta padronanza strumentale coniugata con una piena maturità e consapevolezza dei propri mezzi espressivi.
Compositore polistrumentista argentino che risiede in Italia da 25 anni, Pablo Corradini ha studiato flauto traverso diplomandosi successivamente in piano jazz. Parallelamente si è dedicato allo studio costante del bandoneon, attività che ha affinato confrontandosi spesso con i grandi maestri bandoneonisti del paese natio. Dopo “Betango” ecco la sua nuova produzione caratterizzata ancora una volta dalla riproposizione in chiave jazzistica dei ritmi tradizionali argentini. Per questa nuova impresa, Corradini ha chiamato accanto a se musicisti di vaglia quali Marco Postacchini al sax tenore e soprano e al flauto, Simone Maggio al piano, Roberto Gazzani al contrabbasso e Gianluca Nanni batteria e percussioni cui si aggiungono come special guests Javier Girotto al quena flute (flauto diritto andino) in “Tempo Atras” e un trio d’archi nella title track (Carlo Celsi violino, Fabio Cappella viola, Giuseppe Franchellucci cello). In repertorio undici brani tutti scritti dal leader che propongono un repertorio assai variegato in cui figurano diversi ritmi del folclore argentino come la zamba, la chacarera ed il tango, declinati però attraverso un linguaggio prettamente jazzistico in cui l’improvvisazione non è certo secondaria. Tra i diversi brani particolarmente significativi i due citati in precedenza in cui figurano gli ospiti, ambedue caratterizzati da una dolce linea melodica ben interpretata rispettivamente da Javier Girotto e dal trio d’archi. Dal canto suo il leader conferma appieno quanto di buono aveva già messo in mostra nei precedenti lavori vale a dire una assoluta padronanza strumentale coniugata con una piena maturità e consapevolezza dei propri mezzi espressivi.
Aaron Diehl – “The Vagabond” – Mack Avenue 1153
 Ecco un altro album per trio pianoforte, batteria e contrabbasso. Protagonista Aaron Diehl, nome non particolarmente noto anche se si tratta di un artista davvero di grande spessore: non a caso Aaron Diehl è soprannominato “The Real Diehl” da Winton Marsalis ed è considerato dai critici del New York Times tra i più sofisticati e virtuosi pianisti jazz viventi. In questo album, accompagnato da Paul Sikivie al contrabbasso e Gregory Hutchinson alla batteria, Diehl evidenzia i molteplici aspetti della sua personalità artistica attraverso un repertorio variegato in cui accanto a sue composizioni, figurano brani di grandi personaggi del jazz come Sir Roland Hanna e John Lewis e due pezzi riconducibili alla musica colta come “March From Ten Pieces for Piano, Op. 12” di Sergei Prokofiev e “Piano Etude No. 16” di Philip Glass. L’album si divide, quindi, in due parti: nei primi sette brani Diehl si presenta nella duplice veste di compositore ed esecutore ed in ambedue evidenzia una spiccata sensibilità. Le sue composizioni non sono di facilissimo ascolto ma la ricerca di una precisa linea melodica si appalesa sempre precisa mentre le armonizzazioni ben si attagliano al disegno complessivo del pezzo. L’esecutore di assoluta originalità vien fuori nella presentazione di “A Story Often Told, Seldom Heard” di Sir Roland Hanna e del celebre “Milano” di John Lewis: in questi casi, pur rispettando l’originario impianto dei brani, il pianista ne offre una interpretazione affatto personale e ricercata. Infine, nelle due composizioni rispettivamente di Prokofiev e Philip Glass Diehl evidenzia l’ottima conoscenza del pianismo “classico” supportato, cioè, da studi approfonditi non solo della musica jazz. In ogni caso, qualunque repertorio affronti, Diehl si caratterizza per un stile raffinato ed elegante, per un tocco di straordinaria leggerezza, doti che trovano le loro radici, oltre che nello studio cui prima si faceva riferimento, in un indubbio talento naturale. Un’ultima non secondaria notazione: l’album è dedicato alla memoria di Lawrence “Lo” Leathers, batterista statunitense, caduto vittima di un agguato il 3 giugno del 2019 all’età di 38 anni.
Ecco un altro album per trio pianoforte, batteria e contrabbasso. Protagonista Aaron Diehl, nome non particolarmente noto anche se si tratta di un artista davvero di grande spessore: non a caso Aaron Diehl è soprannominato “The Real Diehl” da Winton Marsalis ed è considerato dai critici del New York Times tra i più sofisticati e virtuosi pianisti jazz viventi. In questo album, accompagnato da Paul Sikivie al contrabbasso e Gregory Hutchinson alla batteria, Diehl evidenzia i molteplici aspetti della sua personalità artistica attraverso un repertorio variegato in cui accanto a sue composizioni, figurano brani di grandi personaggi del jazz come Sir Roland Hanna e John Lewis e due pezzi riconducibili alla musica colta come “March From Ten Pieces for Piano, Op. 12” di Sergei Prokofiev e “Piano Etude No. 16” di Philip Glass. L’album si divide, quindi, in due parti: nei primi sette brani Diehl si presenta nella duplice veste di compositore ed esecutore ed in ambedue evidenzia una spiccata sensibilità. Le sue composizioni non sono di facilissimo ascolto ma la ricerca di una precisa linea melodica si appalesa sempre precisa mentre le armonizzazioni ben si attagliano al disegno complessivo del pezzo. L’esecutore di assoluta originalità vien fuori nella presentazione di “A Story Often Told, Seldom Heard” di Sir Roland Hanna e del celebre “Milano” di John Lewis: in questi casi, pur rispettando l’originario impianto dei brani, il pianista ne offre una interpretazione affatto personale e ricercata. Infine, nelle due composizioni rispettivamente di Prokofiev e Philip Glass Diehl evidenzia l’ottima conoscenza del pianismo “classico” supportato, cioè, da studi approfonditi non solo della musica jazz. In ogni caso, qualunque repertorio affronti, Diehl si caratterizza per un stile raffinato ed elegante, per un tocco di straordinaria leggerezza, doti che trovano le loro radici, oltre che nello studio cui prima si faceva riferimento, in un indubbio talento naturale. Un’ultima non secondaria notazione: l’album è dedicato alla memoria di Lawrence “Lo” Leathers, batterista statunitense, caduto vittima di un agguato il 3 giugno del 2019 all’età di 38 anni.
Kit Downes – “Dreamlife Of Debris” – ECM 2632
 Musicista assolutamente atipico questo Kit Downes, il quale, dopo essersi formatosi nel coro della cattedrale di Norwich dove ha imparato a suonare l’organo, si è successivamente innamorato del jazz ascoltando Oscar Peterson. Di qui una musica spesso straniante in cui si mescolano echi i più diversi. Se ne era avuta piena consapevolezza in “Obsidian” in cui Kit suona in splendida solitudine l’organo da chiesa coadiuvato da Tom Challenger al sax tenore in un solo brano. Stesso discorso per quest’ultimo “Dreamlife Of Debris” registrato nel 2018 nella sala da concerto dell’Università di Huddersfield, anch’essa dotata di un organo a canne, strumento cui Downes non sembra proprio voler rinunciare, così come non sembra voler fare a meno di determinati spazi che consentono una certa qualità di suono. Come spiegato da Steve Lake nelle esaurienti note che accompagnano l’album, il titolo dello stesso riporta una frase tratta dal documentario “Patience (After Sebald)” di Grant Gee, che traduce in immagini i testi vergati da W.G. Sebald, durante i suoi viaggi nella contea di Suffolk, testi che in particolare hanno ispirato il suo capolavoro, “Gli anelli di Saturno”. L’impianto basico di “Dreamlife Of Debris” è simile a quello di Obsidian in quanto pone in primo piano l’improvvisazione ma se ne differenzia sotto due aspetti non secondari: qui Downes ha voluto affiancare all’organo altri strumenti (ancora Tom Challenger sax tenore, Lucy Railton cello, Stian Westerhus chitarra, Sebastian Rochford batteria) e, in secondo luogo, si è presentato non solo come organista ma anche come pianista. Il risultato è assolutamente positivo in quanto l’ascoltatore è immerso in atmosfere senza tempo in cui jazz, musica da chiesa, echi folk, richiami alla musica colta da camera si mescolano incredibilmente in atmosfere il cui fascino è difficile da descrivere. Ascoltate il disco e capirete a cosa ci si riferisce.
Musicista assolutamente atipico questo Kit Downes, il quale, dopo essersi formatosi nel coro della cattedrale di Norwich dove ha imparato a suonare l’organo, si è successivamente innamorato del jazz ascoltando Oscar Peterson. Di qui una musica spesso straniante in cui si mescolano echi i più diversi. Se ne era avuta piena consapevolezza in “Obsidian” in cui Kit suona in splendida solitudine l’organo da chiesa coadiuvato da Tom Challenger al sax tenore in un solo brano. Stesso discorso per quest’ultimo “Dreamlife Of Debris” registrato nel 2018 nella sala da concerto dell’Università di Huddersfield, anch’essa dotata di un organo a canne, strumento cui Downes non sembra proprio voler rinunciare, così come non sembra voler fare a meno di determinati spazi che consentono una certa qualità di suono. Come spiegato da Steve Lake nelle esaurienti note che accompagnano l’album, il titolo dello stesso riporta una frase tratta dal documentario “Patience (After Sebald)” di Grant Gee, che traduce in immagini i testi vergati da W.G. Sebald, durante i suoi viaggi nella contea di Suffolk, testi che in particolare hanno ispirato il suo capolavoro, “Gli anelli di Saturno”. L’impianto basico di “Dreamlife Of Debris” è simile a quello di Obsidian in quanto pone in primo piano l’improvvisazione ma se ne differenzia sotto due aspetti non secondari: qui Downes ha voluto affiancare all’organo altri strumenti (ancora Tom Challenger sax tenore, Lucy Railton cello, Stian Westerhus chitarra, Sebastian Rochford batteria) e, in secondo luogo, si è presentato non solo come organista ma anche come pianista. Il risultato è assolutamente positivo in quanto l’ascoltatore è immerso in atmosfere senza tempo in cui jazz, musica da chiesa, echi folk, richiami alla musica colta da camera si mescolano incredibilmente in atmosfere il cui fascino è difficile da descrivere. Ascoltate il disco e capirete a cosa ci si riferisce.
Ethan Iverson Quartet – “Common Practice” – ECM 2643
 Splendido album del quartetto del pianista Ethan Iverson innervato dalla presenza di Tom Harrell e completato da una eccellente ritmica con Ben Street al contrabbasso e Eric McPherson alla batteria). L’album registrato live al Village Vanguard nel gennaio del 2017 ci consegna un mainstream attualizzato, ricco di swing, esplicitato attraverso sia composizioni oramai classiche (ad esempio “The Man I Love”, “I Can’t Get Started”, “Sentimental Journey”, “All The Things You Are” e “We”) sia nuovi brani dovuti anche al pianista di Menomonie quali “Philadelphia Creamer” e “Jed From Teaneck” che rappresentano un mirabile esempio dell’approccio swing del quartetto. Iverson – lo ricordo per quei quattro, cinque che ancora non lo sapessero – è stato membro fondatore del trio jazz d’avanguardia The Bad Plus con il contrabbassista Reid Anderson e il batterista Dave King, che è riuscito a ricollocarsi in contesti assai diversi. E’ il caso, per l’appunto di questo “Common Practice”, il cui risultato è davvero notevole: l’intesa tra il leader e la tromba di Tom Harrell (classe 1946, votato nel 2018 come miglior trombettista dell’anno dalla U.S. Jazz Journalists Association) si staglia su un tessuto musicale ben disegnato in cui le invenzioni melodico-armoniche del leader sono sostenute da una sezione ritmica capace sempre di proiettare la musica in avanti, in una sorta di slancio che mai viene meno. Si ascolti al riguardo l’interpretazione di quel “Sentimental Journey” composto nel 1944 da Les Brown e Ben Homer (musica) e Bud Green (parole), portato al successo dapprima da Doris Day e successivamente inciso da molti jazzisti tra cui Lionel Hampton, Buck Clayton con Woody Herman, Ben Sidran, Frank Sinatra e Rosemary Clooney. Ma il brano citato è solo un esempio di quanto il gruppo sia ottimamente attrezzato anche per merito della sezione ritmica: si ascolti ancora nel successivo ”Out Of Nowhere” il centrato assolo di Ben Street al contrabbasso.
Splendido album del quartetto del pianista Ethan Iverson innervato dalla presenza di Tom Harrell e completato da una eccellente ritmica con Ben Street al contrabbasso e Eric McPherson alla batteria). L’album registrato live al Village Vanguard nel gennaio del 2017 ci consegna un mainstream attualizzato, ricco di swing, esplicitato attraverso sia composizioni oramai classiche (ad esempio “The Man I Love”, “I Can’t Get Started”, “Sentimental Journey”, “All The Things You Are” e “We”) sia nuovi brani dovuti anche al pianista di Menomonie quali “Philadelphia Creamer” e “Jed From Teaneck” che rappresentano un mirabile esempio dell’approccio swing del quartetto. Iverson – lo ricordo per quei quattro, cinque che ancora non lo sapessero – è stato membro fondatore del trio jazz d’avanguardia The Bad Plus con il contrabbassista Reid Anderson e il batterista Dave King, che è riuscito a ricollocarsi in contesti assai diversi. E’ il caso, per l’appunto di questo “Common Practice”, il cui risultato è davvero notevole: l’intesa tra il leader e la tromba di Tom Harrell (classe 1946, votato nel 2018 come miglior trombettista dell’anno dalla U.S. Jazz Journalists Association) si staglia su un tessuto musicale ben disegnato in cui le invenzioni melodico-armoniche del leader sono sostenute da una sezione ritmica capace sempre di proiettare la musica in avanti, in una sorta di slancio che mai viene meno. Si ascolti al riguardo l’interpretazione di quel “Sentimental Journey” composto nel 1944 da Les Brown e Ben Homer (musica) e Bud Green (parole), portato al successo dapprima da Doris Day e successivamente inciso da molti jazzisti tra cui Lionel Hampton, Buck Clayton con Woody Herman, Ben Sidran, Frank Sinatra e Rosemary Clooney. Ma il brano citato è solo un esempio di quanto il gruppo sia ottimamente attrezzato anche per merito della sezione ritmica: si ascolti ancora nel successivo ”Out Of Nowhere” il centrato assolo di Ben Street al contrabbasso.
Louis Sclavis – “Characters On A Wall” – ECM 2645
 Molti i riferimenti colti in questo album, vincitore del referendum “Top Jazz” nella categoria “disco internazionale dell’anno”, del clarinettista Louis Sclavis coadiuvato da Benjamin Moussay al piano, Christophe Lavergne alla batteria e Sarah Murcia al contrabbasso. L’ispirazione principale risiede nell’arte del pittore Ernest Pignon-Ernest con il quale Sclavis ha avuto modo di collaborare lungamente a partire dagli anni ’80. In effetti le opere di Pignon-Ernest erano state in precedenza oggetto dell’album di Sclavis “Napoli’s Walls” del 2002, disco ispirato ad un ciclo di immagini che il pittore aveva disegnato sui muri della città campana dal 1987 al 1995 aventi ad oggetto la rappresentazione della morte, le donne di Napoli ed i culti pagani e cristiani. Questa volta l’artista francese, in cinque dei suoi brani originali (“L’heure Pasolini”, “La dame de Martigues”, “Extases”, “Prison” e “Darwich dans la ville”) si ispira a dipinti realizzati da Pignon-Ernest in location diverse, da Parigi alla Palestina. Il disco è completato da un brano di Moussay, “Shadows and Lines”, e due improvvisazioni collettive. Altra differenza rispetto all’album precedente è che mentre in “Napoli’s Walls” si faceva un certo uso dell’elettronica, in questo “Characters” il gruppo è totalmente acustico Ciò detto, l’apertura è significativamente intitolata “L’heure Pasolini”, un brano intimista che disegna assai bene il quadro generale entro cui il gruppo si muoverà lungo tutto l’album. Ovvero una musica ricercata, in cui scrittura e improvvisazione si bilanciano, con la sezione ritmica che lavora quasi in sottofondo per creare le condizioni ideali in cui il leader inserisce i propri straordinari assolo caratterizzati sempre da un suono personale, limpido. Suono che si adatta perfettamente sia ai brani di più chiara ispirazione jazzistica, sia a quelle composizioni in cui si evince chiaramente un’ispirazione di matrice classica, nonostante si tratti di improvvisazioni collettive. Un’ultima notazione: l’album è corredato da un esauriente libretto con prefazione dello stesso Sclavis e ampie note di Stéphane Ollivier.
Molti i riferimenti colti in questo album, vincitore del referendum “Top Jazz” nella categoria “disco internazionale dell’anno”, del clarinettista Louis Sclavis coadiuvato da Benjamin Moussay al piano, Christophe Lavergne alla batteria e Sarah Murcia al contrabbasso. L’ispirazione principale risiede nell’arte del pittore Ernest Pignon-Ernest con il quale Sclavis ha avuto modo di collaborare lungamente a partire dagli anni ’80. In effetti le opere di Pignon-Ernest erano state in precedenza oggetto dell’album di Sclavis “Napoli’s Walls” del 2002, disco ispirato ad un ciclo di immagini che il pittore aveva disegnato sui muri della città campana dal 1987 al 1995 aventi ad oggetto la rappresentazione della morte, le donne di Napoli ed i culti pagani e cristiani. Questa volta l’artista francese, in cinque dei suoi brani originali (“L’heure Pasolini”, “La dame de Martigues”, “Extases”, “Prison” e “Darwich dans la ville”) si ispira a dipinti realizzati da Pignon-Ernest in location diverse, da Parigi alla Palestina. Il disco è completato da un brano di Moussay, “Shadows and Lines”, e due improvvisazioni collettive. Altra differenza rispetto all’album precedente è che mentre in “Napoli’s Walls” si faceva un certo uso dell’elettronica, in questo “Characters” il gruppo è totalmente acustico Ciò detto, l’apertura è significativamente intitolata “L’heure Pasolini”, un brano intimista che disegna assai bene il quadro generale entro cui il gruppo si muoverà lungo tutto l’album. Ovvero una musica ricercata, in cui scrittura e improvvisazione si bilanciano, con la sezione ritmica che lavora quasi in sottofondo per creare le condizioni ideali in cui il leader inserisce i propri straordinari assolo caratterizzati sempre da un suono personale, limpido. Suono che si adatta perfettamente sia ai brani di più chiara ispirazione jazzistica, sia a quelle composizioni in cui si evince chiaramente un’ispirazione di matrice classica, nonostante si tratti di improvvisazioni collettive. Un’ultima notazione: l’album è corredato da un esauriente libretto con prefazione dello stesso Sclavis e ampie note di Stéphane Ollivier.
Israel Varela- “The Labyrinth Project” – VVJ 131
 Ecco una sorta di internazionale del jazz: a guidarla il compositore, percussionista e vocalist messicano Israel Varela; al suo fianco il sassofonista canadese-americano Ben Wendel conosciuto soprattutto per essere un membro fondatore del gruppo Kneebody che nel 2009 si è meritato una nomination ai Grammy, il pianista tedesco Florian Weber il cui primo album “Minsarah” del 2006 ha vinto il premio della critica discografica tedesca, il bassista brasiliano Alfredo Paixao vincitore di numerosi Grammy Awards e “collaboratore” di alcune stelle anche al di fuori dell’ambito jazzistico come Julio Iglesias, , Liza Minelli, Henry Salvador… fino al ‘nostro’ Pino Daniele. Insomma un insieme composto da quattro spiccate personalità, evidentemente portatrici di culture e input differenziati, che si incontrano dando vita ad un ensemble del tutto originale…così come originale è la musica da loro proposta. Musica difficile da classificare dal momento che accanto a brani di chiara impronta jazzistica (si ascolti i lunghi assolo di Weber e di Wendel in “Heliopolis”) è possibile ascoltare episodi in cui ci si allontana dal jazz per approdare su sponde diverse come in “Azul” affidata alla coinvolgente e mai scontata vocalità di Israel Varela, in alcuni tratti addirittura commovente. Il quale subito dopo conferma in “Nueve secretos” di essere soprattutto uno strepitoso batterista accompagnando in solitudine il trascinante assolo di Ben Wendel. Nel conclusivo “Cuatro” si ricostituisce il gruppo in una sorta di rielaborazione di tutto il materiale sonoro offerto nell’album, quindi attenzione alle dinamiche, sapiente uso della tavolozza coloristica, giusta suddivisione degli assolo, eccellente equilibrio di scrittura e improvvisazione, il tutto conseguenza di un sapido arrangiamento.
Ecco una sorta di internazionale del jazz: a guidarla il compositore, percussionista e vocalist messicano Israel Varela; al suo fianco il sassofonista canadese-americano Ben Wendel conosciuto soprattutto per essere un membro fondatore del gruppo Kneebody che nel 2009 si è meritato una nomination ai Grammy, il pianista tedesco Florian Weber il cui primo album “Minsarah” del 2006 ha vinto il premio della critica discografica tedesca, il bassista brasiliano Alfredo Paixao vincitore di numerosi Grammy Awards e “collaboratore” di alcune stelle anche al di fuori dell’ambito jazzistico come Julio Iglesias, , Liza Minelli, Henry Salvador… fino al ‘nostro’ Pino Daniele. Insomma un insieme composto da quattro spiccate personalità, evidentemente portatrici di culture e input differenziati, che si incontrano dando vita ad un ensemble del tutto originale…così come originale è la musica da loro proposta. Musica difficile da classificare dal momento che accanto a brani di chiara impronta jazzistica (si ascolti i lunghi assolo di Weber e di Wendel in “Heliopolis”) è possibile ascoltare episodi in cui ci si allontana dal jazz per approdare su sponde diverse come in “Azul” affidata alla coinvolgente e mai scontata vocalità di Israel Varela, in alcuni tratti addirittura commovente. Il quale subito dopo conferma in “Nueve secretos” di essere soprattutto uno strepitoso batterista accompagnando in solitudine il trascinante assolo di Ben Wendel. Nel conclusivo “Cuatro” si ricostituisce il gruppo in una sorta di rielaborazione di tutto il materiale sonoro offerto nell’album, quindi attenzione alle dinamiche, sapiente uso della tavolozza coloristica, giusta suddivisione degli assolo, eccellente equilibrio di scrittura e improvvisazione, il tutto conseguenza di un sapido arrangiamento.
da synpress44 | 25/Set/2019 | Comunicati stampa
TRENTINOINJAZZ 2019
e
TrentinoIn Jazz Club
presentano:
Giovedì 26 settembre 2019
ore 21.30
Circolo Operaio Paganini
Via S. Giovanni Bosco 5
Rovereto
MACK
Prima data autunnale per il TrentinoInJazz 2019, giovedì 26 settembre con il nuovo appuntamento del TrentinoIn Jazz Club – ideato da Emilio Galante – al Circolo Operaio Paganini di Rovereto: Federico Squassabia (tastiere), Marco Frattini (batteria) e Mattia Matta Dallara (campioni, elettronica), ovvero il trio Mack.
Mack è un vortice di hip hop ed elettronica formato da tastiere galleggianti, bassi profondi, intense tessiture ritmiche e freestyle rap. Già presenti al TrentinoInJazz 2017 con lo slogan-manifesto A Future Soul Pulse, i tre compongono una formazione dall’approccio creativo e devoto alla presenza costante di groove. Un universo musicale a base di hip hop, neo soul, jazz e avanguardia.
Prossimo appuntamento: mercoledì 2 ottobre Il jazz in Italia – gli italiani nel jazz (tavola rotonda) + concerto del Sonata Islands Quintet a Trento.
da synpress44 | 10/Set/2019 | Comunicati stampa
TRENTINOINJAZZ 2019
e
TrentinoIn Jazz Club
presentano:
Giovedì 12 settembre 2019
ore 21.30
Circolo Operaio Paganini
Via S. Giovanni Bosco 5
Rovereto
RAFFA & THE BLUEBIRDS LAB
Ultima data estiva per il TrentinoInJazz 2019, giovedì 12 settembre con il nuovo appuntamento del TrentinoIn Jazz Club – ideato da Emilio Galante – al Circolo Operaio Paganini di Rovereto: Raffa & The BlueBirds Lab, ovvero Stefano Raffaelli (piano e live electronics), Nana Kofi Motobi (freestyle), Sehrat Akbal (voce/baglama), Bbeta (live electronics) e Carlos Pinheiro (sax).
Bluebirds Lab è il nuovo progetto del pianista trentino Stefano Raffaelli. Un vero e proprio laboratorio sonoro che indaga e sperimenta connessioni tra ambito elettronico, jazz e musica popolare. I musicisti partecipanti sono in continua turnazione, per togliere qualsiasi certezza e stabilità ai risultati di volta in volta raggiunti, e nella certezza che incognita e movimento possano generare stimoli creativi inconsueti. E’ un progetto multiculturale e multirazziale, che vede la presenza di figure straniere quali il rapper africano Nana Kofi Motobi, il kurdo Serhat Akbal (Kurdistan), il sassofonista portoghese Carlos Pinheiro.
Prossimo appuntamento: giovedì 26 settembre Mack a Rovereto (TN).
da synpress44 | 12/Giu/2019 | Comunicati stampa
APS Trentino Jazz
Fondazione CARITRO
Provincia Autonoma di Trento
Regione Autonoma Trentino Alto Adige
presentano:
TRENTINOINJAZZ 2019
otto anni di grande jazz!
(altro…)

 Massimo Barbiero, batterista e percussionista, è senza dubbio uno dei musicisti italiani più coerenti e originali, senza che, a tutt’oggi, abbia ottenuto i riconoscimenti che merita. Anche questo suo ultimo album si inserisce nell’ambito di quelle produzioni di qualità cui l’artista ci ha abituati oramai da molti anni. L’organico è un trio con Eloisa Manera al violino ed al violino elettrico a cinque corde e Emanuele Sartoris al pianoforte. In repertorio dieci brani che sostanziano un omaggio a “Il maestro e Margherita” di Bulgakov, uno dei più importanti lavori del Novecento letterario, e “Woland” è uno dei nomi germanici del Diavolo, ed è anche il nome (in russo Воланд) di uno dei personaggi chiave di questo romanzo. Quindi un concept album in cui la sapienza compositiva di Barbiero trova ancora una volta il modo di esplicarsi appieno, anche se questa volta il carico compositivo è ripartito egualmente fra i tre artisti. Ammesso e non concesso che sia ancora importante definire ciò che si ascolta, incasellarlo in una cornice predeterminata, ebbene con la musica di questo album tutto ciò non è possibile. Non è jazz propriamente detto, non è musica colta nell’accezione del termine ma una sorta di percorso tra culture musicali diverse, alle volte molto diverse. E sta proprio qui la bravura dei musicisti che nulla concedono al facile ascolto riuscendo comunque a conquistare l’attenzione dell’ascoltatore sin dal brano d’apertura, “Abadonna” di Massimo Barbiero, in cui violino e pianoforte quasi si inseguono su un terreno accidentato che taluni hanno voluto accostare ad atmosfere impressioniste. In “Margherita”, sempre di Massimo Barbiero, è soprattutto il violino, ben supportato dal tappeto ritmico disegnato dal leader, a dettare le atmosfere del brano, questa volta più leggibili e narrative, in cui si avvertono echi sia di Vivaldi sia di Paganini. Di livello anche la suite in tre parti, di undici minuti, “Suite dei tre demoni” di Eloisa Manera, sempre in bilico fra scrittura ed improvvisazione, come del resto l’intero disco. La conclusione è affidata ad una composizione di Sartoris, “Pilato, potere temporale”, in cui il pianismo dell’autore si evidenzia in tutta la sua essenzialità, ben lontana da qualsivoglia esibizionismo.
Massimo Barbiero, batterista e percussionista, è senza dubbio uno dei musicisti italiani più coerenti e originali, senza che, a tutt’oggi, abbia ottenuto i riconoscimenti che merita. Anche questo suo ultimo album si inserisce nell’ambito di quelle produzioni di qualità cui l’artista ci ha abituati oramai da molti anni. L’organico è un trio con Eloisa Manera al violino ed al violino elettrico a cinque corde e Emanuele Sartoris al pianoforte. In repertorio dieci brani che sostanziano un omaggio a “Il maestro e Margherita” di Bulgakov, uno dei più importanti lavori del Novecento letterario, e “Woland” è uno dei nomi germanici del Diavolo, ed è anche il nome (in russo Воланд) di uno dei personaggi chiave di questo romanzo. Quindi un concept album in cui la sapienza compositiva di Barbiero trova ancora una volta il modo di esplicarsi appieno, anche se questa volta il carico compositivo è ripartito egualmente fra i tre artisti. Ammesso e non concesso che sia ancora importante definire ciò che si ascolta, incasellarlo in una cornice predeterminata, ebbene con la musica di questo album tutto ciò non è possibile. Non è jazz propriamente detto, non è musica colta nell’accezione del termine ma una sorta di percorso tra culture musicali diverse, alle volte molto diverse. E sta proprio qui la bravura dei musicisti che nulla concedono al facile ascolto riuscendo comunque a conquistare l’attenzione dell’ascoltatore sin dal brano d’apertura, “Abadonna” di Massimo Barbiero, in cui violino e pianoforte quasi si inseguono su un terreno accidentato che taluni hanno voluto accostare ad atmosfere impressioniste. In “Margherita”, sempre di Massimo Barbiero, è soprattutto il violino, ben supportato dal tappeto ritmico disegnato dal leader, a dettare le atmosfere del brano, questa volta più leggibili e narrative, in cui si avvertono echi sia di Vivaldi sia di Paganini. Di livello anche la suite in tre parti, di undici minuti, “Suite dei tre demoni” di Eloisa Manera, sempre in bilico fra scrittura ed improvvisazione, come del resto l’intero disco. La conclusione è affidata ad una composizione di Sartoris, “Pilato, potere temporale”, in cui il pianismo dell’autore si evidenzia in tutta la sua essenzialità, ben lontana da qualsivoglia esibizionismo. Carmine Ioanna, fisarmonicista d’origine irpina, e Francesco Bearzatti, sassofonista e clarinettista cresciuto nella provincia friulana, sono i “responsabili” di questo godibile album. Il titolo riflette la predilezione dei due artisti per raccontare, attraverso la musica, storie, in questo caso specifico ‘favole’. Il sodalizio nasce due anni or sono sulla base della comune volontà di improvvisare divertendosi e questa caratteristica si coglie appieno ascoltando l’album, declinato attraverso composizioni dei due artisti, un brano tratto dalla tradizione dell’Azerbaijan e tre improvvisazioni espressamente dichiarate come tali. Neppure per un attimo si avverte la sensazione che l’uno voglia prevaricare l’altro ma, sottolinea Ioanna, – siamo “due persone che si amano, si completano, non si sovrappongono mai perché vanno nella stessa direzione”. “Soprattutto c’è, secondo me, – ribadisce Bearzatti – una bella mescolanza di ego, nel senso che non c’è nessuno che sovrasta l’altro”. Una musica, quindi, che ci consegna due artisti in grado di improvvisare costantemente, mai perdendo il bandolo della matassa, anzi continuando a sviluppare un discorso sempre coerente e con tale intensità da non far rimpiangere la mancanza degli altri strumenti. Sassofono e fisarmonica, nella mani dei due artisti, riescono a produrre una massa sonora spesso di tipo orchestrale che si inserisce in una atmosfera davvero magica, “da favola” per riportarci al titolo dell’album, in cui si avvertono echi della musica popolare così come del jazz, della musica contemporanea, della world music. Il tutto, sottolinea ancora Bearzatti, per aprire delle piccole brecce, non già per fare musica di massa, e per puntare al grande pubblico.
Carmine Ioanna, fisarmonicista d’origine irpina, e Francesco Bearzatti, sassofonista e clarinettista cresciuto nella provincia friulana, sono i “responsabili” di questo godibile album. Il titolo riflette la predilezione dei due artisti per raccontare, attraverso la musica, storie, in questo caso specifico ‘favole’. Il sodalizio nasce due anni or sono sulla base della comune volontà di improvvisare divertendosi e questa caratteristica si coglie appieno ascoltando l’album, declinato attraverso composizioni dei due artisti, un brano tratto dalla tradizione dell’Azerbaijan e tre improvvisazioni espressamente dichiarate come tali. Neppure per un attimo si avverte la sensazione che l’uno voglia prevaricare l’altro ma, sottolinea Ioanna, – siamo “due persone che si amano, si completano, non si sovrappongono mai perché vanno nella stessa direzione”. “Soprattutto c’è, secondo me, – ribadisce Bearzatti – una bella mescolanza di ego, nel senso che non c’è nessuno che sovrasta l’altro”. Una musica, quindi, che ci consegna due artisti in grado di improvvisare costantemente, mai perdendo il bandolo della matassa, anzi continuando a sviluppare un discorso sempre coerente e con tale intensità da non far rimpiangere la mancanza degli altri strumenti. Sassofono e fisarmonica, nella mani dei due artisti, riescono a produrre una massa sonora spesso di tipo orchestrale che si inserisce in una atmosfera davvero magica, “da favola” per riportarci al titolo dell’album, in cui si avvertono echi della musica popolare così come del jazz, della musica contemporanea, della world music. Il tutto, sottolinea ancora Bearzatti, per aprire delle piccole brecce, non già per fare musica di massa, e per puntare al grande pubblico. Ecco un album raffinato, oserei dire in alcuni momenti sofisticato, in cui si privilegia senza remora alcuna la ricerca della bella melodia. Di qui un repertorio che spazia da alcuni temi cari agli appassionati di jazz (uno per tutti “My Favorite Things”), alla canzone francese, rappresentata da ben quattro titoli (“Et maintenant” di Gilbert Bécaud, “Ne me quitte pas” di Jacques Brel, “L’hymne à l’amour” di Edith Piaf e “La Bohème” di Charles Aznavour), dalla black music (“I Can’t Help It” di Stevie Wonder e Susaye Greene) ad esplicite reminiscenze blues (“Butterfly” di Herbie Hancock)… alle atmosfere vagamente brasiliane di “The Island” di Ivan Lins, Marilyn e Alan Bergman,… con l’aggiunta di due intermezzi strumentali “End of Chapter One e Two”. A cucinare questa gustosa ricetta sono la cantante americana di origini haitiane Martine Thomas che attualmente vive a Zara, coadiuvata dai Black Coffee, il trio croato costituito da Renato Švorinić, bassista e leader, dal pianista Ivan Ivić e dal batterista Jadran Dučić, cui si aggiungono come special guests Daniele di Bonaventura, bandoneon, presente solo in “Et maintenant”, e Massimo Donà, la cui tromba si ascolta in quattro tracce. Vista la varietà dei brani si potrebbe temere una certa disomogeneità dell’album. Invece “Once Upon A Time” mantiene una sua intrinseca coerenza derivante dal come il gruppo approccia la materia: innanzitutto la ferma volontà di rispettare le linee melodiche dei vari pezzi cui si aggiungono i sapidi arrangiamenti di Renato Švorinić e Ivan Ivić. E il discorso appare quanto mai evidente soprattutto nei quattro pezzi francesi interpretati con gusto ed eleganza dalla Thomas e impreziositi da arrangiamenti mai banali. In questo senso particolarmente apprezzabile è anche la versione di “I Can’t Help It” con un centrato assolo di Ivić al piano elettrico.
Ecco un album raffinato, oserei dire in alcuni momenti sofisticato, in cui si privilegia senza remora alcuna la ricerca della bella melodia. Di qui un repertorio che spazia da alcuni temi cari agli appassionati di jazz (uno per tutti “My Favorite Things”), alla canzone francese, rappresentata da ben quattro titoli (“Et maintenant” di Gilbert Bécaud, “Ne me quitte pas” di Jacques Brel, “L’hymne à l’amour” di Edith Piaf e “La Bohème” di Charles Aznavour), dalla black music (“I Can’t Help It” di Stevie Wonder e Susaye Greene) ad esplicite reminiscenze blues (“Butterfly” di Herbie Hancock)… alle atmosfere vagamente brasiliane di “The Island” di Ivan Lins, Marilyn e Alan Bergman,… con l’aggiunta di due intermezzi strumentali “End of Chapter One e Two”. A cucinare questa gustosa ricetta sono la cantante americana di origini haitiane Martine Thomas che attualmente vive a Zara, coadiuvata dai Black Coffee, il trio croato costituito da Renato Švorinić, bassista e leader, dal pianista Ivan Ivić e dal batterista Jadran Dučić, cui si aggiungono come special guests Daniele di Bonaventura, bandoneon, presente solo in “Et maintenant”, e Massimo Donà, la cui tromba si ascolta in quattro tracce. Vista la varietà dei brani si potrebbe temere una certa disomogeneità dell’album. Invece “Once Upon A Time” mantiene una sua intrinseca coerenza derivante dal come il gruppo approccia la materia: innanzitutto la ferma volontà di rispettare le linee melodiche dei vari pezzi cui si aggiungono i sapidi arrangiamenti di Renato Švorinić e Ivan Ivić. E il discorso appare quanto mai evidente soprattutto nei quattro pezzi francesi interpretati con gusto ed eleganza dalla Thomas e impreziositi da arrangiamenti mai banali. In questo senso particolarmente apprezzabile è anche la versione di “I Can’t Help It” con un centrato assolo di Ivić al piano elettrico. Affrontare la registrazione di un album per sole ance è impresa quanto mai difficile da cui sono usciti indenni solo alcuni grandissimi personaggi quali Sonny Rollins, Steve Lacy, Lee Konitz, Anthony Braxton. In questo album ascoltiamo un artista italiano, Felice Clemente, che usa sax tenore, sax soprano e clarinetto, in una registrazione effettuata nella chiesa settecentesca di Montecalvo Versiggia il 15 e 16 novembre del 2019. La scelta della location non è stata casuale o indifferente: in effetti, come acutamente sottolinea Paolo Fresu nelle note che accompagnano l’album, la dimensione armonica di un solo di sax e clarinetto si esplica nella magia dei rimandi di echi e riverberi, che traggono spunto dalla navata e dalle arcate di una chiesa o di una basilica. Quasi a dimostrare quanto il fitto dialogo tra gli strumenti e il luogo che li accoglie sia frutto di un “antico matrimonio che appartiene alla storia dell’uomo”. Ecco quindi come, grazie anche ad una presa di suono eccellente, sia possibile apprezzare in tutta la loro bellezza queste architravi sonore rette da echi, riverberi che solo in un ambiente come quello di una chiesa (ovviamente con caratteristiche particolari) sarebbe stato possibile ottenere. Ma tutto ciò non sarebbe stato possibile se non ci fosse stata anche e soprattutto la valentia di Felice Clemente compositore, arrangiatore, esecutore di grande raffinatezza che ha voluto disegnare un percorso non facile attraverso un repertorio che parte da un classico del jazz, “Harlem Nocturne” di Hearle Hagen per concludersi con una libera improvvisazione, passando attraverso tre sue composizioni originali, e brani di Branford Marsalis, Godard, Morricone, Nuzzolese, Di Gregorio, Javier Perz Forte e Bach.
Affrontare la registrazione di un album per sole ance è impresa quanto mai difficile da cui sono usciti indenni solo alcuni grandissimi personaggi quali Sonny Rollins, Steve Lacy, Lee Konitz, Anthony Braxton. In questo album ascoltiamo un artista italiano, Felice Clemente, che usa sax tenore, sax soprano e clarinetto, in una registrazione effettuata nella chiesa settecentesca di Montecalvo Versiggia il 15 e 16 novembre del 2019. La scelta della location non è stata casuale o indifferente: in effetti, come acutamente sottolinea Paolo Fresu nelle note che accompagnano l’album, la dimensione armonica di un solo di sax e clarinetto si esplica nella magia dei rimandi di echi e riverberi, che traggono spunto dalla navata e dalle arcate di una chiesa o di una basilica. Quasi a dimostrare quanto il fitto dialogo tra gli strumenti e il luogo che li accoglie sia frutto di un “antico matrimonio che appartiene alla storia dell’uomo”. Ecco quindi come, grazie anche ad una presa di suono eccellente, sia possibile apprezzare in tutta la loro bellezza queste architravi sonore rette da echi, riverberi che solo in un ambiente come quello di una chiesa (ovviamente con caratteristiche particolari) sarebbe stato possibile ottenere. Ma tutto ciò non sarebbe stato possibile se non ci fosse stata anche e soprattutto la valentia di Felice Clemente compositore, arrangiatore, esecutore di grande raffinatezza che ha voluto disegnare un percorso non facile attraverso un repertorio che parte da un classico del jazz, “Harlem Nocturne” di Hearle Hagen per concludersi con una libera improvvisazione, passando attraverso tre sue composizioni originali, e brani di Branford Marsalis, Godard, Morricone, Nuzzolese, Di Gregorio, Javier Perz Forte e Bach. Ecco un altro gradevole album firmato Cordoba Reunion, ovvero il prestigioso quartetto costituito da musicisti tutti nativi della stessa città, Cordoba, ma residenti in paesi diversi (Francia, Italia e Argentina): Javier Girotto ai sassofoni, Gerardo Di Giusto al piano, Gabriel “Minino” Garay percussioni e batteria e Carlos “El Tero” Buschini basso e guembri. Registrato a Milano nel marzo del 2019, l’album contiene undici tracce di cui nove firmate dagli stessi membri del gruppo e due da Julien Lourau un sassofonista francese classe 1970. Come già nei precedenti album, “Argentina Jazz” del 2004 e “Sin lugar a dudas” del 2008, il gruppo si muove su direttrici molto ben individuabili: uno straordinario mix tra tanghi, milonghe e chacareras da un lato, jazz, improvvisazione, sperimentazione dall’altro. Evidentemente una impresa così difficile può essere intrapresa con un minimo di possibilità di successo solo se ad affrontarla sono musicisti che coniugano una spiccata personalità individuale con una capacità di rapportarsi ai compagni d’avventura. Ebbene i quattro musicisti in oggetto possiedono ambedue queste doti essendo tecnicamente molto ferrati ma allo stesso tempo capaci di condurre il discorso musicale sulla base di una profonda empatia. Risultato: un latin-jazz assolutamente coinvolgente che risponde ad un progetto musicale in cui la ricchezza ritmica della musica argentina, seppur ancorata al ricco patrimonio folklorico del Paese, dimostra come la stessa non sia solo tango e milonga, ma molto, molto di più.
Ecco un altro gradevole album firmato Cordoba Reunion, ovvero il prestigioso quartetto costituito da musicisti tutti nativi della stessa città, Cordoba, ma residenti in paesi diversi (Francia, Italia e Argentina): Javier Girotto ai sassofoni, Gerardo Di Giusto al piano, Gabriel “Minino” Garay percussioni e batteria e Carlos “El Tero” Buschini basso e guembri. Registrato a Milano nel marzo del 2019, l’album contiene undici tracce di cui nove firmate dagli stessi membri del gruppo e due da Julien Lourau un sassofonista francese classe 1970. Come già nei precedenti album, “Argentina Jazz” del 2004 e “Sin lugar a dudas” del 2008, il gruppo si muove su direttrici molto ben individuabili: uno straordinario mix tra tanghi, milonghe e chacareras da un lato, jazz, improvvisazione, sperimentazione dall’altro. Evidentemente una impresa così difficile può essere intrapresa con un minimo di possibilità di successo solo se ad affrontarla sono musicisti che coniugano una spiccata personalità individuale con una capacità di rapportarsi ai compagni d’avventura. Ebbene i quattro musicisti in oggetto possiedono ambedue queste doti essendo tecnicamente molto ferrati ma allo stesso tempo capaci di condurre il discorso musicale sulla base di una profonda empatia. Risultato: un latin-jazz assolutamente coinvolgente che risponde ad un progetto musicale in cui la ricchezza ritmica della musica argentina, seppur ancorata al ricco patrimonio folklorico del Paese, dimostra come la stessa non sia solo tango e milonga, ma molto, molto di più. La genesi di questo album viene esplicitata dallo stesso leader laddove afferma da un canto che il progetto è nato dall’incontro con Jeff Ballard conosciuto molti anni addietro durante una masterclass a Siena, dall’altro che “Il dono” è per lui quello dell’incontro, per cui “donare o ricevere sono due aspetti dello stesso gesto”. Gesto che si concretizza in questo album in cui il musicista napoletano, ben sostenuto da Aldo Vigorito al basso, suo ‘storico’ compagno d’avventure musicali, e dal già citato Jeff Ballard alla batteria (particolarmente importante la sua militanza nel trio di Brad Meldhau), presenta undici brani tutti di sua composizione, eccezion fatta per “O Impro Mio” (Ferraiuolo-Vigorito-Ballard), “Improtune” (Ferraiuolo-Vigorito-Ballard) e “Somebody Loves Me” (George Gershwin). I pezzi originali, per esplicita ammissione dello stesso pianista, sono dedicati alle persone a lui più care. La caratura dell’album appare evidente sin dal primo brano, “Fire Island”: i tre si muovono su un piano di assoluta parità ritagliandosi spazi appropriati (ad esempio in questo brano possiamo già gustare un preciso e gustoso assolo di Aldo Vigorito). Nasce da qui una musica che si inscrive nell’alveo del jazz canonico, con improvvisazioni serrate (particolarmente azzeccata quella sulla falsa riga di “O sole mio” trasformato in “O impro mio”), scambi trascinanti, ricerca di suadenti linee melodiche (particolarmente apprezzate da chi scrive quelle di “4 Septembre” e “C’est tout”) mentre in “Baires” specie nella parte finale si avverte una certa influenza ‘tanguera”. Infine “Improtune” si avventura su terreni contigui al free per tornare ad atmosfere più consuete con la convincente interpretazione del gershwiano “Somebody Loves Me”.
La genesi di questo album viene esplicitata dallo stesso leader laddove afferma da un canto che il progetto è nato dall’incontro con Jeff Ballard conosciuto molti anni addietro durante una masterclass a Siena, dall’altro che “Il dono” è per lui quello dell’incontro, per cui “donare o ricevere sono due aspetti dello stesso gesto”. Gesto che si concretizza in questo album in cui il musicista napoletano, ben sostenuto da Aldo Vigorito al basso, suo ‘storico’ compagno d’avventure musicali, e dal già citato Jeff Ballard alla batteria (particolarmente importante la sua militanza nel trio di Brad Meldhau), presenta undici brani tutti di sua composizione, eccezion fatta per “O Impro Mio” (Ferraiuolo-Vigorito-Ballard), “Improtune” (Ferraiuolo-Vigorito-Ballard) e “Somebody Loves Me” (George Gershwin). I pezzi originali, per esplicita ammissione dello stesso pianista, sono dedicati alle persone a lui più care. La caratura dell’album appare evidente sin dal primo brano, “Fire Island”: i tre si muovono su un piano di assoluta parità ritagliandosi spazi appropriati (ad esempio in questo brano possiamo già gustare un preciso e gustoso assolo di Aldo Vigorito). Nasce da qui una musica che si inscrive nell’alveo del jazz canonico, con improvvisazioni serrate (particolarmente azzeccata quella sulla falsa riga di “O sole mio” trasformato in “O impro mio”), scambi trascinanti, ricerca di suadenti linee melodiche (particolarmente apprezzate da chi scrive quelle di “4 Septembre” e “C’est tout”) mentre in “Baires” specie nella parte finale si avverte una certa influenza ‘tanguera”. Infine “Improtune” si avventura su terreni contigui al free per tornare ad atmosfere più consuete con la convincente interpretazione del gershwiano “Somebody Loves Me”. Ecco un’altra prima discografica: protagonista il chitarrista Tommaso Gambini torinese ma newyorkese di adozione, alla testa di un gruppo ad organico variabile composto dai suoi abituali collaboratori Manuel Schmiedel al pianoforte, Ben Tiberio al contrabbasso e Adam Arruda alla batteria cui si aggiungono l’alto sassofonista olandese Ben Van Gelder, il tenor sassofonista e compositore americano Dayna Stephens, il clarinettista Jacopo Albini e la flautista Anggie Obin. In scaletta sette brani tutti firmati dal chitarrista, e riferiti al racconto omonimo dello scrittore inglese Edward Morgan Forster del 1909, racconto che paradossalmente sembra avere molti punti di contatto con la tragica realtà di oggi. Forster parla di una Macchina inventata dall’uomo che prende il sopravvento sulla nostra stessa volontà; sostituite i termini Macchina con Virus e il gioco è fatto. Quindi, almeno sulla carta, si tratta di un concept album. Ma, come al solito in questi casi si pone l’interrogativo: è riuscita la musica a tradurre in suoni tali concetti? Francamente non del tutto; non ho sentito quel clima, cupo, drammatico che forse meglio si sarebbe attagliato alla situazione di cui sopra. Ad onor del vero, il brano d’apertura, anche grazie all’inserto parlato tratto dal volume in oggetto, riflette bene il clima dello stesso ma nei brani successivi è come se l’atmosfera si addolcisse e quindi la tensione si allentasse. Comunque, onestamente, non ho letto il racconto per cui potrebbe darsi che anche i successivi pezzi riflettano in qualche modo i contenuti dello scritto. Ma tutto ciò è abbastanza irrilevante in quanto poco toglie alla valenza dell’album che risulta apprezzabile: Gambini scrive bene, arrangia altrettanto bene e come chitarrista si è fatto ampiamente conoscere collaborando con jazzisti quali Antonio Sanchez, George Garzone, Miguel Zenon e non si lavora con personaggi del genere se non sei più che bravo.
Ecco un’altra prima discografica: protagonista il chitarrista Tommaso Gambini torinese ma newyorkese di adozione, alla testa di un gruppo ad organico variabile composto dai suoi abituali collaboratori Manuel Schmiedel al pianoforte, Ben Tiberio al contrabbasso e Adam Arruda alla batteria cui si aggiungono l’alto sassofonista olandese Ben Van Gelder, il tenor sassofonista e compositore americano Dayna Stephens, il clarinettista Jacopo Albini e la flautista Anggie Obin. In scaletta sette brani tutti firmati dal chitarrista, e riferiti al racconto omonimo dello scrittore inglese Edward Morgan Forster del 1909, racconto che paradossalmente sembra avere molti punti di contatto con la tragica realtà di oggi. Forster parla di una Macchina inventata dall’uomo che prende il sopravvento sulla nostra stessa volontà; sostituite i termini Macchina con Virus e il gioco è fatto. Quindi, almeno sulla carta, si tratta di un concept album. Ma, come al solito in questi casi si pone l’interrogativo: è riuscita la musica a tradurre in suoni tali concetti? Francamente non del tutto; non ho sentito quel clima, cupo, drammatico che forse meglio si sarebbe attagliato alla situazione di cui sopra. Ad onor del vero, il brano d’apertura, anche grazie all’inserto parlato tratto dal volume in oggetto, riflette bene il clima dello stesso ma nei brani successivi è come se l’atmosfera si addolcisse e quindi la tensione si allentasse. Comunque, onestamente, non ho letto il racconto per cui potrebbe darsi che anche i successivi pezzi riflettano in qualche modo i contenuti dello scritto. Ma tutto ciò è abbastanza irrilevante in quanto poco toglie alla valenza dell’album che risulta apprezzabile: Gambini scrive bene, arrangia altrettanto bene e come chitarrista si è fatto ampiamente conoscere collaborando con jazzisti quali Antonio Sanchez, George Garzone, Miguel Zenon e non si lavora con personaggi del genere se non sei più che bravo. Erroll Garner è sicuramente uno dei giganti della musica jazz. La “Octave Remastered Series”, prodotta da Peter Lockhart e Steve Rosenthal, continua a riproporre alcune delle perle di questo straordinario pianista. Questo ultimo album include nove pezzi tratti da tre album “That’s My Kick” registrato nel 1967 con Milt Hinton basso, Herbert Lovelle e George Jenkins batteria, José Mangual e Johnny Pacheco congas, Wally Richardson e Art Ryerson chitarra; “Up In Erroll’s Room” del novembre dello stesso 1967 con Ike Isaacs basso, Jimmie Smith batteria, Jose Mangual congas featuring “The Brass Bed”; e “Feeling Is Believing” del 1969 con Wally Richardson chitarra, Joe Cocuzzo, Jimmie Smith e Charlie Persip batteria, Jose Mangual congas, Jerry Jemmott e George Duvivier basso. Per chi conosce il jazz, credo bastino solo queste note per comprendere come si tratti di musica di assoluta livello, registrata quando il pianista di Pittsburgh stava vivendo uno dei suoi tanti momenti positivi. In particolare i brani contenuti nell’album ci mostrano un Garner alla testa di formazioni diverse ma che sempre sono in grado di seguire con partecipazione le idee del leader, il cui pianismo, smagliante, mai conosce un attimo di stasi, di indecisione. E siamo sicuri che anche l’ascolto di questo album aprirà una dialettica, a mio avviso del tutto inutile, tra chi considera Garner un assoluto genio musicale (ed io sono tra questi) e chi invece lo valuta pianista di eccellente tecnica ma troppo dedito a inutili virtuosismi.
Erroll Garner è sicuramente uno dei giganti della musica jazz. La “Octave Remastered Series”, prodotta da Peter Lockhart e Steve Rosenthal, continua a riproporre alcune delle perle di questo straordinario pianista. Questo ultimo album include nove pezzi tratti da tre album “That’s My Kick” registrato nel 1967 con Milt Hinton basso, Herbert Lovelle e George Jenkins batteria, José Mangual e Johnny Pacheco congas, Wally Richardson e Art Ryerson chitarra; “Up In Erroll’s Room” del novembre dello stesso 1967 con Ike Isaacs basso, Jimmie Smith batteria, Jose Mangual congas featuring “The Brass Bed”; e “Feeling Is Believing” del 1969 con Wally Richardson chitarra, Joe Cocuzzo, Jimmie Smith e Charlie Persip batteria, Jose Mangual congas, Jerry Jemmott e George Duvivier basso. Per chi conosce il jazz, credo bastino solo queste note per comprendere come si tratti di musica di assoluta livello, registrata quando il pianista di Pittsburgh stava vivendo uno dei suoi tanti momenti positivi. In particolare i brani contenuti nell’album ci mostrano un Garner alla testa di formazioni diverse ma che sempre sono in grado di seguire con partecipazione le idee del leader, il cui pianismo, smagliante, mai conosce un attimo di stasi, di indecisione. E siamo sicuri che anche l’ascolto di questo album aprirà una dialettica, a mio avviso del tutto inutile, tra chi considera Garner un assoluto genio musicale (ed io sono tra questi) e chi invece lo valuta pianista di eccellente tecnica ma troppo dedito a inutili virtuosismi. Album d’esordio per il pianista Giulio Gentile e la vocalist Emanuela Di Benedetto che da giovani appassionati di musica Jazz, hanno poi studiato al dipartimento Jazz del Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara. Il duo nasce nel 2012 e si fortifica attraverso la partecipazione a numerosi festival, tra cui “MuntagninJazz”, “La Settimana Mozartiana”, il “Castelbuono Jazz Festival”, la rassegna “Sabato in Concerto Jazz” per “Archivi Sonori”. Presto arrivano anche i primi riconoscimenti come il Premio “BEST BAND” al “Bucharest International Jazz Competition 2016”, l’affermazione al “Premio Marco Tamburini 2016” per la sezione band mentre nel 2017 sono vincitori del “Premio Nazionale delle Arti” sezione Jazz tenutosi a Milano Logico, quindi, che si giungesse a questo primo album il cui organico è completato dal batterista Marcello Di Leonardo, dal bassista Luca Bulgarelli, dal sassofonista Manuel Trabucco e dal flicornista Jorge Ro. In repertorio otto brani con musica di Gentile e testi della vocalist. Tenendo conto che si tratta di una ‘prima’ assoluta, l’album presenta note positive riscontrabili soprattutto nella bella intesa tra voce e pianoforte, nella delicatezza dei temi proposti, nella eleganza con cui si manifesta l’amore per la musica e nell’attenzione con cui si guarda alla realtà di oggi. Ecco quindi un omaggio alla città di New York da parte di una giovane donna, una dichiarazione d’amore verso una natura che si vorrebbe più tutelata, un grido di dolore per la lontananza dell’amato/a, un ritratto dell’emigrazione ricco di poesia.
Album d’esordio per il pianista Giulio Gentile e la vocalist Emanuela Di Benedetto che da giovani appassionati di musica Jazz, hanno poi studiato al dipartimento Jazz del Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara. Il duo nasce nel 2012 e si fortifica attraverso la partecipazione a numerosi festival, tra cui “MuntagninJazz”, “La Settimana Mozartiana”, il “Castelbuono Jazz Festival”, la rassegna “Sabato in Concerto Jazz” per “Archivi Sonori”. Presto arrivano anche i primi riconoscimenti come il Premio “BEST BAND” al “Bucharest International Jazz Competition 2016”, l’affermazione al “Premio Marco Tamburini 2016” per la sezione band mentre nel 2017 sono vincitori del “Premio Nazionale delle Arti” sezione Jazz tenutosi a Milano Logico, quindi, che si giungesse a questo primo album il cui organico è completato dal batterista Marcello Di Leonardo, dal bassista Luca Bulgarelli, dal sassofonista Manuel Trabucco e dal flicornista Jorge Ro. In repertorio otto brani con musica di Gentile e testi della vocalist. Tenendo conto che si tratta di una ‘prima’ assoluta, l’album presenta note positive riscontrabili soprattutto nella bella intesa tra voce e pianoforte, nella delicatezza dei temi proposti, nella eleganza con cui si manifesta l’amore per la musica e nell’attenzione con cui si guarda alla realtà di oggi. Ecco quindi un omaggio alla città di New York da parte di una giovane donna, una dichiarazione d’amore verso una natura che si vorrebbe più tutelata, un grido di dolore per la lontananza dell’amato/a, un ritratto dell’emigrazione ricco di poesia. Nel panorama musicale internazionale Dimitri Grechi Espinoza si è oramai ritagliato uno spazio ben preciso grazie alla sua ricerca che conduce oramai da tempo e che si sostanzia nel progetto Oreb, il monte dove Mosé incontrò Dio. E credo basti questo solo elemento per capire la dimensione in cui opera il sassofonista. Anche questo suo ultimo lavoro, intitolato “The Spiritual Way” per la Ponderosa Music Records, si inserisce, dunque, in quella ricerca che attraverso la musica conduce all’estasi. In particolare in questo terzo volume di Oreb, Dimitri affronta il tema delle virtù spirituali, dando eco e risonanza a uno scritto della tradizione cinese che delinea un percorso di ascesi interiore. Il tutto espresso, ovviamente, attraverso una musica la cui particolarità può essere facilmente percepita se solo la si ascolti con un minimo di attenzione e cuore aperto. In compagnia del suo fido sax tenore, Dimitri ha inciso questo album nel febbraio del 2019 in una località del tutto particolare come il Battistero di Pisa di San Giovanni in Piazza dei Miracoli, un luogo che data la sua particolare acustica è risultato fondamentale per la riuscita dell’impresa. Ed in effetti l‘artista pone a base della sua ricerca anche il rapporto fra suono e spazio-sonoro e il suo significato spirituale. Il suono del sax si staglia stentoreo, preciso, nitido, straordinariamente coinvolgente, ricco di riverberi, che richiama altri grandi del passato primo fra tutti il John Coltrane nella versione più intimista e spirituale. Così il sassofonista ci trascina in un mondo “altro”, un mondo in cui noi tutti avremmo forse voglia di rifugiarci dato il terribile momento che stiamo attraversando.
Nel panorama musicale internazionale Dimitri Grechi Espinoza si è oramai ritagliato uno spazio ben preciso grazie alla sua ricerca che conduce oramai da tempo e che si sostanzia nel progetto Oreb, il monte dove Mosé incontrò Dio. E credo basti questo solo elemento per capire la dimensione in cui opera il sassofonista. Anche questo suo ultimo lavoro, intitolato “The Spiritual Way” per la Ponderosa Music Records, si inserisce, dunque, in quella ricerca che attraverso la musica conduce all’estasi. In particolare in questo terzo volume di Oreb, Dimitri affronta il tema delle virtù spirituali, dando eco e risonanza a uno scritto della tradizione cinese che delinea un percorso di ascesi interiore. Il tutto espresso, ovviamente, attraverso una musica la cui particolarità può essere facilmente percepita se solo la si ascolti con un minimo di attenzione e cuore aperto. In compagnia del suo fido sax tenore, Dimitri ha inciso questo album nel febbraio del 2019 in una località del tutto particolare come il Battistero di Pisa di San Giovanni in Piazza dei Miracoli, un luogo che data la sua particolare acustica è risultato fondamentale per la riuscita dell’impresa. Ed in effetti l‘artista pone a base della sua ricerca anche il rapporto fra suono e spazio-sonoro e il suo significato spirituale. Il suono del sax si staglia stentoreo, preciso, nitido, straordinariamente coinvolgente, ricco di riverberi, che richiama altri grandi del passato primo fra tutti il John Coltrane nella versione più intimista e spirituale. Così il sassofonista ci trascina in un mondo “altro”, un mondo in cui noi tutti avremmo forse voglia di rifugiarci dato il terribile momento che stiamo attraversando. Vulcanica, tecnicamente fortissima, semplicemente straordinaria: questi gli apprezzamenti che critici e pubblici di tutto il mondo hanno rivolto a Hiromi Uehara una delle più talentuose protagoniste della nuova scena jazz internazionale. La pianista giapponese (classe 1979) si è messa in luce già da bambina e durante tutti questi anni non ha fatto altro che studiare, suonare, studiare e suonare affinando una tecnica davvero strepitosa e migliorando notevolmente anche l’interpretazione. Queste doti vengono tutte in luce in questo album per solo piano registrato in Giappone nel settembre del 2019. E’ interessante sottolineare come questo sia solo il secondo CD registrato dalla Hiromi per piano solo dopo “Place to Be” del 2009 a conferma di quanto l’artista sia attenta a misurare le proprie capacità. E così “Spectrum” si segnala come una delle migliori prove della pianista che si conferma non solo strumentista in possesso di una conoscenza profonda della tastiera, capace di padroneggiare diversi linguaggi, ma anche interprete raffinata, attenta ad ogni aspetto della sua performance. Hiromi accarezza letteralmente ogni tasto dello strumento, dando a ciascuna nota un suo peso specifico cosicché l’esecuzione raggiunge livelli di profondità non facilmente eguagliabili. Cosa che si nota sia nei brani originali, sia nei pezzi già famosi come “Blackbird” di Lennon-McCartney, “Rhapsody in Various Shades of Blue” ovvero “Rhapsody in blue” corredata da varie interpolazioni, alcune originali altre tratte da “Blue Train” di John Coltrane e “Behind Blue Eyes” di Pete Townshend. Splendida la chiusura affidata ad un melodico “Sepia Effect”.
Vulcanica, tecnicamente fortissima, semplicemente straordinaria: questi gli apprezzamenti che critici e pubblici di tutto il mondo hanno rivolto a Hiromi Uehara una delle più talentuose protagoniste della nuova scena jazz internazionale. La pianista giapponese (classe 1979) si è messa in luce già da bambina e durante tutti questi anni non ha fatto altro che studiare, suonare, studiare e suonare affinando una tecnica davvero strepitosa e migliorando notevolmente anche l’interpretazione. Queste doti vengono tutte in luce in questo album per solo piano registrato in Giappone nel settembre del 2019. E’ interessante sottolineare come questo sia solo il secondo CD registrato dalla Hiromi per piano solo dopo “Place to Be” del 2009 a conferma di quanto l’artista sia attenta a misurare le proprie capacità. E così “Spectrum” si segnala come una delle migliori prove della pianista che si conferma non solo strumentista in possesso di una conoscenza profonda della tastiera, capace di padroneggiare diversi linguaggi, ma anche interprete raffinata, attenta ad ogni aspetto della sua performance. Hiromi accarezza letteralmente ogni tasto dello strumento, dando a ciascuna nota un suo peso specifico cosicché l’esecuzione raggiunge livelli di profondità non facilmente eguagliabili. Cosa che si nota sia nei brani originali, sia nei pezzi già famosi come “Blackbird” di Lennon-McCartney, “Rhapsody in Various Shades of Blue” ovvero “Rhapsody in blue” corredata da varie interpolazioni, alcune originali altre tratte da “Blue Train” di John Coltrane e “Behind Blue Eyes” di Pete Townshend. Splendida la chiusura affidata ad un melodico “Sepia Effect”. “Viola” è il secondo album dei Karabà, al secolo Alessandro Casciaro al pianoforte e compositore dei brani, Alberto Stefanizzi alla batteria e Stefano Rielli al contrabbasso.
“Viola” è il secondo album dei Karabà, al secolo Alessandro Casciaro al pianoforte e compositore dei brani, Alberto Stefanizzi alla batteria e Stefano Rielli al contrabbasso. ” – Palomar records 58
” – Palomar records 58 Nel secondo album – “Mesmer” – Morpurgo è ancora in trio ma con Giovanni Maier al contrabbasso e Pietro Ricci alla batteria; l’album esce per la ‘Palomar records’ una piccola etichetta fondata e curata da Giovanni Maier, che lavora esclusivamente in autoproduzione e con tirature limitate. Questo “Mesmer” è dedicato quasi totalmente alle musiche di Paul Motian in quanto sei delle composizioni presentate sono del batterista (la settima è invece di Charlie Haden). Il risultato è più che eccellente data da un canto la valenza delle composizioni che lumeggiano al meglio la capacità di scrittura di Motian spesso non adeguatamente valorizzata, dall’altro la capacità del trio di renderle proprie e quindi di reinterpretarle in modo personale ma pertinente. Si parte con “Psalm” title track dell’omonimo album registrato nel dicembre 1981 dal gruppo comprendente Paul Motian, Bill Frisell alla chitarra, Joe Lovano al sax tenore, Billy Drewes ai sax tenore e alto, Ed Schuller al basso e si chiude con “Mesmer” tratto dall’album “Garden of Eden” del 2004. Per tutta la durata dell’album i tra si muovono quasi con cautela, rifuggendo da qualsivoglia esibizione di bravura tecnica e affidandosi molto all’interpretazione. Di qui una musica suggestiva, misurata, spesso eseguita per sottrazione senza che però venga compressa l’abilità individuale. Si ascolti ad esempio il magnifico duetto basso batteria in “Morpion” tratto dall’album “One Time Out” (Blue Note 1987).
Nel secondo album – “Mesmer” – Morpurgo è ancora in trio ma con Giovanni Maier al contrabbasso e Pietro Ricci alla batteria; l’album esce per la ‘Palomar records’ una piccola etichetta fondata e curata da Giovanni Maier, che lavora esclusivamente in autoproduzione e con tirature limitate. Questo “Mesmer” è dedicato quasi totalmente alle musiche di Paul Motian in quanto sei delle composizioni presentate sono del batterista (la settima è invece di Charlie Haden). Il risultato è più che eccellente data da un canto la valenza delle composizioni che lumeggiano al meglio la capacità di scrittura di Motian spesso non adeguatamente valorizzata, dall’altro la capacità del trio di renderle proprie e quindi di reinterpretarle in modo personale ma pertinente. Si parte con “Psalm” title track dell’omonimo album registrato nel dicembre 1981 dal gruppo comprendente Paul Motian, Bill Frisell alla chitarra, Joe Lovano al sax tenore, Billy Drewes ai sax tenore e alto, Ed Schuller al basso e si chiude con “Mesmer” tratto dall’album “Garden of Eden” del 2004. Per tutta la durata dell’album i tra si muovono quasi con cautela, rifuggendo da qualsivoglia esibizione di bravura tecnica e affidandosi molto all’interpretazione. Di qui una musica suggestiva, misurata, spesso eseguita per sottrazione senza che però venga compressa l’abilità individuale. Si ascolti ad esempio il magnifico duetto basso batteria in “Morpion” tratto dall’album “One Time Out” (Blue Note 1987). Il sassofonista norvegese Marius Neset (Bergen 1985) si ripresenta al pubblico del jazz alla testa del suo gruppo anglo-scandinavo (Ivo Neame piano, Jim Hart vibrafono, marimba e percussioni, Petter Eldh basso, Anton Eger batteria e percussioni) con il robusto supporto della London Sinfonietta, complesso di ben 19 elementi diretta da Geoffrey Paterson con cui Neset, sempre per la ACT, aveva già inciso nel 2016 l’album “Snowmelt”. Neset è a ben ragione considerato uno dei migliori jazzisti delle nuove generazioni tanto che la rivista Downbeat lo considera non solo uno dei più eccitanti artisti jazz del momento ma anche un musicista di straordinaria preparazione tecnica dotato altresì di una felice vena compositiva. Doti, queste, che risaltano evidenti anche da quest’ultimo album, contenente un paio di suite intitolate rispettivamente “Viaduct part 1” in 6 capitoli e “Viaduct part.2” in 4 elementi. Originariamente commissionata per il concerto d’apertura del Kongsberg Jazz Festival nel 2018, “Viaduct” ha offerto a Neset la fantastica opportunità di mostrare le molteplici facce del suo stile, così composito, ricco di richiami, colorito e soprattutto capace di convogliare numerosi input provenienti da fonti diverse. Il suo sassofono è sempre preciso, con un sound potente sia al tenore sia al soprano, che richiama sia il migliore Brecker sia il grandissimo Garbarek, capace di dettare le atmosfere che si respirano per tutta la durata dell’album. Certo, la bravura di Neset come sassofonista è indubbia, ma non sarebbe stata sufficiente a determinare la bontà dell’album se non fosse stata declinata attraverso le dieci composizioni originali dello stesso Neset che riescono a coniugare il jazz propriamente inteso, ricco quindi anche di improvvisazione, con la musica classica contemporanea.
Il sassofonista norvegese Marius Neset (Bergen 1985) si ripresenta al pubblico del jazz alla testa del suo gruppo anglo-scandinavo (Ivo Neame piano, Jim Hart vibrafono, marimba e percussioni, Petter Eldh basso, Anton Eger batteria e percussioni) con il robusto supporto della London Sinfonietta, complesso di ben 19 elementi diretta da Geoffrey Paterson con cui Neset, sempre per la ACT, aveva già inciso nel 2016 l’album “Snowmelt”. Neset è a ben ragione considerato uno dei migliori jazzisti delle nuove generazioni tanto che la rivista Downbeat lo considera non solo uno dei più eccitanti artisti jazz del momento ma anche un musicista di straordinaria preparazione tecnica dotato altresì di una felice vena compositiva. Doti, queste, che risaltano evidenti anche da quest’ultimo album, contenente un paio di suite intitolate rispettivamente “Viaduct part 1” in 6 capitoli e “Viaduct part.2” in 4 elementi. Originariamente commissionata per il concerto d’apertura del Kongsberg Jazz Festival nel 2018, “Viaduct” ha offerto a Neset la fantastica opportunità di mostrare le molteplici facce del suo stile, così composito, ricco di richiami, colorito e soprattutto capace di convogliare numerosi input provenienti da fonti diverse. Il suo sassofono è sempre preciso, con un sound potente sia al tenore sia al soprano, che richiama sia il migliore Brecker sia il grandissimo Garbarek, capace di dettare le atmosfere che si respirano per tutta la durata dell’album. Certo, la bravura di Neset come sassofonista è indubbia, ma non sarebbe stata sufficiente a determinare la bontà dell’album se non fosse stata declinata attraverso le dieci composizioni originali dello stesso Neset che riescono a coniugare il jazz propriamente inteso, ricco quindi anche di improvvisazione, con la musica classica contemporanea. Enrico Pieranunzi è musicista colto e in quanto tale ‘aperto’ verso tutte le altre forme artistiche. Nel passato, anche recente, ne abbiamo avuto prova evidente riscontrando la sua profonda predilezione per il cinema e le colonne sonore. Si ricordi, ad esempio, il concerto organizzato il 20 febbraio scorso dall’Ambasciata d’Italia e dall’Istituto di Cultura Italiana a Washington in occasione del centenario della nascita di Federico Fellini, con Enrico Pieranunzi, accompagnato da Luca Bulgarelli al basso e da Mauro Beggio alla batteria, impegnato in un repertorio interamente dedicato alle colonne sonore del maestro romagnolo. In questo album l’interesse del pianista romano è rivolto alle arti figurative: immaginatevi una galleria d’arte in cui sono esposti i capolavori di Pollock, Hopper, Picasso, Paul Klee, Rothko, Matisse e Mondrian; Enrico si sofferma dinnanzi ad ogni quadro e disegna, in splendida solitudine, con le note del pianoforte o alla celesta, un affresco da inserire in una ipotetica ‘cornice’, “Frame” per l’appunto. L’effetto è quanto meno intrigante: Pieranunzi non si smentisce e la sua arte pianistica rifulge sempre luminosa sia che si avventuri in stupefacenti e trascinanti avventure magari con illustri partner d’oltre oceano, sia, come in questo caso, che si rivolga di più al suo coté intimista regalandoci una serie di bozzetti che illustrano meglio di mille parole le sue riflessioni determinate dai pittori sopra citati. Un’ultima considerazione: capita sempre più spesso che la data di pubblicazione di un disco sia di molto posteriore alla sua incisione; ad esempio questo album è stato registrato nel 2012 ma pubblicato solo nel febbraio di questo non felicissimo 2020.
Enrico Pieranunzi è musicista colto e in quanto tale ‘aperto’ verso tutte le altre forme artistiche. Nel passato, anche recente, ne abbiamo avuto prova evidente riscontrando la sua profonda predilezione per il cinema e le colonne sonore. Si ricordi, ad esempio, il concerto organizzato il 20 febbraio scorso dall’Ambasciata d’Italia e dall’Istituto di Cultura Italiana a Washington in occasione del centenario della nascita di Federico Fellini, con Enrico Pieranunzi, accompagnato da Luca Bulgarelli al basso e da Mauro Beggio alla batteria, impegnato in un repertorio interamente dedicato alle colonne sonore del maestro romagnolo. In questo album l’interesse del pianista romano è rivolto alle arti figurative: immaginatevi una galleria d’arte in cui sono esposti i capolavori di Pollock, Hopper, Picasso, Paul Klee, Rothko, Matisse e Mondrian; Enrico si sofferma dinnanzi ad ogni quadro e disegna, in splendida solitudine, con le note del pianoforte o alla celesta, un affresco da inserire in una ipotetica ‘cornice’, “Frame” per l’appunto. L’effetto è quanto meno intrigante: Pieranunzi non si smentisce e la sua arte pianistica rifulge sempre luminosa sia che si avventuri in stupefacenti e trascinanti avventure magari con illustri partner d’oltre oceano, sia, come in questo caso, che si rivolga di più al suo coté intimista regalandoci una serie di bozzetti che illustrano meglio di mille parole le sue riflessioni determinate dai pittori sopra citati. Un’ultima considerazione: capita sempre più spesso che la data di pubblicazione di un disco sia di molto posteriore alla sua incisione; ad esempio questo album è stato registrato nel 2012 ma pubblicato solo nel febbraio di questo non felicissimo 2020. Già altre volte, questa testata si è occupata di Andreas Schaerer sottolineandone le innumerevoli virtù e la capacità di interpretare più parti in commedia dal momento che la sua arte gli consente di fare non solo ciò che hanno fatto i più grandi vocalist del jazz, ma di esibirsi come “beatboxer”, di imitare vari strumenti e di improvvisare con uno scat inventivo e trascinante. Questa volta lo svizzero di Berna si presenta alla testa del suo gruppo “Hildegard Lernt Fliegen” il più creativo e originale progetto musicale che la Svizzera abbia potuto offrire in questi ultimi anni. In effetti una performance del gruppo è sempre qualcosa di straordinario dal momento che è difficile stabilire se si tratti di un concerto jazz, rock, rap, di cabaret, di musica da circo (si ascolti, ad esempio il brano d’apertura “Dripping Pint”) con incursioni sempre misurate anche nel mondo dell’elettronica. Ad assecondare le acrobazie vocali di Andreas cinque solisti di eccellenza quali il trombonista e tubista Andreas Tschopp, i sassofonisti Matthias Wenger e Benedikt Reising (che si ascoltano rispettivamente anche al flauto e al clarinetto basso), il bassista Marco Muller e Christoph Steiner alla batteria e alla marimba. Il tutto rinforzato, purtroppo in un solo brano “Embraced By The Earth” dalla presenza del celebrato fisarmonicista francese Vincent Peirani e dalla intensa voce di Jessana Némitz. Così la musica scorre impetuosa, tutt’altro che banale, lontana da qualsivoglia piacevolezza superficiale in cui l’ascoltatore è coinvolto nella sua totalità, mente e corpo, emozione e intelletto. Da questo punto di vista è difficile scegliere in particolare qualche brano anche se personalmente ho maggiormente apprezzato il già citato pezzo in cui si ascoltano anche Peirani e la Némitz e il brano di chiusura “Love Warrior: Part I-IV” che si muove su coordinate più spiccatamente jazzistiche.
Già altre volte, questa testata si è occupata di Andreas Schaerer sottolineandone le innumerevoli virtù e la capacità di interpretare più parti in commedia dal momento che la sua arte gli consente di fare non solo ciò che hanno fatto i più grandi vocalist del jazz, ma di esibirsi come “beatboxer”, di imitare vari strumenti e di improvvisare con uno scat inventivo e trascinante. Questa volta lo svizzero di Berna si presenta alla testa del suo gruppo “Hildegard Lernt Fliegen” il più creativo e originale progetto musicale che la Svizzera abbia potuto offrire in questi ultimi anni. In effetti una performance del gruppo è sempre qualcosa di straordinario dal momento che è difficile stabilire se si tratti di un concerto jazz, rock, rap, di cabaret, di musica da circo (si ascolti, ad esempio il brano d’apertura “Dripping Pint”) con incursioni sempre misurate anche nel mondo dell’elettronica. Ad assecondare le acrobazie vocali di Andreas cinque solisti di eccellenza quali il trombonista e tubista Andreas Tschopp, i sassofonisti Matthias Wenger e Benedikt Reising (che si ascoltano rispettivamente anche al flauto e al clarinetto basso), il bassista Marco Muller e Christoph Steiner alla batteria e alla marimba. Il tutto rinforzato, purtroppo in un solo brano “Embraced By The Earth” dalla presenza del celebrato fisarmonicista francese Vincent Peirani e dalla intensa voce di Jessana Némitz. Così la musica scorre impetuosa, tutt’altro che banale, lontana da qualsivoglia piacevolezza superficiale in cui l’ascoltatore è coinvolto nella sua totalità, mente e corpo, emozione e intelletto. Da questo punto di vista è difficile scegliere in particolare qualche brano anche se personalmente ho maggiormente apprezzato il già citato pezzo in cui si ascoltano anche Peirani e la Némitz e il brano di chiusura “Love Warrior: Part I-IV” che si muove su coordinate più spiccatamente jazzistiche. Il cantante, pianista e songwriter inglese Ian Shaw è considerato, insieme a Mark Murphy e Kurt Elling, uno dei migliori cantanti jazz di sesso maschile di tutto il mondo. Lo evidenziano i tanti riconoscimenti ottenuti in questi anni: miglior Vocalist Jazz ai BBC Jazz Awards nel 2007 e nel 2004, e nomination nella categoria Miglior Vocalist del Regno Unito ai JazzFM Awards nel 2013… In questo album Ian è accompagnato da un trio italiano composto da Alessandro Di Liberto al piano, Tommaso Scannapieco al basso ed Enzo Zirilli alla batteria. In programma accanto ad alcuni grandi classici ‘leggeri’ come “People”, cavallo di battaglia di Barbara Streisand dal film “Funny girl” del 1964 (arrangiato per l’occasione da Di Liberto), e “Smile” di Charlie Chaplin arrangiata da Enzo Zirilli, ecco alcuni standards del jazz tra i meno battuti come “Use me” di Bill Withers che chiude l’intero disco. In tutti i brani risalta evidente il ruolo svolto dagli strumentisti che riescono a intessere un tappeto ritmico-armonico in cui si inserisce con assoluta pertinenza la voce di Ian Shaw che, dal canto suo, evidenzia una maturità espressiva non comune. Di solito quando si ascolta un disco il cui leader è un cantante (indipendentemente dal sesso) la formula è quella del vocalist con accompagnamento. In questo caso la situazione è completamente diversa in quanto il gruppo appare perfettamente coeso e si muove all’unisono dando ad ognuno la possibilità di mettersi in evidenza. Certo, Ian Shaw è la stella dell’album e la sua prestazione è assolutamente all’altezza dei suoi precedenti album che hanno giustificato, nel tempo, i riconoscimenti cui in apertura si faceva riferimento. I brani sono tutti notevoli con una preferenza, del tutto personale, per il celeberrimo “Smile” di Charlie Chaplin.
Il cantante, pianista e songwriter inglese Ian Shaw è considerato, insieme a Mark Murphy e Kurt Elling, uno dei migliori cantanti jazz di sesso maschile di tutto il mondo. Lo evidenziano i tanti riconoscimenti ottenuti in questi anni: miglior Vocalist Jazz ai BBC Jazz Awards nel 2007 e nel 2004, e nomination nella categoria Miglior Vocalist del Regno Unito ai JazzFM Awards nel 2013… In questo album Ian è accompagnato da un trio italiano composto da Alessandro Di Liberto al piano, Tommaso Scannapieco al basso ed Enzo Zirilli alla batteria. In programma accanto ad alcuni grandi classici ‘leggeri’ come “People”, cavallo di battaglia di Barbara Streisand dal film “Funny girl” del 1964 (arrangiato per l’occasione da Di Liberto), e “Smile” di Charlie Chaplin arrangiata da Enzo Zirilli, ecco alcuni standards del jazz tra i meno battuti come “Use me” di Bill Withers che chiude l’intero disco. In tutti i brani risalta evidente il ruolo svolto dagli strumentisti che riescono a intessere un tappeto ritmico-armonico in cui si inserisce con assoluta pertinenza la voce di Ian Shaw che, dal canto suo, evidenzia una maturità espressiva non comune. Di solito quando si ascolta un disco il cui leader è un cantante (indipendentemente dal sesso) la formula è quella del vocalist con accompagnamento. In questo caso la situazione è completamente diversa in quanto il gruppo appare perfettamente coeso e si muove all’unisono dando ad ognuno la possibilità di mettersi in evidenza. Certo, Ian Shaw è la stella dell’album e la sua prestazione è assolutamente all’altezza dei suoi precedenti album che hanno giustificato, nel tempo, i riconoscimenti cui in apertura si faceva riferimento. I brani sono tutti notevoli con una preferenza, del tutto personale, per il celeberrimo “Smile” di Charlie Chaplin. Tutti conosciamo Baba Sissoko; ebbene Djime è il di lui nipote che vive a Bamako in Mali. Come si dice buon sangue non mente e anche questo artista è degno della massima attenzione. Si badi bene, però: la sua musica non è quella sorta di jazz fortemente contaminato dall’Africa che ha reso famoso Baba; qui siamo sul terreno della musica africana, meglio maliana, lontana da qualsivoglia contaminazione e proprio per questo di grande fascino. Djime si presenta alla testa del suo gruppo, “Djama Djigui” una formazione assolutamente particolare in quanto composta da fratelli, cugini, vicini che sono cresciuti assieme, discendenti della grande famiglia dei Griot Sissoko, tra cui ovviamente il più volte citato Baba. L’album, oltre della maestria del leader al ngoni (strumento a corda proprio dell’Africa occidentale) e al tama (strumento a percussione sempre dell’Africa occidentale) e dello straordinario affiatamento del gruppo, si avvale della splendida voce della moglie di Djime, Aichata Bah. Oltre a quella di Aichata, si possono altresì ascoltare le voci di Baba in “Ma Kono Djarabi” e in “Djumara Djeli”, di Sadibuou Kanté in “Djuku Ya Magnie” e di Samba Tourè in “Anka Miri”, tutti in veste di ospiti. Particolarmente significativo il brano che chiude l’album,”Tama solo”, in cui Djime Sissoko evidenzia tutto il suo virtuosismo per l’appunto al tama. “Kabako”, oramai l’avrete già capito, ci conduce in un meraviglioso viaggio attraverso il Mali grazie alla sua musica che affonda le proprie radici nella tradizione di quella terra.
Tutti conosciamo Baba Sissoko; ebbene Djime è il di lui nipote che vive a Bamako in Mali. Come si dice buon sangue non mente e anche questo artista è degno della massima attenzione. Si badi bene, però: la sua musica non è quella sorta di jazz fortemente contaminato dall’Africa che ha reso famoso Baba; qui siamo sul terreno della musica africana, meglio maliana, lontana da qualsivoglia contaminazione e proprio per questo di grande fascino. Djime si presenta alla testa del suo gruppo, “Djama Djigui” una formazione assolutamente particolare in quanto composta da fratelli, cugini, vicini che sono cresciuti assieme, discendenti della grande famiglia dei Griot Sissoko, tra cui ovviamente il più volte citato Baba. L’album, oltre della maestria del leader al ngoni (strumento a corda proprio dell’Africa occidentale) e al tama (strumento a percussione sempre dell’Africa occidentale) e dello straordinario affiatamento del gruppo, si avvale della splendida voce della moglie di Djime, Aichata Bah. Oltre a quella di Aichata, si possono altresì ascoltare le voci di Baba in “Ma Kono Djarabi” e in “Djumara Djeli”, di Sadibuou Kanté in “Djuku Ya Magnie” e di Samba Tourè in “Anka Miri”, tutti in veste di ospiti. Particolarmente significativo il brano che chiude l’album,”Tama solo”, in cui Djime Sissoko evidenzia tutto il suo virtuosismo per l’appunto al tama. “Kabako”, oramai l’avrete già capito, ci conduce in un meraviglioso viaggio attraverso il Mali grazie alla sua musica che affonda le proprie radici nella tradizione di quella terra. L’ afroamericano Warren Wolf, anche attraverso i suoi quattro precedenti album pubblicati per la Mack Avenue tra il 2005 e il 2016, si è affermato come uno dei migliori vibrafonisti degli ultimi anni e in questa nuova incisione ha chiamato accanto a sé giovani sideman e alcuni veterani. Con lui ecco quindi Brett Williams al Fender Rhodes ed al pianoforte, Richie Godds al basso elettrico e su “Livin’ the Good Life” al contrabbasso, Mark Whitfeld su due brani alla chitarra, Carroll “CV” Dashell III alla batteria ed alle percussioni e due cantanti che si alternano: Imani-Grace Cooper e Marcellus “bassman” Shepard. L’album è sostanzialmente incentrato sul R&B, sul soul e su una fusion di qualità, mentre dal punto di vista dell’ispirazione, il fattore dominante è l’amore declinato attraverso le sue mille sfaccettature; è lo stesso Wolf a chiarirlo: “Questo è un album sull’amore e la musica che mi fa stare bene – spiega Wolf – A questo punto della mia carriera, volevo solo dimostrare che posso essere versatile ed esprimermi in molti stili diversi”. Così ad esempio “For Ma” è dedicato alla madre, Celeste Wolf, deceduta nel 2015, “Sebastian e Zoë” è un delicato omaggio ai suoi due bambini più piccoli, mentre “Come And Dance With Me” è stata scritta per la moglie che è una ballerina. Da quanto sin qui detto, risulta evidente come l’album riuscirà particolarmente gradito a quanti amano la black music nella sua accezione più ampia. Tuttavia, ad opinione del vostro recensore, uno dei pezzi meglio riusciti è “Sebastian and Zoe” in cui Shepard , con espliciti riferimenti a Barry White, dialoga con Imani-Grace Cooper facendo rivivere quelle atmosfere che hanno segnato per molti di noi gli anni ’70.
L’ afroamericano Warren Wolf, anche attraverso i suoi quattro precedenti album pubblicati per la Mack Avenue tra il 2005 e il 2016, si è affermato come uno dei migliori vibrafonisti degli ultimi anni e in questa nuova incisione ha chiamato accanto a sé giovani sideman e alcuni veterani. Con lui ecco quindi Brett Williams al Fender Rhodes ed al pianoforte, Richie Godds al basso elettrico e su “Livin’ the Good Life” al contrabbasso, Mark Whitfeld su due brani alla chitarra, Carroll “CV” Dashell III alla batteria ed alle percussioni e due cantanti che si alternano: Imani-Grace Cooper e Marcellus “bassman” Shepard. L’album è sostanzialmente incentrato sul R&B, sul soul e su una fusion di qualità, mentre dal punto di vista dell’ispirazione, il fattore dominante è l’amore declinato attraverso le sue mille sfaccettature; è lo stesso Wolf a chiarirlo: “Questo è un album sull’amore e la musica che mi fa stare bene – spiega Wolf – A questo punto della mia carriera, volevo solo dimostrare che posso essere versatile ed esprimermi in molti stili diversi”. Così ad esempio “For Ma” è dedicato alla madre, Celeste Wolf, deceduta nel 2015, “Sebastian e Zoë” è un delicato omaggio ai suoi due bambini più piccoli, mentre “Come And Dance With Me” è stata scritta per la moglie che è una ballerina. Da quanto sin qui detto, risulta evidente come l’album riuscirà particolarmente gradito a quanti amano la black music nella sua accezione più ampia. Tuttavia, ad opinione del vostro recensore, uno dei pezzi meglio riusciti è “Sebastian and Zoe” in cui Shepard , con espliciti riferimenti a Barry White, dialoga con Imani-Grace Cooper facendo rivivere quelle atmosfere che hanno segnato per molti di noi gli anni ’70.