da Gerlando Gatto | 18/Apr/2024 | Novità, Primo piano, Recensioni
Tanto buon jazz a Roma: tra domenica 7 aprile e sabato 14 aprile abbiamo assistito ad alcune performance di eccellente livello presentate alla Casa del Jazz e al Teatro Studio dell’Auditorium.
Ma procediamo con ordine.
 Domenica pomeriggio alla Casa del Jazz, in programma il piano-solo del siracusano Francesco Branciamore. L’artista si è affermato nel panorama internazionale come batterista di straordinario talento, collaborando con alcuni dei più bei nomi del jazz italiano e internazionale quali Lee Konitz, Evan Parker, Barre Philips, Ray Mantilla, Keith Tippet, Pier Favre, Paul Rutherford, Michel Godard, Enrico Rava, Gianluigi Trovesi, Enrico Intra, Eugenio Colombo, Paolo Fresu. Negli ultimissimi anni ha deciso di cambiare strada e misurarsi con il pianoforte, strumento certo non facile da affrontare. Dopo un periodo di studi ecco i risultati: due album, in ordine cronologico «Aspiciens Pulchritudinem» del 2018 e «Skies of Sea» del 2021. Ed è proprio da queste due produzioni che Branciamore ha tratto la maggior parte dei brani presentati a Roma.
Domenica pomeriggio alla Casa del Jazz, in programma il piano-solo del siracusano Francesco Branciamore. L’artista si è affermato nel panorama internazionale come batterista di straordinario talento, collaborando con alcuni dei più bei nomi del jazz italiano e internazionale quali Lee Konitz, Evan Parker, Barre Philips, Ray Mantilla, Keith Tippet, Pier Favre, Paul Rutherford, Michel Godard, Enrico Rava, Gianluigi Trovesi, Enrico Intra, Eugenio Colombo, Paolo Fresu. Negli ultimissimi anni ha deciso di cambiare strada e misurarsi con il pianoforte, strumento certo non facile da affrontare. Dopo un periodo di studi ecco i risultati: due album, in ordine cronologico «Aspiciens Pulchritudinem» del 2018 e «Skies of Sea» del 2021. Ed è proprio da queste due produzioni che Branciamore ha tratto la maggior parte dei brani presentati a Roma.
Il pianismo di Branciamore è abbastanza particolare: intendiamoci, nessuno sforzo di stupire l’ascoltatore né tanto meno di evidenziare una tecnica prodigiosa. Dinnanzi allo strumento, il pianista è come se mettesse a nudo la sua natura. Di qui una musica che magari dapprima ti lascia indifferente ma che poi, con il trascorrere dei minuti, ti entra dentro proprio perché hai la sensazione di ascoltare un moto dell’animo. Francesco non ha timore di evidenziare il suo essere tendente alla malinconia, ma lo fa con gusto con misura, senza esagerare. Anche la natura dei brani è funzionale a questo disegno. Brevi bozzetti di circa tre minuti con Branciamore impegnato a mai perdere il filo del discorso che si svolge con straordinaria continuità senza che l’ascoltatore percepisca un attimo di stanca, peggio ancora di dejà vu.
Molti i momenti particolari anche se ci ha particolarmente colpiti il sentito omaggio al leader del gruppo EST, il compianto Esbjörn Svensson, “Thinking to EST”.
*******
 Ed eccoci lunedì sera all’Auditorium Parco della Musica, Teatro Studio, per il doppio concerto del quintetto di Danilo Blaiotta e del gruppo Moonari.
Ed eccoci lunedì sera all’Auditorium Parco della Musica, Teatro Studio, per il doppio concerto del quintetto di Danilo Blaiotta e del gruppo Moonari.
Danilo Blaiotta è di sicuro uno dei personaggi più interessanti affermatosi in questi ultimi tempi. Pianista, compositore, arrangiatore, scrittore ha da poco pubblicato un interessante album dal titolo suggestivo e altamente simbolico “Planetariat”. Due sono le fonti che hanno ispirato questo album: il poeta della controcultura americana -nonché uno dei massimi esponenti dell’era post-beat generation- Jack Hirschman, scomparso circa un anno fa e conosciuto personalmente dal pianista; l’esigenza di denunciare le innumerevoli storture che Blaiotta percepisce nella società di oggi. La sua, in effetti, è musica “sociale” nel senso che, come sottolinea lo stesso artista, non si limita ad osservare ma va ben oltre denunciando “un certo assenteismo dai problemi di carattere sociale come conseguenza di un appiattimento culturale che ci condanna a poca riflessione”. Di qui undici brani che ci parlano di problemi tanto attuali quanto drammatici: la situazione a Gaza, lo sfruttamento continuo e costante dell’Africa, la follia dei computer della Borsa di New York, i numerosi attacchi in Medio Oriente da parte dell’organizzazione militare del patto atlantico, una dedica alla Madre Terra, l’assurdità di chi è pagato per uccidere un altro uomo, altra dedica questa volta a Gino Strada, un breve Requiem per le morti nel Mediterraneo, un omaggio alla resistenza del popolo greco nei confronti dell’ingerenza economica da parte di Commissione Europea, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale, a chiudere, un grido di dolore e di pietà della parte sfortunata del mondo nei confronti dell’oppressione militare, economica e bancaria del capitalismo moderno. Come si nota un vero e proprio cahier de doléance delle gravi storture che attanagliano il mondo. Ovviamente si può essere più o meno d’accordo con le tesi sostenute da Blaiotta ma in questa sede ci interessa molto di più la sua musica.
Bene, partendo da queste premesse, anche ciò che abbiamo ascoltato all’Auditorium conferma le ottime impressioni che l’album ci aveva suscitato: a nostro avviso non c’è alcun dubbio circa l’onestà intellettuale del compositore. La sua musica non ha – e non può avere – alcunché di consolatorio ma si svolge dura, spigolosa, quasi senza un attimo di tregua con i cinque perfettamente in linea, pronti ad assecondare le intenzioni del leader, pronti ad unirsi a quella sorta di grido di dolore che la musica, a volte lancinante, evoca. Tutto bene, dunque?
Non proprio. Come si accennava, parte integrante del progetto sono le liriche di Jack Hirschman che si possono ascoltare in ben sette degli undici pezzi e che contribuiscono non poco alla valenza del progetto. Bene, abbiamo usato il termine “ascoltare” ma del tutto impropriamente in quanto, per una non felice presa di suono, le poesie recitate con passione dalla vocalist Valentina Ramunno, sono state praticamente inascoltabili, con ciò orbando il set di un elemento davvero importante. E questo dimostra ancora una volta come un concerto sia la risultante di più fattori tra cui i tecnici del suono che non sono certo all’ultimo posto.
*******
 Domenica 13 eccoci nuovamente alla Casa del Jazz per ascoltare la vocalist Sonia Spinello in trio con Eugenia Canale al pianoforte e Achille Succi al sax alto, clarinetto e clarinetto basso.
Domenica 13 eccoci nuovamente alla Casa del Jazz per ascoltare la vocalist Sonia Spinello in trio con Eugenia Canale al pianoforte e Achille Succi al sax alto, clarinetto e clarinetto basso.
In programma la presentazione dell’album “Flow” cofirmato da Sonia Spinello e Eugenia Canale, ed uscito recentemente per l’abeat.
Due i presupposti su cui si fonda l’intero progetto: da un lato un’accurata ricerca timbrica, dall’altro la possibilità di un’improvvisazione estemporanea considerata come il filo conduttore dell’intero impianto narrativo.
Per quanto concerne il primo elemento, Spinello e Canale collaborano oramai da parecchio tempo e il loro connubio artistico è in grado di produrre frutti copiosi. Le abilità pianistiche della Canale (grande tecnica, speciale senso estetico, gusto per il non usuale) si fonda perfettamente con il canto della Spinello che già in passato aveva dimostrato di intendere la voce come una sorta di sussurro dell’animo, una forma dolce, gentile, di comunicare stati d’animo, emozioni. Di qui una musica delicata, introversa, che poco concede allo spettacolo ma molto alla riflessione, una musica che ti induce a riflettere, a meditare, a cercare un rapporto più stretto con la propria spiritualità… ove se ne sentisse il bisogno, cosa tutt’altro che scontata.
Così è facile avvertire la musica come un flusso che si sviluppa costantemente senza una precisa scrittura: come accenna la stesa Spinello, nell’album si lascia che la musica prenda forma dall’ascolto reciproco e fluisca trasformandosi continuamente. Come conseguenza tra l’ascolto del disco in cui figurano molti ospiti e il live non si avverte molta differenza anche perché Achille Succi, con i suoi centrati interventi – anche in questo caso senza alcuno sfoggio di tecnica fine a sé stessa – riesce a dare il giusto colore a situazioni non banali.
Insomma un gran bel concerto che conferma appieno quanto di buono abbiamo già scritto sul conto della Spinello la cui collaborazione con Eugenia Canale siamo sicuri darà ancora risultati apprezzabili.
Gerlando Gatto
da Gerlando Gatto | 23/Mar/2024 | Eventi, Novità, Primo piano, Recensioni
Non sono certo moltissimi, oggi, i musicisti che mai deludono, gli artisti che non sbagliano un colpo sia nelle produzioni discografiche sia negli eventi live. Bene, tra questi pochi c’è sicuramente il sassofonista Roberto Ottaviano il quale giorni fa si è esibito alla Casa del Jazz di Roma alla testa del suo quintetto ‘Eternal Love’ con Marco Colonna al clarinetto basso, Alexander Hawkins al pianoforte, Giovanni Majer al contrabbasso e Ermanno Baron alla batteria in sostituzione di Zeno De Rossi.
L’occasione mi è particolarmente gradita per ribadire un concetto che porto avanti oramai da tanti anni: Ottaviano è uno dei più grandi musicisti europei, un sassofonista e un band-leader che non ha ancora raccolto tutto ciò che effettivamente merita. In effetti Ottaviano ha sviluppato un linguaggio del tutto personale in cui il gusto per l’improvvisazione si coniuga da un lato con la profonda conoscenza delle tradizioni jazzistiche dall’altro con la ferrea volontà di guardare sempre avanti. Il tutto impreziosito da una tecnica che gli consente di esprimere compiutamente i sentimenti, le sensazioni del momento che, proprio per questo, riescono a smuovere nell’ascoltatore un mondo di emozioni.
Il concerto di Roma è stato salutato dalla folta partecipazione di un pubblico numeroso che ha seguito con entusiasmo la musica eseguita da Ottaviano e compagni. Musica che come recita il titolo del suo ultimo cd – “People” – è una sorta di inno alla pace, alla tolleranza, alla concordia universale. Ma non solo ché il musicista ci tiene a lumeggiare un altro elemento della sua poetica: la necessità sociale di denunciare ciò che non va. Dall’osservazione dell’umanità, con tutti i suoi pregi e difatti, nasce questo album in cui Roberto ha voluto raccogliere alcuni dei momenti salienti del gruppo durante le sue esibizioni nel tentativo di “disegnare ritratti di questa umanità fatta di persone incontrate realmente e virtualmente, persone che ci hanno dato qualcosa, i loro luoghi ed i loro respiri».
 Nelle circa due ore di concerto, Ottaviano ha presentato quasi per intero il contenuto del disco vale a dire quattro delle sue cinque composizioni originali (Mong’s Speakin’, Hariprasad, Homo Sum e Ohnedaruth) e i brani At The Wheel Well di Nikos Kypourgos, Gare Guillemans di Misha Mengelberg e come bis, Caminho Das Águas di Rodrigo Manhero e African Marketplace di Abdullah Ibrahim.
Nelle circa due ore di concerto, Ottaviano ha presentato quasi per intero il contenuto del disco vale a dire quattro delle sue cinque composizioni originali (Mong’s Speakin’, Hariprasad, Homo Sum e Ohnedaruth) e i brani At The Wheel Well di Nikos Kypourgos, Gare Guillemans di Misha Mengelberg e come bis, Caminho Das Águas di Rodrigo Manhero e African Marketplace di Abdullah Ibrahim.
Ora, a prescindere dai contenuti sociali sopra esposti, la musica in sé è semplicemente superlativa. L’intesa tra i cinque è perfetta e anche l’apporto singolo è in linea con la cifra generale del gruppo. E l’empatia che si respira all’interno di “Eternal Love” è dimostrata dal fatto che a Roma la mancanza del batterista titolare Zeno De Rossi non è stata avvertita più di tanto data la facilità, la spontaneità con cui Ermanno Baron si è inserito. Insomma un quintetto davvero straordinario in cui ogni segmento sonoro si incastra alla perfezione nel puzzle magnificamente disegnato dal leader.
Gerlando Gatto
da Gerlando Gatto | 08/Feb/2024 | News, Primo piano
Cari amici jazzofili, così come lo scorso anno pubblichiamo un pezzo di Amedeo Furfaro che continua, giustamente, a insistere su un tasto ben specifico: essere una sorta di sprone affinché il Festival dia spazio anche ai generi musicali meno mainstream tra cui, ovviamente, il jazz. Dato che non scriverò alcunché sul Festival, mi sono permesso di aggiungere alla nota di Furfaro una mia considerazione su quello che personalmente considero uno dei momenti più bassi raggiunti dalla televisione Italiana durante tutta la sua ormai lunga vita. (G.G)
*****
Repetita juvant, dicunt. Ed eccoci ancora qui a discettare del Festival della Canzone Italiana per chiederci, a partire proprio dalla detta denominazione, se tutta la canzone italica vi sia rappresentata. Certo il Festival è divenuto un megacontenitore in cui ospitare dell’altro anche perché sarebbe inopportuno isolare in vitro la canzone dal resto (società, cinema, varietà, moda, attorialità, gossip etc.) poiché la canzone è immersa fino al collo nel mondo che la circonda. Epperò la sensazione che una parte del mondo canoro nostrano sia scarsamente presente è forte, ancora in questa edizione.

E non parliamo solo del jazz – il che ci additerebbe al pubblico ludibrio per “conflitto di interessi”, musicali, s’intende – ma anche di altri filoni i cui interpreti potrebbero essere ben degni di gareggiare occupando, distintamente per sezione, un qualche spazio nelle prime tre serate (una alla volta, per carità!). Un po’ come per l’Orpheus Award, l’articolazione potrebbe essere una triade di generi che andrebbe a coprire gran parte delle “macchie di leopardo” lasciate dalla attuale conformazione del festival. Ecco, a seguire, i termini della proposta:
- lezione canzone lirico-classica.
- Sezione canzone jazz/Blues.
- Sezione canzone napoletana/ ethno-world.
L’obiezione che ci si potrebbe aspettare è che, spruzzati qua e là, assieme a pop melodico cantautorale rap rock etc. ci sono già spezzoni di jazz, lirica, musica partenopea etc. Ma il tutto è affidato a criteri variabili mentre il nodo sarebbe garantire ai tre settori di cui sopra un minimo di visibilità e di chance nel cimentarsi, non più esclusi dalla kermesse della città dei fiori.
E lo share, dove lo mettiamo, lo share? Si, qualcuno cambierà canale. Ma ci sono varie fasce di telespettatori che risultano ad oggi desaparecidos e che potrebbero tornare a pigiare i tasti del telecomando direzione Sanremo compensando “perdite” magari irrisorie. E poi, comunque, la corazzata Rai schierata davanti a quel porto ligure andrebbe a riprendere uno spettacolo in cui anche gruppi “minoritari” di telespettatori, non “riserve indiane”, che pagano idealmente il biglietto tramite il canone, avrebbero modo e occasione di riconoscersi in una programmazione a tutto campo, nazionale oltre che pop(olare).
A chi rivolgere questa modesta proposta? Ad Amadeus, in primis, se verrà confermato direttore artistico anche per il prossimo anno, in ciò anticipando in qualche modo la politica con il suo “premierato” di fatto. O comunque a chi avrà la competenza decisionale pro-tempore, confidando nella possibilità che il palcoscenico dell’Ariston possa diventare veramente “aperto”.
Amedeo Furfaro
 Comunque non possiamo concludere questa “lettera aperta” senza citare il caso scandaloso di John Travolta: ma si può invitare un’icona del cinema mondiale per fargli fare quella figura di merda? Io credo di no; di qui un altro piccolo suggerimento: il Festival si doti di qualcuno che sappia scrivere i testi del programma altrimenti si andrà sempre peggio. E il fatto che gli italiani si ostinino a guadare il Festival, non significa che lo stesso risulti un prodotto di qualità quale invece dovrebbe essere e a tutt’oggi non è. (G.G.)
Comunque non possiamo concludere questa “lettera aperta” senza citare il caso scandaloso di John Travolta: ma si può invitare un’icona del cinema mondiale per fargli fare quella figura di merda? Io credo di no; di qui un altro piccolo suggerimento: il Festival si doti di qualcuno che sappia scrivere i testi del programma altrimenti si andrà sempre peggio. E il fatto che gli italiani si ostinino a guadare il Festival, non significa che lo stesso risulti un prodotto di qualità quale invece dovrebbe essere e a tutt’oggi non è. (G.G.)
da Gerlando Gatto | 18/Dic/2023 | I nostri CD, News, Primo piano, Recensioni
 Heinz Holliger, Anton Kernjak – “Eventail” – ECM New Series
Heinz Holliger, Anton Kernjak – “Eventail” – ECM New Series
Consentitemi di aprire questa rubrica in modo assolutamente nuovo, vale a dire con una sortita nel campo della musica classica. Lo faccio perché questo album mi ha semplicemente incantato e credo valga la pena di essere ascoltato soprattutto da quanti, come me, amano la musica francese dei primi anni del secolo scorso incentrata sull’oboe. In programma musiche di Messiaen, Koechlin, Jolivet, Ravel, Debussy, Milhaud, Saint-Saens, Casadeus. L’ oboista e compositore svizzero Heinz Holliger (classe 1939) è considerate uno dei migliori oboisti al mondo particolarmente versato nel genere che si ascolta in questo album; al suo fianco Anton Kernjak, che ebbe modo di collaborare con Holliger nell’album “Aschenmusik” del 2014, mentre l’arpista francese Alice Belugou l’ascoltiamo in un solo brano di Andre Jovilet “Controversia” per oboe e arpa. L’ascolto è impreziosito dal libretto che accompagna il CD in cui Holliger spiega perché ha scelto questi brani illustrandone la valenza storica e artistica.
 Veljo Tormis – “Reminiscentiae” – ECM New Series
Veljo Tormis – “Reminiscentiae” – ECM New Series
Un’altra prestigiosa realizzazione di ECM nella collana New Series. Protagonista la musica di Veljo Tormis (1930-2017) considerato a ragione uno dei più grandi compositori corali contemporanei nonché uno dei più importanti compositori del XX secolo in Estonia. Nell’album sono contenute memorie che evocano scene dell’infanzia di Tormis in un alternarsi di situazioni sonore che vedono protagonisti ora il coro e i due soprani più un recitativo, ora il coro e l’orchestra, ora il mezzo-soprano Iris Oja e l’orchestra, ora il coro, il soprano Maria Valdmaa ora alcuni solisti come Indrek Vanu alla tromba, Madis Metsamart alle percussioni e Linda Vood al flauto. L’album assume una particolare rilevanza anche perché è stato personalmente curato da Tõnu Kaljuste che per decadi è stato uno dei più stretti collaboratori di Tomis e che nell’occasione, oltre a dirigere la Tallinn Chamber Orchestra ha scelto personalmente il materiale da far ascoltare, ivi compreso quel ‘The Tower Bell in My Village’ che Tormis compose nel 1978 appositamente per un tour che Kaljuste effettuò di lì a poco. Insomma un album in cui Kaljuste riflette tutto il suo amore, la sua ammirazione verso il compositore scomparso la cui musica non può che affascinare ad onta degli anni che passano.
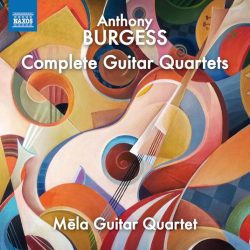 Anthony Burgess – “Complete Guitar Quartets” – Naxos
Anthony Burgess – “Complete Guitar Quartets” – Naxos
Il compositore inglese Anthony Burgess (1917-1993) fu personalità poliedrica, capace di eccellere sia nella letteratura sia nella musica. In quest’ultimo campo compose una serie di quartetti per chitarra che vengono qui presentati in edizione integrale, unitamente ad altre due composizioni, di cui una ‘traditional’ e le altre due dovute rispettivamente all’estro di Gustav Holst e Car Maria von Weber. Tornando ai quartetti di Burgess, composti negli anni ’80, la cosa strana è che Anthony mai ha suonato la chitarra eppure in molte sue novelle il protagonista principale è proprio un chitarrista. Il primo quartetto rilevante, “Quatuor pour Guitares”, completato nel 1986, fu scritto per l’ Aighetta Quartet, e fu eseguito per la prima volta presso l’ Academié Rainer III di Monaco; sottotitolato ‘Quatuor en hommage a Maurice Ravel’ evidenzia una forte influenza della musica francese. Come già accennato, oltre ai quartetti in questo album compare “Trois Morceaux Irlandais” ovvero tre trascrizioni e arrangiamenti di altrettante arie Irlandesi che evidenziano le grandi capacità di Burgess anche come arrangiatore. Un’ultima ma non secondaria notazione: nell’album a suonare la musica di Burgess è chiamato il Mēla Guitar Quartet ovvero Matthew Robinson, George Tarlton, Daniel Bovey e Jiva Housden.
Torniamo sempre con ECM sul terreno jazzistico
 Wolfgang Muthspiel – “Dance of the Elders” – ECM
Wolfgang Muthspiel – “Dance of the Elders” – ECM
Il chitarrista Wolfgang Muthspiel si ripresenta alla testa del suo trio con Scott Coley al contrabbasso e Brian Blade alla batteria per bissare il successo ottenuto con il precedente album “Angular Blues” del 2018. Ancora una volta la musica dell’artista presenta molteplici riferimenti sia alla musica folk sia alla musica classica solo che, in questa occasione, abbiamo ascoltato un Muthspiel più attratto dalle linee melodiche il più delle volte perfettamente riconoscibili. Di qui un fraseggio sempre originale, misurato, tecnicamente ineccepibile e sempre molto, molto elegante. Dei sette brani presentati nell’album (tutti a firma del leader eccezion fatta per “Liebeslied” di Kurt Weill e Berthold Brecht e “Amelia”) il brano che meglio esemplifica quanto fin qui detto è proprio il conclusivo “Amelia”: si tratta di una splendida ballad di Joni Mitchell che il trio reinterpreta con rara delicatezza e con un linguaggio prettamente jazzistico a conferma, se pur ce ne fosse bisogno, che il jazz si identifica non già per quel che si suona ma per come lo si suona.
 Maciej Obara Quartet – “Frozen Silence” – ECM
Maciej Obara Quartet – “Frozen Silence” – ECM
Maciej Obara è un sassofonista polacco (alto e tenore) che ha già alle spalle una fortunata carriera sia come leader sia come sideman in altri gruppi. Con questo nuovo album è alla sua terza realizzazione per ECM e si ripresenta alla testa del suo collaudato quartetto che ha già alle spalle una lunga storia. Al piano troviamo Dominik Wania anch’egli polacco, un altro grande talento che si è incontrato con Obara una decina di anni fa in un ensemble di Tomasz Stanko. Da 2012 i due sono stati raggiunti da una sezione ritmica norvegese composta dal bassista Ole Morten Vagan e dal percussionista Gard Nilssen. Sette delle otto composizioni dell’album sono state scritte durante il periodo della pandemia e quindi riflettono al meglio il lato interiore di Maciej Obara. Di qui un’atmosfera sempre assai meditativa, alle volte velata da una certa malinconia, il tutto declinato con un linguaggio pacato, mai sopra le righe, che non vuol affermare alcuna validità tecnica ma solo rispondere appieno a quelle che sono le intenzioni comunicative del leader. Molto interessante anche il gioco sulle dinamiche che esplicita al meglio l’empatia tra i membri del quartetto.
 Sinikka Langeland – “Wind And Sun” – ECM
Sinikka Langeland – “Wind And Sun” – ECM
Undici composizioni della vocalist norvegese Sinikka Langeland su testi del poeta Jon Fosse più un brano scritto sempre dalla Langelad ma questa volta in collaborazione con Geirr Tveitt. Ad accompagnare la leader un quartetto composto da Trygve Seim – già collaboratore della stessa Langeland – al sax tenore e soprano, Mathias Eick alla tromba, Mats Eilertssen al contrabbasso e Thomas Stronen alla batteria, musicisti tutti ben noti a chi segue il jazz nordico. L’album rispecchia ancora una volta quelle che sono le coordinate stilistiche della Langeland, vale a dire una musica essenziale, senza fronzoli, che trae i suoi motivi ispiratori il più delle volte direttamente dal ricco patrimonio folkloristico nonché dagli input che provengono direttamente dalla natura. Non è certo un caso che la vocalist abbia messo in musica i versi di uno dei più importanti poeti e drammaturghi contemporanei come Jon Fosse – anch’egli norvegese – conosciuto come “il nuovo Ibsen”. Ma chi si aspettasse un album dalle sonorità arcaiche rimarrebbe deluso in quanto il gruppo si muove invece su elementi di assoluta modernità sorretti da grande preparazione tecnica e da un idem sentire con la vocalist. Sentite, ad esempio, come il sax (ora soprano ora tenore) di Seim sottolinei alcuni passaggi che il kantele di Sinikka continua ad eseguire in sottofondo con una stratificazione di suoni tutt’altro che banale.
Restiamo in Norvegia con le produzioni Losen
 Sara Calvanelli, Virginia Sutera – “Ejadira” – Losen
Sara Calvanelli, Virginia Sutera – “Ejadira” – Losen
La Losen si va caratterizzando sempre più per la presenza nel suo catalogo di musicisti non norvegesi tra cui parecchi italiani. Questa volta è il caso di un duo al femminile composto da Sara Calvanelli, accordeon, indian harmonium, loops, cojo, voce e Virginia Sutera, violino. Davvero strana la genesi di questo album per cui vale la pena raccontarla brevemente. La Calvanelli è fisarmonicista arguta che ama sia la scrittura sia la libera improvvisazione; dal canto suo Virginia Sutera è violinista anch’essa attenta all’improvvisazione ma soprattutto all’interazione tra la musica e le altre arti. Siamo nell’autunno del 2020, tempo di lock-down. Le due musiciste decidono di incontrarsi seppure solo per corrispondenza: di qui uno scambio di idee, di prove, di registrazioni fino a quando chiuso il periodo del lock-down, le due si incontrano personalmente dando vita all’album in oggetto. Date le premesse tutto il disco si basa su un libero gioco improvvisativo tra le due che dimostrano di avere un’ottima intesa passando da sonorità che richiamano il barocco a momenti folk fino ad atmosfere più “moderne”.
 Sudeshna Bhattacharya & Somnath Roy –“Mousson de Calcutta” – Losen
Sudeshna Bhattacharya & Somnath Roy –“Mousson de Calcutta” – Losen
Ancora una sortita fuori dai confini nazionali da parte di questa coraggiosa etichetta che si è spinta sino a considerare la musica indiana…anche se poi la registrazione è stata effettuata a Oslo. Anche di questo album è protagonista un duo ben lontano, come si accennava, dalle terre e dalle atmosfere nordiche: Sudeshna Bhattacharya e Somnath Roy. Si tratta di un connubio apparentemente improbabile: Sudeshna è infatti uno dei migliori specialisti di sarod, lo strumento a corde tipico della tradizione musicale dell’Hindustan mentre Somnath è conosciuto per la sua straordinaria abilità nel percuotere il ghatam, strumento tipico della musica carnatica indiana. E’ possibile far coesistere questi due generi sulla carta così diversi? Secondo gli esperti di musica indiana assolutamente no: viceversa i due artisti, con questo album, hanno dimostrato che sì, è possibile, basta intendersi su ciò che si vuole esprimere, basta possedere una straordinaria tecnica di base e il gioco è fatto. In repertorio tre composizioni create da Bhattacharya che durano ben sei, 13 e 38 minuti; in tutte e tre spicca il meraviglioso canto della già citata Somnath Roy che riesce ad emozionare ogni ascoltatore al di là di qualsivoglia barriera di terra e di lingua.
Benvenuta alla Ipogeo Records
E’ con vero piacere che salutiamo questa nuova etichetta discografica Ipogeo Records fondata di recente da Filippo Cosentino, uno dei principali compositori e musicisti jazz contemporanei.
Come sottolineano i responsabili dell’etichetta, fondamentale è la solidità del team di produzione. Da un lato il gruppo di lavoro, che nelle figure chiave è formato da Filippo Cosentino, fondatore, producer e direttore artistico; Federico Mollo, fonico e assistente di produzione; Adriana Riccomagno, ufficio stampa e coordinamento team di distribuzione; Fabrizia Gar e Carlotta Vacchetti, team grafico. Particolare attenzione viene dedicata alla cura del catalogo musicale assicurato dalla casa editrice Cose Note Edizioni. Le sezioni del catalogo sono: jazz music, songwriting e cantautorato; musica contemporanea; early music; soundtrack.
In jazz music e musica contemporanea, tre progetti sono stati ammessi al primo turno di ballottaggio dei Grammy® Awards in due differenti edizioni: 65th Recording Academy / GRAMMYs for the Grammy® Awards Heros, Filippo Cosentino feat. Danilo Mineo e Daniele Bertone, nella categoria Best New Artist; Carlotta The Musical, James David Spellman / Filippo Cosentino, nella categoria Best Theatre Music essendo in effetti la colonna sonora di uno spettacolo teatrale; e quest’anno alla 66th Recording Academy / GRAMMYs for the Grammy® Awards Ask, Filippo Cosentino, nella categoria Best Instrumental Contemporary Music mentre Leeway, singolo tratto da Ask, Filippo Cosentino & Marc Copland feat. Daniele Bertone, nella categoria Best Jazz Performance.
 Nella categoria Jazz i primi due lavori pubblicato sono stati “Multiverse” solo in versione digitale e quindi “Heros” di Filippo Cosentino. In quest’ultimo album la formazione è il trio in cui il leader, chitarrista, è accompagnato dal formidabile pianista Marc Copland, per moltissimi anni componente della formazione di John Abercrombie, e Daniele Bertone alla batteria e percussioni. In programma sette composizioni del leader in cui si evidenzia da un lato le capacità strumentali di tutti e tre i musicisti, dall’altro le ottime capacità compositive di Cosentino che di certo non scopriamo oggi. Le atmosfere predilette sono un mix di jazz, folk e country anche se qua e là riemerge l‘anima mediterranea del leader.
Nella categoria Jazz i primi due lavori pubblicato sono stati “Multiverse” solo in versione digitale e quindi “Heros” di Filippo Cosentino. In quest’ultimo album la formazione è il trio in cui il leader, chitarrista, è accompagnato dal formidabile pianista Marc Copland, per moltissimi anni componente della formazione di John Abercrombie, e Daniele Bertone alla batteria e percussioni. In programma sette composizioni del leader in cui si evidenzia da un lato le capacità strumentali di tutti e tre i musicisti, dall’altro le ottime capacità compositive di Cosentino che di certo non scopriamo oggi. Le atmosfere predilette sono un mix di jazz, folk e country anche se qua e là riemerge l‘anima mediterranea del leader.
In Italia scendono in campo anche i grossi calibri
 Amato Jazz Trio – “Keep Straight On” – abeat
Amato Jazz Trio – “Keep Straight On” – abeat
Elio Amato piano, Alberto Amato contrabbasso e Loris Amato batteria sono i componenti dell’Amato Jazz Trio, una delle formazioni più longeve he a storia del jazz italiano conosca. Una storia costellata di successi straordinari colti in tutto il mondo tanto che non a caso l’amico Franco Faienz li aveva definiti uno dei più originali trii d’Europa e oltre”. La storia del Trio comincia nel 1979 in Sicilia, a Canicattini Bagni, dove i tre fratellini Elio, Alberto e Sergio si divertono a suonare assieme. Ben presto si fanno notare a livello locale e arrivano i primi ingaggi, i primi concerti. Nel periodo che va dal 1985 al 1987 la svolta: il gruppo viene chiamato per aprire i concerti di stelle quali Betty Carter, Muhual Richard Abrams e Wynton Marsalis. Nel 1988 il gruppo vince a Milano il concorso indipendenti per l’allora celebre rivista Fare Musica e subito dopo il jazz contest della Dire. ottenendo come premio la possibilità di incidere il loro primo disco intitolato ‘Jazz Contest 88’. Da quel momento l’Amato Jazz trio incide una serie di album sempre di grande successo e soprattutto ottiene il plauso indiscriminato di pubblico e di critica mantenendo il suo standard qualitativo sempre molto elevato. Cosa che si ripete anche in quest’ultimo album in cui i tre fratelli convincono sempre di più. La loro è davvero una musica ‘universale’ nel senso che nel stessa confluiscono input assai diversi provenienti ovviamente dal bop, dal free jazz, dalla tradizione classica e dalle straordinarie armonizzazioni proprie della musica dei primo del ‘900, il tutto senza dimenticare le origini mediterranee del trio che trova in ognuno dei componenti l’interprete ideale per quel che in quel momento si sta eseguendo. Di qui la difficoltà di segnalare un brano piuttosto che un altro…anche se qualche parola in più desideriamo spenderla per “Arvo” scritto da Alberto Amato: si tratta di un sentito omaggio al compositore estone Arvo Pärt contenuto in poco meno di quattro minuti in cui le influenze minimaliste la fanno da padrone trasportando l’ascoltatore in un mondo “altro”, ben lontano dalle nefandezze di quello odierno.
 Claudio Angeleri – “Concerto feat. Gianluigi Trovesi” – Dodicilune
Claudio Angeleri – “Concerto feat. Gianluigi Trovesi” – Dodicilune
Si intitola semplicemente “Concerto” il nuovo album firmato Claudio Angeleri e registrato live in occasione del Bergamo/Brescia Capitale della Cultura Italiana il 20 maggio 2023 presso l’Auditorium Modernissimo Nembro. Nella versione live i quadri di Gianni Bergamelli si intrecciano con le composizioni musicali di Claudio Angeleri, i testi narrativi di Maurizio Franco e le animazioni di Adriano Merigo che danzano in tempo reale con le improvvisazioni dei diversi solisti. Il CD che vi presentiamo è quindi un album a tema in cui il pianista e compositore bergamasco desidera omaggiare i grandi della cultura lombarda. Per affrontare questo difficile compito Angeleri ha chiamato accanto a sé una schiera di eccellenti musicisti quali Gianluigi Trovesi (clarinetto), Giulio Visibelli (sax soprano e flauto), Gabriele Comeglio (sax alto), Marco Esposito (basso elettrico), Matteo Milesi (batteria), Paola Milzani (impegnata sia come solista vocale sia come direttrice del coro), il giovane talento Nicholas Lecchi (sax tenore) e il coro The Golden Guys. In programma otto brani tutti scritti dallo stesso Angeleri eccezion fatta per “Lacrimosa” tratto dalla Messa da Requiem op. 73 di Gaetano Donizetti, mentre le liriche di “Light and Dark” e “Armida” sono state scritte da Alessia Marcassoli. Cercando di mantenersi in un difficilissimo equilibrio tra antico e attuale, Angeleri mette in campo tutta la sua sapienza musicale scrivendo partiture in cui echi di gospel si mescolano a input di chiara influenza “jazz contemporary” nonché classica in cui l’improvvisazione gioca un ruolo di primissimo piano grazie all’interplay che si è costituito tra i musicisti. Al riguardo eccellente il contributo degli artisti citati in precedenza con un Trovesi che sembra non sentire minimamente il peso degli anni che passano anche per lui. Per la cronaca i protagonisti cui sono dedicate le varie performance sono Caravaggio, Arturo Benedetti Michelangeli, Giacomo Costantino Beltrami, Niccolò Tartaglia, Giacomo Quarenghi, Torquato Tasso e le donne della Resistenza. Infine un elemento su cui interviene lo steso Angeleri: la musica, come si accennava, è tratta da uno spettacolo multimediale, procedimento sempre piuttosto rischioso. Di qui la domanda: è possibile gustare la valenza della musica prescindendo da tutto il resto? “Suggerisco afferma Angeleri – di dedicarsi ad un primo ascolto esclusivamente sonoro senza guardare e leggere il booklet: solo pura suggestione uditiva. Gli ascolti e le letture successive offriranno così la possibilità di cambiare prospettiva e replicare più volte le emozioni. Il disco, in questo modo, assume una dimensione plurale e condivisa che lo rende ancora oggi, nel terzo millennio, un mezzo vivo e stimolante per i musicisti di jazz – uso volutamente un termine così ampio – che si esprimono nel tempo reale e per il pubblico che ne fruisce. Anche per questo motivo è stata scelta una versione live di Concerto per catturare una versione unica e irripetibile».
 Dino Betti Van Der Noot – “Let Us Recount Our Dreams” – Audissea
Dino Betti Van Der Noot – “Let Us Recount Our Dreams” – Audissea
Mi onoro di conoscere Dino Betti oramai da qualche decennio ma posso tranquillamente affermare che ben difficilmente ho visto un jazzista conservare un entusiasmo, una lucidità, una positività che sempre riscontro quando parlo con lui. E queste qualità si ritrovano puntualmente negli album che, in questi ultimi tempi Dino licenzia producendo sempre musica di altissima qualità. Ovviamente a questa regola non fa eccezione “Let Us Recount Our Dreams” (“Raccontiamoci i nostri sogni”) chiaramente ispirato da una delle più belle e suggestive pagine di William Shakespeare. A parte l’originalità delle composizioni, è straordinario il modo in cui Betti gioca con le note: lui le fa ruotare, rimbalzare, rincorrere a formare un caleidoscopio che poi, fatalmente va a sfociare in un disegno unitario che evidentemente è lì, nella mente del leader. Ovviamente per raggiungere risultati del genere, è indispensabile poter contare su musicisti che ben conoscono il modo di operare del compositore: non è quindi un caso che anche questa volta Dino Betti Van Der Noot abbia chiamato accanto a sé i ventidue musicisti con i quali ha lavorato negli ultimi anni, in particolare nel precedente “The Silence of the Broken Lute”, con l’aggiunta del trombettista Tiziano Codoro, mentre a scrivere le lunghe note di copertina è stato incaricato il critico statunitense Thomas Conrad le cui considerazioni sono, a mio avviso, condivisibili dalla prima all’ultima riga. Venendo alle nostre personalissime considerazioni, anche in questo album abbiamo ritrovato quelle caratteristiche elencate in apertura con una attenzione maggiore verso certi suoni orientaleggianti che amplificano lo spettro sonoro di cui si serve Dino. Non a caso si è servito di strumenti quali l’arpa, il dizi e il flauto cinese poco usuali nelle orchestre jazz. A Conferma della sua straordinaria conoscenza dell’universo musicale nel suo insieme, non mancano accenni al progressive, accenni sempre misurati e comunque assolutamente pertinenti. Tutto Ciò, agendo allo stesso tempo con l’incrociare delle linee melodiche, con il flusso dinamico che varia in modo straordinario, con il variare delle atmosfere proposte fa sì che l’album mai perda una sola oncia di omogeneità. Insomma un gran bell’album che vale la pena ascoltare più di una volta per capirne ogni più remota sfumatura.
 Maria Pia De Vito – “This Woman’s Work” – PMR
Maria Pia De Vito – “This Woman’s Work” – PMR
Se ci dichiarassimo stupiti dall’ascolto di questo nuovo album di Maria Pia De Vito non saremmo sinceri fino in fondo: in effetti seguiamo la straordinaria carriera della vocalist napoletana da tanti anni e l’abbiamo sempre ammirata per quel suo mai adagiarsi sugli allori di un successo più che meritato, ma continuare a ricercare, ad andare avanti ad esplorare nuovi terreni. Questa volta l’obiettivo è veramente importante e per chi scrive è un piacere sottolinearlo dal momento che proprio a questo argomento ha dedicato un libro: riflessione sulla condizione femminile e su quali strategie sono state attuate dalle donne per resistere in questi lunghi lassi di tempo. Per farlo la De Vito si è avvalsa innanzitutto di un nuovo gruppo senza pianoforte composto da Mirco Rubegni tromba, Giacomo Ancillotto chitarre ed electronics, Matteo Bortone basso ed electroncis, Evita Polidoro batteria. I pezzi in repertorio provengono dal jazz di Tony Williams, Ornette Coleman, dal cantautorato di Elvis Costello e Kate Bush, fino a elementi del folk cui si aggiungono tre pezzi composti a quattro mani dalla leader con Matteo Bortone. L’ispirazione, per esplicita ammissione della stessa De Vito, proviene dalle opere di autrici quali Virginia Woolf, Rebecca Solnit, Margaret Atwood. Il risultato? Assolutamente convincente. La De Vito è del tutto credibile quando affronta la questione femminile anche perché, come si accennava in apertura, ha speso tutta la vita al servizio della musica senza cedere a compromessi e andando sempre dritto per la sua strada. Prescindendo dalle più che lodevoli intenzioni della leader, l’album si segnala per la sua intrinseca valenza artistica: i brani sono tutti significativi, interpretati ora con vigore ora con dolcezza dalla De Vito la cui voce sembra più chiara rispetto ad altre occasioni. More solito la De Vito improvvisa con disinvoltura chiamando in causa la sua profonda conoscenza della musica non solo jazz, ma anche rock, folk e classica. Ovviamente per affrontare una tematica così complessa non solo dal punto di vista musicale, la De Vito si è affidata ad un gruppo di musicisti non solo collaudati ma anche sulla rampa di lancio come la bravissima batterista Evita Polidoro. Al riguardo occorre sottolineare come la scelta si stata più che felice dal momento che il gruppo ha funzionato semplicemente alla perfezione.
 Claudio Fasoli NeXt 4et – “Ambush” – abeat–
Claudio Fasoli NeXt 4et – “Ambush” – abeat–
Conosco Fasoli oramai da parecchi anni e quindi posso affermare, senza tema di smentite, che Claudio è uomo intelligente, spiritoso, cordiale e originale. Queste doti il sassofonista le trasporta nella sua musica che di conseguenza risulta sempre straordinariamente nuova, affascinante, coinvolgente. Ascoltando uno dopo l’altro i vari suoi dischi si rimane davvero stupefatti di come l’artista abbia saputo trovare una chiave sempre nuova per le sue composizioni. Così anche questo “Ambush” presenta una sua spiccata originalità che lo distingue nettamente dai precedenti album, originalità che può farsi risalire ad un uso più spregiudicato e intenso dell’elettronica che trova nella chitarra di Simone Massaron un interprete fondamentale. Le note sembrano quasi rimbalzare da un lato all’altro del pentagramma senza soluzione di continuità con il leader che guida il gruppo con mano ferma anche se le parti improvvisate paiono davvero tante. Il tutto senza che mai il discorso narrativo perda la sua logica: Fasoli è sempre perfettamente a suo agio qualunque strumento imbracci ( sax tenore o sax soprano) e qualunque ruolo rivesta in quello specifico momento. E al riguardo non si può non rilevare la grandezza di Fasoli come compositore, un musicista che conosce benissimo il linguaggio musicale anche al di là del jazz, che sa perfettamente da dove partire e dove arrivare e che soprattutto riesce sempre ad esprimere i propri sentimenti all’interno di una scrittura che sa valutare assai bene anche il valore del silenzio, l’importanza del respiro nella musica, nell’universo sonoro. Non a caso Nat Hentoff ha scritto di lui “che non lo si può confondere con nessun’altro”. Molto ben studiato anche il repertorio in cui a brani veloci si alternano atmosfere più riflessive e intimistiche. Che portano l’ascoltatore a chiedersi con curiosità ‘cosa ascolterò adesso?’. Come ci piace sottolineare sempre in occasioni del genere, quando un album riesce così bene certo il merito va alle composizioni, al leader…ma anche al resto del gruppo che per l’occasione è costituito dal già citato Simone Massaron chitarra elettrica, Tito Mangialajo Rantzer contrabbasso e Stefano Grasso percussioni.
 Nicola Mingo – “My Sixties in Jazz” – Alfa Music
Nicola Mingo – “My Sixties in Jazz” – Alfa Music
Come si è forse già capito dalle mie note, i jazzisti italiani che hanno più di 50 anni praticamente li conosco tutti…o quasi. Ma coloro i quali posso definire “amici” sono ovviamente pochi, molto pochi. Ecco, Nicola Mingo è uno di questi anni. L’ho conosco da tempo e tra di noi si è instaurato un bellissimo rapporto fatto di reciproca stima ed amicizia. Stima ed amicizia che però non mi impediscono di valutare con tutta l’oggettività di cui sono capace le sue ‘imprese’ musicali. E proprio partendo da tale presupposto non ho alcun timore di essere smentito affermando che quest’ultima produzione del chitarrista napoletano è fra le cose migliori da lui incise nel corso degli anni. Nicola è uno dei musicisti più coerenti che abbia conosciuto: lui è u amante del bop e a questo linguaggio rimane fortemente ancorato nonostante i boppers in esercizio permanente effettivo siano rimasti veramente pochi ed è questa una considerazione imprescindibile nel valutare l’album. Lo stesso si pone, infatti, come un esplicito omaggio da un canto ai 60 anni di jazz di Mingo in senso autobiografico e, dall’altro esplicita il chitarrista “a quegli anni Sessanta che hanno prodotto fenomeni musicali come l’hard bop, Art Blakey and Jazz Messengers e tutte le derivazioni chitarristiche come Grant Green, Wes Montgomery, Kenny Burrell, Barney Kessel, Tal Farlow, Joe Pass, Pat Martino, George Benson, miei punti di riferimento stilistici”. M per essere ancora più chiari Mingo aggiunge che “questo progetto rappresenta un contributo personale, moderno ed innovativo al linguaggio del bebop e al suo fraseggio, nato con Charlie Parker e Dizzie Gillespie e ulteriormente sviluppatosi in una continua evoluzione fino ad approdare alla nostra contemporaneità”. Obiettivo centrato? A mio avviso assolutamente sì. La modernità di Mingo nell’approcciare uno dei linguaggi più complessi del jazz è sotto gli occhi (o meglio le orecchie) di tutti e può rappresentare, soprattutto per i più giovani, un momento di attenta rilettura di uno dei periodi più gloriosi nella storia del jazz, un momento che, specie negli ultimi anni, non tutti hanno saputo interpretare, nel modo più giusto facendolo apparire vecchio e superato. Ottimo, è anche questo è un grande pregio, il rivolgersi a compagni di viaggio che hanno saputo ben interpretare gli intendimenti del leader: Francesco Marziani piano, Pietro Ciancaglini contrabbasso e Pietro Iodice batteria sono risultati perfetti, assolutamente inseriti nel progetto studiato da Mingo.
 Modern Art Trio – “Modern Art Trio” – Gleam Records
Modern Art Trio – “Modern Art Trio” – Gleam Records
Franco D’Andrea pianoforte, piano elettrico e sax soprano, Franco Tonani batteria e tromba, Bruno Tommaso contrabbasso sono gli artefici di una registrazione che è rimasta iconica, una registrazione che ha spinto la Gleam Records a ristampare per la quarta volta il disco in oggetto. Questa ulteriore ripresentazione dell’album è il frutto di una importante opera di restauro audio voluta dal produttore Angelo Mastronardi e realizzata grazie al fortuito ritrovamento del nastro originale da parte dell’editore Luca Sciascia e accuratamente restaurato e masterizzato dal fonico Jeremy Loucas negli Stati Uniti. L’album è disponibile in edizione limitata su Vinile 180 gr. (bauletto con inedito booklet) e su CD (formato gatefold con booklet arricchito), dal 10 novembre 2023 e distribuito da IRD International Distribution. Ciò detto vediamo più da vicino i contenuti musicali (e non solo) di questo “Modern Art Trio”. Siamo nell’aprile del 1970 a Roma e già da qualche anno (per la precisione dal 1967) è attivo il Il Modern Art Trio che rimarrà in attività fino al 1972. La prima formazione vedeva al contrabbasso Marcello Melis che lascerà il posto l’anno successivo a Giovanni Tommaso, il quale a sua volta nel 1969 sarà sostituito da Bruno Tommaso. Il primo e unico disco del trio riporta sulla copertina la sigla “Progressive Jazz”, un chiaro riferimento alla musica suonata. L’album fece scalpore in quanto si trattava di un primo tentativo di mettere ordine in un linguaggio che di ordine non voleva sentir parlare come ricorderanno chi quegli anni ha vissuto in prima persona. E che il tentativo fosse già di per sé piuttosto ambizioso se non addirittura velleitario lo evidenzia lo stesso D’Andrea quando nel libro dedicato a Gato Barbieri da Andrea Polinelli afferma: Quando con Gato facemmo ‘Ultimo tango’ io venivo fuori da questa cosa terribile che era il MAT nel quale come linguaggio musicale stavo completamente da un’altra parte”. Comunque a parte le sensazioni che i componenti il trio possono esprimere oggi, resta il fatto che il disco rappresentò una grossa novità specie per il panorama italico dal momento che in ogni modo rappresenta una sorta di dichiarazioni di intenti, un documento in cui Tonani e compagni illustrano le ricerche che in quel momento stavano portando avanti, ricerche che come dimostrerà un attento ascolto del disco, avevano, hanno e avranno un loro perché.
 Roberto Ottaviano – “A che punto è la notte”, “Astrolabio mistico” – Dodicilune
Roberto Ottaviano – “A che punto è la notte”, “Astrolabio mistico” – Dodicilune
Credo di aver speso tutte le aggettivazioni possibili parlando di Roberto Ottaviano che considero in assoluto uno degli artisti più innovativi, immaginifici, tecnicamente superlativi, coerenti con alcuni inderogabili principi di fondo quale in primo luogo l’onestà intellettuale, che calchino le scene del jazz internazionale. E ciò che si abbia riguardo sia ai concerti sia alle registrazioni. A quest’ultimo riguardo due sono le perle che il sassofonista barese Roberto Ottaviano ha deciso di regalarci nel corso di questo 2023 che ci sta salutando: la prima – “Roberto Ottaviano & Pinturas – A che punto è la notte” – è un progetto interamente pugliese in cui il gruppo guidato da Ottaviano è completato dalla chitarra di Nando di Modugno, dal contrabbasso di Giorgio Vendola e dalla batteria e dalle percussioni di Pippo D’Ambrosio. Il progetto è dedicato alla memoria del chitarrista pugliese Rino Arbore prematuramente scomparso nel 2021. Per chi ama leggere “A che puto è la notte” avrà sicuramente richiamato il titolo di un racconto di Fruttero e Lucentini ma Ottaviano spiega chiaramente che la frase è stata usata strumentalmente solo perché “può racchiudere in sé molte altre atmosfere e richiami, come quelli contenuti in diversa letteratura”. Ciò premesso, l’album si snoda minuto dopo minuto, attimo dopo attiamo, scoprendo di volta in volta le sue innumerevoli sfaccettature. Ecco quindi trapelare nelle composizioni originali il profondo radicamento dei musicisti nella realtà mediterranea bilanciato in qualche modo dai due brani che aprono e chiudono il disco, di “O Silencio das Estrellas” della cantante e compositrice brasiliana Fatima Guedes e “Avalanche”, del cantautore canadese Leonard Cohen. Ma a parte queste citazioni quel che colpisce è soprattutto l’empatia che si avverte tra i musicisti e la loro capacità improvvisativa che emerge magari laddove non te l’aspetti.
Il secondo volume in realtà è a firma doppia – “Michel Godard, Roberto Ottaviano – Astrolabio mistico – Dodicilune” e racconta la vita di Bianca Lancia, «l’unica donna che l’imperatore Federico II di Svevia abbia mai amato». Per questa non facile impresa l’ 11 e 12 settembre scorsi al Castello Normanno-Svevo di Gioia del Colle (Ba), si sono dati appuntamento il serpentone e il basso elettrico di Michel Godard, il sax soprano di Roberto Ottaviano, il canto di Ninfa Giannuzzi, la tiorba di Luca Tarantino, i testi e la voce recitante di Anita Piscazzi. In programma quattordici brani originali scritti dai musicisti, con testi di Anita Piscazzi e arrangiamenti di Michel Godard e Luca Tarantino. In perfetta coerenza con la storia raccontata, l’album è pervaso da una a volte struggente malinconia come nel bellissimo brano d’apertura firmato da Roberto Ottaviano. E questo tono soffuso, raccolto si avverte per tutta la durata dell’album che acquisisce così una propria personalità ben distinta dal clamore della sperimentazione ad ogni costo o dalla riproposizione sic et simpliciter di modelli usati e abusati. Insomma una originalità di esposizione che caratterizza non già da oggi le produzioni dei due leader; ad ulteriore conferma si ascolti il terzo brano, “Light the Earth”, per l’appunto scritto da Godard.
Gerlando Gatto
da Gerlando Gatto | 25/Nov/2023 | News, Primo piano
È proprio vero che programmare è una cosa, attuare è un’altra. Quest’anno mi ero ripromesso di vedere cinque concerti del recente Roma Jazz Festival che mi era parso ben strutturato e con proposte nuove e interessanti.
Purtroppo non è andata come volevo e sono stato costretto ad assistere solo a tre concerti perdendomi quelli del pianista sudafricano Nduduzo Makhathini (il 9 novembre) e del gruppo Yellowjackets (11 novembre) che seguo da tempo immemore.
Dell’anteprima di Ibrahim Maalouf il 12 ottobre “A proposito di jazz” ha già riferito; oggi vi do conto degli altri due concerti cui ho assistito: Judith Hill il 4 novembre, Vincent Peirani Trio il 5 novembre.
Preceduta da una fama non immeritata, Judith Hill si è esibita alla Sala Petrassi dell’Auditorium dinnanzi ad un pubblico entusiasta e assai numeroso. Veramente particolare la formazione dal momento che la vocalist afro-americana aveva accanto a sé la madre Michiko alle tastiere e all’organo e il padre Robert (alias Pee Wee) al basso elettrico; alla batteria l’unico “estraneo”, il vulcanico John Staten.
Nata a Los Angeles, Judith viene, quindi, da una famiglia di origini nipponico/afroamericane che può a ben ragione definirsi “musicale”, nell’accezione più completa del termine. Ha dedicato tutta la sua vita alla musica tanto da essere attualmente, oltre che un’ottima vocalist, anche un’eccellente pianista e chitarrista. Dopo aver sviluppato le sue attitudini lavorando come cronista a fianco di vere e proprie icone della musica quali Michael Jackson, Stevie Wonder e Prince ha intrapreso una strada da solista che le sta assicurando grande successo presso le platee di tutto il mondo. In effetti le performance della Hill, stando a quanto s’è visto e ascoltato a Roma, sono davvero trascinanti. La sua voce calda, la sua intonazione, il preciso senso del ritmo le consentono, infatti, di transitare con estrema disinvoltura dal soul al R&B, dal funk al blues il tutto in un’atmosfera sempre “assai calda” che vede il continuo coinvolgimento del pubblico.
Efficace in tutte le interpretazioni personalmente l’ho particolarmente apprezzata in “Angel in the Dark” una composizione di Prince, “Better Days” e “Beautiful Life” scritte dalla stessa Hill mentre tra i brani più scatenati, particolarmente coinvolgente “That Power”
-

-
Judith Hill
-

-
Vincent Peirani
Di natura completamente diversa il concerto del fisarmonicista francese Vincent Peirani in trio con il chitarrista italiano ma oggi stabilmente a Parigi Federico Casagrande, e il batterista di origine israeliana Ziv Ravitz, oggi cittadino di New York. Ho seguito la carriera di Peirani da quando nel 2009 si affacciò sul mondo del jazz con un album particolarmente originale e promettente. Promesse mantenute negli anni successivi che hanno consacrato Peirani come uno dei migliori fisarmonicisti al mondo. Ma, se devo dire la verità, quest’ultima strada intrapresa da Vincent, così come evidenziato dal concerto romano, non mi convince più di tanto. Certo la maestria dell’artista è sempre là, così come la sua classe nell’arrangiare i pezzi, e la sua profonda conoscenza dell’universo jazzistico. Ma questo immergersi in atmosfere molto slargate (un po’ alla nordica, tanto per intenderci) i continui riferimenti alla musica “moderna” , la prevalenza della struttura sull’improvvisazione, e soprattutto il continuo ripetere di brevi segmenti melodici hanno fatto perdere un po’ di mordente alla sua musica.
Nel repertorio del concerto romano figurano alcuni brani presenti nell’ultimo album “Jokers” pubblicato nel 2022 con la stessa formazione presentata nella Capitale: tra questi “River” tratta da ‘Church of Scars’ (2018) della cantante Bishop Briggs, in cui il canto viene sostituito dalla fisarmonica; particolarmente interessante “Salsa Fake” il cui titolo è tutto un programma: in effetti il brano inizia con un assolo di chitarra che ci porta in atmosfere latine assecondato dalle note suadenti e melanconiche della fisarmonica, ma ben presto le cose cambiano: intervengono batteria e chitarra, il clima del pezzo muta completamente, adesso ci si avvicina ad una forma sofisticata di rock a segnare, a mio avviso, il punto più alto dell’intero concerto proprio perché le concezioni di Peirani riescono a elaborare una ricetta nuova e coinvolgente.
Il concerto si chiude con “Ninna nanna” eseguito come bis, sicuramente il brano più melodico dell’intera serata in cui sono evidenti i riflessi di certe melopee italiche.
Gerlando Gatto
da Gerlando Gatto | 07/Nov/2023 | Editoriali, News, Primo piano
Se n’è andato anche lui dopo una vita straordinaria, dedicata alla musica: all’età di 94 anni ci ha lasciati Dino Piana uno degli artisti che ha contribuito in primissima persona con il suo trombone a scrivere la storia del jazz italiano. Anni attraversati con straordinaria raffinatezza, leggiadria, gentilezza. In effetti si può benissimo essere grandi musicisti senza per questo essere particolarmente simpatici: bene Dino Piana ha invece rappresentato quel che nel mondo “normale” si intende “Un vero signore”.
E per un momento lasciamo da parte i suoi meriti musicali per soffermarci sul Piana uomo: l’ho conosciuto parecchi anni fa ed una volta ho avuto l’onore di ospitarlo nel salotto di casa mia, assieme al figlio Franco, per una interessante chiacchierata sullo stato di salute del jazz italiano. L’ho sempre trovato, oltre che di una innata ed invidiabile eleganza, sempre disponibile, cortese, con il sorriso sulle labbra, bendisposto verso tutti… e soprattutto contento della vita di musicista. Talmente contento che queste qualità le ha trasmesse al figlio Franco, anch’egli persona e musicista di assoluto livello, al quale vanno le più sentite condoglianze mie personali e di tutta la redazione di “A proposito di jazz”… senza dimenticare la compagna di una vita che l’ha sempre sostenuto in questa innata passione.
Passione che si può ben riassumere in una frase che Dino pronunciò nel corso di un’intervista rilasciataci nel 2010: «Ti posso dire che io vivo la performance sempre allo stesso modo, e cioè, quando io vado a fare un concerto sono in uno stato… di follia. È una follia, una gioia, che diventano quasi un… un malessere, ecco». E per quei quattro o cinque che non conoscono Dino Piana, cerchiamo di riassumere in poche righe una carriera di oltre sessant’anni… Dino inizia il suo cammino nel 1959 quando si presenta al concorso radiofonico “La coppa del Jazz”, mettendosi immediatamente in luce come solista. Quindi entra nel quintetto Basso-Valdambrini e nelle orchestre radiofoniche e televisive, continuando l’attività jazzistica. Nella sua lunga carriera prende parte a numerosi festival nazionali ed internazionali fra cui: Comblain-la-Tour, Lugano, Berlino, Lubiana, Nizza… nonché a numerosi concerti per la RTF a Parigi, per la RTB a Bruxelles, per l’UER di Stoccolma, Oslo, Barcellona, Londra, Copenaghen. Ovviamente, sono innumerevoli le collaborazioni con straordinari musicisti quali, tanto per fare qualche nome, Chet Baker, Frank Rosolino, Slide Hampton, Kenny Klarke, Charles Mingus, Pedro Iturralde, Paco de Lucia, George Coleman, Kay Winding, con il quale ha inciso il disco “Duo Bones”. Suona nelle Big Band di Thad Jones, Mel Lewis, Bob Brookmeyer. Il 12 maggio 1993 si esibisce in una reunion del sestetto “Basso-Valdambrini” alla Town Hall di New York.
Parallelamente, molti sono i dischi in cui è possibile ascoltarlo, sia come leader sia come side man; tra gli ultimi: “Reflections” a nome Dino & Franco Piana Ensemble e soprattutto “Al gir dal bughi” (il giro del Boogie) registrato nel 2019.
Ciao Dino chissà quante belle orchestre troverai lassù.
Gerlando Gatto
 Domenica pomeriggio alla Casa del Jazz, in programma il piano-solo del siracusano Francesco Branciamore. L’artista si è affermato nel panorama internazionale come batterista di straordinario talento, collaborando con alcuni dei più bei nomi del jazz italiano e internazionale quali Lee Konitz, Evan Parker, Barre Philips, Ray Mantilla, Keith Tippet, Pier Favre, Paul Rutherford, Michel Godard, Enrico Rava, Gianluigi Trovesi, Enrico Intra, Eugenio Colombo, Paolo Fresu. Negli ultimissimi anni ha deciso di cambiare strada e misurarsi con il pianoforte, strumento certo non facile da affrontare. Dopo un periodo di studi ecco i risultati: due album, in ordine cronologico «Aspiciens Pulchritudinem» del 2018 e «Skies of Sea» del 2021. Ed è proprio da queste due produzioni che Branciamore ha tratto la maggior parte dei brani presentati a Roma.
Domenica pomeriggio alla Casa del Jazz, in programma il piano-solo del siracusano Francesco Branciamore. L’artista si è affermato nel panorama internazionale come batterista di straordinario talento, collaborando con alcuni dei più bei nomi del jazz italiano e internazionale quali Lee Konitz, Evan Parker, Barre Philips, Ray Mantilla, Keith Tippet, Pier Favre, Paul Rutherford, Michel Godard, Enrico Rava, Gianluigi Trovesi, Enrico Intra, Eugenio Colombo, Paolo Fresu. Negli ultimissimi anni ha deciso di cambiare strada e misurarsi con il pianoforte, strumento certo non facile da affrontare. Dopo un periodo di studi ecco i risultati: due album, in ordine cronologico «Aspiciens Pulchritudinem» del 2018 e «Skies of Sea» del 2021. Ed è proprio da queste due produzioni che Branciamore ha tratto la maggior parte dei brani presentati a Roma. Ed eccoci lunedì sera all’Auditorium Parco della Musica, Teatro Studio, per il doppio concerto del quintetto di Danilo Blaiotta e del gruppo Moonari.
Ed eccoci lunedì sera all’Auditorium Parco della Musica, Teatro Studio, per il doppio concerto del quintetto di Danilo Blaiotta e del gruppo Moonari. Domenica 13 eccoci nuovamente alla Casa del Jazz per ascoltare la vocalist Sonia Spinello in trio con Eugenia Canale al pianoforte e Achille Succi al sax alto, clarinetto e clarinetto basso.
Domenica 13 eccoci nuovamente alla Casa del Jazz per ascoltare la vocalist Sonia Spinello in trio con Eugenia Canale al pianoforte e Achille Succi al sax alto, clarinetto e clarinetto basso.




 Comunque non possiamo concludere questa “lettera aperta” senza citare il caso scandaloso di John Travolta: ma si può invitare un’icona del cinema mondiale per fargli fare quella figura di merda? Io credo di no; di qui un altro piccolo suggerimento: il Festival si doti di qualcuno che sappia scrivere i testi del programma altrimenti si andrà sempre peggio. E il fatto che gli italiani si ostinino a guadare il Festival, non significa che lo stesso risulti un prodotto di qualità quale invece dovrebbe essere e a tutt’oggi non è. (G.G.)
Comunque non possiamo concludere questa “lettera aperta” senza citare il caso scandaloso di John Travolta: ma si può invitare un’icona del cinema mondiale per fargli fare quella figura di merda? Io credo di no; di qui un altro piccolo suggerimento: il Festival si doti di qualcuno che sappia scrivere i testi del programma altrimenti si andrà sempre peggio. E il fatto che gli italiani si ostinino a guadare il Festival, non significa che lo stesso risulti un prodotto di qualità quale invece dovrebbe essere e a tutt’oggi non è. (G.G.) Heinz Holliger, Anton Kernjak – “Eventail” – ECM New Series
Heinz Holliger, Anton Kernjak – “Eventail” – ECM New Series Veljo Tormis – “Reminiscentiae” – ECM New Series
Veljo Tormis – “Reminiscentiae” – ECM New Series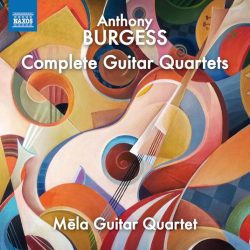 Anthony Burgess – “Complete Guitar Quartets” – Naxos
Anthony Burgess – “Complete Guitar Quartets” – Naxos Wolfgang Muthspiel – “Dance of the Elders” – ECM
Wolfgang Muthspiel – “Dance of the Elders” – ECM Maciej Obara Quartet – “Frozen Silence” – ECM
Maciej Obara Quartet – “Frozen Silence” – ECM Sinikka Langeland – “Wind And Sun” – ECM
Sinikka Langeland – “Wind And Sun” – ECM Sara Calvanelli, Virginia Sutera – “Ejadira” – Losen
Sara Calvanelli, Virginia Sutera – “Ejadira” – Losen Sudeshna Bhattacharya & Somnath Roy –“Mousson de Calcutta” – Losen
Sudeshna Bhattacharya & Somnath Roy –“Mousson de Calcutta” – Losen  Nella categoria Jazz i primi due lavori pubblicato sono stati “Multiverse” solo in versione digitale e quindi “Heros” di Filippo Cosentino. In quest’ultimo album la formazione è il trio in cui il leader, chitarrista, è accompagnato dal formidabile pianista Marc Copland, per moltissimi anni componente della formazione di John Abercrombie, e Daniele Bertone alla batteria e percussioni. In programma sette composizioni del leader in cui si evidenzia da un lato le capacità strumentali di tutti e tre i musicisti, dall’altro le ottime capacità compositive di Cosentino che di certo non scopriamo oggi. Le atmosfere predilette sono un mix di jazz, folk e country anche se qua e là riemerge l‘anima mediterranea del leader.
Nella categoria Jazz i primi due lavori pubblicato sono stati “Multiverse” solo in versione digitale e quindi “Heros” di Filippo Cosentino. In quest’ultimo album la formazione è il trio in cui il leader, chitarrista, è accompagnato dal formidabile pianista Marc Copland, per moltissimi anni componente della formazione di John Abercrombie, e Daniele Bertone alla batteria e percussioni. In programma sette composizioni del leader in cui si evidenzia da un lato le capacità strumentali di tutti e tre i musicisti, dall’altro le ottime capacità compositive di Cosentino che di certo non scopriamo oggi. Le atmosfere predilette sono un mix di jazz, folk e country anche se qua e là riemerge l‘anima mediterranea del leader. Amato Jazz Trio – “Keep Straight On” – abeat
Amato Jazz Trio – “Keep Straight On” – abeat Claudio Angeleri – “Concerto feat. Gianluigi Trovesi” – Dodicilune
Claudio Angeleri – “Concerto feat. Gianluigi Trovesi” – Dodicilune Dino Betti Van Der Noot – “Let Us Recount Our Dreams” – Audissea
Dino Betti Van Der Noot – “Let Us Recount Our Dreams” – Audissea Maria Pia De Vito – “This Woman’s Work” – PMR
Maria Pia De Vito – “This Woman’s Work” – PMR Claudio Fasoli NeXt 4et – “Ambush” – abeat–
Claudio Fasoli NeXt 4et – “Ambush” – abeat–  Nicola Mingo – “My Sixties in Jazz” – Alfa Music
Nicola Mingo – “My Sixties in Jazz” – Alfa Music Modern Art Trio – “Modern Art Trio” – Gleam Records
Modern Art Trio – “Modern Art Trio” – Gleam Records Roberto Ottaviano – “A che punto è la notte”, “Astrolabio mistico” – Dodicilune
Roberto Ottaviano – “A che punto è la notte”, “Astrolabio mistico” – Dodicilune










