da Gerlando Gatto | 26/Ott/2022 | News, Primo piano
 La mattina, appena sveglio – maledetta abitudine – per prima cosa do uno sguardo alla rassegna stampa che mi arriva sul telefonino. E così ho fatto anche stamane; ad un certo punto, ancora non del tutto sveglio, noto la foto di un bell’uomo, giovane. Tra me e me penso: ma questo lo conosco. A poco a poco i neuroni si mettono in moto e lo riconosco, è lui, è Franco e capisco immediatamente: Franco Fayenz se ne è andato in un luogo, per chi ci crede, sicuramente migliore di questa terra.
La mattina, appena sveglio – maledetta abitudine – per prima cosa do uno sguardo alla rassegna stampa che mi arriva sul telefonino. E così ho fatto anche stamane; ad un certo punto, ancora non del tutto sveglio, noto la foto di un bell’uomo, giovane. Tra me e me penso: ma questo lo conosco. A poco a poco i neuroni si mettono in moto e lo riconosco, è lui, è Franco e capisco immediatamente: Franco Fayenz se ne è andato in un luogo, per chi ci crede, sicuramente migliore di questa terra.
La notizia è di quelle che si fatica a digerire anche se l’età di Franco (92 anni) ci aveva messo tutti in preallarme. Ma, come al solito, una cosa è immaginare altra cosa è vivere una determinata realtà.
Cercherò in questo breve ricordo di non lasciarmi andare a quell’ondata di tristezza che mi ha avvolto questa mattina anche se lo confesso non è facile. Conoscevo Franco non so bene se da 40 o 50 anni. Il nostro era un bel rapporto sempre improntato al sorriso, allo scherzo, al comune amore per il jazz.
Quando ci incontravamo o ci sentivamo per telefono lui amava prendersi gioco di me, inventando giochi di parole sui miei nome e cognome, ma lo faceva in modo così amorevole, col sorriso sulle labbra che sembrava voler dire “non badare alle mie parole, ti voglio bene” che era impossibile arrabbiarsi.
-
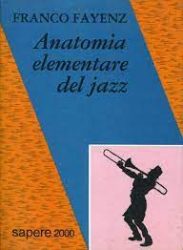
-

Ovviamente c’erano anche momenti più seri, quelli in cui si parlava di musica ed era un piacere ascoltarlo anche perché lui ti raccontava eventi, episodi vissuti in prima persona. Eventi che lo hanno visto protagonista della scena jazzistica almeno per trent’anni di fila in cui Franco si è segnalato come un grande divulgatore grazie ai suoi articoli, ai suoi libri e alle sue apparizioni in TV. Non dimentichiamo che negli anni Settanta Fayenz, assieme a Franco Cerri, collabora a “Jazz in Italia”, un programma di Carlo Bonazzi declinato attraverso una serie di interviste ai jazzisti le cui performances in giro per i jazz club della Penisola venivano mandati in onda. La sua brillante carriera è stata costellata da molti riconoscimenti che riteniamo superfluo ricordare in questa sede. Basti solo considerare il fatto che la stima da parte dei musicisti mai è venuta meno nei suoi confronti anche quando, per lunghi anni, ha lavorato per un quotidiano che mai è stato in cima alle preferenze dell’ambiente jazzistico globalmente considerato.
L’ultima volta che ci siam visti è stato nel 2015 durante il Festival Udine Jazz e non è stato un bel vedere dal momento che si vedeva come Franco, purtroppo, accusasse il peso dell’età anche se l’arguzia e la voglia di scherzare erano quelle di sempre.
-

-
Courtesy Udin&Jazz 25, 2015
ph Luca A. d’Agostino Phocus Agency
Adesso non scherza più… almeno su questa terra. Ciao Franco, vai ad ascoltare altre melodie!
Gerlando Gatto
da Gerlando Gatto | 19/Ott/2022 | Interviste, News, Primo piano
Pianista e compositore raffinato ma anche uomo di rara disponibilità e gentilezza, Phil Markowitz – classe 1952 – è a mio avviso uno dei tanti musicisti ancora sottovalutato. E dire che nella sua vita di cose ne ha fatte tante. Basti al riguardo scorrere la sua ricca discografia e lo troviamo sia alla testa di proprie indimenticabili formazioni, sia come sideman accanto ad altri veri e propri giganti del jazz quali Chet Baker, Dave Liebman e Bob Mintzer.
Di recente abbiamo ascoltato il doppio album inciso in solitaria durante un concerto all’Auditorium Parco della Musica di Roma il 9 maggio del 2006. Ne siamo rimasti particolarmente colpiti e abbiamo avuto il desiderio di intervistarlo. Ci siamo rivolti all’amico Giorgio Enea, dell’ufficio stampa dell’Auditorium, il quale ci ha fornito un contatto mail. Così ci siamo scritti e Phil ci ha risposto immediatamente. Di qui l’intervista che pubblichiamo di seguito.
-Partiamo da un doppio album registrato live a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, il 9 maggio del 2006 ma pubblicato solo poche settimane fa. Ricorda qual era il suo stato d’animo quando suonò questa splendida musica?
“Ero davvero felice di suonare in concerto da solo e ovviamente anche un po’ nervoso prima di salire sul palco, cosa assolutamente normale. Ricordo di essermi molto concentrato per questa performance, considerato che si trattava di una scaletta parecchio impegnativa, e di essere stato infine molto soddisfatto grazie alla magnifica risposta del pubblico, cosa molto incoraggiante. I tre bis, poi, sono stati semplicemente meravigliosi”.
-Nel frattempo, sono trascorsi ben 16 anni; come è cambiato Phil Markowitz in questo lasso di tempo?
“Penso che quando uno arriva ai 50 anni più o meno sa chi è, ergo ci sono stati degli sviluppi da quel giorno ma essenzialmente il mio cammino musicale ha seguito la stessa strada eclettica che ho sempre intrapreso”.
– Qual è attualmente il suo approccio verso la musica?
“Da un punto di vista compositivo il mio approccio è quello di creare strutture in ambienti molto ben definiti e di suonare creativamente e inventivamente all’interno di esse. Per quanto riguarda le performance in gruppo è ed è sempre stato lo stesso: supportare la band, essere preparati e saper giocare di squadra”.
– Adesso riandiamo indietro nel tempo: un po’ come tutti i musicisti di jazz, anche lei prima di guidare propri gruppi ha militato come sideman in formazioni guidate da altri. Quanto ciò è importante nella formazione di un musicista?
“Se sei un musicista che si occupa del ritmo, che sia il pianoforte, il basso, la batteria o altri strumenti a corda, è cruciale per il tuo sviluppo musicale. Si deve saper valutare ogni situazione musicale e ogni musicista che si accompagna; ciò affina le tue abilità musicali e devi essere un artista maturo per avere successo. Io dico sempre ai miei studenti che le abilità di accompagnatore sono la parte più importante della disciplina di ognuno: una cosa è essere un gran solista, altra cosa è saper accompagnare. È la capacità di accompagnare che ti permette di far suonare bene la musica e di farti conservare il lavoro dato che così facendo metti il tuo leader nelle condizioni migliori!”.
– C’è stato un momento nella sua vita, nel suo percorso artistico che le ha fatto capire di essere in grado di affrontare una sua personalissima carriera?
“Non sono sicuro di aver capito la domanda ma in sintesi è stato il mio amore per la musica improvvisata che suoniamo e ovviamente i numerosi e incredibili maestri che ho avuto durante il mio percorso a spingermi verso una carriera fatta di musica. Inoltre, ho capito molto presto che è assolutamente importante essere un compositore con una propria, ben specifica unicità che ti consente di creare quegli ambienti nei quali s’innesta il panorama sonoro che ti rende immediatamente riconoscibile”.
– Lei ha ottenuto, per l’appunto, una straordinaria visibilità anche come compositore quando ha suonato con Toots Thielemans a NYC. Come ricorda quel periodo?
“New York negli anni Ottanta era magnifica, c’era un sacco di lavoro. Suonavo con Chet Baker, Toots, la Mel Lewis Big Band e, poco prima, con Joe Chambers; mi guadagnavo da vivere suonando nella downtown, in concerti con diversi gruppi. In sintesi, è stato un periodo molto fertile. Ovviamente sono molto grato a Toots, con il quale ho lavorato per quattro anni e che fu anche uno dei miei primi mentori quando studiavo al College nella Eastman School of Music. C’era questa meravigliosa confluenza di circostanze: ad esempio Bill Evans veniva al nostro concerto a N.Y. e noi suonavamo “Sno’ Peas”, un pezzo che Toots eseguiva ogni sera”.
– Tra gli artisti con i quali ha suonato a lungo figurano Chet Baker e Dave Liebman, musicisti differenti quasi da ogni punto di vista. Qual è stato il suo rapporto con i due?
“Con Chet avevo un bellissimo rapporto anche se era più anziano di noi. In quel tempo – quando ero più vicino ai trenta che ai vent’anni – suonavo con la band. Lui era molto paziente con noi e dava il buon esempio a tutti. Ho certamente imparato l’arte dell’accompagnamento durante questo periodo; se qualcuno suonava un accordo sbagliato dietro a Chet rovinava le sue meravigliose e incontaminate sortite solistiche degne di Mozart. Quando mi sono trasferito a New York negli ultimi anni Settanta, conoscevo già Dave Liebman dalle sue registrazioni con Miles ed Elvin Jones e la band “Quest”, che aveva con Richie Beirach. Quando ero in città andavo quasi ad ogni concerto in cui c’erano loro; era sempre stato il sogno della mia vita suonare con Dave e nei primi anni Novanta il mio desiderio venne esaudito. Lui è sempre stato per me un assiduo e sincero maestro, mi ha sempre appoggiato ed ha avuto una grande e meravigliosamente positiva influenza nella mia vita. Penso che l’aver avuto, sin da giovanissimo, un interesse molto forte per la musica del XX secolo e per l’armonia cromatica mi abbia reso più pronto per i suoi concerti. La “Saxophone Summit” è stata senza dubbio la miglior band con cui abbia suonato e quell’esperienza ventennale rimane la più entusiasmante che abbia vissuto nel mondo del jazz. Ci sono moltissime registrazioni meravigliose con quel gruppo e aver suonato con Joe Lovano, Michael Brecker, Ravi Coltrane, Greg Osby e naturalmente Dave Liebman è stata un’esperienza formativa dal valore incommensurabile. Per non parlare di Billy Hart che è senza ombra di dubbio il miglior batterista con cui abbia avuto il piacere di suonare”.
– Lei suona da solo, in combo e in big band. In quale situazione preferisce esprimersi?
“Adoro il piano trio perché come leader ti dà la maggior flessibilità mentre plasmi la musica. Anche il duo è estremamente gratificante, sebbene sia più difficile: devi accompagnare, essere tutta la band e suonare da solo. È un ambiente meraviglioso. D’altro canto, suonare con la sezione fiati è stato molto bello; in effetti per la big band è una lunga storia ma basti sapere che se si è pianisti in quel contesto è necessario sapere tutto ciò che l’arrangiatore ha messo in ogni spartito. La mia band con il violinista Zach Brock (jazzista statunitense, classe 1974, membro degli Snarky Puppy dal 2007 n.d.a.) è stata molto gratificante; ho sempre voluto lavorare con un violinista e ho sempre creduto che piano e violino siano un perfetto abbinamento sonoro”.
– Oggi il jazz è diventato materia di insegnamento e Lei se ne occupa appieno. A suo avviso, quanto è importante per il futuro della ‘nostra’ musica questo tipo di formazione?
“L’educazione jazz è una sorta di spada a doppio taglio. Ritengo che in questo momento sia importante perché la scena è molto più ristretta adesso rispetto a quanto lo fosse negli anni ’70 e ’80. Sono grato per la mia esperienza universitaria alla Eastman School of Music, dove ho incontrato Gordon Johnson (contrabbassista e chitarrista statunitense classe 1952 n.d.a) e il batterista Ted Moore con i quali ho fondato una band chiamata “Petrus” che vinse un concorso nazionale per il miglior gruppo jazz giovane con in palio una performance al Newport Jazz Festival del 1973. Nei prossimi mesi rilasceremo finalmente le nostre registrazioni in studio, che avevo conservato nel mio armadio… suonano come se fossero di oggi. Tutto ciò non sarebbe mai successo se non ci fossimo incontrati in Conservatorio. Le connessioni che si creano in ambito musicale con le persone che incontri, gli insegnamenti che puoi ricevere da grandi musicisti che normalmente non avresti opportunità di incontrare e la musica che crei, durano per la vita. E sono cose che non si dimenticano. È chiaro che per avere una preparazione più approfondita si deve studiare in Conservatorio, e ciò prevede dei costi; certo, si possono trovare insegnanti anche tra i musicisti di strada, ma non è la stessa cosa; tuttavia, nella scena attuale ognuno deve avere la consapevolezza di ciò cui va incontro: non tutti diventano star o super star, spesso i migliori musicisti non sono i più famosi, e spesso i più famosi non sono i migliori. Io ritengo che la pedagogia, come io l’ho sviluppata nei numerosi anni in cui sono stato educatore, specie negli ultimi 20 anni nel programma di laurea e dottorato nella “Manhattan School of Music”, mi abbia aiutato a definire il mio stile. Imparare ad insegnare può agevolare notevolmente il proprio sviluppo”.
– C’è qualche musicista che ritiene particolarmente importante per la Sua di formazione?
“Tutta la gente che ho menzionato in precedenza è molto importante: Chet Baker, Dave Liebman e posso aggiungere Bob Mintzer e Maurizio Giammarco in Italia. Queste sono le persone principali con cui ho avuto lunghe collaborazioni. Ma ovviamente ce ne sono state tante altre lungo il cammino dalle quali, ogni qualvolta si suoni assieme, si impara qualcosa”.
– Quando pensa di tornare in Italia?
“Si spera il prima possibile: È il mio posto preferito dove suonare”.
E noi ce lo auguriamo di tutto cuore; a presto Phil…
Gerlando Gatto
da Gerlando Gatto | 07/Set/2022 | Interviste, News, Primo piano
Vocalist di grande spessore, Cristina Zavalloni è una delle poche artiste italiane ad aver frequentato con successo e competenza ambedue gli ambiti del jazz e della musica colta. Percorrere le tape della sua lunga e luminosa carriera in questa sede sarebbe assolutamente inutile. Basta, forse, sottolineare come da 1982 ad oggi abbia registrato a suo nome una quindicina di album, l’ultimo dedicato alle musiche di Nino Rota che abbiamo recensito in questi stessi spazi. Ed è proprio da “Parlami di me” le canzoni di Nino Rota, che prende il via questa nostra intervista realizzata a Roma di recente.
– Come è nata l’idea di questo disco?
“L’idea è stata di Tonino Miscenà, patron dell’Egea, etichetta con cui avevo già collaborato in passato lungamente per tre o quattro dischi; successivamente c’è stata una pausa nell’attività dell’etichetta in quanto Miscenà ha fatto un’esperienza di lavoro diversa in Colombia e poi ha avuto il desiderio di ripartire con la musica, con produzioni un po’ ragionate, pensate. E tra queste rientra proprio questo album di cui stiamo parlando. E’ stato lui a propormi di incidere un disco con le musiche di Nino Rota ben sapendo che non avrei detto immediatamente di sì”.
– Per quale motivo?
“Perché dovevo prima studiare bene la situazione, capire di cosa si stava parlando, innamorarmi del progetto come faccio sempre quando la proposta arriva dall’esterno. E quindi aderire se la cosa mi convinceva completamente. Ci son voluti vari mesi ma non perché la musica non fosse bellissima ma perché si trattava di capire quale potesse essere la mia versione dei fatti. Poi ad un certo punto ho immaginato questo filo rosso cui accenno sempre quando parlo di questo lavoro”.
-

-
Cristina Zavalloni
foto Marcella Fierro©
-

-
Cristina Zavalloni
foto Marcella Fierro©
-

-
Cristina Zavalloni
foto Marcella Fierro©
– Vale a dire?
“Intendo riferirmi alle carrellate femminili, ai ruoli di personaggi femminili un po’ evinte dai film da cui sono tratte le canzoni che hanno dei testi aggiunti a posteriori. Proprio oggi ascoltavo un poadcast su Pasolini: fa parte di quella tendenza che si era affermata subito dopo la guerra di vedere se dei grandi intellettuali, dei letterati, dei poeti potessero mettere dei versi a delle canzoni che erano parte dell’immaginario di tutti e che quindi erano popolari; in questo senso è stata una sfida, io credo, riuscitissima in quegli anni. Tornando a noi, quando mi sono immaginata questa carrellata di personaggi femminili mi è scattata una scintilla sul percorso da fare all’interno di queste canzoni, come poter entrare, in altre parole come se fossi un personaggio all’interno di un’opera”.
– Partendo da ciò che mi hai appena detto, la scelta dei pezzi e dei musicisti è stata fatta assieme con Miscenà?
“Tutto è stato fatto di comune accordo ma lui ha sempre lasciato che la proposta venisse da me. Questo lavoro io l’ho fatto a quattro mani con Cristiano Arcelli che è l’arrangiatore ed anche il mio compagno nella vita. Insomma abbiamo deciso tutto assieme. Particolarmente importante la scelta dell’ensemble: io ci tenevo molto ad evitare quella direzione bandistica che spesso è associata alla musica di Rota perché mi sembra che questo coté sia già stato molto esplorato. Mi sembrava più importante dare maggiore spazio alla dimensione di compositore colto di Rota che pure si coglie nella sue canzoni. Di qui la scelta di un gruppo classico, il ClaraEnsemble, fondato nel 2019 e con cui ho sempre lavorato da allora, abbinato a dei musicisti di jazz, anche loro compagni di viaggio oramai da lunga pezza. Ecco quindi al clarinetto Gabriele Mirabassi, al sassofono soprano Cristiano Arcelli, al trombone Massimo Morganti, al pianoforte, Manuel Magrini e al contrabbasso Stefano Senni. Devo comunque confessarti che la prima scintilla per la scelta dell’organico è scaturita da una versione di Caetano Veloso di “Parlami di me” o di “Come tu mi vuoi” tradotta in portoghese…lì c’è come al solito Jaques Morelenbaum al violoncello ma ci sono anche gli archi. Ho mandato il file a Miscenà e lui aveva paura che il disco diventasse troppo colto…ma alla fine ho avuto ragione io”.
– Tu hai fatto poco fa dei riferimenti al jazz. Ma come si fa a definire oggi se un disco è jazz oppure no? Francamente io non ci riesco.
“Neppure io, se è per questo. Per quanto concerne il disco di cui stiamo parlando era importante che ci fosse anche dell’improvvisazione…che non fosse tutta musica scritta. Ad esempio il pianoforte non ha tutta la parte scritta”.
– Ma il vocale non mi sembra improvvisato
“In effetti non lo è. Io non improvviso mai; anche quado insegno improvvisazione vocale, io mai improvviso in quanto non ho quell’amore, non mi riconosco in quella pratica… poi in realtà improvviso ma lo faccio sulla modifica di una cellula melodica oppure improvviso con le parole, sul testo, aprire degli spazi improvvisi. Ciò perché io vengo da quelle esperienze: i collettivi di improvvisazione radicale e nel frattempo studiavo musica classica”.
– C’è in tal senso una cantante che per te possa costituire un punto di riferimento?
“Ce ne sono tante così come tanti sono gli album. Ce n’è uno in cui Bill Evans suona con una cantante svedese, Monica Zetterlund, e il disco è semplicemente meraviglioso in quanto lei canta con una semplicità ed una naturalezza semplicemente straordinarie (“Waltz for Debby” del 1964 con Monica Zetterlund n.d.r. ). Poi quando senti Cécile McLorin Salvant che improvvisa, è bellissimo ma è il suo linguaggio, la sua storia…non la mia”.
– Oggi cosa rappresenta la musica per te?
“Questa è una domanda tutt’altro che banale. Ho dato per scontato che fosse la mia ragione di vita per un lungo lasso di tempo poi, quando sono diventata mamma, molto tardi, questa mia percezione è un po’ cambiata. Negli ultimi anni, per effetto anche delle circostanze esterne, ci siam dovuti fermare e allora mi sono interrogata: innanzitutto volevo continuare a fare musica così come avevo fatto in passato?…domanda cui non ho dato una risposta. Comunque a conti fatti penso che la musica ancora oggi sia il mio destino: io vengo da una famiglia di musicisti, mio padre era un musicista e c’erano molte aspettative sul fatto che io facessi la musicista…in realtà mi sento di non avere scelta. La fortuna è però che tutto questo, fare musica, mi piace da impazzire, quindi è un destino che accolgo alle volte in modo un po’ conflittuale ma più in generale con grande gioia, perché questa è la mia vita. Quando si comincia a suonare tutto scompare e resta questo grande, immenso piacere di fare musica, di fare ciò che mi piace”.
– E L’attività didattica…?
“No, non è un ripiego se è questo che volevi chiedermi. Ho la fortuna di vivere di musica e come ti dicevo vengo da una famiglia in cui la musica era di casa. Mio padre ha costruito una sorte di ricchezza con la musica per cui io mai sono partita da una situazione di bisogno che mi spingesse a fare qualcosa a scapito di qualcos’altro. Così io non ho mai insegnato in Conservatorio, non ho fatto graduatorie per insegnare. Ad un certo punto è arrivato questo invito dal St. Louis di Roma quando mia figlia aveva due, tre anni ed ero quindi entrata nella modalità di occuparmi anche degli altri. Da questo dare è fiorito l’amore per l’insegnamento che rimane però altalenante: ci sono periodi in cui, se ho molte cose da fare, parecchi progetti da portare avanti anche nel campo della musica classica per cui ho bisogno di studiare molto, le energie per l’insegnamento vengono un po’ meno. Intendiamoci: io do sempre il massimo, ma di quello che posso e io stessa mi rendo conto che in alcuni casi non è abbastanza”.
– Tocchiamo un altro tasto particolarmente delicato: qual è oggi il tuo rapporto con la critica o se preferisci con i critici musicali?
“Mi ha sempre fatto molta tenerezza l’affermazione di alcuni miei colleghi che mi dicevano ‘ma lascia perdere i critici tanto le recensioni non le fa più nessuno, nessuno ti critica…’io viceversa ho avuto la fortuna di essere stata spesso oggetto di molte critiche, anche feroci, ma è stimolante perché se ti criticano significa che ti hanno ascoltato attentamente. Certo si soffre, ci si sta male ma bisogna accettarle perché queste sono le regole del gioco. Certo è importante l’onestà intellettuale di chi ti critica. Quando invece questa critica è gratuita, allora cerco di proteggermi, di tutelarmi”.
– Perché molti musicisti reagiscono male anche ad una leggera critica?
“Perché si soffre”.
– Ho capito. Ma queste, come si diceva, sono le regole del gioco…se ci si mette in gioco questo è l’eventuale prezzo da pagare…Anzi oggi purtroppo di critiche negative se ne vedono troppo, troppo poche…
“Certo ma non tutti sono disposti a soffrire per crescere”.
– Durante il periodo della pandemia si era detto: ‘ne usciremo bene, saremo tutti più buoni, più tolleranti’. Non mi pare che le cose stiano andando proprio così…
“E’ proprio vero. Al contrario siamo tutto incattiviti ma più che violenza noto una preoccupante miseria emotiva. L’unica spiegazione che riesco a darmi è che la gente ha paura di perdere la possibilità di vivere di musica e questa è una possibilità purtroppo oggettiva”.
– Ma questa acredine che travalica i confini della musica per investire tutti gli ambiti del vivere civile?
“A mio avviso c’è sempre stata solo che ora si manifesta di più come se la gente avesse perso qualche forma inibitoria: bisogna proteggersi in primo luogo circondandosi di persone che hanno una luce diversa, una energia diversa. Io vado sui social il meno possibile, li uso solo per fini promozionali per la stessa ragione per cui leggo con pudore le interviste”.
Gerlando Gatto
da Gerlando Gatto | 31/Mag/2022 | I nostri libri, Primo piano, Recensioni

Ted Gioia – “Storia del Jazz” – EDT – pgg. 614 – € 35,00
 Non molto tempo fa discutevo con un amico musicista (ma anche scrittore e più in generale attento osservatore della realtà) se nell’attuale situazione fosse o meno giustificata la pubblicazione di una nuova storia del jazz. Trovare un punto di intesa non è stato difficile: certo oramai molto si è scritto sulla storia della musica afro-americana ma molto resta ancora da scrivere, da scoprire, da chiarire. In buona sostanza una storia del jazz oggi si giustifica se risponde ad alcuni ben precisi requisiti: innanzitutto che sul passato ci dica qualcosa di nuovo rispetto a quanto finora scritto, sul presente che ci illumini su quanto sta accadendo sulla scena internazionale, sul futuro che vengano lumeggiate le nuove linee di tendenza. Il tutto accompagnato da una fluidità di racconto che eviti il più possibile incorniciati e box che finiscono con il distrarre e far perdere il filo del discorso.
Non molto tempo fa discutevo con un amico musicista (ma anche scrittore e più in generale attento osservatore della realtà) se nell’attuale situazione fosse o meno giustificata la pubblicazione di una nuova storia del jazz. Trovare un punto di intesa non è stato difficile: certo oramai molto si è scritto sulla storia della musica afro-americana ma molto resta ancora da scrivere, da scoprire, da chiarire. In buona sostanza una storia del jazz oggi si giustifica se risponde ad alcuni ben precisi requisiti: innanzitutto che sul passato ci dica qualcosa di nuovo rispetto a quanto finora scritto, sul presente che ci illumini su quanto sta accadendo sulla scena internazionale, sul futuro che vengano lumeggiate le nuove linee di tendenza. Il tutto accompagnato da una fluidità di racconto che eviti il più possibile incorniciati e box che finiscono con il distrarre e far perdere il filo del discorso.
Ebbene questi requisiti sono tutti presenti nella nuova edizione della “Storia del Jazz” di Ted Gioia pubblicata dalla EDT in collaborazione con Fondazione Siena Jazz – Accademia nazionale del jazz Centro di attività e formazione musicale, che si avvale della precisa traduzione di Francesco Martinelli il quale, com’è suo costume, scrive in maniera fluida, scattante, priva di qualsiasi autocompiacimento letterario sicché lo spirito dell’autore viene pienamente rispettato.
Il volume è diviso in undici capitoli (da “La preistoria del jazz” a “La resurrezione del jazz”) con l’aggiunta di quattro Note dedicate rispettivamente a “Letture consigliate”, “Ascolti consigliati”, “Ringraziamenti” e il sempre indispensabile “Indice analitico”. Da questa partizione si capisce come l’Autore parta dalle origini della musica afro-americana per giungere sino ai nostri giorni. Così, nella narrazione di Gioia, ritroviamo tutte le figure più importanti del jazz – da Jelly Roll Morton a Louis Armstrong, da Duke Ellington al Cotton Club, ai giganti del cool come Gerry Mulligan, Stan Getz, e Lester Young, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Ornette Coleman…fino ai postmodernisti della scena downtown – inseriti in una cornice politica e socio-economica che costituisce uno dei punti di forza delle opere di Gioia. In effetti la musica non nasce spontaneamente come una sorta di fungo ma è il portato di tutta una serie di esperienze: di qui fondamentale comprendere il contesto in cui un certo linguaggio nasce e si sviluppa. E Gioia è davvero un maestro nel descrivere tutto ciò, nel farci capire – ad esempio – che cosa significò per i musicisti di colore negli States rivolgersi al be-bop mentre la seconda guerra mondiale volgeva al termine.
Ma è nella seconda parte del libro che a nostro avviso troviamo le notazioni più interessanti. Sono le pagine in cui l’Autore esamina “La resurrezione del jazz” partendo dalla “Resurrezione del cantante di jazz”.
Convincente la tesi sostenuta da Gioia per cui, in questi ultimissimi decenni, il jazz ha riscoperto in qualche modo le sue radici di musica del popolo avviando un dialogo nuovo e non programmato con la cultura di massa. E il ponte che ha permesso tutto ciò è stato varato da artisti quali Kamasi Washington, Robert Glasper, Esperanza Spalding i quali – sono parole di Gioia – “hanno dimostrato che possono utilizzare tutta la gamma stilistica delle canzoni odierne senza perdere le proprie radici jazzistiche”. Una visione, come si nota, assolutamente rivoluzionaria che rende finalmente obsoleto il dibattito circa la presunta “morte del jazz”. In tale quadro anche i cantanti hanno svolto un ruolo di primissimo piano tenendo strettamente collegato il jazz alla musica commerciale. Quasi inutile sottolineare come accanto alle notazioni di carattere sociale, Gioia mai dimentica di indicare le registrazioni che meglio possono corroborare il suo discorso.
Di grande utilità pratica le letture consigliate e gli ascolti consigliati che possono costituire una guida sia per chi voglia approfondire la materia sia per chi ad essa si avvicini per la prima volta
Insomma un volume che non può mancare nella libreria di chi ama la musica.
Amedeo Furfaro, Lionello Pogliani – “Musiche in mente” – The Writer – pgg. 127 – € 12,00
 Scritto a due mani dal nostro collaboratore Amedeo Furfaro e da Lionello Pogliani, rispettivamente giornalista e critico musicale il primo, e collaboratore scientifico dell’Università di Valencia, il secondo, il volume affronta il problema del linguaggio musicale sotto il profilo sia delle cosiddette scienze sociali e umane sia delle scienze strettamente intese. Di qui una lettura interessante in quanto si intersecano due tipi di logica in un momento in cui, viceversa, si tende a parcellizzare ogni discorso e quindi a esaltare il ruolo della specializzazione sempre e comunque. In buona sostanza obiettivo del lavoro, perfettamente centrato, è mettere in campo una concezione organica della musica che viene ricondotta in un unico arco culturale combinando idee che in genere non sono messe in correlazione fra di loro. In particolare, nella prima parte Pogliani, avvalendosi anche della collaborazione di Michel Villaz e Laurent Vercueil, si muove tra fisica, chimica, astronomia, biologia, acustica, medicina, mentre nella seconda parte Furfaro, partendo dalla sua formazione storico-politologica e antroposociale oltre che musicale, illustra le sue idee traendo ispirazione dalle occasioni più disparate come una lettura, una serata al cinema, una foto, una ricorrenza, un’intervista tutte su filo del discorso musicale.
Scritto a due mani dal nostro collaboratore Amedeo Furfaro e da Lionello Pogliani, rispettivamente giornalista e critico musicale il primo, e collaboratore scientifico dell’Università di Valencia, il secondo, il volume affronta il problema del linguaggio musicale sotto il profilo sia delle cosiddette scienze sociali e umane sia delle scienze strettamente intese. Di qui una lettura interessante in quanto si intersecano due tipi di logica in un momento in cui, viceversa, si tende a parcellizzare ogni discorso e quindi a esaltare il ruolo della specializzazione sempre e comunque. In buona sostanza obiettivo del lavoro, perfettamente centrato, è mettere in campo una concezione organica della musica che viene ricondotta in un unico arco culturale combinando idee che in genere non sono messe in correlazione fra di loro. In particolare, nella prima parte Pogliani, avvalendosi anche della collaborazione di Michel Villaz e Laurent Vercueil, si muove tra fisica, chimica, astronomia, biologia, acustica, medicina, mentre nella seconda parte Furfaro, partendo dalla sua formazione storico-politologica e antroposociale oltre che musicale, illustra le sue idee traendo ispirazione dalle occasioni più disparate come una lettura, una serata al cinema, una foto, una ricorrenza, un’intervista tutte su filo del discorso musicale.
In conclusione un volume che vuole essere uno stimolo ad una riflessione complessiva su come lo sviluppo dell’arte musicale abbia interessato ed investito tutto l’arco dello scibile umano.
Amedeo Furfaro – “Pasolini – Luoghi, incontri, suoni” – The Writer – pgg. 103 – € 12,00
 In questo ulteriore volume, pubblicato nei primi mesi di quest’anno, Furfaro raccoglie i suoi scritti dedicati a Pasolini e riguardanti essenzialmente tre aspetti, luoghi, incontri e suoni. Di particolare importanza, per quanto concerne “A proposito di jazz”, la terza tranche in cui si tenta una panoramica del rapporto di Pasolini con la musica. L’Autore esamina quindi i vari aspetti delle relazioni di Pasolini con la musica partendo dalle colonne sonore dei suoi film per passare ad una discografia essenziale (jazz escluso) che copre gli anni dal 1960 al 1975 in cui sono elencati brani che vedono Pasolini nella veste di paroliere. Negli anni ’80 si collocano alcuni lavori discografici che hanno il merito di ripercorrere tappe importanti dell’excursus creativo pasoliniano, come “La musica nel cinema di Pasolini” (General Music 1984) in cui Morricone riassume le sue musiche per cinque pellicole firmate Pasolini. Interessante anche un altro lavoro, sempre dell’84, “Pour Pier Paolo, Poèmes de Pier Paolo Pasolini mis en musique par Giovanna Marini (Le Chant du monde). Negli anni seguenti Pasolini continua ad ispirare molte pagine musicali, dagli omaggi espliciti di cantanti e gruppi come Pino Marino, Massimiliano Larocca, Radio Dervish fino a compositori come Nicola Piovani e a registi come Nanni Moretti.
In questo ulteriore volume, pubblicato nei primi mesi di quest’anno, Furfaro raccoglie i suoi scritti dedicati a Pasolini e riguardanti essenzialmente tre aspetti, luoghi, incontri e suoni. Di particolare importanza, per quanto concerne “A proposito di jazz”, la terza tranche in cui si tenta una panoramica del rapporto di Pasolini con la musica. L’Autore esamina quindi i vari aspetti delle relazioni di Pasolini con la musica partendo dalle colonne sonore dei suoi film per passare ad una discografia essenziale (jazz escluso) che copre gli anni dal 1960 al 1975 in cui sono elencati brani che vedono Pasolini nella veste di paroliere. Negli anni ’80 si collocano alcuni lavori discografici che hanno il merito di ripercorrere tappe importanti dell’excursus creativo pasoliniano, come “La musica nel cinema di Pasolini” (General Music 1984) in cui Morricone riassume le sue musiche per cinque pellicole firmate Pasolini. Interessante anche un altro lavoro, sempre dell’84, “Pour Pier Paolo, Poèmes de Pier Paolo Pasolini mis en musique par Giovanna Marini (Le Chant du monde). Negli anni seguenti Pasolini continua ad ispirare molte pagine musicali, dagli omaggi espliciti di cantanti e gruppi come Pino Marino, Massimiliano Larocca, Radio Dervish fino a compositori come Nicola Piovani e a registi come Nanni Moretti.
Ovviamente anche il mondo del jazz ha omaggiato Pasolini; Furfaro ricorda al riguardo la performance del Roberto Gatto in “Accattone” e la “Suite per Pierpaolo” a cura di Glauco Venier con Alba Nacicovitch. Ma è in “Appunti per un’Orestiade Africana” che la relazione fra Pasolini e il jazz trova il suo baricentro; ciò in ragione del fatto che buona parte della colonna sonora è affidata a jazzisti quali Gato Barbieri, Marcello Melis e Famoudou Don Moye. A seguire una discografia in cui il jazz “latu sensu” tiene a sottolineare Amedeo, compare a fianco della figura di Pasolini.
Guido Michelone – “Il jazz e i mondi” – Arcana – pgg. 390 – € 24,00
 Davvero infaticabile Guido Michelone, didatta, studioso, giornalista e scrittore tra i più prolifici che il mondo del jazz italiano conosca. Ecco, quindi, una sua nuova fatica editoriale significativamente intitolata “Il jazz e i mondi”. Un titolo che può esplicativo non potrebbe essere. Nelle circa 400 pagine del volume, l’Autore, grazie ai numerosi viaggi compiuti tra Usa, Brasile, Giappone, Canada, Nord Africa e Medioriente, ci racconta, in maniera chiara ed esplicita com’è suo costume, il come e perché il jazz ha trovato diritto di cittadinanza in tutti questi Paesi
Davvero infaticabile Guido Michelone, didatta, studioso, giornalista e scrittore tra i più prolifici che il mondo del jazz italiano conosca. Ecco, quindi, una sua nuova fatica editoriale significativamente intitolata “Il jazz e i mondi”. Un titolo che può esplicativo non potrebbe essere. Nelle circa 400 pagine del volume, l’Autore, grazie ai numerosi viaggi compiuti tra Usa, Brasile, Giappone, Canada, Nord Africa e Medioriente, ci racconta, in maniera chiara ed esplicita com’è suo costume, il come e perché il jazz ha trovato diritto di cittadinanza in tutti questi Paesi
Si tratta di una narrazione a tratti affascinante in quanto si capisce finalmente come il jazz abbia potuto perdere le sue caratteristiche originarie per assumere le connotazioni di una musica universale senza più confini ma specchio della civiltà di ogni singolo Paese, come risultato necessario di quella contaminazione tra le diverse culture di ogni angolo del mondo. Di qui una sorta di viaggio straordinario, suddiviso in 29 capitoli dedicati ognuno ad una parte del mondo, elencate in ordine alfabetico, per cui si parte dall’Afghanistan per chiudere con “Zingari in jazz” dedicato alla musica manouche. Nel libro, accanto a nome e cognome di ogni jazzman, viene indicato lo strumento musicale mentre alla fine di ogni capitolo è riportata tra parentesi la data, grosso modo compresa tra il 2001 e il 2022, ad indicare il periodo in cui viene redatto il resoconto musicale del viaggio compiuto nella nazione indicata.
Ogni capitolo è impreziosito da una accurata discografia mentre il volume nel suo insieme è completato da una sempre utile bibliografia. Purtroppo manca quell’indice analitico che in un volume del genere sarebbe risultato particolarmente importante.
Renzo Ruggeri – “Elementi di Musica Jazz: CORSO BASE per fisarmonica” – Voglia d’Arte Production – pgg.165 – € 25,00
 “Questo lavoro di Ruggieri – condotto con serietà e competenza – è un avvenimento per la fisarmonica.” Gianni Coscia
“Questo lavoro di Ruggieri – condotto con serietà e competenza – è un avvenimento per la fisarmonica.” Gianni Coscia
Con queste parole il grande patriarca della fisarmonica jazz italiana ha tenuto a battesimo l’uscita della prima versione del testo, circa 25 anni fa, quando esso rappresentava il primo libro internazionale per questo strumento con elementi di jazz moderno.
Ruggieri – da esperto didatta – affronta la materia in maniera profonda proponendo una suddivisione razionale dei capitoli, non lesinando esercizi pratici di grande efficacia. La nuova versione si propone una riscrittura del testo, un ampliamento degli argomenti in base alle esperienze degli anni di utilizzo, una razionalizzazione degli schemi e degli esercizi. Sicuramente è stato il primo testo ad introdurre in maniera approfondita dei “policordi” ovvero la pressione di più tasti contemporaneamente nella mano sinistra, tecnica che lo stesso Ruggieri definisce imperfetta ma molto efficace.
La vera novità è rappresentata, comunque, dalle “backing tracks” dei brani del metodo (nuove composizioni sulle strutture armoniche di famosi standard) suonate da affermati professionisti: Maurizio Rolli (contrabbasso), Mauro De Federicis (chitarra), Niki Barulli (batteria). Quest’ultime tutte disponibili gratuitamente sui circuiti online sia in versione completa che “minus bass”, o “minus harmony”, o “minus drums” a simulare le diverse situazioni che lo studente incontrerà.
Da sottolineare la sempre “elegante ed efficace” vena melodica di Ruggieri che si manifesta anche negli esercizi.
Di prossima uscita la versione inglese e nei prossimi anni quella INTERMEDIA e AVANZATA.
Distribuito in tutto il mondo da AMAZON è possibile acquistarlo direttamente su:
https://www.amazon.it/dp/B095GD37SN
Le basi sono disponibili gratuitamente su:
SPOTIFY
https://open.spotify.com/album/3gupaPMqTIuQekv9J8cwzL?si=NG6oHNIfTKa9eGMQQDIyXA
YOUTUBE
https://youtu.be/r0EVSxyEOB4
Vincenzo Staiano – “Solid – Quel diavolo di Scott LaFaro” – Arcana – pgg. 174 – € 16,00
 Ecco un volume che sarà ben accolto da tutti gli appassionati di jazz, in special modo dai pianisti e dai contrabbassisti. Racconta, infatti, la storia di un connubio assolutamente straordinario, un incontro che ha cambiato la storia del jazz in relazione al classico combo pianoforte, batteria, contrabbasso. Ci si riferisce ovviamente alla straordinaria intesa che nell’arco di pochissimo tempo si costituì tra Bill Evans e Scott LaFaro, un’intesa che sconvolse definitivamente la gerarchia degli strumenti nel trio (completato all’epoca da Paul Motian) cosicché il pianoforte perse il ruolo di guida per essere affiancato, a pari condizioni, da batteria e contrabbasso. Certo, a dirlo oggi, sembra qualcosa di scontato ma se si risale all’epoca in cui Evans e LaFaro si incontrarono, vale a dire il 1959, si scoprirà come la musica proposta dal trio fosse assolutamente rivoluzionaria. In questo suo scritto Staiano pone l’accento sulla figura del contrabbassista prematuramente scomparso nel 1961, offrendone un ritratto illuminante anche perché ci fa comprendere come, già prima di incontrare Bill Evans, fosse artista in possesso di una propria ben specifica cifra stilistica. Particolare attenzione viene, così, dedicata al periodo che va dal 1955, quando Scott lascia l’università di Itaca per iniziare il suo primo tour come professionista, sino a quel tragico incidente che il 6 luglio del 1961 gli costa la vita. Grazie ad un racconto ben articolato, sorretto da una prosa che conosce l’italiano, il volume si legge quasi tutto d’un fiato arricchito da una serie di contributi originali. In effetti in Italia pochissimo era stato scritto su LaFaro per cui il libro di Vincenzo Staiano assume un’importanza particolare. L’autore, per questa sua prima pregevole monografia, si è avvalso della biografia di Scotty (con questo nomignolo era noto LaFaro e questo si utilizza nel libro) redatta dalla sorella Helene, nonché di una grande quantità di contributi sull’artista, come l’intervista di Martin Williams apparsa sul periodico “Jazz Review”, un articolo del 1968 di Jean-Pierre Binchet su “Jazz Magazine”, un sito web a lui dedicato nel 1998 da Charles A. Ralston, nonché di moltissimi altri contributi elencati nella ricca appendice bibliografica e webgrafica, cui si affianca una discografia.
Ecco un volume che sarà ben accolto da tutti gli appassionati di jazz, in special modo dai pianisti e dai contrabbassisti. Racconta, infatti, la storia di un connubio assolutamente straordinario, un incontro che ha cambiato la storia del jazz in relazione al classico combo pianoforte, batteria, contrabbasso. Ci si riferisce ovviamente alla straordinaria intesa che nell’arco di pochissimo tempo si costituì tra Bill Evans e Scott LaFaro, un’intesa che sconvolse definitivamente la gerarchia degli strumenti nel trio (completato all’epoca da Paul Motian) cosicché il pianoforte perse il ruolo di guida per essere affiancato, a pari condizioni, da batteria e contrabbasso. Certo, a dirlo oggi, sembra qualcosa di scontato ma se si risale all’epoca in cui Evans e LaFaro si incontrarono, vale a dire il 1959, si scoprirà come la musica proposta dal trio fosse assolutamente rivoluzionaria. In questo suo scritto Staiano pone l’accento sulla figura del contrabbassista prematuramente scomparso nel 1961, offrendone un ritratto illuminante anche perché ci fa comprendere come, già prima di incontrare Bill Evans, fosse artista in possesso di una propria ben specifica cifra stilistica. Particolare attenzione viene, così, dedicata al periodo che va dal 1955, quando Scott lascia l’università di Itaca per iniziare il suo primo tour come professionista, sino a quel tragico incidente che il 6 luglio del 1961 gli costa la vita. Grazie ad un racconto ben articolato, sorretto da una prosa che conosce l’italiano, il volume si legge quasi tutto d’un fiato arricchito da una serie di contributi originali. In effetti in Italia pochissimo era stato scritto su LaFaro per cui il libro di Vincenzo Staiano assume un’importanza particolare. L’autore, per questa sua prima pregevole monografia, si è avvalso della biografia di Scotty (con questo nomignolo era noto LaFaro e questo si utilizza nel libro) redatta dalla sorella Helene, nonché di una grande quantità di contributi sull’artista, come l’intervista di Martin Williams apparsa sul periodico “Jazz Review”, un articolo del 1968 di Jean-Pierre Binchet su “Jazz Magazine”, un sito web a lui dedicato nel 1998 da Charles A. Ralston, nonché di moltissimi altri contributi elencati nella ricca appendice bibliografica e webgrafica, cui si affianca una discografia.
La figura di LaFaro assume così una valenza particolare sottolineata anche dal titolo del libro, “Solid”, che come ci spiega lo stesso Staiano richiama l’essenza di un messaggio inviato a Scott da Miles Davis, un messaggio con cui il trombettista gli faceva capire di volerlo nella sua formazione come contrabbassista.
da Gerlando Gatto | 09/Mag/2022 | I nostri CD, Primo piano, Recensioni
I NOSTRI CD

 Jon Balke Siwan – “Hafla” – ECM
Jon Balke Siwan – “Hafla” – ECM
A distanza di tanti secoli ancora sopravvive il mito di Al-Andalus ovvero di quella Spagna medievale musulmana, in cui sotto la guida di colti principi arabi, musulmani, ebrei e cristiani vivevano tutti insieme senza distinzione alcuna di razza e/o di religione. Ecco, questo mito viene ora riattualizzato dalla musica di Siwan, il collettivo musicale transculturale e trans-idiomatico guidato dal tastierista e compositore norvegese Jon Balke, giunto al suo terzo album dedicato alla materia in oggetto. Questa volta uno accanto all’altro troviamo un musicista kemençe turco (Derya Turkan), un maestro iraniano del tombak (Pedram Khavar Zamini), un batterista norvegese di aperte vedute (Helge Norbakken), una nutrita sezione di archi specialisti del barocco guidata da Bjarte Ejke e una cantante algerina, Mona Boutchebak, che interpreta testi e di Wallada bint al-Mustakfi, la principessa omayyade di Cordoba dell’XI secolo e di altri poeti a lei contemporanei quali Ibn Zaydun (1003-1071, suo appassionato amante) e Ibn Sara As-Santarini (1043-1123). L’album non si presta ad un semplice ascolto né tanto meno ad una facile lettura. Si tratta di musica complessa, caratterizzata da un contesto in cui le parole hanno un peso spesso importante, e da un inusuale impasto sonoro determinato dalla coesistenza di strumenti che appartengono a mondi culturali diversi. Il leader tenta di assemblare il tutto con l’ impegno e la passione che gli sono propri, anche se il risultato non sempre è dei migliori.
 Flavio Boltro, Fabio Giachino – “Things to Say” – Cam Jazz
Flavio Boltro, Fabio Giachino – “Things to Say” – Cam Jazz
Suonare in duo è sempre molto impegnativo, forse più della prova in solitario. Il fatto è che quando ci si esibisce in due occorre che i musicisti si conoscano molto bene e riescano così a precedere le intenzioni l’uno dell’altro sì da assicurare alla musica una fluidità che non conosce intoppi. Ecco, tutto ciò lo si ritrova in questo album interpretato da due grandi jazzisti italiani. Flavio Boltro (classe 1961) è artista oramai maturo che ha raggiunto una perfetta padronanza dello strumento il che gli consente di evidenziare un bel suono, pieno, ricco supportato da un fraseggio mai fine a se stesso e da una indubbia capacità di intonare suadenti linee melodiche. Giachino (classe 1986) è un pianista che ha conquistato pubblico e critica grazie ad uno stile raffinato in cui sottile ironia e padronanza della dinamica si coniugano mirabilmente, il tutto declinato con una personale dimensione dello spazio (lo si ascolti in “Prelude to Salina”). In programma un repertorio tutto composto da original a firma soprattutto di Fabio Giachino il che conferma vieppiù la maturità di questo pianista. Di qui una musica che scorre fluida caratterizzata spesso da notevole intensità emotiva e soprattutto da una perfetta intesa tra i due musicisti che, pur proveniendo da ambienti diversi, riescono a fondere le loro esperienze in un unicum raffinato. Ed è una sensazione che si percepisce immediatamente sin dall’ascolto del primo brano in programma, “Piccola Nina” di Flavio Boltro, sino a quel “Spicy Blues” ancora di Boltro che chiude l’album.
 Avishai Cohen – “Naked Truth” – ECM
Avishai Cohen – “Naked Truth” – ECM
Tra le stelle di primaria grandezza che rifulgono nel panorama jazzistico internazionale, un suo posto di rilievo ce l’ha sicuramente il trombettista israeliano Avishai Cohen. Registrato negli Studios La Buissonne a Pernes-les-Fontaines nel Sud della Francia, nel settembre del 2021, sotto la produzione ECM, l’album ci consegna un Cohen sotto certi aspetti inediti. Abbandonate le atmosfere “elettriche” del precedente album, il trombettista si consegna al suo pubblico in estrema sincerità, con una musica tutta giocata sul coté dell’intimismo e declinata attraverso otto parti di una lunga suite intitolata “Naked Truth” e da un brano conclusivo, “Departure”. Avishai suona con la perizia che ben conosciamo ma è l’atmosfera generale dell’album che, come si diceva, lo proietta in una luce diversa. Perfettamente coadiuvato da Yonathan Avishai al piano, dal bassista Barak Mori e dal batterista Ziv Ravitz, il leader disegna una sorta di percorso che si snoda coerentemente quasi illustrando vari stati d’animo. Così si passa da pezzi di chiara impronta crepuscolare a frammenti in cui la tromba pare schiarirsi e aprirsi ad orizzonti più rosei fino a sfiorare il clima tipico delle ballad.
Da sottolineare come, accanto al leader, suona uno splendido Yonathan Avishai il cui pianoforte si pone come autentico alter-ego del leader prendendo egli stesso in mano il pallino del discorso (si ascolti al riguardo la convincente Part.V).
Come si accennava, il disco si chiude con la poesia “Departure”, dell’autrice israeliana Zelda Schneurson Mishkovsky (1914.1984), recitata dallo stesso Cohen sul tappeto strumentale degli altri musicisti.
 Claudio Cojaniz – “Orfani” – Caligola
Claudio Cojaniz – “Orfani” – Caligola
Poeta della tastiera. Così mi sento di definire Claudio Cojaniz dopo l’ascolto di questo bell’album registrato nell’aprile del 2021 a Treviso dall’oramai rodato quartetto del pianista completato da un sempre straordinario Alessandro Turchet al contrabbasso (a mio avviso uno dei migliori bassisti italiani), Luca Colussi alla batteria e Luca Grizzo percussioni. In repertorio sette composizioni dello stesso Cojaniz. Conosco Claudio oramai da tanti anni ma francamente non so dire con precisione a quali “orfani” si riferisce. Orfani di cosa? Di chi? Personalmente ho avvertito, comunque, nella musica di Cojaniz una sorta di dolore di fondo, di grande malinconia come se l’artista volesse farci riflettere sui tanti guai che in questo momento affliggono l’umanità. Certo, non ci si riferisce alla guerra ché l’album è stato inciso prima, ma resta egualmente la sensazione di un disagio, di un modo di vedere una realtà che non ci piace più di tanto. Ecco, penso che in questo caso il riferimento al blues, non tanto come struttura, ma come musica che rispecchia uno stato d’animo, sia assolutamente presente. E la cosa non stupisce più di tanto ove si tenga presente da un canto la lunga militanza di Cojaniz nell’ambito del jazz (il suo pianismo è ancora una volta coerente, del tutto idoneo alle sue volontà espressive), dall’altro i frequenti richiami africaneggianti che il musicista ha già fatto nei precedenti lavori. Insomma un artista che dimostra, ancora una volta, una profonda conoscenza del linguaggio jazzistico non solo dal punto di vista musicale ma anche da ciò che questo linguaggio ha rappresentato – e ancora oggi rappresenta – per le popolazioni di colore negli States…e non solo.
 Lorenzo De Finti Quartet – “Mysterium Lunae” – Losen
Lorenzo De Finti Quartet – “Mysterium Lunae” – Losen
Strano ma vero, un quartetto italiano che incide per una etichetta norvegese e non è la prima volta dato che il pianista Lorenzo De Finti ha già inciso per la Losen altri due album. Ma veniamo a quest’ultimo “Mysterium Lunae” registrato a Torino nei primi tre giorni del luglio 2021. Per quest’ultima fatica discografica, il gruppo si è arricchito di un prestigioso elemento, il trombettista e flicornista Alberto Mandarini unanimemente considerato musicista a 360 gradi. A completare il gruppo Stefano Dall’Ora al basso e Marco Castiglioni alla batteria. In programma sei brani firmati congiuntamente da De Fanti e Dall’Ora. De Finti è musicista di larga esperienza avendo suonato in orchestre sinfoniche, nella celebrata Instabile Orchestra e accanto a Paolo Conte in molte tournées. Ciò gli ha permesso di elaborare un proprio stile caratterizzato da un sound originale e dalla capacità di scavare a fondo in ogni composizione per trarne ogni possibile implicazione. E tutto ciò si evince dall’ascolto dell’album in oggetto che si apre con la composizione forse più interessante, “Mysterium Lunae”, che si richiama espressamente all’antica metafora per cui un oggetto freddo può diventare fonte di bellezza riflettendo, però, una luce più grande proveniente da qualcos’altro. Ecco quindi questo vero e proprio richiamo alla speranza, sentimento che nel corso della pandemia (periodo in cui è stato registrato il CD) purtroppo è andato quasi perso. Ma i quattro non si limitano a focalizzare uno stato d’animo ché l’album prosegue con una serie di atmosfere cangianti grazie all’attento uso dei colori e delle dinamiche che appaiono già patrimonio consolidato del quartetto.
 Joey DeFrancesco – “More Music” – Mack Avenue
Joey DeFrancesco – “More Music” – Mack Avenue
Non c’è dubbio alcuno che tra quanti suonano ancora oggi l’organo Hammond Joey DeFrancesco sia tra i più bravi. Ma il nostro non si limita a maneggiare con maestria l’organo dal momento che suona bene anche la tromba, il sax tenore, le tastiere e il piano. E ce ne dà prova in questo album in cui presenta undici composizioni (ben dieci a sua firma) in cui, accompagnato da una ritmica composta da Michael Ode alla batteria e Lucas Brown chitarra, organo e tastiere, si diverte ad evidenziare il suo multistrumentismo. E lo fa già in apertura interpretando alla tromba il brano “Free” che, a scanso di equivoci, nulla a che vedere ha con il free jazz. Eccolo ancora alla tromba nel blues “Where to Go”, mentre nelle due ballads, “Lady G” ed “Angel Calling”, si misura con il sax tenore… ma tutto ciò non sarebbe stato sufficiente senza un brano cantato… e voila “And If You Please”, cosicché in alcuni brani l’Hammond B3 viene suonato da Lucas Brown, anch’egli polistrumentista di assoluto livello. Da quanto sin qui detto risulta abbastanza evidente come tutto l’album sia all’insegna della gioia di suonare, di poter eseguire senza tema di essere criticati la musica che piace. Certo, se ci si dovesse poi chiedere in quale veste preferiamo Joey, la risposta non può che essere una ed una sola: all’organo Hammond di cui DeFrancesco rimane uno straordinario interprete, capace di trarre dallo strumento tutta una serie di nuances, di sfumature che pochi altri sanno imitare.
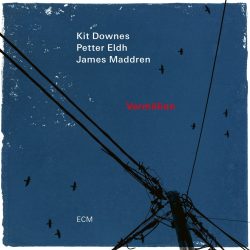 Kit Downes – “Vermillion” – ECM
Kit Downes – “Vermillion” – ECM
Dopo i suoi due precedenti album per ECM, “Dreamlife of Debris” del 2019 e “Obsidian” del 2017 in cui suonava un organo da chiesa a canne, il musicista inglese Kit Downes si ripresenta alla testa di un classico piano-trio coadiuvato dallo svedese Petter Edh già ammirato nel trio di Django Bates al contrabbasso e il britannico James Maddren alla batteria. In realtà al momento della registrazione di questo album, i tre si conoscevano già bene avendo suonato assieme sotto l’insegna di Trio Enemy. Questo “Vermillion” risente molto della formazione musicale del leader: abituato a frequentare quasi indistintamente territori classici, moderni e jazzistici, il pianista infonde alla sua musica uno spirito affatto particolare che la pone piuttosto lontana da ciò che normalmente si immagina debba essere un trio di jazz. In effetti qui non troviamo una continua pulsazione ritmica, né linee melodiche facilmente identificabili ma un flusso costante di musica tutta giocata su toni meditativi. Ovviamente – Evans insegna – non c’è alcuna gerarchia fra i tre strumenti che dialogano su un piano di assoluta parità alla ricerca di un’espressività interiore che mai viene meno. Di qui la sensazione, non si sa bene quanto veritiera, che la scrittura la faccia da padrona sull’improvvisazione. Insomma una sorta di viaggio introspettivo declinato attraverso dieci composizioni di pianista e contrabbassista e la cover di Jimi Hendrix, “Castles Made of Sand” tratto da “Axis: bold as Love” del 1967che chiude meravigliosamente l’album.
 Mathias Eick – “When We Leave” – ECM
Mathias Eick – “When We Leave” – ECM
Il trombettista Mathias Eick è uno di quei musicisti che mai ti delude. Ogni suo album è una summa di quel che oggi dovrebbe rappresentare, a nostro avviso, la figura del jazzista, vale a dire un musicista che pur conoscendo perfettamente la tradizione, volge lo sguardo al futuro. E lo fa con la piena consapevolezza dei propri mezzi espressivi. Ingredienti, questi, che si ritrovano appieno in “When We Leave” registrato a Oslo nell’agosto 2020 da un organico piuttosto ampio guidato da Mathias Eick (nell’occasione anche alle tastiere) e completato da Andreas Ulvo al piano, dal bassista Audun Erlien, da Hakon Aase violino e percussioni, dai due batteristi e percussionisti Torstein Lofthus e Helge Andreas Norbakken e dal chitarrista Stian Carstensen il cui apporto risulta tutt’altro che secondario. Come abbiamo già avuto modo di apprezzare nei suoi precedenti lavori, la musica di Eick si mantiene su atmosfere intimiste, malinconiche, declinata attraverso il fitto colloquio dei musicisti che sembrano aderire perfettamente a quelle che sono le linee guida dettate dal leader. Di qui una insieme di linee melodiche sempre riconoscibili, un perfetto controllo del ritmo ben supportato da una sezione quanto mai precisa ed efficiente, ed un gioco sulle dinamiche che spesso si fa apprezzare per la sua originalità. Tra i vari strumentisti precedentemente citati, da sottolineare ancora una volta la prova del violinista Hakon Aase che oltre ad eseguire spesso il tema all’unisono con la tromba del leader, si produce in pregevoli assolo. Ma il fulcro di tutto è sempre lui, Mathias Eick il cui strumento si staglia sempre preciso, puntuale, così come le sue capacità compositive dato che tutti i brani dell’album sono dovuti alla sua penna.
 Antonio Flinta – “Secrets of a Kiri Tree” – Autoprod.
Antonio Flinta – “Secrets of a Kiri Tree” – Autoprod.
Sono passati circa due anni da quando, discutendo con Antonio Flinta, gli chiesi come mai non si fosse ancora cimentato al piano-solo dopo una intensa carriera. Antonio mi rispose che l’avrebbe fatto solo se si fosse sentito pronto. Il momento è arrivato ed ecco questo “Secrets of a Kiri Tree” in cui il pianista cileno ci spinge a guardarci nel profondo, a riscoprire quel che abbiamo dentro, anche se per farlo probabilmente abbiamo bisogno di qualcuno che si spinga in tal senso. E per ottenere tale scopo Flinta sceglie un repertorio tanto vasto quanto difficile. Ecco quindi Paco de Lucia con “Cancion de amor”, accanto a George Fragos (“I Hear a Rhapsody”), la straordinaria Violeta Parra (“Gracias a la vida”) assieme al gigante del jazz Thelonious Monk (”’Round Midnight”) il tutto completato da tre originals di Antonio. A nostro avviso il meglio dell’album lo si ritrova nelle composizioni dello stesso pianista. Scevro da qualsivoglia preoccupazione se non quella di lasciarsi andare al proprio istinto, Flinta inanella una serie di improvvisazioni davvero notevoli in cui mai si perde il filo del discorso tanto è solida la base su cui l’artista costruisce i suoi edifici musicali. Così risulta quanto mai arduo distinguere le parti improvvisate da quelle scritte, ammesso poi che la cosa abbia un minimo di importanza. Così il pianismo di Flinta scorre fluido sicuro, lucido, essenziale, mai sovracaricato di orpelli inutili e pur tuttavia sempre in grado di incuriosire l’ascoltatore. Quanto agli altri brani, abbiamo particolarmente apprezzato la versione di “Gracias a la vida” che conserva intatta la sua dolce e malinconica linea melodica.
 Tord Gustavsen – “Opening” – ECM
Tord Gustavsen – “Opening” – ECM
Ancora un piano-trio questa volta di marca norvegese. A costituirlo sono infatti il pianista Tord Gustavsen, il contrabbassista Steinar Raknes (responsabile anche di un sapiente e sobrio uso dell’elettronica) e il batterista Jarle Vespestad ovvero tre dei migliori musicisti che il panorama jazz norvegese possa oggi offrire. E il risultato è in effetti di grande rilevanza. Certo non scopriamo in questa sede lo straordinario talento del pianista, ma fa immenso piacere constatare come uno dopo l’altro tutti i lavori di Tord si mantengano su un livello di assoluta eccellenza. In programma, questa volta, dodici brani di cui nove a firma del leader cui si aggiungono un brano traditional e due pezzi firmati rispettivamente da Geir Tveitt – figura centrale del movimento culturale norvegese negli anni ’30 – e da Egil Hovland, compositore classico che si formò studiando tra gli altri con Aaron Copland e a Firenze con Luigi Dallapiccola. E da queste poche note si può già comprendere quanto ampio sia l’universo musicale di riferimento di Gustavsen e quindi dell’intero trio. Di qui una musica saldamente ancorata al patrimonio norvegese, e nordico più in generale. Ecco quindi la rivisitazione, già al secondo pezzo, di un brano abbastanza celebrato in Svezia, “Visa från Rättvik” (Vista dalla città di Rättvik), già inserito da Jan Johansson – uno tra i più grandi pianisti svedesi di cui Gustavsen ha dichiarato di sentire l’influenza – nell’album del 1964, “Jazz pa Svenska”, album che all’epoca vendette la stratosferica cifra di 250.000 copie. Gustavsen stravolge il pezzo rendendolo praticamente suo e lo stesso fa per tutta la durata dell’album mai offrendo musica banale o scontata. Si ascolti, ad esempio, il suo modo di intendere il tango in “Helensburgh Tango”, lontano che più non si potrebbe dalle atmosfere tipiche tanguere. Splendida la versione di “Var Sterk, Min Sjel” assolutamente rispettosa dell’originale del già citato Egil Hovland.
 Roberto Laneri – “Musica finta / Blue Prints” – Da Vinci Classics
Roberto Laneri – “Musica finta / Blue Prints” – Da Vinci Classics
Roberto Laneri – “South of No Border” – Black Sweat Records
Il polistrumentista Roberto Laneri si ripresenta con due album registrati rispettivamente nel 1998 e in un arco temporale che va dal 2014 al 2018. Ma procediamo con ordine. “Musica finta / Blue Prints”, registrato come si diceva nel 1998 ma pubblicato solo nei primi mesi del 2020, va inquadrato correttamente grazie al sottotitolo “A Study in Metamusicology”. Si tratta, cioè, di un album assai complesso, di lettura difficile, in cui Laneri – come egli stesso afferma, suonando al sax soprano alcuni rags di Scott Joplin ha provato ad introdurre dei cambiamenti nel testo, dapprima minimi, poi sempre più articolati, fino ad arrivare alla composizione di pezzi autonomi e paralleli, da suonarsi assieme ai pezzi originali. “L’effetto di questa estremizzazione – aggiunge Laneri – è paragonabile alle prospettive impossibili di Escher, oppure ai disegni tridimensionali generati al computer, dai quali possono emergere immagini complementari eppur assai diverse da quelle immediatamente apparenti”. Fin qui le premesse metodologiche. Ma il risultato musicale? Laneri presenta composizioni originali, unite a quelle di Schumann, Schubert ma anche Joplin e Jelly Roll Morton. Quindi linguaggi differenti ricondotti ad unità per una sorta di opera di ampio respiro divisa in cinque capitoli. Per questa impresa Laneri (sax soprano, sampling e sound treatment) ha chiamato accanto a sé la pianista Maria Jolanda Masciovecchio e Alan Ferry come spoken voice.
 “South of No Border” (come si diceva registrato tra il 2014 e il 2018 ma anch’esso pubblicato poche settimane fa) vede Roberto Laneri (clarinetto, clarinetto basso, sax sopranino, sax soprano e alto, didjeridoo, shruti box, voce e percussioni) alla testa di un gruppo comprendente Giuppi Paone voce, Raffaela Siniscalchi voce, Eleonora Vulpiani chitarra, Luigi Polsini contrabbasso e Laugi Marino zarb. Contrariamente al primo album, in questo caso il repertorio è come una sorta di finestra affacciata sulle musiche del mondo. Ecco, quindi, dopo l’apertura affidata alle melodie orientaleggianti di “Malia” (scritta da Laneri), il choro brasiliano “Tico-Tico no fubá” (scritto da Zequinha de Abreu nel 1917, accanto al bolero cubano “Contigo En La Distancia” scritto dal cantautore César Portillo de la Luz quando aveva 24 anni nel 1946, il tutto impreziosito da 4 original del leader. A confronto con un tale repertorio, Laneri dà ancora una volta prova non solo della sua indiscussa preparazione tecnica ma anche della profonda conoscenza del panorama musicale internazionale. Le sue interpretazioni risultano, quindi, assolutamente pertinenti: traendo feconda ispirazione da svariate tradizioni, riesce a produrre una sintesi che non conosce confini geografici grazie ad una concezione visionaria della musica senza barriere. Insomma un disco originale nella concezione e nell’esecuzione.
“South of No Border” (come si diceva registrato tra il 2014 e il 2018 ma anch’esso pubblicato poche settimane fa) vede Roberto Laneri (clarinetto, clarinetto basso, sax sopranino, sax soprano e alto, didjeridoo, shruti box, voce e percussioni) alla testa di un gruppo comprendente Giuppi Paone voce, Raffaela Siniscalchi voce, Eleonora Vulpiani chitarra, Luigi Polsini contrabbasso e Laugi Marino zarb. Contrariamente al primo album, in questo caso il repertorio è come una sorta di finestra affacciata sulle musiche del mondo. Ecco, quindi, dopo l’apertura affidata alle melodie orientaleggianti di “Malia” (scritta da Laneri), il choro brasiliano “Tico-Tico no fubá” (scritto da Zequinha de Abreu nel 1917, accanto al bolero cubano “Contigo En La Distancia” scritto dal cantautore César Portillo de la Luz quando aveva 24 anni nel 1946, il tutto impreziosito da 4 original del leader. A confronto con un tale repertorio, Laneri dà ancora una volta prova non solo della sua indiscussa preparazione tecnica ma anche della profonda conoscenza del panorama musicale internazionale. Le sue interpretazioni risultano, quindi, assolutamente pertinenti: traendo feconda ispirazione da svariate tradizioni, riesce a produrre una sintesi che non conosce confini geografici grazie ad una concezione visionaria della musica senza barriere. Insomma un disco originale nella concezione e nell’esecuzione.
 Roberto Magris – “Match Point” – JMood / Roberto Magris – “Duo & Trio” – JMood
Roberto Magris – “Match Point” – JMood / Roberto Magris – “Duo & Trio” – JMood
Tra i musicisti che riescono a conservare un alto livello delle proprie produzioni, lavorando in ambedue le sponte dell’Atlantico, c’è sicuramente il pianista Roberto Magris di cui segnaliamo due nuove uscite. Il primo – “Match Point” – registrato a Miami l’8 dicembre del 2018, è stato a ben ragione considerato da critici statunitensi come uno degli album più interessanti pubblicati negli ultimi mesi. “Match Point” vede il pianista triestino alla testa di un quartetto dai mille colori completato dal cubano Alfredo Chacon al vibrafono e percussioni, dal batterista Rodolfo Zunica proveniente dal Costa Rica e dallo statunitense Dion Kerr al basso. In repertorio otto brani equamente divisi tra composizioni dello stesso Magris e brani di giganti della tastiera quali Richard Kermode tastierista americano, noto soprattutto per essersi esibito con Janis Joplin, Malo e Santana, McCoy Tyner, Thelonious Monk, Randy Weston. Da quanto sin qui detto è già possibile avere un’idea della musica che Magris ci propone, una musica che, saldamente ancorata alla produzione, presenta quel tocco di “latino” che impreziosisce il tutto. Al riguardo basti ascoltare “Caban Bamboo Highlife” di Randy Weston, uno dei jazzisti preferiti da Magris, con Chacon e Zuniga in grande evidenza.
In “Duo & Trio” Magris adotta una formula diversa esibendosi in sei brani in duo con il sassofonista Mark Colby e in cinque pezzi in gruppo con Elisa Pruett al basso, Brian Steever alla batteria mentre Pablo Sanhueza alle congas è presente solo in “Melody for C” di Sonny Clark e “Samba Rasta” di Andrew Hill. Per il resto i compositori visitati da Magris fanno parte dell’Olimpo della musica quali Elmo Hope, Bernstein, Ray Noble, Shuman, Kurt Weill; il tutto completato, come al solito, da alcune composizioni dello stesso Magris. L’ascolto dell’album lascia pienamente soddisfatti per almeno due ordini di motivi: innanzitutto la straordinaria maestria di Roberto Magris che, dall’alto della sua immensa preparazione pianistica, affronta con estrema disinvoltura partiture assai diversificate tra di loro (eccolo intimista e toccante in “Old Folks”, classico nell’accezione più completa del termine in “Cherokee”, trascinante improvvisatore in “Melody for C”); in secondo luogo per la scelta di collaboratori sempre di livello. Da segnalare, in questa occasione il lavoro del sassofonista Mark Colby che sia al tenore sia al soprano evidenzia una forte personalità scevra da qualsivoglia intento di stupire chi ti ascolta.
 Dino & Franco Piana Ensemble – “Reflections” –Alfa Music
Dino & Franco Piana Ensemble – “Reflections” –Alfa Music
Attualmente l’ensemble diretto dalla premiata ditta “Dino & Franco Piana” è una delle migliori formazioni del jazz attuale. Ciò anche perché nel suo ambito, oltre ai citati leader, figurano artisti di grande spessore quali la pianista Stefania Tallini, il bassista Dario Deidda e il batterista Roberto Gatto. In quest’ultima fatica discografica il gruppo è affiancato dalla B.i.m. Orchestra mentre il repertorio comprende dieci brani di cui ben sei composti da Franco Piana (altresì flicornista e arrangiatore del gruppo), altri due original dovuti rispettivamente a Lorenzo Corsi e Stefania Tallini e due standard, “Skylark” di Hoagy Carmichael e “Embraceable You” di George Gershwin. Il progetto nasce durante il lockdown dalle riflessioni dei due leader che hanno focalizzato l’attenzione sulle molteplici possibilità d’espressione che i vari organici possono offrire. Di qui il far ricorso, per ogni brano, ad un organico diverso. Si inizia così da “Skylark”, suonato dal trombone di Dino Piana in solo, passando poi a brani in duo – trio – quartetto – quintetto – sestetto, fino ad arrivare ad arrangiamenti per quartetto d’archi (B.i.m. Orchestra), 4 flauti, piano e flicorno. Come le precedenti prove dei Piana, anche questo album entra di diritto tra i migliori album di jazz italiano pubblicati negli ultimi mesi in quanto la bellezza dei temi è supportata e valorizzata da arrangiamenti ben strutturati e altrettanto ben eseguiti da una formazione che presenta anche individualità di tutto rispetto. Senza dimenticare i due leader – di cui comunque spesse volte abbiamo tessuto le lodi – bisogna sottolineare l’apporto di Stefania Tallini che si conferma jazzista a tutto tondo capace sia di sviluppare suadenti linee melodiche sia di imporre un ritmo preciso e coinvolgente (la si ascolti in “D and F”). Ma la citazione di questo brano è solo un esempio ché tutto l’album merita di essere ascoltato.
 Valentina Ranalli, Enrico Pieranunzi – “Cantare Pieranunzi” – Alfa Music
Valentina Ranalli, Enrico Pieranunzi – “Cantare Pieranunzi” – Alfa Music
Enrico Pieranunzi Quintet – “The Extra Something” – Cam Jazz
Quasi contemporaneamente sono usciti due pregevoli album che vedono impegnato Enrico Pieranunzi. Nel primo – “Cantare Pieranunzi” – il pianista romano si presenta nella triplice veste di leader dello Youth Project (con Giuseppe Romagnoli al basso, Cesare Mangiocavallo alla batteria e Giacomo Serino alla tromba), compositore e arrangiatore. Il tutto al servizio della vocalist Valentina Ranalli. La genesi dell’album è assai particolare e ce la illustra lo stesso Pieranunzi nelle note che accompagnano il CD: in buona sostanza “Cantare Pieranunzi” è il frutto della tesi di laurea in canto jazz presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma di Valentina Ranalli che ha presentato un lavoro incentrato su pezzi del pianista, cui ha aggiunto le parole in italiano, inglese, francese e napoletano. Incuriosito dall’iniziativa e dopo aver ascoltato la vocalist, Pieranunzi decide di mettere il tutto su disco e bene ha fatto dal momento che l’album è di assoluto livello. Le undici tracce contenute nell’album sono interpretati dalla Ranalli con sincera partecipazione dialogando intensamente con il pianoforte di Enrico: si ascolti, ad esempio, “You Know”. Ma è tutta la performance della cantante che convince e che fa ottimamente sperare per il suo futuro; fra i pezzi da segnalare “Suspension points” fatto di poche note ma di tanta emozione, e “Persona” in cui la Ranalli si trova particolarmente a suo agio esprimendosi nella lingua della sua terra, il partenopeo.
 Completamente diverso il secondo album – “The Extra Something” – registrato live il 13 e 14 gennaio 2016 al Village Vanguard da un quintetto che vedeva il pianista romano in compagnia di Diego Urcola tromba e trombone (semplicemente straordinario nella title tracke), Seamus Blake sax tenore (particolarmente convincente in “Atoms”), Ben Street basso e Adam Cruz batteria. E per quanti seguono il jazz non c’è bisogno di altre parole per sottolineare il valore assoluto della band. Valore assoluto che si evidenzia in tutto il repertorio, sette brani tutti composti dal pianista. Pieranunzi, come spesso gli capita, è in uno stato di grazie e conduce il gruppo con mano sicura, del tutto consapevole dell’intesa che ha raggiunto con i compagni di viaggio. Dal punto di vista compositivo non scopriamo certo oggi il suo senso della struttura che mai l’abbandona, per cui se consideriamo tutti questi elementi si capisce bene perché il ben noto Brian Morton abbia incluso Enrico tra “i più significativi musicisti contemporanei”. Nelle note di copertina Pieranunzi dedica espressamente questo terzo CD Live at The Village Vanguard a Lorraine Gordon in memoriam, senza la quale né questo né i precedenti due si sarebbero potuti realizzare. Ricordiamo per inciso che il pianista romano è forse l’unico musicista italiano nella veste di leader ed uno dei pochissimi europei ad aver suonato nel leggendario jazz club a forma di diamante aperto da Max Gordon nel 1935 al 178 Seventh Avenue South di Manhattan.
Completamente diverso il secondo album – “The Extra Something” – registrato live il 13 e 14 gennaio 2016 al Village Vanguard da un quintetto che vedeva il pianista romano in compagnia di Diego Urcola tromba e trombone (semplicemente straordinario nella title tracke), Seamus Blake sax tenore (particolarmente convincente in “Atoms”), Ben Street basso e Adam Cruz batteria. E per quanti seguono il jazz non c’è bisogno di altre parole per sottolineare il valore assoluto della band. Valore assoluto che si evidenzia in tutto il repertorio, sette brani tutti composti dal pianista. Pieranunzi, come spesso gli capita, è in uno stato di grazie e conduce il gruppo con mano sicura, del tutto consapevole dell’intesa che ha raggiunto con i compagni di viaggio. Dal punto di vista compositivo non scopriamo certo oggi il suo senso della struttura che mai l’abbandona, per cui se consideriamo tutti questi elementi si capisce bene perché il ben noto Brian Morton abbia incluso Enrico tra “i più significativi musicisti contemporanei”. Nelle note di copertina Pieranunzi dedica espressamente questo terzo CD Live at The Village Vanguard a Lorraine Gordon in memoriam, senza la quale né questo né i precedenti due si sarebbero potuti realizzare. Ricordiamo per inciso che il pianista romano è forse l’unico musicista italiano nella veste di leader ed uno dei pochissimi europei ad aver suonato nel leggendario jazz club a forma di diamante aperto da Max Gordon nel 1935 al 178 Seventh Avenue South di Manhattan.
 Serena Spedicato – “Io che amo solo te” – Dodicilune
Serena Spedicato – “Io che amo solo te” – Dodicilune
Non sempre la bellezza della confezione corrisponde alla bontà del contenuto. In questo caso, la Dodicilune ha realizzato qualcosa di eccellente affidando alla vocalist Serena Spedicato (utilizzata anche come splendida voce narrante) un repertorio per noi italiani impossibile da dimenticare, all’interno di una confezione sobriamente elegante. In realtà Serena Spedicato e lo scrittore Osvaldo Piliego avevano dato vita a questo loro progetto originale come concerto/spettacolo con la regia di Riccardo Lanzarone, che solo successivamente è approdato alla forma libro/cd. Così la Dodicilune ci presenta un prezioso libretto, con la grafica di Marina Damato, autrice delle foto con Maurizio Bizzochetti, e i testi inediti di Osvaldo Piliego che accompagnano dodici brani tra i più belli e rappresentativi del cantautorato italiano, rielaborati in una forma nuova grazie agli arrangiamenti del fisarmonicista Vince Abbracciante coadiuvato da Nando Di Modugno (chitarra classica) e Giorgio Vendola (contrabbasso). Le canzoni proposte appartengono tutte alla cd. “scuola genovese” vale a dire Luigi Tenco, Fabrizio De André, Gino Paoli, Sergio Endrigo, Umberto Bindi, Bruno Lauzi. In buona sostanza tutto il lavoro ruota attorno ai cantautori che sono cresciuti e si sono formati in quel di Genova, ove sul finire degli anni Cinquanta si sviluppò un movimento culturale e artistico che rivoluzionò il mondo della canzone italiana. Ed è proprio questo clima che si respira ascoltando l’album. Molte le positività del lavoro: le centrate interpretazioni della vocalist che evidenzia una musicalità ed una sensibilità non comuni, i testi intelligenti che aiutano (soprattutto i più giovani) a capire ciò che si ascolta, ma soprattutto gli arrangiamenti di Vince Abbracciante che oramai non ne sbaglia una. Misurarsi con dei veri e proprio mostri sacri della musica non è certo impresa facile: ebbene il fisarmonicista ha affrontato l’impresa con passione e professionalità regalandoci degli arrangiamenti che, senza alcunché togliere al fascino originario, hanno rivestito i brani di una patina jazzistica pertinente ed affascinante. Ovviamente più che positiva anche l’apporto di Nando Di Modugno e Giorgio Vendola per un album di sicuro rilievo.
 Andrés Thor – Hereby – Losen
Andrés Thor – Hereby – Losen
Siamo veramente grati alla norvegese Losen Records per la possibilità che ci offre di far conoscere al pubblico italiano dei veri e propri talenti che, non avendo ancora raggiunto fama internazionale, difficilmente raggiungono le nostre platee. E’ il caso del chitarrista islandese Andrés Thor che, giunto al suo settimo album da leader, si presenta al pubblico alla testa di un trio completato dall’altro islandese Magnús Trygvason Eliassen batteria e dal francese Nicolas Moreaux contrabbasso. Quello di Thor è un fraseggio molto personale, pulito, chiaro, senza alcuna pretesa di sperimentalismo o di sensazionalismo. La sua idea di guidare il trio si avvicina molto alla lezione impartita da Bill Evans con Scott LaFaro. Quindi una formazione che si muove su basi paritetiche in cui ognuno può improvvisare ed esprimere la propria personalità all’interno di una cornice ben delineata dalle nove composizioni tutte a firma dello stesso Thor. Da un punto di vista prettamente chitarristico, Thor è chiaramente ispirato da tre grandi esponenti della chitarra jazz – Jim Hall, John Scofield e Pat Metheny – mentre sotto un profilo più generale tra i suoi maggiori interessi figurano rock band come i Led Zeppelin e i Doors nonché Jimi Hendrix e John Coltrane. Come si nota un universo di riferimento assai ampio che Thor dimostra di aver assorbito molto bene soprattutto nel modo in cui costruisce le sue composizioni, dotate tutte di un eccellente senso architettonico e ben arrangiate. Da sottolineare che mentre nei primi sette brani Andrés utilizza la chitarra elettrica, negli ultimi due imbraccia lo strumento acustico senza che ciò influenzi minimamente l’omogeneità dell’album.
 Mark Turner – “Return From The Stars” – ECM
Mark Turner – “Return From The Stars” – ECM
Registrato a New York nel novembre del 2019, questo album vede impegnato un quartetto piano-less guidato dal sassofonista Mark Turner e completato da Jason Palmer alla tromba, Joe Martin al contrabbasso e Jonathan Pinson alla batteria. L’album si inserisce in quella nuova corrente musicale che si allontana molto dal jazz mainstream per inserirsi in ciò che si può definire “musica moderna” tout court. Ma, a questo punto, qualcuno potrebbe chiedersi: si tratta ancora di jazz? Lasciamo ad altri la risposta a questo inutile quesito per soffermarci su un altro interrogativo molto più pregnante: si tratta di musica di qualità o no? La risposta non può che essere positiva: si, si tratta di musica di qualità dal momento che risponde ad alcuni requisiti facilmente individuabili. Intendiamo riferirci, innanzitutto, alla natura delle composizioni: Turner scrive benissimo, con perfetto senso delle proporzioni, lasciando ad ognuno dei suoi collaboratori il giusto spazio pur essendo comunque in condizione di ricondurre il discorso ad unità; il tutto corroborato dalla capacità di creare una omogeneità di fondo. Ma ciò sarebbe stato inutile se ad interpretare queste complesse partiture non ci fossero stati dei musicisti completi, preparati. Si ascolti, ad esempio, con quanta pertinenza il trombettista segua il leader nelle sue escursioni o di come il batterista riesca ad inserire il suo drumming nelle complesse trame disegnate dal leader mentre il basso non perde un colpo nel supportare il ritmo del gruppo. Insomma un disco tutto da gustare, per palati raffinati.
 Cristina Zavalloni – “Parlami di me” – Egea
Cristina Zavalloni – “Parlami di me” – Egea
“Parlami di me” è il suggestivo titolo di questo nuovo album dedicato alle musiche di Nino Rota, all’anagrafe Giovanni Rota Rinaldi, scomparso nel 1979 e a ben ragione considerato, a livello mondiale, uno dei massimi esponenti dei compositori che hanno dedicato la loro vita al cinema. Basti ricordare le colonne sonore di quasi tutti i film di Fellini nonché le colonne sonore del Padrino e Il padrino – Parte II vincendo, per quest’ultimo, il Premio Oscar alla migliore colonna sonora. Evidentemente il connubio tra jazz e musiche da film non è certo una novità eppure ogni nuovo album del genere va ascoltato con la massima attenzione data la delicatezza della materia. In effetti estrapolare tale musiche dal contesto per cui sono nate e farne un qualcosa a sé stante è impresa tutt’altro che banale. A cimentarsi con questo difficile compito è ora una delle nostre migliori vocalist, Cristina Zavalloni, accompagnata da quattro musicisti di assoluto livello quali Gabriele Mirabassi al clarinetto, Cristiano Arcelli al sax soprano (nonché responsabile degli ottimi arrangiamenti), Massimo Morganti al trombone e Manuel Magrini al pianoforte, cui si aggiunge il ClaraEnsemble, sestetto costituito da flauto, contrabbasso, due violini, viola e violoncello. Un organico, quindi, piuttosto ampio che si attaglia perfettamente sia alla voce della Zavalloni sia agli arrangiamento di Arcelli. La vocalist entra quasi in punta di piedi nell’universo di Nino Rota, ma subito dopo se ne appropria, lo fa suo e lo reinterpreta con chiavi sempre originali pur nulla perdendo dell’originario fascino. Così riascoltiamo alcune perle del Maestro che hanno stupendamente accompagnato le immagini volute dai più grandi registi italiani da Fellini a Visconti, da Wertmuller a Zeffirelli…Il repertorio dell’album si completa con l’unica canzone scritta integralmente, dalla Zavalloni, “Prova tu”, che si integra perfettamente nel discorso generale portato avanti da “Parlami di me”.
Gerlando Gatto
da Amedeo Furfaro | 19/Feb/2022 | Guide all'ascolto, News, Primo piano
Lo scorso 8 febbraio è stato approvato dalla Camera, dopo il Senato, il disegno di legge di riforma costituzionale che prevede fra l’altro un nuovo comma dell’art. 9 della Costituzione che statuisce il rinvio al legislatore ordinario della definizione di modi e forme per la tutela degli animali (oltre che, finalmente, dell’ambiente e non solo del paesaggio).
La riserva di legge è una novità che recepisce i contenuti del Trattato sul Funzionamento UE nel punto di cui all’art. 13 laddove è sancito che “ l’Unione e gli stati membri devono, poiché gli animali sono esseri senzienti, porre attenzione totale alle necessità degli animali”. La senzienza è ora dunque uno status giuridico riconosciuto agli animali nell’ordinamento giuridico italiano. Ed è lo spunto per alcune riflessioni, su queste colonne, su che tipo eventuale di senzienza musicale possa sussistere fra l’ animale e l’uomo.
È il caso anzitutto di sottolineare che diversi compositori si sono ispirati al mondo animale. La fantasia zoologica del Carnevale degli animali di Saint-Saëns è una splendida occasione celebrativa del legame fra uomo e animali attraverso le note. Così dicasi della fiaba Pierino e il lupo di Prokof’ev, che cinquant’anni dopo, nel 1936, “doppia” gli animali con gli strumenti (uccellino/flauto, anatra/oboe, gatto/clarinetto, lupo/corni). Un ventennio ancora ed è Olivier Messiaen a scrivere le partiture pianistiche del Catalogue d’Oiseaux con i canti di uccello classificati, nella prefazione, in gridi, strofe, cadenze-assoli … ciò a otto secoli dal Cantico delle Creature!
Immaginazione, ispirazione, onomatopea. La Animal House offre un campionario di possibili suoni per concerti e dischi.
La primordiale polifonia del Concordu e Tenore di Orosei, coro sardo che ha collaborato fra gli altri con Salis e Sissoko, si fonda sull’armonia di contra (verso della pecora), bassu (imitazione del bue) e mesuvoche (fischio del vento).
Non solo le voci, anche gli strumenti giocano una loro parte. Nel jazz c’è chi, come il sax di Dewey Redman nell’album Look for the Black Star del 1975, produce animaleschi suoni gutturali. O come il percussionista Airto Moreira che usa con Miles Davis la cuica, tamburo ad attrito brasiliano tipico del samba, il cui suono, alle origini, in Africa, era associato al ruggito della leonessa (secondo altri vicino al vocio della scimmia).
Oltre alla aneddotica, la prospettiva può riguardare progetti più ampi e persino trend stilistici.
Il trombettista Wynton Marsalis, in Spaces, ha associato i movimenti della suite affidata alla Lincoln Center Orchestra di volta in volta a galline, leoni, rane…(S. Mohamed, npr.org/2016 ).
Molto prima di lui era stato Ellington a creare nei ’20s il leopardato ed esotico jungle style che ricreava in note le atmosfere della giungla africana. Non solo. Gli animali a volte possono diventare attori in scena.
Nel 1990 fece scalpore, all’Europa Jazz Festival di Noci, una mucca che sfilava davanti al palco durante il concerto del pianista russo Sergey Kuryokhin.
Nei live il compianto leader dei Pop Mekhanika era solito inserire cavalli, oche con bande musicali (come avvenuto nella rassegna pugliese), il tutto per una scena “totale” con situazioni “allargate” bipedi-quadrupedi di spettacolarità circense. Era la sua una maniera follemente geniale di stravolgere l’idea stessa di concerto coinvolgendo nella esibizione esseri viventi presi dall’ambiente circostante, (re)incarnando una tradizione che vede il jazz lasciarsi alle spalle l’accademia per farsi pura performance.
-

-
Sergey Kuryokhin
-

-
Pink Floyd cover
-

-
Il Carnevale degli animali – Camille Saint-Saëns
Gli animali, è notorio, fanno capolino in tanti testi e titoli di brani musicali.
Si sfogli al riguardo la classifica “per mucche” stilata nel 2001 dal “Music Research Group” di Leicester che vede ai primi posti REM, Simon and Garfunkel davanti al Beethoven ovviamente della Pastorale. Senza essere esperti di zoomusicologia si è incuriositi dalla circostanza che grazie alla musica i maiali ingrassino meglio e le pecore producano lana in quantità superiore.
Certamente più che il guardare il “gatto pianista” su YouTube o l’esecuzione “a quattro zampe” su tastiera di una coppia di micetti del tutto speciale od anche la jazz band che suonando “When The Saints” ravvicina a sè un gruppo di vacche al pascolo.
Gesti meccanici, certo. Non è lecito immaginare nella realtà una fattoria degli animali canterina come Nella vecchia fattoria. Tuttavia viene da riflettere sull’accoglienza che, nel nostro immaginario musicale, hanno gli animali. Al punto di redigere graduatorie come “30 Best Horse Songs” (horseillustrated.com) e di dedicare intere cover a mucche tipo Atom Heart Mother , quinto album dei Pink Floyd.
Guardando in dettaglio al repertorio jazzistico si annoverano Silver Swan Rag di Joplin e Tiger Rag della ODJB, Watch Dog, nella versione di Etta James, la Animal Dance del Modern Jazz Quartet, e perché no il sincopato Maramao perché sei morto. Rinviamo comunque alla lettura delle Songs about animals riportate da John Dennis su www.theguardian il 28/4/2011 per un quadro più completo (sarebbe interessante stilarlo anche per le songs italiane, a partire magari da Una zebra a pois).
Nei testi della popular, citazione d’obbligo per The Dog Song di Nellie McKay e per le orecchiabili Felix The Cat e Dolce Lassie, ed ancora da serie tv La canzone di Rin Tin Tin , le varie sigle dell’inossidabile Commissario Rex e nei cartoni animati quella di Titti e (gatto) Silvestro.
Ci sarebbe poi una marea di canzoni “ juniores “– da Johnny Bassotto di Lauzi ad Al lupo al lupo di Dalla, da Occhi di gatto a 44 gatti, e alle varie melodie dedicate ai vari Micio e Fido di casa nostra, molti dei quali, diciamoci la verità, funzionano da antistress per i rispettivi padroni.
Ma la senzienza ci porta infine ad approfondire l’altro “punto di vista” nel rapporto musicale di cui sopra , quello animale.
Esiste un filone di studi, si prenda ad esempio il “Journal of Feline Medicine and Surgery” dell’Università della Louisiana, relativo a ricerche che comprovano le proprietà tranquillizzanti di certa musica nei confronti di cani e gatti. Il film degli Aristogatti aveva visto lontano? In un certo senso si, ma la propensione verso il jazz non è diffusa.
Secondo il “Vet.Journal” dello scorso 19 gennaio, in uno scritto di materia musicoterapica specifico sui gatti, i compositori preferiti sarebbero Bach e Chopin le cui melodie darebbero un effetto calmante nel far superare loro il logorio della moderna vita da cani (e gatti). Una croccante scoperta, questa, in linea con gli esperimenti sulle galline che fanno più uova sentendo Mozart e sulle vacche che, nell’ascoltare sinfonica, producono più latte per come a suo tempo assodato da altri accreditati studiosi statunitensi ed all’esperienza della Muzak Inc. che produceva musica poi diffusa in stalle e pollai.
Alcuni ricercatori hanno spostato il tiro verso reggae e soft rock che, a detta della Scottish SPCA, associazione che collabora con l’università di Glasgow, pare piacciano ai cani (midogguide.com/it/dog) che per contro odierebbero l’heavy metal.
Per tornare al jazz, chissà se, come avvenuto per Elègie di Gabriel Fauret, l’amico animale intra moenia non si senta sopito, sedotto da Bill Evans!
A dire il vero il dailyJournal.net del 13 luglio 2017 ci ha rassicurato al riguardo – “gli animali possono gioire dei suoni smooth del jazz” – nel presentare una serie di concerti allo zoo di Indianapolis. Ma la cronaca giornalistica non è detto combaci con la evidenza scientifica. Sul jazz, a proposito di animali acquatici e suoni del mare, sarebbero gli squali, secondo uno studio australiano pubblicato su “Animal Cognition” ripreso da “National Geographic”, a manifestare “propensione per questo genere musicale” (corriere.it, 21/5/2018).
E David Rothenberg, filosofo compositore e clarinettista jazz, è giunto alla conclusione che “è possibile creare sicuramente un linguaggio di interposizione, anche casualmente jazz, che si raccorda per raccogliere segnali non decifrabili in prima approssimazione” (cfr. E. Garzia, Jazz ed ispirazione “animalista”, percorsimusicali.eu, 1/9/2015).
Resta il fatto che molti risultati scientifici inerenti ai “senzienti” felini e canidi domestici paiono a tutti gli effetti acquisiti. Col timore per i collezionisti che cani e gatti alla fine se ne possano contendere i dischi di jazz a suono di morsi e graffi!
Amedeo Furfaro
 La mattina, appena sveglio – maledetta abitudine – per prima cosa do uno sguardo alla rassegna stampa che mi arriva sul telefonino. E così ho fatto anche stamane; ad un certo punto, ancora non del tutto sveglio, noto la foto di un bell’uomo, giovane. Tra me e me penso: ma questo lo conosco. A poco a poco i neuroni si mettono in moto e lo riconosco, è lui, è Franco e capisco immediatamente: Franco Fayenz se ne è andato in un luogo, per chi ci crede, sicuramente migliore di questa terra.
La mattina, appena sveglio – maledetta abitudine – per prima cosa do uno sguardo alla rassegna stampa che mi arriva sul telefonino. E così ho fatto anche stamane; ad un certo punto, ancora non del tutto sveglio, noto la foto di un bell’uomo, giovane. Tra me e me penso: ma questo lo conosco. A poco a poco i neuroni si mettono in moto e lo riconosco, è lui, è Franco e capisco immediatamente: Franco Fayenz se ne è andato in un luogo, per chi ci crede, sicuramente migliore di questa terra.
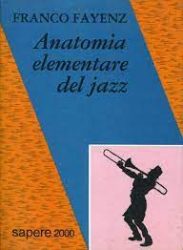
















 Jon Balke Siwan – “Hafla” – ECM
Jon Balke Siwan – “Hafla” – ECM Flavio Boltro, Fabio Giachino – “Things to Say” – Cam Jazz
Flavio Boltro, Fabio Giachino – “Things to Say” – Cam Jazz Avishai Cohen – “Naked Truth” – ECM
Avishai Cohen – “Naked Truth” – ECM Claudio Cojaniz – “Orfani” – Caligola
Claudio Cojaniz – “Orfani” – Caligola Lorenzo De Finti Quartet – “Mysterium Lunae” – Losen
Lorenzo De Finti Quartet – “Mysterium Lunae” – Losen Joey DeFrancesco – “More Music” – Mack Avenue
Joey DeFrancesco – “More Music” – Mack Avenue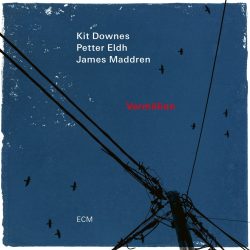 Kit Downes – “Vermillion” – ECM
Kit Downes – “Vermillion” – ECM Mathias Eick – “When We Leave” – ECM
Mathias Eick – “When We Leave” – ECM Antonio Flinta – “Secrets of a Kiri Tree” – Autoprod.
Antonio Flinta – “Secrets of a Kiri Tree” – Autoprod. Tord Gustavsen – “Opening” – ECM
Tord Gustavsen – “Opening” – ECM Roberto Laneri – “Musica finta / Blue Prints” – Da Vinci Classics
Roberto Laneri – “Musica finta / Blue Prints” – Da Vinci Classics “South of No Border” (come si diceva registrato tra il 2014 e il 2018 ma anch’esso pubblicato poche settimane fa) vede Roberto Laneri (clarinetto, clarinetto basso, sax sopranino, sax soprano e alto, didjeridoo, shruti box, voce e percussioni) alla testa di un gruppo comprendente Giuppi Paone voce, Raffaela Siniscalchi voce, Eleonora Vulpiani chitarra, Luigi Polsini contrabbasso e Laugi Marino zarb. Contrariamente al primo album, in questo caso il repertorio è come una sorta di finestra affacciata sulle musiche del mondo. Ecco, quindi, dopo l’apertura affidata alle melodie orientaleggianti di “Malia” (scritta da Laneri), il choro brasiliano “Tico-Tico no fubá” (scritto da Zequinha de Abreu nel 1917, accanto al bolero cubano “Contigo En La Distancia” scritto dal cantautore César Portillo de la Luz quando aveva 24 anni nel 1946, il tutto impreziosito da 4 original del leader. A confronto con un tale repertorio, Laneri dà ancora una volta prova non solo della sua indiscussa preparazione tecnica ma anche della profonda conoscenza del panorama musicale internazionale. Le sue interpretazioni risultano, quindi, assolutamente pertinenti: traendo feconda ispirazione da svariate tradizioni, riesce a produrre una sintesi che non conosce confini geografici grazie ad una concezione visionaria della musica senza barriere. Insomma un disco originale nella concezione e nell’esecuzione.
“South of No Border” (come si diceva registrato tra il 2014 e il 2018 ma anch’esso pubblicato poche settimane fa) vede Roberto Laneri (clarinetto, clarinetto basso, sax sopranino, sax soprano e alto, didjeridoo, shruti box, voce e percussioni) alla testa di un gruppo comprendente Giuppi Paone voce, Raffaela Siniscalchi voce, Eleonora Vulpiani chitarra, Luigi Polsini contrabbasso e Laugi Marino zarb. Contrariamente al primo album, in questo caso il repertorio è come una sorta di finestra affacciata sulle musiche del mondo. Ecco, quindi, dopo l’apertura affidata alle melodie orientaleggianti di “Malia” (scritta da Laneri), il choro brasiliano “Tico-Tico no fubá” (scritto da Zequinha de Abreu nel 1917, accanto al bolero cubano “Contigo En La Distancia” scritto dal cantautore César Portillo de la Luz quando aveva 24 anni nel 1946, il tutto impreziosito da 4 original del leader. A confronto con un tale repertorio, Laneri dà ancora una volta prova non solo della sua indiscussa preparazione tecnica ma anche della profonda conoscenza del panorama musicale internazionale. Le sue interpretazioni risultano, quindi, assolutamente pertinenti: traendo feconda ispirazione da svariate tradizioni, riesce a produrre una sintesi che non conosce confini geografici grazie ad una concezione visionaria della musica senza barriere. Insomma un disco originale nella concezione e nell’esecuzione. Roberto Magris – “Match Point” – JMood / Roberto Magris – “Duo & Trio” – JMood
Roberto Magris – “Match Point” – JMood / Roberto Magris – “Duo & Trio” – JMood Dino & Franco Piana Ensemble – “Reflections” –Alfa Music
Dino & Franco Piana Ensemble – “Reflections” –Alfa Music Valentina Ranalli, Enrico Pieranunzi – “Cantare Pieranunzi” – Alfa Music
Valentina Ranalli, Enrico Pieranunzi – “Cantare Pieranunzi” – Alfa Music Completamente diverso il secondo album – “The Extra Something” – registrato live il 13 e 14 gennaio 2016 al Village Vanguard da un quintetto che vedeva il pianista romano in compagnia di Diego Urcola tromba e trombone (semplicemente straordinario nella title tracke), Seamus Blake sax tenore (particolarmente convincente in “Atoms”), Ben Street basso e Adam Cruz batteria. E per quanti seguono il jazz non c’è bisogno di altre parole per sottolineare il valore assoluto della band. Valore assoluto che si evidenzia in tutto il repertorio, sette brani tutti composti dal pianista. Pieranunzi, come spesso gli capita, è in uno stato di grazie e conduce il gruppo con mano sicura, del tutto consapevole dell’intesa che ha raggiunto con i compagni di viaggio. Dal punto di vista compositivo non scopriamo certo oggi il suo senso della struttura che mai l’abbandona, per cui se consideriamo tutti questi elementi si capisce bene perché il ben noto Brian Morton abbia incluso Enrico tra “i più significativi musicisti contemporanei”. Nelle note di copertina Pieranunzi dedica espressamente questo terzo CD Live at The Village Vanguard a Lorraine Gordon in memoriam, senza la quale né questo né i precedenti due si sarebbero potuti realizzare. Ricordiamo per inciso che il pianista romano è forse l’unico musicista italiano nella veste di leader ed uno dei pochissimi europei ad aver suonato nel leggendario jazz club a forma di diamante aperto da Max Gordon nel 1935 al 178 Seventh Avenue South di Manhattan.
Completamente diverso il secondo album – “The Extra Something” – registrato live il 13 e 14 gennaio 2016 al Village Vanguard da un quintetto che vedeva il pianista romano in compagnia di Diego Urcola tromba e trombone (semplicemente straordinario nella title tracke), Seamus Blake sax tenore (particolarmente convincente in “Atoms”), Ben Street basso e Adam Cruz batteria. E per quanti seguono il jazz non c’è bisogno di altre parole per sottolineare il valore assoluto della band. Valore assoluto che si evidenzia in tutto il repertorio, sette brani tutti composti dal pianista. Pieranunzi, come spesso gli capita, è in uno stato di grazie e conduce il gruppo con mano sicura, del tutto consapevole dell’intesa che ha raggiunto con i compagni di viaggio. Dal punto di vista compositivo non scopriamo certo oggi il suo senso della struttura che mai l’abbandona, per cui se consideriamo tutti questi elementi si capisce bene perché il ben noto Brian Morton abbia incluso Enrico tra “i più significativi musicisti contemporanei”. Nelle note di copertina Pieranunzi dedica espressamente questo terzo CD Live at The Village Vanguard a Lorraine Gordon in memoriam, senza la quale né questo né i precedenti due si sarebbero potuti realizzare. Ricordiamo per inciso che il pianista romano è forse l’unico musicista italiano nella veste di leader ed uno dei pochissimi europei ad aver suonato nel leggendario jazz club a forma di diamante aperto da Max Gordon nel 1935 al 178 Seventh Avenue South di Manhattan. Serena Spedicato – “Io che amo solo te” – Dodicilune
Serena Spedicato – “Io che amo solo te” – Dodicilune Andrés Thor – Hereby – Losen
Andrés Thor – Hereby – Losen Mark Turner – “Return From The Stars” – ECM
Mark Turner – “Return From The Stars” – ECM Cristina Zavalloni – “Parlami di me” – Egea
Cristina Zavalloni – “Parlami di me” – Egea









