da Danilo Blaiotta | 15/Mag/2023 | News, Primo piano
Si dice che lo strumento musicale più vicino alla voce umana sia il violoncello. Questione di frequenze, di timbro, di oscillazione. Certamente. Un sassofono è un’altra cosa: non è dalle frequenze che si misura la voce umana del sassofono, ma dalla profondità e dall’intensità dell’espressione del linguaggio ad esso abbinato. Si comunica il cosa, che influenza certamente anche il come. Parlare Jazz, come parlare inglese, o spagnolo. Il jazz è l’idioma perfetto per la dolcezza e la sofferenza, per la morbidezza e l’urlo. I contrasti dell’Uomo del ‘900 ritrovano in questa musica una lingua imprescindibile, autentica, deliziosa-gentile-cattiva. Il demoniaco ed il paradisiaco in un corpo solo. Un po’ come ritroviamo in alcune partiture leggendarie dell’800 romantico. Certo. Cosa è cambiato dunque? Semplicemente questa volta non vi è premeditazione nella descrizione umana, vi è altresì estemporaneità, quella stessa del linguaggio parlato. Come facile deduzione di questo ragionamento, possiamo dunque parlare di rassomiglianza del romanticismo all’uomo riflessivo e forse scrivente, più che parlante. Il jazz sarebbe dunque lo strumento più straordinariamente simile alla parola, poiché essa stessa, in qualsiasi idioma, è frutto di miscellanea improvvisazione su di un bagaglio contenente gli strumenti necessari al linguaggio stesso.
Il sassofono non è dunque, per frequenze e timbro, lo strumento dal suono più simile all’umana dannazione. Il sassofono quando suona del jazz però, spesso lo è. Massimo Urbani quando soffia nel sax alto, lo è più di chiunque altro.
Nato a Roma nel quartiere di Monte Mario l’8 maggio 1957, ascolta la prima banda di paese in villeggiatura estiva nei pressi di Ladispoli, la Riccione degli anni ’60 per i romani. Secondo Maurizio Urbani, fratello di 4 anni più piccolo e grande tenorista, tutto partì da una di quelle vacanze con i nonni tant’è che, tornati a Roma, gli comprarono un clarinetto. Aveva 11 anni.
La serie di circostanze che accaddero da lì ai successivi 3 anni sembrano uscite da una sceneggiatura a metà tra il cinema neorealista e la follia felliniana. Massimo suona nella banda di Monte Mario, ascolta i racconti del suo parente Luciano Urbani (che grazie al padre in quel periodo assisteva alle mitiche edizioni di Jazz Concerto di Adriano Mazzoletti alla RAI), ascolta i dischi di Charlie Parker del padre (che non era musicista, faceva l’infermiere a Santa Maria della Pietà) e frequenta la casa del compianto sassofonista Tony Formichella, che gli fa ascoltare i primi dischi di rhythm’n’blues e di jazz e lo porta alle prime jam session romane.
Tutto torna? No, se il risultato è che, a soli 14 anni in un quartiere popolare di Roma, senza quasi sapere cosa fosse un conservatorio di musica, Massimo improvvisava come fosse stato la reincarnazione di Parker.
Roma degli anni ’70 viveva un fermento musicale di altissimo livello. Tra le tante iniziative che segnarono la vita di tutti i più importanti musicisti di allora e dei successivi decenni, voglio citarne due di fondamentale importanza: l’apertura nel 1971 del Music Inn da parte di Pepito e Picchi Pignatelli, e il corso sperimentale di Jazz che partì, grazie a Giorgio Gaslini, al Conservatorio Santa Cecilia. Gli esterni al Conservatorio potevano partecipare al corso solamente da uditori: in quel periodo Massimo Urbani e Maurizio Giammarco si iscrissero. Gaslini permise l’iscrizione agli esterni poiché affermò che, se avessero richiesto il diploma a Louis Armstrong o a Ella Fitzgerald, non avrebbero potuto partecipare ad un corso di jazz (comprendendo da subito dunque la difficile, già dal principio, coesistenza dello studio del jazz a livello accademico).
Gli albori di Massimo Urbani, fondamentali per capire le basi di tutta la sua vita musicale.
-

-
Massimo Urbani
-

-
Massimo Urbani
Max suonava dunque il bop come un demonio, ma frequentava l’avanguardia di Gaslini e il free di Mario Schiano con cui registrò ad esempio, a soli 16 anni, il suo primo album in studio. La fama di questo incredibile ragazzino vestito da bopper navigato arrivò al grande trombettista Enrico Rava, il quale andò a Roma apposta per sentirlo suonare. Nel 1976 lo portò in tour negli States. Intervistai Rava su Urbani qualche anno fa, il quale mi raccontò: “In tutte le jam session newyorkesi Massimo faceva fuori tutti gli altri sassofonisti uno dopo l’altro, non c’era partita”. Ma Max era pur sempre un ragazzo poco più che adolescente di Monte Mario. Celebre fu l’episodio in cui, pieno di vergogna per aver rotto un registratore in casa del trombettista, sparì per due notti dormendo al Central Park e tornò, poco prima di un’esibizione per la TV americana, con la febbre alta e senza vestiti da poter indossare. Massimo Urbani era un puro, non aveva filtri e non apparteneva di certo a quel mondo borghese che, volenti o nolenti, stava già risucchiando le energie della musica afroamericana trasformandola successivamente in qualcosa di eccessivamente elitario. Max incarnava la purezza di alcuni leggendari personaggi che avevano letteralmente segnato la storia di questa musica. Intendiamoci, non sto assolutamente cavalcando cliché sull’artista maledetto, sul genio squattrinato o incompreso, sulla rivalsa di questa musica come riscossa dei ceti popolari. Penso invece che la storia del jazz si sia attorniata di figure provenienti dal mondo popolare quanto da quello borghese e che sia stato proprio questo connubio, democraticamente, a far arrivare alle nostre orecchie capolavori senza tempo. Certamente però, oggigiorno, non possiamo far finta di non notare quanto questa musica si sia eccessivamente imborghesita, negli ambienti più che nelle note, perdendo talvolta uno spirito divulgativo e spensierato che si poteva ritrovare, ad esempio nel blues e nella musica nera, tra le fasce sociali più deboli.
La più celebre frase di Urbani, detta spontaneamente e senza giri di parole “L’avanguardia è nei sentimenti”, sintetizza tutto il mio discorso nel modo più alto e semplice possibile.
Tra la fine degli anni ’70 e per tutti gli anni ‘80 Massimo Urbani, pur rimanendo un ragazzo di quartiere, divenne dunque un sassofonista di successo richiesto in lungo e in largo, sia come leader che come sideman. Cresciuto nell’epoca della sperimentazione, la frase sopra citata è la sua risposta a chi gli chiede il motivo dell’essersi allontanato, all’apice della sua carriera, dal free e dalle cosiddette avanguardie che egli aveva ben conosciuto ad esempio con Rava o ancor di più con Schiano e Gaslini. Max riscopre il bop ma lo fa da musicista navigato e colmo di moltitudini di esperienze: oltre al suo ruolo nel periodo free lo ritroviamo ad esempio, seppur brevemente, a fianco degli Area nel jazz-rock come addirittura in un disco della Nannini. Non è il suo mondo però. Non lo è nemmeno il bop, in realtà. Massimo Urbani è Massimo Urbani.
Lo sanno bene anche i numerosi artisti internazionali con cui collabora (attorniato da tutti coloro che sono stati protagonisti attivi del periodo più incredibile della storia del jazz italiano). Qualche nome: da Chet Baker a Steve Grossman, da Mike Melillo a Red Rodney, da John Surman a Jack DeJohnette, da Lester Bowie a Kenny Wheeler, da Steve Lacy ad Art Farmer. Con Enrico Rava poi, lo ricordiamo accompagnato dalle ritmiche Hill/Astarita e dal celebre tandem norvegese Daniellson e Christensen negli stessi anni in cui registravano nel quartetto europeo di Keith Jarrett e Jan Garbarek.
Tra gli album a suo nome particolarmente di impatto vi sono certamente “Urlo” con Massimo Faraò, Pietro Leveratto e Gianni Cazzola e ancor di più “Easy to love” con Furio di Castri e Roberto Gatto alla ritmica ed un indimenticabile Luca Flores al pianoforte. Ricordando in un’intervista con Roberto Gatto questo album, Roberto mi faceva notare (a ragione) come Flores anticipi il modo di suonare di Brad Mehldau di almeno un decennio; fu un incontro tra solisti immensi, due giganti, che per uno strano scherzo del destino non abitano più entrambi su questa Terra.
Altri album che hanno destato la mia attenzione sono “Via G.T.” di Giovanni Tommaso del 1987 con Danilo Rea, Paolo Fresu e Roberto Gatto (da cui un celebre tour newyorkese) e “The Blessing”, ultimo disco in studio a suo nome registrato nel febbraio 1993, pochi mesi prima della sua scomparsa, praticamente con la stessa formazione di Via G.T. ad eccezione del solo Paolo Fresu e con l’aggiunta di Maurizio Urbani al sax tenore, prodotto dallo stesso Roberto Gatto.
L’epilogo arrivò nel giugno del 1993, dopo una storica settimana all’Alexander Platz Jazz Club di Roma per quelli che furono gli ultimi concerti ufficiali (ben documentati nel disco live che ne seguì) di Max, in compagnia di Andrea Beneventano, Dario Rosciglione, Gegè Munari e con ospite Red Rodney.
Fu proprio all’Alexander Platz che, nel marzo 2020, decisi di fare un grande omaggio a Massimo in quella che fu una storica diretta radiofonica di quasi 3 ore, con protagonisti racconti e musica partoriti da buona parte di coloro che collaborarono con lui. Per chi volesse riascoltare quella mitica puntata andata in onda sull’emittente Radio Città Aperta, mi permetto di allegare qui il podcast integrale.
https://www.radiocittaperta.it/podcast/speak-low-con-danilo-blaiotta-del-03-03-2020/
In questo sintetico ma sentito racconto della gigantesca carriera di Massimo Urbani, non ho volutamente citato i suoi noti problemi legati all’eroina, che portarono a quella maledetta notte tra il 23 e il 24 giugno 1993. Per chi avesse qualche dubbio, vorrei fortemente sottolineare che la musica di Max non è legata al suo essere alterato dagli effetti delle droghe. Massimo Urbani era libertà ma grande attinenza e precisione ritmica, era dotato di un orecchio bionico come di un senso del timing fuori dal normale. La musica di Max era lucida, limpida, oserei dire “nonostante” gli eccipienti, e non “grazie a”.
Il cliché del musicista che altera le proprie condizioni per suonare meglio ed in modo più ispirato la musica ed in particolare il jazz, è totalmente distante dall’universo di Urbani. Max era libero ma musicalmente lucido, come gran parte dei musicisti che hanno fatto uso di droghe, nel bop newyorkese dei favolosi anni ’40 come successivamente nell’Europa di fine anni ’60, e poi nel trentennio successivo.
Massimo Urbani era libero, limpido e brillava di luce luminosa: le note del suo sax alto scintillavano tanto su un fast quanto su un’improvvisazione libera. Alle volte gridava, si, con gli armonici, forse come avrebbe voluto gridare una sua qualche insicurezza legata alla vita reale? Non ci è dato saperlo e non ci deve nemmeno interessare. Che ci interessi, invece, l’emozione di quell’urlo come di quelle scale vorticose. Che ci interessi il canto meraviglioso dell’improvvisazione su ‘Lover Man’, uscito dal soffio di Max come dall’ugola di una Maria Callas vestita di ance e adornata di chiavi.
Vediamoci ciò che vogliamo, ma forse, più di ogni altra cosa, il sentimento di un artista profondo come pochi, vero come pochi, talentuoso come pochi, nella storia di questa straordinaria musica che tutti noi continuiamo a voler, imperterriti e forse anche un po’ contro ogni razionalità, portare avanti.
Danilo Blaiotta
da Marina Tuni | 10/Mag/2023 | Interviste, News, Primo piano
Si dice che nella botte piccola si conserva il vino più buono e in quel di Staranzano, piccola località di settemila anime in Friuli-Venezia Giulia, nella provincia di Gorizia, nella botte ci hanno messo appunto un delizioso e prezioso Festival dell’Acqua, con trenta appuntamenti in quattro giorni, dall’11 al 14 maggio, e di cui sentiremo sicuramente parlare a lungo (https://acquafestival.it/ ).
Tanti sono i motivi per pensare di collocare a Staranzano un concept-festival dedicato a questo prezioso elemento, principio ordinatore del mondo: in primis perché nel suo territorio s’incontrano armoniosamente le acque del mare, dei fiumi, della laguna e quindi perché non seguire il loro corso in un fluire di talk scientifici, performance teatrali, percorsi di ricerca, concerti, laboratori, eventi espositivi, escursioni e incontri letterari?
Detto fatto!
In questa prima edizione, trova spazio anche la musica jazz in una delle sue massime espressioni contemporanee: il grande pianista ed improvvisatore Danilo Rea, che si esibirà sabato 13 maggio (ore 21) alla Sala Pio X (ingresso libero su prenotazione al link: https://acquafestival.it/danilo-rea-in-concerto/ )
Di Danilo si potrebbero scrivere interi trattati, avendo egli suonato con il gotha del jazz, della classica, del pop, in una lunghissima carriera iniziata ai tempi del liceo classico con un gruppo dal bizzarro nome “Gigi sax e il suo complesso”! Celie a parte, dopo gli studi di pianoforte classico al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, un debutto nell’universo progressive rock con i New Perigeo e successivamente nel mondo del jazz, a partire dal 1975, con il Trio di Roma, Rea raggiunge una popolarità internazionale e collabora con artisti quali Chet Baker, Lee Konitz, Steve Grossman, Michael Brecker, Tony Oxley, Joe Lovano, Gato Barbieri, Aldo Romano, Brad Mehldau, Danilo Pérez, Luis Bacalov (e sono solo alcuni…) e in Italia con Mina, Pino Daniele, Claudio Baglioni, Gino Paoli, Domenico Modugno; senza dimenticare il sempervirens progetto Doctor 3, un unicum nel panorama musicale italiano per aver saputo rileggere il pop in chiave jazz con grande sapienza (Pietropaoli, Rea, Sferra, recentemente intervistati per noi da Daniele Mele http://www.online-jazz.net/?s=doctor+3 ).
A Staranzano, il pianista romano eseguirà un affascinante repertorio dedicato all’acqua, in piano solo. Comunque, trattati a parte, se desiderate scoprire chi è davvero Danilo Rea, leggete il suo bellissimo libro-biografia “Il Jazzista Imperfetto”, scritto a quattro mani con Marco Videtta (Rai Libri).
–MT: parto innanzitutto con una mia curiosità personale: posto che non ho dubbi che il repertorio da te scelto e dedicato all’acqua rappresenterà – almeno per me – una “sovrapposizione sensoriale”: hai presente la sinestesia… ascoltare la tua musica e udire un colore, insomma… sensazioni così? Mi viene in mente “La Mer” di Debussy con quegli accordi che si rincorrono e gli occhi che si riempiono di tutte le sfumature del blu… e vedi il movimento ininterrotto delle onde del mare, fino a sentirlo dentro di te.
Puoi anticipare ai nostri lettori che cosa hai elaborato per raccordare l’elemento sonoro a questo elemento naturale, così prezioso per la vita sulla terra?
DR: Il tuo riferimento a Debussy mi sembra di grande ispirazione, non a caso qualche anno fa registrai per prova una improvvisazione pianistica proprio su quel brano.
Si l’acqua, la marea, il suono della pioggia, delle onde che si infrangono, è Musica! Spesso mi addormento con suoni d’acqua…
Per il concerto di Staranzano ho in mente una serie di temi come Moon River di Mancini, Wave di Jobim, Caruso e 4/3/1943 di Dalla, Sapore di Sale dell’amico Gino Paoli, per continuare con Bridge over Troubled Water di Simon e Garfunkel e tanti altri.
Vedremo come riuscirò a legarli insieme durante l’improvvisazione nel concerto stesso.
–MT: la melodia è un po’ come l’acqua, va lasciata libera di scorrere perché il suo movimento è evoluzione, apertura mentale e desiderio di conoscenza. Tu sei un poeta dell’improvvisazione e conosco pochi musicisti che come te rispettano la melodia anche nel processo improvvisativo; inoltre hai creato un nuovo idioma espressivo nel piano solo. Forse il tuo segreto è che tu non suoni mai in modo auto-referenziale ma unicamente per suscitare emozioni in chi ti ascolta?
DR: si, suono per scambiare emozioni con chi mi ascolta, altrimenti non ci sarebbe motivo per suonare!
Suono giocando sempre attorno alla melodia, proprio perché nel piano solo godo di totale libertà e posso uscire dal concetto di tema e conseguente assolo.
Entro ed esco dal brano in piena libertà, come in un sogno, una cascata di note che partono sempre da un tema a me caro, forse caro anche a chi ascolta.
-

-

–MT: attraverso la tua musica hai la rara capacità di raccontare storie sorprendenti; il tuo è un pianismo che, se me lo concedi, definirei antinomico… ovvero fatto di continui contrasti, dolcezza e irruenza, lirismo e carattere, il calore della passione e la precisione della tecnica e ogni qualvolta io abbia ascoltato un tuo concerto, partendo da un’idea che mi ero fatta su quello che avrei potuto sentire, puntualmente, alla fine, mi sono sempre ritrovata piacevolmente spiazzata. Passi dai Beatles a Verdi, da Chopin ai Rolling Stones, da Bernstein a De André ed è strano, perché si ha la netta impressione che quei brani siano stati composti ad hoc per il tuo pianoforte.
Cos’è? Forse la conseguenza del tuo modo estemporaneo – e mai asservito ad alcuna imposizione stilistica – di approcciarti alla musica?
DR: credo che dai contrasti esca la musica, che non esista un pianissimo senza un fortissimo e che nell’improvvisare un intero concerto ci sia bisogno di avere una capacità di regia estemporanea, in maniera tale da creare tensione e rilassamento, per calmarsi, sognare e poi ripartire al galoppo.
Un buon improvvisatore non deve accontentarsi di essere bravo nella struttura dell’improvvisazione, deve andare oltre, guardare il brano come parte di un mosaico che dura l’intero concerto, come un racconto nel quale la melodia guida le emozioni. È come se tutta la musica del mondo avesse una matrice comune, Beatles, Puccini, De Andrè, prendendo le loro melodie e suonandole al pianoforte a modo mio, nel bene e nel male, si ritrovano unite.
–MT: tempo fa lessi una tua intervista dove dicevi che i grandi musicisti classici del passato erano soliti improvvisare e che tu e Ramin Bahrami (insieme hanno realizzato il meraviglioso album “Bach is in the Air – N.d.A) non vi siete limitati a rileggere Bach né l’avete toccato ma avete “aggiunto”. Vista la già incredibile complessità dell’armonia bachiana e le sue invenzioni contrappuntistiche, ci spieghi che cosa tu e Bahrami avete inteso per “aggiungere”?
DR: con Bahrami è venuto tutto naturale, grazie alla sua fiducia nelle mie improvvisazioni che lui definisce in stile Bachiano: lui suona ed interpreta la partitura originale.
In pratica abbiamo aggiunto l’improvvisazione alla partitura, cosa credo mai fatta. In genere i jazzisti hanno sempre portato la musica di Bach a tempo di swing, quindi riarrangiandola completamente…
Questa operazione è molto delicata, tenendo conto della perfezione della scrittura di Bach, ma l’abbiamo fatta nel rigoroso rispetto della musica del Maestro di Lipsia.
D’altronde Bach era un grande improvvisatore e forse non sarebbe male se i giovani musicisti classici ripristinassero nel loro corso di studi l’arte dell’improvvisazione.
–MT: cosa pensi di quanti, con riferimento ad alcuni cantanti di musica leggera che hanno voluto in qualche modo rivolgersi al jazz, criticano questa scelta ritenendola opportunistica e priva di qualsivoglia motivazione artistica?
DR: rispondo che sono anni che mi criticano per questo, ma seguo il cuore; improvviso su ciò che mi piace, senza preconcetti, ovvero, intendo dire che io stesso ho avuto critiche nel senso opposto, perché amavo improvvisare su un repertorio pop… trovo invece che sia una scelta reciprocamente utile, perché c’è tanto da imparare da ambo le parti!
–MT: infine, so che sei un grande appassionato di motociclette, credo di aver letto che ne possiedi una decina. Verrai nella mia meravigliosa terra di acque, vento, arte, vini e cibi eccellenti con quel mezzo?
Scherzo, naturalmente, sebbene sia convinta che tu potresti anche farlo! Ti è rimasto qualcosa delle volte in cui sei venuto in Friuli-Venezia Giulia? Ricordo vividamente le tue performance a Udine con Tavolazzi e a Grado con Biondini.
DR: verrò in treno ma spesso viaggio verso i concerti in moto.
Il contatto con l’esterno, con l’aria, con la pioggia che cambia l’odore dell’asfalto, il caldo, il freddo, li puoi godere e subire solo in moto… però sono sensazioni forti che restano dentro, come d’altronde la vostra bellissima Regione.
Marina Tuni ©
da Gerlando Gatto | 14/Apr/2023 | News, Primo piano
Chi abita in Italia ed ama il jazz non può non aver incontrato, almeno una volta nella vita, le straordinarie foto di Silvia Lelli e Roberto Masotti la coppia, – nella vita e nel lavoro – di fotografi ravennati di nascita e milanesi d’adozione, che ha saputo raccontare il mondo delle performing arts e della musica attraverso la sensibilità del loro sguardo.

Silvia Lelli e Roberto Masotti
Purtroppo Masotti ci ha lasciati nell’aprile dello scorso anno all’età di 75 anni, dopo una malattia che l’aveva colpito più di un anno fa, ma il suo ricordo è ben presente nel mondo del jazz.
Benissimo ha fatto, quindi, l’Associazione Tempi Moderni a organizzare la mostra SGUARDI che fino al 4 giugno abiterà le stanze e i saloni di Palazzo Fruscione (Salerno). Curata da Silvia Lelli la mostra SGUARDI racchiude le opere frutto di oltre 40 anni di carriera della stessa Lelli e di Roberto Masotti. Si tratta di una produzione davvero estesa e di eccezionale livello tanto da essere dichiarata dal Ministero dei Beni Culturali, nel 2018, “bene di interesse storico”.
La mostra si suddivide in tre sezioni: Musiche/Kontakthof-Kontrapunkt/Nucleus che a Palazzo Fruscione saranno declinate nei tre piani.
Musiche (fotografie di Lelli e Masotti). In questa sezione si scava nell’archivio di Lelli e Masotti che, come scriveva Domenico Piraina, direttore di Palazzo Reale di Milano che nel 2019 ospitò la grande mostra, è una miniera inesauribile di conoscenza e di memoria che consente di ricostruire e rivivere quasi mezzo secolo di storia del teatro, della musica, della danza, di performing arts, di vedere “all’opera” migliaia di personalità, di avere una visione puntuale anche dei cambiamenti sociali e culturali che si sono verificati. Una sezione composta da 109 fotografie e un’installazione video dal titolo Musiche Revisited.
Kontakthof- Kontrapunkt (fotografie di Silvia Lelli). La sezione è composta da 20 opere fotografiche e ripercorre la storia di 3 rappresentazioni in 30 anni, del celebre lavoro dedicato alla complessità dei rapporti uomo-donna della coreografa e regista tedesca Pina Bausch. Leonetta Bentivoglio, così descrive il lavoro della Lelli: Le foto che rappresentano il frutto del viaggio di Silvia attraverso i tre “Kontakthof”, definite da una beltà essenziale e vigorosa, mai affettata o patinata, ci danno un’ottica in più sulla sostanza di quella specie di monumento al teatrodanza che è lo spettacolo di Pina nato nel ‘78. Lo sguardo della fotografa non si limita a registrare l’attimo, ma ce lo fa vedere tramite il filtro di una sensibilità per così dire “aggiuntiva”.
Nucleus (fotografie di Roberto Masotti). La sezione è un omaggio al lavoro di Roberto Masotti e al suo rapporto di lungo corso, professionale e umano, con il cantautore catanese Franco Battiato, scomparso nel maggio 2021. L’esposizione è una anteprima internazionale e si compone di 16 scatti, che, come scrive Carlo Maria Cella, sono un viaggio nel tempo, dai primi anni 70, in cui Battiato si forma e si afferma nel mondo della musica, fino al 1997 dei grandi concerti, in cui i fan di quasi tre generazioni, comprese alcune nemmeno nate quando certe canzoni erano state scritte, lo innalzano nel cielo delle stelle fisse.
Unitamente all’esposizione per il settimo anno ritornano i Racconti del Contemporaneo: ASCOLTI. Parole/Note/Suoni/Visioni. L’idea, nel solco del format consolidato delle ultime sei edizioni, è quella di promuovere, all’interno di Palazzo Fruscione, eventi gratuiti di approfondimento della tematica generale affrontata nella mostra di quest’anno. Il calendario della VII Rassegna dei Racconti del Contemporaneo prevede talk, concerti ed incontri musicali e il consueto ciclo di cinema d’essai, con presentazioni d’autore, della domenica pomeriggio. Ad aprire quest’ultima sezione la proiezione (domenica 16 aprile – ore 19) la storica pellicola di Herzog, “Fitzcarraldo”. Ma le Visioni domenicali a Palazzo Fruscione prevedono anche la proiezione de “Il Concerto”; “Pina”; “Birdman”; “La sera della prima”; “Il cigno nero”; “New York, New York”.
Tra i vari appuntamenti, da segnalare infine che, nella giornata del 24 aprile dedicata al primo anniversario dalla scomparsa di Roberto Masotti, si esibiranno il sassofonista Roberto Ottaviano, il violoncellista, esperto di sonorizzazione ambientale, Walter Prati e il Carla Marciano Quartet. Infine per la sezione Note il giornalista e critico musicale, Riccardo Bertoncelli ha immaginato cinque appuntamenti legati a cinque dischi storici in perfetto dialogo con le fotografie di Roberto Masotti. Dagli Area a Keith Jarrett passando per Battiato, John Cage e Philip Glass.
Gerlando Gatto
da Amedeo Furfaro | 23/Feb/2023 | I nostri CD, News, Primo piano, Recensioni
Il 4et, nel jazz, è una formazione intermedia fra solisti/ combo e gruppi più nutriti nonché ensembles ed orchestre. Una “centralità” che garantisce sia snellezza che ricchezza di suoni oltre comunque ad una completezza che dipende dalla gamma strumentale e dalle caratteristiche dei musicisti. A seguire segnaliamo una sestina di nuovi dischi di “band dei quattro” dai quali emerge varietà di proposte e combinazioni. Il 4 non sarà un numero perfetto ma a guardare la storia del jazz verrebbe da pensare che certi postulati sulla presunta imperfezione sono … imperfetti. Oltretutto il quattro in numerologia simboleggia realtà concretezza solidità nonché la precisione del quadrato e il senso del moto che dà il quadrilatero; ed ancora i quattro punti cardinali est ovest nord sud i quali orientano tanto jazz in circolazione.
 Del Piano/Olivieri/Mazza/Marini, Double 3, Caligola Records
Del Piano/Olivieri/Mazza/Marini, Double 3, Caligola Records
L’album Double 3 (Caligola) è a nome di quattro musicisti in quanto trattasi per così dire di un disco-matrioska. Dalla quaterna di jazzisti che vi concorrono infatti vengon fuori due trii avant-garde dalla stessa asse (più che sezione) ritmica, con Roberto Del Piano al basso elettrico e Alberto Olivieri alla batteria nonché all’ alto e voce Cristina Mazza nei brani “Cane di sabbia”, “Forgotten Names”, “Beauty is A Rare Thing” di Ornette Coleman e “Double Moon”nonché il baritono/flauto/piano di Bruno Marini in “Endemic”, “Yogi”, “Brazz!”, “Flute and Cats”, “Sunset Enigma”. Nelle esecuzioni non si avverte più di tanto l’alternanza dei cambi che non vanno a mutare l’ossatura dell’insieme. C’è poi che le composizioni sono firmate da chi vi partecipa. Verrebbe quasi da pensare che tre più tre potrebbe fare quattro se non ci fosse la matematica ad ostacolarne l’addizione e l’opinione. O più semplicemente che non c’è 3 senza 4et in questo lavoro di frammischi fra volute (in)esattezze infiorate dagli sminuzzamenti metrici della batteria e dai voli di calabrone del baritono, dalle acrobazie del basso e dai volteggi vocali della sassofonista.
 Canova Trio feat. Fulvio Sigurtà, Agata, Filibusta Records
Canova Trio feat. Fulvio Sigurtà, Agata, Filibusta Records
Agata, pietra della famiglia dei quarzi, è l’azzeccato nome di battesimo scelto per l’album del Canova Trio. Secondo la pianista e vocalist Elisa Marangon tale minerale ha qualità vicine alla musica grazie a geometrie e tonalità che spaziano dal bianco al verde, dal muschiato al pizzo blu. E’ così pensando che lei leviga un iridato e irradiato intaglio jazzistico assieme alla bassista Roberta Brighi ed al batterista Massimiliano Salina. Al trio si aggiunge talora il trombettista Fulvio Sigurtà in qualità di ospite, apprezzato da chi scrive in “Circles in the Sand” di Svensson e Castle. Altri pezzi – “Very Early” di Bill Evans e “Footprints” di Shorter – sono eseguiti utilizzando, della tavolozza timbrica, le marcature più calde e brillanti. Due composizioni di Jobim – “Chovendo na roseira” e “Falando de Amor” – valorizzano la trasparenza della voce della Marangon che dà il massimo, a livello di scrittura, in “Les Trois Soeurs à la plage”, uno degli originals (su undici complessivi) di cui quattro da lei firmati e due cofirmati con i colleghi del trio (plus guest). La folgorazione deriva dal dipinto “Las Tres Hermanas en la playa” del pittore spagnolo Joachim Sorolla, impressionista dal tratto luminista. Per una musica che, nel riprodurne i lineamenti, si insinua, nei contrasti ombra-luce, en plein air.
 Giovanni Benvenuti , An Hour Of Existence, AMP Music & Records
Giovanni Benvenuti , An Hour Of Existence, AMP Music & Records
Il tenorista senese Giovanni Benvenuti nell’album An Hour Of Existence (AMP) coinvolge la propria band composta di altri tre musicisti: il pianista tedesco Christian Pabst, il contrabbassista Francesco Pierotti e il batterista Dario Rossi. Il lavoro discografico si rifà ad un racconto di fantascienza in cui uno dei protagonisti, non più in vita, si materializza per un’ora all’anno. In quel breve lasso di tempo deve scegliere come muoversi, se viverlo semplicemente o imprimervi in qualche modo una svolta. Un po’ come nel film “Momenti di trascurabile felicità” di Daniele Luchetti in cui Pif torna sulla terra, dal paradiso, per poco più di un’ora, per risolvere le pendenze sospese ovvero riassaporare momenti felici. Dal canto suo Benvenuti, in un’ora circa di musica, si gioca bene le carte a disposizione. I sette brani originati da questa visione fra new age e science fiction, per quanto immaginifici siano – come “King’s Mustache” o “General Krottendorf” – e per quanto risentano di influssi extrajazzistici – le scale arabeggianti del n.5, quello che dà titolo al cd – si muovono in un contemporary che malassa materiali vari dallo svolgimento ritmico mosso e plurilineare nella modulazione melodica del sax. Il disco avvicina storia e fantascienza sul terreno jazzistico per come già emerso nel precedente album Paolina and The Android, accolto favorevolmente dalla critica. Lì due androidi avveravano il mancato incontro di un paio di secoli prima fra il poeta Keats e la Bonaparte. Nel nuovo album i personaggi sono vari come la narrazione. Così come la musica del 4et.
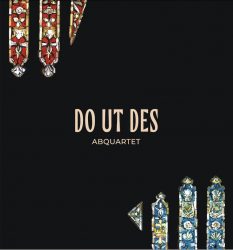 ABQuartet, Do Ut Des, Red & Blue.
ABQuartet, Do Ut Des, Red & Blue.
Guido D’Arezzo, dopo aver inventato attorno al Mille la moderna notazione musicale, nell’assegnare i nomi alle note, non avrebbe immaginato che nel 1972 un gruppo di rock progressivo come i New Trolls avrebbe chiamato un proprio l.p. Ut, termine che, oltre all’avverbio affinché, indica il Do nell’ars musica. Ancor meno il teorico avrebbe pensato che, nel terzo millennio, un quartetto jazz come l’ABQuartet avrebbe approntato un album con sostrato latino (non latin, si badi bene) intitolandolo Do Ut Des per indicare non tanto il significato comune di interscambio bensì il Do Do Re bemolle (traduzione del detto in gradi della scala temperata in base alla denominazione latino-germanica). La frase, volendo, potrebbe riferirsi al rapporto fra i musicisti che “donano” invenzioni allo spettatore che li ricambia con il proprio (ap)plauso. Od anche potrebbe simboleggiare il “contratto” che i musicisti stipulano nel formare un gruppo o addirittura rimandare ad un’idea di interplay come “obbligazione” e cioè musica praticata in forma pattizia in cui ogni strumento “dà il la” ad un altro aspettando una risposta per generare nell’insieme un’armonia complessiva. Il pianista Antonio Bonazzo, il clarinettista Francesco Chiapperini, il contrabbassista Cristiano Da Ros e il batterista/percussionista Fabrizio Carriero hanno realizzato sette brani circondati da tale aura medievale già a partire da titoli come “Ut Queant Laxis” dove la prima sillaba Ut è la prima delle note di un metà verso (emistichio, non metaverso) seguita da Resonare Fibris/Mira gestorum/Famili tuorum/Solve polluti/ Labii reatum/Sancte/Iohannes (Ut/Re/Mi/Fa/Sol/La/S/I). Da altri brani come “Lux Originis” e “Dies Irae” si percepiscono i frequenti cambi di registro acustico e di gamma modale che i “trovieri” adattano, girellando fra l’alleluiatico ed il melismatico, compenetrando, in tal guisa, la storia della musica all’attuale vita artistica “mondana”.
 Zhu Quartet, GINKGO, Workin’ Label.
Zhu Quartet, GINKGO, Workin’ Label.
Il ricordo di una pianta di ginkgo biloba che Alberto Zuanon, contrabbassista, osserva oramai cresciuta, nella stagione dell’autunno, fa da stimolo iniziale all’album Ginkgo, inciso per Workin’ Label con lo Zhu Quartet: Michele Polga, saxtenorista, Paolo Vianello, pianista, Stefano Cosi, batterista e ovviamente il leader contrabbassista. Piant’antica, la ginkgo biloba, che ha infuso di sé il title-track del cd, brano dalla forma-canzone che sa espandere un’idea di serenità. In “Creative Process” la mente dell’Autore (e quella degli Interpreti) procede, nel ristrutturare dati e impulsi di partenza, a trasformarli in flusso sonoro. “Sabato pomeriggio con Tommaso” è composizione delicata dedicata ad un allievo che nel confronto col maestro rivela tutta la propria curiosità e devozione. “Agitato” guarda al navigante che affronta il mare tempestoso, il che in musica è rappresentato dagli strumenti che alzano il livello e l’altezza delle proprie onde sonore, amplificando certi contrasti ritmica-piano/sax già ascoltati in “Costante”. Il più placido “2022” è un personalissimo “Le Quattro Stagioni” in sunto jazz impresse nell’anno che è appena tramontato. Chiudono la decade di titoli il nostalgico “Altri tempi”, l’atrabile “ Prima del sonno” e “Laguna”, ispirato dalla visione di quella veneta. Un lavoro, insomma, che si annuncia invitante già a partire dall’”Intro”, meritevole di essere diffuso anche in circùiti, ove attivati, di “disc/crossing”.
 Marco Vavassori feat. Lincetto/Smiderle/Uliana, Walking with Bob, Caligola Records.
Marco Vavassori feat. Lincetto/Smiderle/Uliana, Walking with Bob, Caligola Records.
Buone nuove dal North East jazzistico italiano. Ed è ancora Caligola Records a consegnarci novità discografiche che denotano l’ indubbia vitalità musicale in quell’area. E’ la volta del contrabbassista-compositore jesolano Marco Vavassori, con alle spalle brillanti studi al Conservatorio di Rovigo, che pubblica Walking with Bob, il suo primo album da leader.
Accanto a lui ben figurano tre musicisti legati da solido legame di amicizia e cioè il clarinettista Michele Uliana, il pianista Alberto Lincetto e il batterista Enrico Smiderle. Un quartetto, dunque, che fa già le dovute presentazioni con il primo degli otto brani in tracklist, il lirico “Hocking”, mettendo in scena un sound che impasta idee permeate di solare cantabilità. Il successivo “Sognando” ma ancor più l’alveo mediterraneo di “Shukran” e quello balcanico in “Kurkuma”, lasciano trasparire una certa sensibilità verso le arie folk. “Hare” si caratterizza perché a un certo punto contrabbasso e piano si dispongono a sezione “ritmica” nel supportare batteria e clarinetto mentre “InContra” ha tema ed impro insistenti su un giro di accordi iterante e crescente in intensità graduale nei circa otto e passa minuti di musica fiondante. In “J. Be Blues” il gruppo pare indossare un visore virtuale che guarda al passato, al tempo di Jimmy Blanton, antesignano di tanti contrabbassisti. Il conclusivo “Francesco’s Smile” ha risvolti nordeste, per rimanere al termine geografico già nominato. Insomma un walking, quello del contrabbasso, verso gli itinerari sonori più svariati ed imprevedibili.
Amedeo Furfaro
da Amedeo Furfaro | 28/Gen/2023 | Novità, Primo piano, Recensioni
La seguente selezione di dieci album è un Decathlon fatta per “disciplina” di strumento dei leader di formazione. Ovviamente la scelta è un’istantanea hic et nunc, dettata dal momento. E’ un po’ come al Fantabasket od al Fantacalcio! Si individuano le individualità fra quelle più in forma, e si inseriscono a tavolino in una squadra virtuale che esiste solo sulla carta. Dopo un po’ è prevista una rotazione dei nomi, oltretutto quella proposta non è una classifica delle valenze ma una inquadratura parziale del materiale discografico che ci si ritrova in attesa di esaminarne dell’altro. Il team che ne vien fuori è un ipotetico ensemble di cd con sax/tromba/piano/tastiere/vibrafono/violino/contrabbasso/batteria/percussioni/musica d’insieme.
- Stefano Conforti Quintet, Different Moods. Omaggio a Yusef Lateef, Notami Jazz
 L’omaggio a Yusef Lateef (William Evans), grande tenorsassofonista flautista oboista e fagottista americano, come quello che Stefano Conforti ha prodotto per Notami Jazz è di quelli destinati a lasciare il segno. Intanto è un tributo, oggi a dieci anni dalla morte, ad un jazzista dal curriculum straordinario che annovera collaborazioni con Gillespie, Burrell, Grant Green, Mingus, Fuller, Cannonball e Nat Adderley, Lawson, Cecil McBee, ma soprattutto a chi ha sviluppato, dopo gli inizi bop, “different moods” di un “sound ricco e denso di growl “ (Barithel-Gauffre) con influssi mediorientali. Pur consapevole nella difficoltà ad accostarsi ad un siffatto polistrumentista il sassofonista-flautista-oboista italiano vi si è cimentato disinvoltamente nell’album “Different Moods. Omaggio a Yusef Lateef”, inciso per Notami Jazz, con la formazione che vede Doriano Marcucci a chitarra acustica trombone didgeridoo e percussioni, Tonino Monachesi alla chitarra elettrica, David Padella a basso elettrico e contrabbasso e Roberto Bisello alla batteria. Il quintet ha riproposto in tutto otto brani – fra i quali “Metaphor”, “Road runner”, “The Golden flùte”, “Belle isle”, “Spartacus” di Alex North – con buona resa specie se si pensa a certi tributi alla naftalina che capita di ascoltare qua e là. Le esecuzioni, se non sono calligrafiche sul piano filologico-musicale, lo sono a livello di sonorità estesa e tensione distesa nel segno di un musicista dalla narrazione inzeppata di riferimenti filosofici e poetici, espressi tramite una musica che lui stesso ha definito “auto-fisiopsichica”.
L’omaggio a Yusef Lateef (William Evans), grande tenorsassofonista flautista oboista e fagottista americano, come quello che Stefano Conforti ha prodotto per Notami Jazz è di quelli destinati a lasciare il segno. Intanto è un tributo, oggi a dieci anni dalla morte, ad un jazzista dal curriculum straordinario che annovera collaborazioni con Gillespie, Burrell, Grant Green, Mingus, Fuller, Cannonball e Nat Adderley, Lawson, Cecil McBee, ma soprattutto a chi ha sviluppato, dopo gli inizi bop, “different moods” di un “sound ricco e denso di growl “ (Barithel-Gauffre) con influssi mediorientali. Pur consapevole nella difficoltà ad accostarsi ad un siffatto polistrumentista il sassofonista-flautista-oboista italiano vi si è cimentato disinvoltamente nell’album “Different Moods. Omaggio a Yusef Lateef”, inciso per Notami Jazz, con la formazione che vede Doriano Marcucci a chitarra acustica trombone didgeridoo e percussioni, Tonino Monachesi alla chitarra elettrica, David Padella a basso elettrico e contrabbasso e Roberto Bisello alla batteria. Il quintet ha riproposto in tutto otto brani – fra i quali “Metaphor”, “Road runner”, “The Golden flùte”, “Belle isle”, “Spartacus” di Alex North – con buona resa specie se si pensa a certi tributi alla naftalina che capita di ascoltare qua e là. Le esecuzioni, se non sono calligrafiche sul piano filologico-musicale, lo sono a livello di sonorità estesa e tensione distesa nel segno di un musicista dalla narrazione inzeppata di riferimenti filosofici e poetici, espressi tramite una musica che lui stesso ha definito “auto-fisiopsichica”.
- Sean Lucariello, Despite It All, Caligola Records
 Gli editor italiani fanno sempre più scouting. Succede anche in campo discografico con label come Caligola Records che pubblica lavori di giovani e/o esordienti per rimpolpare di forze fresche il catalogo. Una politica editoriale che spesso viene premiata dagli ok di pubblico e critica, prospettiva che saremmo pronti a sottoscrivere per l’album Despite It All del trombettista-flicornista nonché compositore Sean Lucariello. E’ indubbio che questa coppia di strumenti principe del jazz ha sempre un fascino che seduce. Ed è di un camaleontismo unico il suo modificarsi a seconda della collocazione. Nel quintetto italo-spagnolo assortito da Lucariello che vede Edoardo Doreste Velasquez a sax soprano e alto, Sasha Lattuca al pianoforte, Francesco Bordignon al contrabbasso e Ignacio Ampurdanès Ruz alla batteria, la cornice è l’esatto contrario dello strepitio tanto è armonicamente sottile. E la tromba, il cui suono a momenti pare richiamare il Wheeler più compassato, vira sciolta la canna d’imboccatura in brani come l’introduttivo “Astral Conjunctions” scritto da Bordignon seguito da “Il Maestro e la Margherita” che il leader ha inteso dedicare a Bulgakov. L’attenzione letteraria è comune con il pianista, autore della suite “Tendre Est La Nuit”, chiaro il riferimento al romanzo di Fitzgerald, dove pare che la tastiera rincorra il silenzio, forse la vera e segreta aspirazione della musica, nonostante tutto. Lasciando scorrere il cd dall’ulteriore “notturno” “Song With No Title” si passa poi ad una atmosfera di taglio più nettamente bop in “The Beaty of Boredom” mentre In “Five”, pezzo di Matteo Nicolin, gli accenti si fanno più metropolitani grazie al piglio elettrico del Fender Rhodes di Lattuca.
Gli editor italiani fanno sempre più scouting. Succede anche in campo discografico con label come Caligola Records che pubblica lavori di giovani e/o esordienti per rimpolpare di forze fresche il catalogo. Una politica editoriale che spesso viene premiata dagli ok di pubblico e critica, prospettiva che saremmo pronti a sottoscrivere per l’album Despite It All del trombettista-flicornista nonché compositore Sean Lucariello. E’ indubbio che questa coppia di strumenti principe del jazz ha sempre un fascino che seduce. Ed è di un camaleontismo unico il suo modificarsi a seconda della collocazione. Nel quintetto italo-spagnolo assortito da Lucariello che vede Edoardo Doreste Velasquez a sax soprano e alto, Sasha Lattuca al pianoforte, Francesco Bordignon al contrabbasso e Ignacio Ampurdanès Ruz alla batteria, la cornice è l’esatto contrario dello strepitio tanto è armonicamente sottile. E la tromba, il cui suono a momenti pare richiamare il Wheeler più compassato, vira sciolta la canna d’imboccatura in brani come l’introduttivo “Astral Conjunctions” scritto da Bordignon seguito da “Il Maestro e la Margherita” che il leader ha inteso dedicare a Bulgakov. L’attenzione letteraria è comune con il pianista, autore della suite “Tendre Est La Nuit”, chiaro il riferimento al romanzo di Fitzgerald, dove pare che la tastiera rincorra il silenzio, forse la vera e segreta aspirazione della musica, nonostante tutto. Lasciando scorrere il cd dall’ulteriore “notturno” “Song With No Title” si passa poi ad una atmosfera di taglio più nettamente bop in “The Beaty of Boredom” mentre In “Five”, pezzo di Matteo Nicolin, gli accenti si fanno più metropolitani grazie al piglio elettrico del Fender Rhodes di Lattuca.
- Federica Lorusso, Outside Introspections, Zennez Records/Abeat
 Con un album inciso in Olanda per la Zennez Records, la Abeat Records presenta anche sul mercato italiano Outside Introspections, firmato dalla giovane pianista italiana Federica Lorusso. La musicista fa da calamita nell’ integrato interplay del 4et con Claudio Jr. De Rosa al tenore (e ad al clarinetto in “Take A Breath”), David Macchione al contrabbasso ed Egidio Gentile alla batteria. I jazzisti dimostrano singolarmente di poter vantare notevole “arte/fare” nei nove brani in cui il sax lascia sgolare una “voce” suasiva, il contrabbasso inchioda una probante cadenza nel timing, la batteria gioca costante sull’accentare e sincopare, la leader canta a mò di octaver, unisonica sulle note della tastiera: indizi che fanno la prova di un percorso agile per esporre, esplicare, esplicitare the hidden side of the music. Dall’inside all’extroversion, all’outside i vari gradi compositivi arricciolano un bijou di tracklist che gronda di “assorbimenti” stilistici che non vogliono essere, come il titolo del cd, degli ossimori stilistici – postbop-fusion, pop-classical – che poi tali non sono specie se innaffiati di quei semi creativi sparsi anche nella regione dei tulipani.
Con un album inciso in Olanda per la Zennez Records, la Abeat Records presenta anche sul mercato italiano Outside Introspections, firmato dalla giovane pianista italiana Federica Lorusso. La musicista fa da calamita nell’ integrato interplay del 4et con Claudio Jr. De Rosa al tenore (e ad al clarinetto in “Take A Breath”), David Macchione al contrabbasso ed Egidio Gentile alla batteria. I jazzisti dimostrano singolarmente di poter vantare notevole “arte/fare” nei nove brani in cui il sax lascia sgolare una “voce” suasiva, il contrabbasso inchioda una probante cadenza nel timing, la batteria gioca costante sull’accentare e sincopare, la leader canta a mò di octaver, unisonica sulle note della tastiera: indizi che fanno la prova di un percorso agile per esporre, esplicare, esplicitare the hidden side of the music. Dall’inside all’extroversion, all’outside i vari gradi compositivi arricciolano un bijou di tracklist che gronda di “assorbimenti” stilistici che non vogliono essere, come il titolo del cd, degli ossimori stilistici – postbop-fusion, pop-classical – che poi tali non sono specie se innaffiati di quei semi creativi sparsi anche nella regione dei tulipani.
- Enrico Solazzo, Perfect Journey, Millesuoni/ Via Veneto Jazz
 Se esiste una chiave per creare connessione autentica col pubblico quella è anzitutto la musica. Ed esiste un tipo di comunicazione musicale che avvicina perché la si avverte, semplicemente, coetanea. Il tastierista Enrico Solazzo ce ne dà un saggio con l’album Perfect Journey edito da Millesuoni (mai marchio fu più illuminante) della ViaVeneto Jazz. Vi sono esaltate le sue capacità di arrangiatore, oltre che di solista, unitamente a quelle di musical coach in quanto allenatore di un team che conta qualcosa come quaranta fuoriclasse. Riesce alquanto difficile elencarli tutti per ragioni di spazio. Qualche nome? Dennis Chambers, Gumbi Ortiz, John Pena, Kadir Gonzalez Lòpez, Niclas Campagnol, Baptiste Herbin, Lo Van Gorp fra gli stranieri. Roberto Gatto, Stefano Di Battista, Antonio Faraò, Fabiana Rosciglione, Tony Esposito, Gegè Munari fra gli italiani. Insomma un bel “gruppo misto” alle prese con una quindicina circa di brani fra originali e standard di musica internazionale. Tornando al discorso iniziale come fa un professionista, quale Solazzo, è a comunicare la propria musica nell’epoca dei podcast e del gaming? Intanto non basta esser maestri dell’ entertainment. E non è sufficiente riprendere alla grande hits tipo “Crazy” o “Caruso” per avvicinare l’audience. Ogni epoca ha suoni che le si confanno. Ad esempio le keyboards midi avevano un suono che oggi risulterebbe datato come un moog così come certi effetti campionati. La particolarità di questo disco, a parte il caleidoscopio di collaborazioni, sta nell’aver lo strumentario giusto per l’oggi, nell’averne saputo introiettare lo zeitgeist più positivo con gli arrangiamenti, nel trasmetterlo ad un ampio ventaglio di fasce d’ascolto come tappe di un viaggio perfetto, quello di Enrico Solazzo, di Brindisi: da brindisi!
Se esiste una chiave per creare connessione autentica col pubblico quella è anzitutto la musica. Ed esiste un tipo di comunicazione musicale che avvicina perché la si avverte, semplicemente, coetanea. Il tastierista Enrico Solazzo ce ne dà un saggio con l’album Perfect Journey edito da Millesuoni (mai marchio fu più illuminante) della ViaVeneto Jazz. Vi sono esaltate le sue capacità di arrangiatore, oltre che di solista, unitamente a quelle di musical coach in quanto allenatore di un team che conta qualcosa come quaranta fuoriclasse. Riesce alquanto difficile elencarli tutti per ragioni di spazio. Qualche nome? Dennis Chambers, Gumbi Ortiz, John Pena, Kadir Gonzalez Lòpez, Niclas Campagnol, Baptiste Herbin, Lo Van Gorp fra gli stranieri. Roberto Gatto, Stefano Di Battista, Antonio Faraò, Fabiana Rosciglione, Tony Esposito, Gegè Munari fra gli italiani. Insomma un bel “gruppo misto” alle prese con una quindicina circa di brani fra originali e standard di musica internazionale. Tornando al discorso iniziale come fa un professionista, quale Solazzo, è a comunicare la propria musica nell’epoca dei podcast e del gaming? Intanto non basta esser maestri dell’ entertainment. E non è sufficiente riprendere alla grande hits tipo “Crazy” o “Caruso” per avvicinare l’audience. Ogni epoca ha suoni che le si confanno. Ad esempio le keyboards midi avevano un suono che oggi risulterebbe datato come un moog così come certi effetti campionati. La particolarità di questo disco, a parte il caleidoscopio di collaborazioni, sta nell’aver lo strumentario giusto per l’oggi, nell’averne saputo introiettare lo zeitgeist più positivo con gli arrangiamenti, nel trasmetterlo ad un ampio ventaglio di fasce d’ascolto come tappe di un viaggio perfetto, quello di Enrico Solazzo, di Brindisi: da brindisi!
- Michele Sannelli & The Gonghers, Inner Tales, Wow Records.
 Mezzo secolo dopo i ’70 si può ancora suonare progressive? La risposta è affermativa se non ci si limita a frugare nel modernariato dei suoni vintage o nei mercatini del suono usato. Il prog, alla mezz’età, si presenta quale estetica musicale vigente, contermine a rock e jazz rock. Vero è che in alcuni casi si è assistito ad un ritorno regressivo all’infanzia e in altri la senescenza ne ha incanutito sembianze e portamenti baRock. Quando però capitano fra le mani album energici e briosi come Inner Tales, della Wow, inciso dal vibrafonista Michele Sannelli & The Gonghers, si ha cognizione di come quel “non genere” abbia ancora un carattere … progressivo. Della band, finalista al contest Jam The Future – Music For A New Planet di JazzMi nel 2019 e, nel 2022, prima al Concorso “Chicco Bettinardi” di Piacenza, fanno parte il chitarrista Davide Sartori, il tastierista Edoardo Maggioni, il bassista/contrabbassista Stefano Zambon e il batterista Fabio Danusso. Questo disco d’esordio rivela ad una platea potenzialmente più ampia dei palcoscenici che i musicisti già calcano una forgiata vis sperimentativa che è uno degli stampini del prog brand. Vi campeggiano due icone: Dave Holland in uno dei sette brani di Sannelli (“Uncle Dave”) eppoi c’è il richiamo in denominazione al gruppo space rock dei visionari Gong di Daevid Allen, fondatore degli psichedelici Soft Machine. Le “Storie interne” al compact, dalla romantica “Song for Chiara” all’iterativo “Circle”, dal marcato “Hard Times” al soffuso “Green Light”, dal dinamico “Run Mingo Run” al lirico “Just in Time to Say Goodbye”, vanno peraltro lette non solo in termini di rivisitazione di modelli esistenti bensì di riscoperta di quei modi di far musica d’insieme che risorgono ciclicamente, resistenti alle intemperie, “eterne modernità” per dirla alla Sironi.
Mezzo secolo dopo i ’70 si può ancora suonare progressive? La risposta è affermativa se non ci si limita a frugare nel modernariato dei suoni vintage o nei mercatini del suono usato. Il prog, alla mezz’età, si presenta quale estetica musicale vigente, contermine a rock e jazz rock. Vero è che in alcuni casi si è assistito ad un ritorno regressivo all’infanzia e in altri la senescenza ne ha incanutito sembianze e portamenti baRock. Quando però capitano fra le mani album energici e briosi come Inner Tales, della Wow, inciso dal vibrafonista Michele Sannelli & The Gonghers, si ha cognizione di come quel “non genere” abbia ancora un carattere … progressivo. Della band, finalista al contest Jam The Future – Music For A New Planet di JazzMi nel 2019 e, nel 2022, prima al Concorso “Chicco Bettinardi” di Piacenza, fanno parte il chitarrista Davide Sartori, il tastierista Edoardo Maggioni, il bassista/contrabbassista Stefano Zambon e il batterista Fabio Danusso. Questo disco d’esordio rivela ad una platea potenzialmente più ampia dei palcoscenici che i musicisti già calcano una forgiata vis sperimentativa che è uno degli stampini del prog brand. Vi campeggiano due icone: Dave Holland in uno dei sette brani di Sannelli (“Uncle Dave”) eppoi c’è il richiamo in denominazione al gruppo space rock dei visionari Gong di Daevid Allen, fondatore degli psichedelici Soft Machine. Le “Storie interne” al compact, dalla romantica “Song for Chiara” all’iterativo “Circle”, dal marcato “Hard Times” al soffuso “Green Light”, dal dinamico “Run Mingo Run” al lirico “Just in Time to Say Goodbye”, vanno peraltro lette non solo in termini di rivisitazione di modelli esistenti bensì di riscoperta di quei modi di far musica d’insieme che risorgono ciclicamente, resistenti alle intemperie, “eterne modernità” per dirla alla Sironi.
- Francesco Del Prete Violinorchestra, Controvento/Dodicilune.
 Fra musica e vino, dicono studi scientifici, esiste una relazione profonda. Il rapporto interessa anche i musicisti, si pensi all’opera (“Fin ch’han dal vino”, dal Don Giovanni di Mozart), ai walzer di Strauss (“Vino donna e canto”), agli standard jazz (“The Days of Wine and Roses”), al canto nero di Nina Simone (“Lilac Wine”), al blues di Amy Winehouse (“Cherry Wine”, coautore Nas), al soul/r&b di Otis Redding (“Champagne and Wine”), al pop di Adele (“Drink Wine”). Dalle nostre parti si ritrovano gli stornelli di Gabriella Ferri (“Osteria dei magnaccioni”), le note cantautoriali di Modugno (“Stasera pago io”), Gaber (“Barbera e champagne”), Guccini (“Canzone delle osterie di fuori porta”) con il rock di Ligabue (“Lambrusco e popcorn”) e Zucchero (“Bacco perbacco”) e la “chanson” di Sergio Cammariere (“Il pane il vino la visione”).
Fra musica e vino, dicono studi scientifici, esiste una relazione profonda. Il rapporto interessa anche i musicisti, si pensi all’opera (“Fin ch’han dal vino”, dal Don Giovanni di Mozart), ai walzer di Strauss (“Vino donna e canto”), agli standard jazz (“The Days of Wine and Roses”), al canto nero di Nina Simone (“Lilac Wine”), al blues di Amy Winehouse (“Cherry Wine”, coautore Nas), al soul/r&b di Otis Redding (“Champagne and Wine”), al pop di Adele (“Drink Wine”). Dalle nostre parti si ritrovano gli stornelli di Gabriella Ferri (“Osteria dei magnaccioni”), le note cantautoriali di Modugno (“Stasera pago io”), Gaber (“Barbera e champagne”), Guccini (“Canzone delle osterie di fuori porta”) con il rock di Ligabue (“Lambrusco e popcorn”) e Zucchero (“Bacco perbacco”) e la “chanson” di Sergio Cammariere (“Il pane il vino la visione”).
Dalla terra dei messapi si segnala, nella corrente annata discografica, l’album Rohesia di Francesco Del Prete con la Violinorchestra (Controvento/Dodicilune). Un lavoro non della serie jazz & wine, questo del violinista salentino gravitante anche in area jazz, essendo intriso di sonorità legate al territorio in cui si vendemmiano i cinque vini della Azienda Cantele a cui sono dedicati altrettanti brani. Scrive al riguardo Maria Giovanna Barletta che “in Rohesia Pas Dosè, Rohesia Rosso, Teresa Manara, Rohesia Rosè ed Amativo, ecco una diversità resistente che si riappropria attraverso l’arte poetica della melodia del qui e ora”. Il compact, nel cui progetto sono partecipi Lara Ingrosso (voce), Marco Schiavone e Anna Carla Del Prete (violoncelli), Angela Così (arpa), Emanuele Coluccia (piano) e Roberto “Bob” Mangialardo (chitarre), ha un booklet-winelist esplicativo sui “nettari degli dei” oggetto della selezione e sulla musica loro abbinata a mò di etichetta. Amalgamando pizzica e swing, elettronica ed echi mediterranei, a seconda del carattere e delle caratteristiche, non solo organolettiche, del vino da “sonorizzare”, Del Prete ha generato un prodotto originale che oltretutto fornisce un esempio di come la musica possa essere alleata di un’economia resa “circolare”. Da un disco.
- Marco Trabucco, X (Ics), Abeat Records
 X (Ics), a marchio Abeat Records, del contrabbassista Marco Trabucco, è album che trae spunto nel titolo dal numero decafonico dei ruoli musicali che vi figurano, appunto dieci (Scaramella, pf; Colussi, dr; Vitale, mar; Ghezzo, g.; Andreatta, v.; Dalla Libera, viola; Calamai, fl.; Pennucci, cor., oltre Trabucco nella doppia veste di compositore e strumentista). X, inoltre, rimanda, come scrive Paolo Cavallone nelle liner notes, “all’incognita che risulta dall’accostamento di sonorità cameristiche classiche con quelle del jazz”. X potrebbe stare anche per Pareggio vista l’equivalenza degli apporti fra legni-ottoni e jazz 4et di base con rivoli afrofolk a base di balanon (e marimba). I brani, in tutto cinque che è la metà di dieci (“One For Max”, “Open Space”, “Untitled”, “Meraki”, “Otranto”), scorrono limpidi come un ruscello alle falde di una montagna tant’è che non si avverte (di)stacco fra l’uno e l’altro. Segnale, questo, che la spinta inventiva ha origine da uno statuto creativo fondato su idee fluide sul come moltiplicare (ancora x) temi armonie timbri spazi improvvisativi sui due confini, classica e jazz, promossi a zona franca da etichettature di sorta. Un disco, inoltre, contrassegnato da atmosfere rarefatte e da un lessico talora minimalista – chissammai perché la mente va al film Dieci di Kiarostami – in cui il regista Trabucco da autore si cala appieno nel “personaggio” del musicista che sa trasmettere, agli/cogli altri interpreti, il gioco instabile, tipo playing 1X2 dove è sempre la X a funzionare da centro di gravità.
X (Ics), a marchio Abeat Records, del contrabbassista Marco Trabucco, è album che trae spunto nel titolo dal numero decafonico dei ruoli musicali che vi figurano, appunto dieci (Scaramella, pf; Colussi, dr; Vitale, mar; Ghezzo, g.; Andreatta, v.; Dalla Libera, viola; Calamai, fl.; Pennucci, cor., oltre Trabucco nella doppia veste di compositore e strumentista). X, inoltre, rimanda, come scrive Paolo Cavallone nelle liner notes, “all’incognita che risulta dall’accostamento di sonorità cameristiche classiche con quelle del jazz”. X potrebbe stare anche per Pareggio vista l’equivalenza degli apporti fra legni-ottoni e jazz 4et di base con rivoli afrofolk a base di balanon (e marimba). I brani, in tutto cinque che è la metà di dieci (“One For Max”, “Open Space”, “Untitled”, “Meraki”, “Otranto”), scorrono limpidi come un ruscello alle falde di una montagna tant’è che non si avverte (di)stacco fra l’uno e l’altro. Segnale, questo, che la spinta inventiva ha origine da uno statuto creativo fondato su idee fluide sul come moltiplicare (ancora x) temi armonie timbri spazi improvvisativi sui due confini, classica e jazz, promossi a zona franca da etichettature di sorta. Un disco, inoltre, contrassegnato da atmosfere rarefatte e da un lessico talora minimalista – chissammai perché la mente va al film Dieci di Kiarostami – in cui il regista Trabucco da autore si cala appieno nel “personaggio” del musicista che sa trasmettere, agli/cogli altri interpreti, il gioco instabile, tipo playing 1X2 dove è sempre la X a funzionare da centro di gravità.
- Andrea Penna, A New World, Workin’ Label.
 Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando Dvorjak dedicò al Nuovo Mondo la Sinfonia n. 9! Eppure l’aspirazione/ispirazione dettata dal desiderio, magari utopico, di un mondo diverso e migliore, affiora ancora fra i musicisti. Il batterista-compositore piemontese Andrea Penna, con il c.d. A New World (Workin’ Label), è uno dei pensierosi visionari che “usano” la musica per autoproiettarvi i riflessi interiori del proprio mondo in osservazioni (“It Was Just Like That”), ricordi (“Poki”, “In My Arms”), emozioni (“E Fuori piove”), ritratti (“1B My Dear”), flashes (“Tutto in un Momento”) ora raccolti e ordinati. Ah, ecco perché i dischi li chiamano album! Il relativo sound registra umori provenienti dalla memoria – richiami GRP, echi travel/metheniani, ibridismi similrock – nello sfarinare una tracklist di nove brani di fusion effusiva grazie alla formazione che vede Massimo Artiglia a piano e tastiere, Luca Biggio ai sax, Mario Petracca e Andrea Mignone alle chitarre, Umberto Mari al basso e voce, Antonio Santoro al flauto. Se è lecito esprimere una preferenza la scelta cade sul brano d’apertura, “Parlami Ancora”, “scritto immaginando il mare, il discorrere intenso e rilassato passeggiando sulla spiaggia, con qualche brivido di gioia ed una grande voglia di libertà”. Giusto e opportuno antecederlo per far assaporare da subito il gusto della scoperta dell’immaginifico New World di Andrea Penna.
Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando Dvorjak dedicò al Nuovo Mondo la Sinfonia n. 9! Eppure l’aspirazione/ispirazione dettata dal desiderio, magari utopico, di un mondo diverso e migliore, affiora ancora fra i musicisti. Il batterista-compositore piemontese Andrea Penna, con il c.d. A New World (Workin’ Label), è uno dei pensierosi visionari che “usano” la musica per autoproiettarvi i riflessi interiori del proprio mondo in osservazioni (“It Was Just Like That”), ricordi (“Poki”, “In My Arms”), emozioni (“E Fuori piove”), ritratti (“1B My Dear”), flashes (“Tutto in un Momento”) ora raccolti e ordinati. Ah, ecco perché i dischi li chiamano album! Il relativo sound registra umori provenienti dalla memoria – richiami GRP, echi travel/metheniani, ibridismi similrock – nello sfarinare una tracklist di nove brani di fusion effusiva grazie alla formazione che vede Massimo Artiglia a piano e tastiere, Luca Biggio ai sax, Mario Petracca e Andrea Mignone alle chitarre, Umberto Mari al basso e voce, Antonio Santoro al flauto. Se è lecito esprimere una preferenza la scelta cade sul brano d’apertura, “Parlami Ancora”, “scritto immaginando il mare, il discorrere intenso e rilassato passeggiando sulla spiaggia, con qualche brivido di gioia ed una grande voglia di libertà”. Giusto e opportuno antecederlo per far assaporare da subito il gusto della scoperta dell’immaginifico New World di Andrea Penna.
- Roberto Gatti, Amanolibera, Encore Music
 Quello delle percussioni è un mondo a sé stante con la propria storia, le riviste, i libri, le cattedre, i miti: Don Azpiazù, Ray Barretto, Alex Acuna, Airto Moreira, Chano Pozo, Mino Cinelu, Ralph MacDonald, James Mtume … Quello delle percussioni non è un mondo a sé stante in quanto legato a filo doppio con gli altri strumenti che ne valorizzano al meglio le peculiarità. Sono due affermazioni uguali e contrarie. E bisognerebbe aggiungerne una terza, sempre ambivalente, che le percussioni possono rappresentare un’idea ritmica della musica, il latin, ad esempio, in cui la collocazione solistica è al tempo stesso elemento funzionale spesso imprescindibile dell’ensemble. L’album Amanolibera di Roberto Gatti, percussionista, edito da Encore Music, con circa una trentina di musicisti coinvolti nel progetto – fra gli ospiti anche Horacio El Negro Hernandez, Paoli Mejias, Oscar Valdes, Roberto Quintero, Jhair Sala, Gabriele Mirabassi, Lorenzo Bisogno, Tetraktis – documenta quanto il percussionismo, in particolare quello di spanish tinge, ne sia elemento vitale appunto insostituibile. Gatti vi si è cimentato anche a livello compositivo ragionandoci sopra con un drum set di congas, bongos, cajon, timbales, voce, tessendovi sei brani degli otto in scaletta (“Gatti Song”, “Bombetta”, “Chachaqua”, “Roberto’s Jam”, “Rumba per Giovanni”, “Jicamo 2.0”) in alcuni casi cofirmati, recitando così free hand un rosario sonoro allargato in sincronia al Sudamerica ed in diacronia a figure storiche dell’afrocubanismo. “La Comparsa” di Lecuona e “Giò Toca” di Valdes sono i due pezzi che Gatti non ha assortito dalla collezione personale, consentendo a chi ascolta un ritorno a melodie già metabolizzate con le sue percussioni a far da sorelle siamesi di una batteria con cui dialogare fittamente, da minimo comun denominatore che diventa massimo comun divisore di microscansioni particellari e poliritmie a catena.
Quello delle percussioni è un mondo a sé stante con la propria storia, le riviste, i libri, le cattedre, i miti: Don Azpiazù, Ray Barretto, Alex Acuna, Airto Moreira, Chano Pozo, Mino Cinelu, Ralph MacDonald, James Mtume … Quello delle percussioni non è un mondo a sé stante in quanto legato a filo doppio con gli altri strumenti che ne valorizzano al meglio le peculiarità. Sono due affermazioni uguali e contrarie. E bisognerebbe aggiungerne una terza, sempre ambivalente, che le percussioni possono rappresentare un’idea ritmica della musica, il latin, ad esempio, in cui la collocazione solistica è al tempo stesso elemento funzionale spesso imprescindibile dell’ensemble. L’album Amanolibera di Roberto Gatti, percussionista, edito da Encore Music, con circa una trentina di musicisti coinvolti nel progetto – fra gli ospiti anche Horacio El Negro Hernandez, Paoli Mejias, Oscar Valdes, Roberto Quintero, Jhair Sala, Gabriele Mirabassi, Lorenzo Bisogno, Tetraktis – documenta quanto il percussionismo, in particolare quello di spanish tinge, ne sia elemento vitale appunto insostituibile. Gatti vi si è cimentato anche a livello compositivo ragionandoci sopra con un drum set di congas, bongos, cajon, timbales, voce, tessendovi sei brani degli otto in scaletta (“Gatti Song”, “Bombetta”, “Chachaqua”, “Roberto’s Jam”, “Rumba per Giovanni”, “Jicamo 2.0”) in alcuni casi cofirmati, recitando così free hand un rosario sonoro allargato in sincronia al Sudamerica ed in diacronia a figure storiche dell’afrocubanismo. “La Comparsa” di Lecuona e “Giò Toca” di Valdes sono i due pezzi che Gatti non ha assortito dalla collezione personale, consentendo a chi ascolta un ritorno a melodie già metabolizzate con le sue percussioni a far da sorelle siamesi di una batteria con cui dialogare fittamente, da minimo comun denominatore che diventa massimo comun divisore di microscansioni particellari e poliritmie a catena.
- No Profit Blues Band. Helpin’ Hands. 20th Anniversary LILT di Treviso.
 Musica e medicina. Un’arte e una scienza. Con tante applicazioni e “trasfusioni” dall’area sanitaria a quella musicale destinate a creare effetti benefici di vario ordine, a partire dalla musicoterapia. E sono tanti gli operatori del ramo che hanno coniugato Esculapio ed Euterpe. Pensiamo a medici-compositori come Borodin, ai cantautori Jannacci e Locasciulli, a uno stimato pianista jazz come Angelo Canelli, a trombettisti come il docente di ginecologia Nando Giardina della Doctor Dixie Jazz Band, a chitarristi come il radiologo Vittorio Camardese sperimentatore del tapping sulla seicorde, al medico-batterista Zbigniew Robert Prominski membro dei Behemoth (collaboratore degli Artrosis, tanto per rimanere in tema)… Fra gli stili il blues (e derivati) si evidenzia come una fra le più azzeccate medicine dell’anima. Sono vent’anni che lo sperimenta sul campo la No Profit Blues Band che, per il compleanno, presenta l’album Helpin’ Hands frutto della collaborazione con la LILT di Treviso. Dismessi camici e mascherine, messi nel cassetto bisturi e stetoscopi, la band di professionisti della sanità con pianoforte (Alberto Zorzi), chitarra (Maurizio Marzaro), batteria (Danilo Taffarello), basso (Matteo Gasparello), voci (Teo Pelloia, Jessica Vinci, Luisa Lo Santo, Elisabetta Monastero), saxes ( Giacomo “Jack” Berlese) e armonica (Mauro Erri) ha adoperato un altro tipo di attrezzatura per “radiografare” i dintorni del blues . Scopo dell’”operazione”? Far sorridere i pazienti della LILT trevigiana diffondendo pillole di buonumore con iniezioni di spensieratezza. Un ensemble, il loro, mosso esclusivamente dal piacere di offrire la loro musica come antidoto per quanti vi possano trovare motivo di distrazione. Va detto che i pezzi in scaletta sono stati scelti ed eseguiti con maestria e verve. In scaletta ci sono “Smile” di Chaplin (cavallo di battaglia del fisiatra Zorzi), “Mustang Sally” di Rice (si è in pieno r&b alla Pickett ), “Summertime” (Gershwin forever), “Route 66” di Troup (con versioni che vanno da Nat King Cole agli Stones), “Unchain My Heart” di Sharp (ripreso divinamente fra gli altri da Joe Cocker), “Hoochie Coochie Man” di Dixon (Muddy Waters uber alles), “I Got A Woman” e “Halleluja I Love Her So” di Ray Charles, “Let The Good Times Roll” hit di B.B. King … Musica angelica, macchè diabolica, per lenire le ferite dello spirito.
Musica e medicina. Un’arte e una scienza. Con tante applicazioni e “trasfusioni” dall’area sanitaria a quella musicale destinate a creare effetti benefici di vario ordine, a partire dalla musicoterapia. E sono tanti gli operatori del ramo che hanno coniugato Esculapio ed Euterpe. Pensiamo a medici-compositori come Borodin, ai cantautori Jannacci e Locasciulli, a uno stimato pianista jazz come Angelo Canelli, a trombettisti come il docente di ginecologia Nando Giardina della Doctor Dixie Jazz Band, a chitarristi come il radiologo Vittorio Camardese sperimentatore del tapping sulla seicorde, al medico-batterista Zbigniew Robert Prominski membro dei Behemoth (collaboratore degli Artrosis, tanto per rimanere in tema)… Fra gli stili il blues (e derivati) si evidenzia come una fra le più azzeccate medicine dell’anima. Sono vent’anni che lo sperimenta sul campo la No Profit Blues Band che, per il compleanno, presenta l’album Helpin’ Hands frutto della collaborazione con la LILT di Treviso. Dismessi camici e mascherine, messi nel cassetto bisturi e stetoscopi, la band di professionisti della sanità con pianoforte (Alberto Zorzi), chitarra (Maurizio Marzaro), batteria (Danilo Taffarello), basso (Matteo Gasparello), voci (Teo Pelloia, Jessica Vinci, Luisa Lo Santo, Elisabetta Monastero), saxes ( Giacomo “Jack” Berlese) e armonica (Mauro Erri) ha adoperato un altro tipo di attrezzatura per “radiografare” i dintorni del blues . Scopo dell’”operazione”? Far sorridere i pazienti della LILT trevigiana diffondendo pillole di buonumore con iniezioni di spensieratezza. Un ensemble, il loro, mosso esclusivamente dal piacere di offrire la loro musica come antidoto per quanti vi possano trovare motivo di distrazione. Va detto che i pezzi in scaletta sono stati scelti ed eseguiti con maestria e verve. In scaletta ci sono “Smile” di Chaplin (cavallo di battaglia del fisiatra Zorzi), “Mustang Sally” di Rice (si è in pieno r&b alla Pickett ), “Summertime” (Gershwin forever), “Route 66” di Troup (con versioni che vanno da Nat King Cole agli Stones), “Unchain My Heart” di Sharp (ripreso divinamente fra gli altri da Joe Cocker), “Hoochie Coochie Man” di Dixon (Muddy Waters uber alles), “I Got A Woman” e “Halleluja I Love Her So” di Ray Charles, “Let The Good Times Roll” hit di B.B. King … Musica angelica, macchè diabolica, per lenire le ferite dello spirito.
da Amedeo Furfaro | 13/Set/2022 | I nostri CD, Primo piano, Recensioni
Si viaggiare. Con i dischi lo si può fare low cost, a rischio zero quanto a code, disdette, scioperi, ritardi, scali, turbolenze e chi ne ha più ne metta. Basta avere gli album giusti dove ci si trova ed un po’ di fantasia da stimolare attraverso l’ascolto. Eccone alcuni di quelli utili a immaginare viaggi virtuali verso mete vicine o lontane.
Parlando di Jazz di Viaggio, non potevamo non iniziare con la recensione di un cd inviataci da un critico musicale italiano che vive da tempo a Hong Kong. Il suo nome è Franco Savadori, esperto di jazz, diplomato al Conservatorio G. Tartini di Trieste in timpani e strumenti a percussione e da oltre 25 anni qualificato mercante d’arte e manager di importanti gallerie. Savadori recensisce il cd dei Green Tea inFusion, gruppo del Nord-Est formatosi di recente che annovera tra i suoi componenti tre veterani della fusion e un giovanissimo talento. (Redazione)
GreenTea inFusion, “GreenTea inFusion” (Autop.)
 È proprio vero: le vecchie abitudini sono dure a morire… E così, in maniera a dir vero inaspettata, spunta questa nuovissima raccolta di tracce sonore svolte ed elaborate dagli immaginifici fratelli Fabris, Franco alle tastiere e Maurizio alle percussioni, integrati, per volere di sincronico destino, dal polistrumentista Gianni Iardino, nonché dal tornito e solido basso del giovanissimo Pietro Liut. Come d’abitudine propria al navigato Franco, non a caso forgiatosi anche sui campi di calcio, anche in questa circostanza è stata data piena preminenza al gioco di squadra collettivo, in un contesto di perfetta parità all’interno dei singoli ruoli esecutivi, per quanto sei degli otto brani incisi siano nati dalla felice vena compositiva di Gianni Iardino, pianista d’estrazione accademica, ma saxofonista per immagamento timbrico, come ben si può cogliere dall’ascolto di questa manciata di acquarelli timbrico-armonici. Una musica, questa, veramente posta in (in)fusione), ove le sensazioni speziate delle sonorità riportano ad un mélange ricco di rimandi, ispirazioni, citazioni appena accennate, fondali sonori che in parte inducono alla nostalgia per gusti antichi, all’improvviso riaffiorati per via retronasale, di quelli celati negli anfratti più reconditi di memorie archiviate, ma mai del tutto sopite. Tutto può accadere, e tutto accade, entro le mura all’apparenza ordinate di questi brani. La celebrazione della post-post-modernità in musica? L’amore per il bricolage di generi, stili e prassi organizzative? Forse, può darsi: ma lungi dall’essere una musica preparata “a tavolino”, questi brani procedono lisci e senza alcuna forzatura proprio al pari d’una suadente e profumata tisana dai risvolti concilianti e dagli intenti lenitivi.
È proprio vero: le vecchie abitudini sono dure a morire… E così, in maniera a dir vero inaspettata, spunta questa nuovissima raccolta di tracce sonore svolte ed elaborate dagli immaginifici fratelli Fabris, Franco alle tastiere e Maurizio alle percussioni, integrati, per volere di sincronico destino, dal polistrumentista Gianni Iardino, nonché dal tornito e solido basso del giovanissimo Pietro Liut. Come d’abitudine propria al navigato Franco, non a caso forgiatosi anche sui campi di calcio, anche in questa circostanza è stata data piena preminenza al gioco di squadra collettivo, in un contesto di perfetta parità all’interno dei singoli ruoli esecutivi, per quanto sei degli otto brani incisi siano nati dalla felice vena compositiva di Gianni Iardino, pianista d’estrazione accademica, ma saxofonista per immagamento timbrico, come ben si può cogliere dall’ascolto di questa manciata di acquarelli timbrico-armonici. Una musica, questa, veramente posta in (in)fusione), ove le sensazioni speziate delle sonorità riportano ad un mélange ricco di rimandi, ispirazioni, citazioni appena accennate, fondali sonori che in parte inducono alla nostalgia per gusti antichi, all’improvviso riaffiorati per via retronasale, di quelli celati negli anfratti più reconditi di memorie archiviate, ma mai del tutto sopite. Tutto può accadere, e tutto accade, entro le mura all’apparenza ordinate di questi brani. La celebrazione della post-post-modernità in musica? L’amore per il bricolage di generi, stili e prassi organizzative? Forse, può darsi: ma lungi dall’essere una musica preparata “a tavolino”, questi brani procedono lisci e senza alcuna forzatura proprio al pari d’una suadente e profumata tisana dai risvolti concilianti e dagli intenti lenitivi.
Queste composizioni sono toccate e benedette dalla capacità comune all’intero gruppo di tendere ad una sorta di laconicità opulenta, tra cetre russe, kalimbe equatoriali, koti estremo orientali e tanto altro ancora, che, ben si noti, trova la propria base nel mozartiano lavoro compiuto da Maurizio Fabris alle percussioni, dove la pesantezza batteristica viene sostituita da una elegantissima levità percussiva, tanto timbricamente varia quanto dinamicamente contenuta nell’alveo della sonorità generale. Bello pure l’intreccio dei fondali, distribuiti tra le tastiere di Franco e Gianni, a supporto del traboccante itinerare del contralto dello stesso Iardino, mai dimentico della passionalità melodica, con probabilità la vera carta vincente della godibilità totale di questo fresco e delicato lavoro. Un’operazione portata a termine da quattro anime empaticamente musicali, il cui scopo primario era quello di riuscire a replicare su CD una musica scaturita per il puro gusto di creare assieme la giusta miscela timbrica per le vostre assetate orecchie. Quindi: buon ascolto e buona bevuta. (Franco Savadori)
*** ed ora, spazio alle recensioni di Amedeo Furfaro
Tatiana Valle & Giovanni Guaccero – “Canto Estrangeiro” – Encore Music
 E’ come se alla storia piacesse … shakerare e sperimentare, nel proprio scorrere, nuovi cocktail. L’alchimia è avvenuta con la musica del Brasile dove la cultura dei conquistadores portoghesi, mixata con “spezie” locali, ha plasmato uno specifico heritage generando forme come choro, maxixe e samba, così “distanti” da fado e fandango, a volerne sottolineare la distanza dall’eredità culturale della madrepatria. Con la quale peraltro il rapporto è continuato ad esistere e vive tuttora in Europa, Italia compresa, a causa dell’approdarvi di artisti brasiliani in analogia ad altri colleghi ispanoamericani. Canto Estrangeiro, album della Encore Music a firma della vocalist Tatiana Valle e del pianista Giovanni Guaccero, è una tela sonora e canora del Brasile fuori dal Brasile, un paese-doppio, un’immagine riflessa richiamata e ricamata da Guaccero sui versi di Luis Elòi Stein a partire da Lingua Minha che precede una dozzina di splendide composizioni. Ne ha scritto la musica da “straniero” che ha assimilato Jobim, de Hollanda, Nascimento, il poeta de Moraes….per un viaggio “di ritorno” verso il Rio Grande do Sul, dal Tevere, il cui “voucher” è un compact carioca curato in ogni particolare. Vi hanno partecipato il batterista Bruno Marcozzi, la flautista Barbara Piperno, il chitarrista-mandolinista Marco Ruviaro, con ospiti Giancarlo Bianchetti alla chitarra elettrica, Henrique Cazes al cavaquinho, Fred Martins al canto, Carlos Cèsar Motta alle percussioni e Francesco Maria Parazzoli al cello. Nell’insieme il Brasile di Guaccero-Stein e della Valle non risulta oleografico né saporifero di vintage bensì è partecipe dell’oggi in ruoli di protagonista fra le nuove correnti della musica tropicale ad influsso jazz che spirano forti oltre l’Atlantico.
E’ come se alla storia piacesse … shakerare e sperimentare, nel proprio scorrere, nuovi cocktail. L’alchimia è avvenuta con la musica del Brasile dove la cultura dei conquistadores portoghesi, mixata con “spezie” locali, ha plasmato uno specifico heritage generando forme come choro, maxixe e samba, così “distanti” da fado e fandango, a volerne sottolineare la distanza dall’eredità culturale della madrepatria. Con la quale peraltro il rapporto è continuato ad esistere e vive tuttora in Europa, Italia compresa, a causa dell’approdarvi di artisti brasiliani in analogia ad altri colleghi ispanoamericani. Canto Estrangeiro, album della Encore Music a firma della vocalist Tatiana Valle e del pianista Giovanni Guaccero, è una tela sonora e canora del Brasile fuori dal Brasile, un paese-doppio, un’immagine riflessa richiamata e ricamata da Guaccero sui versi di Luis Elòi Stein a partire da Lingua Minha che precede una dozzina di splendide composizioni. Ne ha scritto la musica da “straniero” che ha assimilato Jobim, de Hollanda, Nascimento, il poeta de Moraes….per un viaggio “di ritorno” verso il Rio Grande do Sul, dal Tevere, il cui “voucher” è un compact carioca curato in ogni particolare. Vi hanno partecipato il batterista Bruno Marcozzi, la flautista Barbara Piperno, il chitarrista-mandolinista Marco Ruviaro, con ospiti Giancarlo Bianchetti alla chitarra elettrica, Henrique Cazes al cavaquinho, Fred Martins al canto, Carlos Cèsar Motta alle percussioni e Francesco Maria Parazzoli al cello. Nell’insieme il Brasile di Guaccero-Stein e della Valle non risulta oleografico né saporifero di vintage bensì è partecipe dell’oggi in ruoli di protagonista fra le nuove correnti della musica tropicale ad influsso jazz che spirano forti oltre l’Atlantico.
Aiòn – “Me vs Myself” – Alterjinga
 Ricorda a momenti le elucubrazioni fonetiche di Bobby McFerrin l’album di Aiòn Me Vs Myself (Giorgio Pinardi) edito da Alterjinga, per lo scavo, a livello di vocalizzazione, effettuato su realtà musicali remote. Non cambia l’approccio sia che provengano dall’Africa della tribù Dagara in “Yelbongura” o dal gaelico in “Scriob” o dal danese arcaico di “Hyggelig”. C’è, in genere, una “manipolazione” dei materiali musicali trattati – e questo accade ancora in “Leys” – che forse lo stesso Demetrio Stratos oggi non avrebbe disdegnato nelle proprie “investigazioni” tendenti a far “cantare la voce”. Il lavoro continua con “Waldeinsamkeit”, impronunciabile termine tedesco che non ha una diretta traduzione in inglese e che vuol dire essere in connessione con la natura (e con la musica) e con “Rwty” (Sfinge in antico egiziano) a riprova di come, in musica, la ricerca etimologica si possa coniugare con quella etnologica. Chiudono l’album il desertico “Kamtar” quindi “aPHaSIa” (stesso significato in italiano) e “Nèkya” ovverossia la discesa agli inferi dei greci, detta in termini psicanalitici il processo younghiano di scoperta dell’inconscio.
Ricorda a momenti le elucubrazioni fonetiche di Bobby McFerrin l’album di Aiòn Me Vs Myself (Giorgio Pinardi) edito da Alterjinga, per lo scavo, a livello di vocalizzazione, effettuato su realtà musicali remote. Non cambia l’approccio sia che provengano dall’Africa della tribù Dagara in “Yelbongura” o dal gaelico in “Scriob” o dal danese arcaico di “Hyggelig”. C’è, in genere, una “manipolazione” dei materiali musicali trattati – e questo accade ancora in “Leys” – che forse lo stesso Demetrio Stratos oggi non avrebbe disdegnato nelle proprie “investigazioni” tendenti a far “cantare la voce”. Il lavoro continua con “Waldeinsamkeit”, impronunciabile termine tedesco che non ha una diretta traduzione in inglese e che vuol dire essere in connessione con la natura (e con la musica) e con “Rwty” (Sfinge in antico egiziano) a riprova di come, in musica, la ricerca etimologica si possa coniugare con quella etnologica. Chiudono l’album il desertico “Kamtar” quindi “aPHaSIa” (stesso significato in italiano) e “Nèkya” ovverossia la discesa agli inferi dei greci, detta in termini psicanalitici il processo younghiano di scoperta dell’inconscio.
Bincoletto-Vio-Trabucco-Drago – “Duende” – Abeat Records
 Il Duende, per Garcia Lorca, è un imprecisato non so che proprio di alcuni toreri, pittori, poeti, musicisti, uno “stile vivo”, “creaciòn en acto”, fluido irresistibile che arriva al pubblico e che, nei “suoni neri” del jazz, è stato da alcuni associato alla Holiday ed a Miles Davis. Il ribattezzare Duende un progetto discografico, come hanno fatto la vocalist Rita Bincoletto, il chitarrista Diego Vio, il percussionista Max Trabucco e l’ospite Anais Drago, violinista, assume l’intento di traslare la cultura flamenca del poeta spagnolo ricercando le relazioni di quel “potere” nel pianeta liquido del Mediterraneo. La loro traversata geOnirica in un ondoso campo largo li porta fino alla Grecia del traditional “Amygdalaki Tsakisa” ed al Medio Oriente di “Isfahan Trip”; quindi, tramite “Desert Way”, eccoli incrociare figure reali (“Isola”) e mitologiche (“Tres Sirenas”). Un lavoro “waterworld” pubblicato da Abeat Records che consta di nove brani in tutto per la maggior parte scritti e/o arrangiati da Bincoletto, Vio e Trabucco, navigatori fra i suoni marini.
Il Duende, per Garcia Lorca, è un imprecisato non so che proprio di alcuni toreri, pittori, poeti, musicisti, uno “stile vivo”, “creaciòn en acto”, fluido irresistibile che arriva al pubblico e che, nei “suoni neri” del jazz, è stato da alcuni associato alla Holiday ed a Miles Davis. Il ribattezzare Duende un progetto discografico, come hanno fatto la vocalist Rita Bincoletto, il chitarrista Diego Vio, il percussionista Max Trabucco e l’ospite Anais Drago, violinista, assume l’intento di traslare la cultura flamenca del poeta spagnolo ricercando le relazioni di quel “potere” nel pianeta liquido del Mediterraneo. La loro traversata geOnirica in un ondoso campo largo li porta fino alla Grecia del traditional “Amygdalaki Tsakisa” ed al Medio Oriente di “Isfahan Trip”; quindi, tramite “Desert Way”, eccoli incrociare figure reali (“Isola”) e mitologiche (“Tres Sirenas”). Un lavoro “waterworld” pubblicato da Abeat Records che consta di nove brani in tutto per la maggior parte scritti e/o arrangiati da Bincoletto, Vio e Trabucco, navigatori fra i suoni marini.
Vincenzo Caruso – “Chansons sous les Doigts” – Dodicilune
 Chansons sous les doigts è una selezione di 19 canzoni francesi arrangiate per piano da Vincenzo Caruso che ci ricorda quanto ci siano vicini, in musica, i cugini transalpini. Sono tratteggiate, nell’album Dodicilune, in modo essenziale, scarnificate del testo con focus sulla melodia e l’armonizzazione con sensibilità moderna. Caruso se ne innamorò giovanissimo tramite gli spartiti inviatigli dallo zio Antonio Di Domenico, chansonnier ed editore a Parigi, coltivando nel tempo una passione pianistica che lo avrebbe portato a collaborare a Irma la Douce, la famosa commedia musicata da Marguerite Monnot, di cui ripropone nel disco la “Piccola Suite per Piano”. I temi proposti sono di nomi altisonanti come Henry Salvador (“Syracuse”), Gilbert Becaud (“Quand il est mort le poète”), Georges Brassens (“J’ai rendez vous avec vous”) … L’antologia rappresenta un omaggio alla chanson in cui il pianoforte contende lo scettro di strumento principe alla fisarmonica e, nel contempo, ne offre un’ampia gamma – “Le tango corse”, lo swing di “On est pas là pour se faire engueler”, l’incipit musorgskiano di “Comèdie”, il walzer di “Domani”, il distillar note alla Satie di “Le deserteur” – che ne saggia la tavolozza espressiva e coloristica. Il disco è chiuso da “Après l’ourage” che potrebbe, perche no, commentare un film di Méliès, muto, tanto la narrazione è affidata alle dieci dita, les doigts, sulla tastiera.
Chansons sous les doigts è una selezione di 19 canzoni francesi arrangiate per piano da Vincenzo Caruso che ci ricorda quanto ci siano vicini, in musica, i cugini transalpini. Sono tratteggiate, nell’album Dodicilune, in modo essenziale, scarnificate del testo con focus sulla melodia e l’armonizzazione con sensibilità moderna. Caruso se ne innamorò giovanissimo tramite gli spartiti inviatigli dallo zio Antonio Di Domenico, chansonnier ed editore a Parigi, coltivando nel tempo una passione pianistica che lo avrebbe portato a collaborare a Irma la Douce, la famosa commedia musicata da Marguerite Monnot, di cui ripropone nel disco la “Piccola Suite per Piano”. I temi proposti sono di nomi altisonanti come Henry Salvador (“Syracuse”), Gilbert Becaud (“Quand il est mort le poète”), Georges Brassens (“J’ai rendez vous avec vous”) … L’antologia rappresenta un omaggio alla chanson in cui il pianoforte contende lo scettro di strumento principe alla fisarmonica e, nel contempo, ne offre un’ampia gamma – “Le tango corse”, lo swing di “On est pas là pour se faire engueler”, l’incipit musorgskiano di “Comèdie”, il walzer di “Domani”, il distillar note alla Satie di “Le deserteur” – che ne saggia la tavolozza espressiva e coloristica. Il disco è chiuso da “Après l’ourage” che potrebbe, perche no, commentare un film di Méliès, muto, tanto la narrazione è affidata alle dieci dita, les doigts, sulla tastiera.
TMR – “Tuscany Music Revolution” – Aut Records
 Ci sono tre quarti d’ora buoni di musica nell’album TMR Tuscany Music Revolution, prodotto dalla label tedesca Aut Records, divisa in sette parti di durata varia che va dai due agli otto minuti. Ne è protagonista l’Improvvisazione con consonanze (II) e minimalismi (III), africanerie (IV) e simil-musica d’oggi (V)… Il parterre artistico internazionale (V. Sutera, v; M. Mazzini, cl; E. Novali, pf; A. Braida, pf; F. Calcagno, cl; A. Bolzoni, g; L. Pissavini, cb; S. Di Benedetto, cb; D. Koutè (perc); S. Scucces (vib.), G. Lattuada (perc); L. D’Erasmo (frame dr); S. Grasso (dr) non “inscena” un ritorno al postfree semmai si pone in termini di attualizzazione e “rivoluzionaria” evoluzione di quell’area creativa che l’ Europa, Italia compresa, ha espresso anche in anni recenti dall’asse anglo-olandese fin giù a scendere sulla cartina geomusicale. Il collettivo è un esempio di interazione democratica e paritaria che, al pari di stormi liberi ma coordinati, delinea impreviste dinamie sonore e traiettorie mutaforma, in un fluttuare a volte sincronico altre no comunque ancorato alla struttura dei vari insiemi che si avvicendano.
Ci sono tre quarti d’ora buoni di musica nell’album TMR Tuscany Music Revolution, prodotto dalla label tedesca Aut Records, divisa in sette parti di durata varia che va dai due agli otto minuti. Ne è protagonista l’Improvvisazione con consonanze (II) e minimalismi (III), africanerie (IV) e simil-musica d’oggi (V)… Il parterre artistico internazionale (V. Sutera, v; M. Mazzini, cl; E. Novali, pf; A. Braida, pf; F. Calcagno, cl; A. Bolzoni, g; L. Pissavini, cb; S. Di Benedetto, cb; D. Koutè (perc); S. Scucces (vib.), G. Lattuada (perc); L. D’Erasmo (frame dr); S. Grasso (dr) non “inscena” un ritorno al postfree semmai si pone in termini di attualizzazione e “rivoluzionaria” evoluzione di quell’area creativa che l’ Europa, Italia compresa, ha espresso anche in anni recenti dall’asse anglo-olandese fin giù a scendere sulla cartina geomusicale. Il collettivo è un esempio di interazione democratica e paritaria che, al pari di stormi liberi ma coordinati, delinea impreviste dinamie sonore e traiettorie mutaforma, in un fluttuare a volte sincronico altre no comunque ancorato alla struttura dei vari insiemi che si avvicendano.
Pietro Lazazzara – “Gypsy Jazz Style” – Stradivarius
 Il chitarrismo manouche, quello praticato a livelli alti di nomadismo dei polpastrelli, può talora lasciar trasparire una certa patina di “monadismo”, per così dire, quando vi si riscontra unità inclusiva del connotato stilistico di base. E’ il caso dell’album Gypsy Jazz Style di Pietro Lazazzara (Stradivarius), seconda uscita discografica a sua firma, con una dozzina di inediti eseguiti all’insegna della convergenza di varietà e contaminazioni. L’ ensemble annovera Antonio Solazzo al basso, Francesco Clemente e Sabrina Loforese al volino, Maria Pia Lazazzara al violoncello, Luigi Vania alla viola, Nicoletta Di Sabato al flauto e Giuseppe Magistro al tamburello. Campeggia sullo sfondo, sin dal primo brano “Mister Swing”, l’ologramma di Django. Poi la musica, strada facendo, si fa intima in “Precious”, intinta di classico in “La via di Pia”, melò in “Walk with Me”, walzer notturno in “The Tale of the Moon”, flamenco in “La tela di Picasso”, tarant(ell)a in “Puglia”, moderato swing in “Blue Night”, sostenuto in “La joie de vivre”, è balcanica in “Circus”, tutta coracon in “Spanish Boulevard”, infine tripudio di note in “Impro in D Minor” con il gruppo che si trasforma in Gypsy Jazz Style Kings.
Il chitarrismo manouche, quello praticato a livelli alti di nomadismo dei polpastrelli, può talora lasciar trasparire una certa patina di “monadismo”, per così dire, quando vi si riscontra unità inclusiva del connotato stilistico di base. E’ il caso dell’album Gypsy Jazz Style di Pietro Lazazzara (Stradivarius), seconda uscita discografica a sua firma, con una dozzina di inediti eseguiti all’insegna della convergenza di varietà e contaminazioni. L’ ensemble annovera Antonio Solazzo al basso, Francesco Clemente e Sabrina Loforese al volino, Maria Pia Lazazzara al violoncello, Luigi Vania alla viola, Nicoletta Di Sabato al flauto e Giuseppe Magistro al tamburello. Campeggia sullo sfondo, sin dal primo brano “Mister Swing”, l’ologramma di Django. Poi la musica, strada facendo, si fa intima in “Precious”, intinta di classico in “La via di Pia”, melò in “Walk with Me”, walzer notturno in “The Tale of the Moon”, flamenco in “La tela di Picasso”, tarant(ell)a in “Puglia”, moderato swing in “Blue Night”, sostenuto in “La joie de vivre”, è balcanica in “Circus”, tutta coracon in “Spanish Boulevard”, infine tripudio di note in “Impro in D Minor” con il gruppo che si trasforma in Gypsy Jazz Style Kings.
Giovanni Angelini – “Freedom Rhythm” – A.MA Records
 “Voyager” è uno dei brani di punta del secondo album firmato dal batterista Giovanni Angelini dal titolo Freedom Rhythm, otto brani, scritti di proprio pugno, dal groove eclettico che mette assieme jazz funk afro soul e che non disdegna il guardare indietro, fino ai fab ’70. Ovviamente si tratta di un jazzista moderno ma con il piacere di far “viaggiare” la propria musica nello spaziotempo pilotandola da bandleader. Piace pensare che il “ritmo in libertà” sia anche quello del drummer che si svincola, crea, costruisce, si autointerpreta. Ed è infatti la veste di compositore quella che vi rispecchia le qualità di ideatore di strutture compless(iv)e caratterizzate da franca immediatezza e circolarità di un suono plasmato con Vince Abbracciante al piano, Dario Giacovelli al basso, Alberto Parmegiani alla chitarra, Gaetano Partipilo all’alto sax, Giuseppe Todisco alla tromba, Antonio Fallacara al trombone quindi Giovanni Astorino al cello. Ai quali si aggiunge il canto di Simona Severini con la “gemma” di “I Need Your Smile”. La sezione dei tre fiati assume un ruolo energico nello sviluppo dei temi (e nell’alternarsi improvvisativo) dalle linee melodiche che effettivamente rimangono impresse, un po’ tutte, da “Subway” fino a “Unity”, “Release The Monkey”, “Wuelva”, “Compass”, e nel contempo si muovono su scansioni metriche e schemi accordali nient’affatto scontati. Insomma ancora un bel prodotto del catalogo A.Ma Records!
“Voyager” è uno dei brani di punta del secondo album firmato dal batterista Giovanni Angelini dal titolo Freedom Rhythm, otto brani, scritti di proprio pugno, dal groove eclettico che mette assieme jazz funk afro soul e che non disdegna il guardare indietro, fino ai fab ’70. Ovviamente si tratta di un jazzista moderno ma con il piacere di far “viaggiare” la propria musica nello spaziotempo pilotandola da bandleader. Piace pensare che il “ritmo in libertà” sia anche quello del drummer che si svincola, crea, costruisce, si autointerpreta. Ed è infatti la veste di compositore quella che vi rispecchia le qualità di ideatore di strutture compless(iv)e caratterizzate da franca immediatezza e circolarità di un suono plasmato con Vince Abbracciante al piano, Dario Giacovelli al basso, Alberto Parmegiani alla chitarra, Gaetano Partipilo all’alto sax, Giuseppe Todisco alla tromba, Antonio Fallacara al trombone quindi Giovanni Astorino al cello. Ai quali si aggiunge il canto di Simona Severini con la “gemma” di “I Need Your Smile”. La sezione dei tre fiati assume un ruolo energico nello sviluppo dei temi (e nell’alternarsi improvvisativo) dalle linee melodiche che effettivamente rimangono impresse, un po’ tutte, da “Subway” fino a “Unity”, “Release The Monkey”, “Wuelva”, “Compass”, e nel contempo si muovono su scansioni metriche e schemi accordali nient’affatto scontati. Insomma ancora un bel prodotto del catalogo A.Ma Records!
Massimo Barbiero – “In Hora Mortis”
 Con In Hora Mortis la ricerca musicale del percussionista Massimo Barbiero, ancora una volta al confine fra filosofia e psicanalisi, si ritrova ad investigare, per il tramite del suono inteso come elemento vitale primario, il momento terminale del vivere. Un argomento che da Platone a Epicuro a Freud ha appassionato e arrovellato il pensiero umano antico e moderno. Barbiero lo affronta con gli “strumenti” che gli sono più congeniali e cioè quelli del suo ricco set percussivo. Per l’occasione suddivide l’hora in più momenti temporali gradualizzandola secondo una scala emotiva augmentante che non tradisce pathos mortiferi o pianti greci. La musica “domina” la possibile angoscia, la esorcizza, prende atto che i minuti che preludono all’ultimo atto dell’esistenza sono vita tout court e come tali possono essere vissuti magari riprodotti e sonorizzati da gong campane ritmi… Barbiero materializza così la propria “fantasia di sparizione” (Fagioli) in un disco coraggioso per Il tema che affronta e offre una lettura del tutto originale del fine vita che va ad installarsi in un percorso artistico di sperimentata coerenza culturale.
Con In Hora Mortis la ricerca musicale del percussionista Massimo Barbiero, ancora una volta al confine fra filosofia e psicanalisi, si ritrova ad investigare, per il tramite del suono inteso come elemento vitale primario, il momento terminale del vivere. Un argomento che da Platone a Epicuro a Freud ha appassionato e arrovellato il pensiero umano antico e moderno. Barbiero lo affronta con gli “strumenti” che gli sono più congeniali e cioè quelli del suo ricco set percussivo. Per l’occasione suddivide l’hora in più momenti temporali gradualizzandola secondo una scala emotiva augmentante che non tradisce pathos mortiferi o pianti greci. La musica “domina” la possibile angoscia, la esorcizza, prende atto che i minuti che preludono all’ultimo atto dell’esistenza sono vita tout court e come tali possono essere vissuti magari riprodotti e sonorizzati da gong campane ritmi… Barbiero materializza così la propria “fantasia di sparizione” (Fagioli) in un disco coraggioso per Il tema che affronta e offre una lettura del tutto originale del fine vita che va ad installarsi in un percorso artistico di sperimentata coerenza culturale.
Amedeo Furfaro








 Del Piano/Olivieri/Mazza/Marini, Double 3, Caligola Records
Del Piano/Olivieri/Mazza/Marini, Double 3, Caligola Records Canova Trio feat. Fulvio Sigurtà, Agata, Filibusta Records
Canova Trio feat. Fulvio Sigurtà, Agata, Filibusta Records Giovanni Benvenuti , An Hour Of Existence, AMP Music & Records
Giovanni Benvenuti , An Hour Of Existence, AMP Music & Records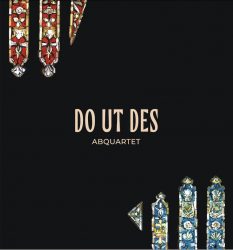 ABQuartet, Do Ut Des, Red & Blue.
ABQuartet, Do Ut Des, Red & Blue. Zhu Quartet, GINKGO, Workin’ Label.
Zhu Quartet, GINKGO, Workin’ Label. Marco Vavassori feat. Lincetto/Smiderle/Uliana, Walking with Bob, Caligola Records.
Marco Vavassori feat. Lincetto/Smiderle/Uliana, Walking with Bob, Caligola Records.









 È proprio vero: le vecchie abitudini sono dure a morire… E così, in maniera a dir vero inaspettata, spunta questa nuovissima raccolta di tracce sonore svolte ed elaborate dagli immaginifici fratelli Fabris, Franco alle tastiere e Maurizio alle percussioni, integrati, per volere di sincronico destino, dal polistrumentista Gianni Iardino, nonché dal tornito e solido basso del giovanissimo Pietro Liut. Come d’abitudine propria al navigato Franco, non a caso forgiatosi anche sui campi di calcio, anche in questa circostanza è stata data piena preminenza al gioco di squadra collettivo, in un contesto di perfetta parità all’interno dei singoli ruoli esecutivi, per quanto sei degli otto brani incisi siano nati dalla felice vena compositiva di Gianni Iardino, pianista d’estrazione accademica, ma saxofonista per immagamento timbrico, come ben si può cogliere dall’ascolto di questa manciata di acquarelli timbrico-armonici. Una musica, questa, veramente posta in (in)fusione), ove le sensazioni speziate delle sonorità riportano ad un mélange ricco di rimandi, ispirazioni, citazioni appena accennate, fondali sonori che in parte inducono alla nostalgia per gusti antichi, all’improvviso riaffiorati per via retronasale, di quelli celati negli anfratti più reconditi di memorie archiviate, ma mai del tutto sopite. Tutto può accadere, e tutto accade, entro le mura all’apparenza ordinate di questi brani. La celebrazione della post-post-modernità in musica? L’amore per il bricolage di generi, stili e prassi organizzative? Forse, può darsi: ma lungi dall’essere una musica preparata “a tavolino”, questi brani procedono lisci e senza alcuna forzatura proprio al pari d’una suadente e profumata tisana dai risvolti concilianti e dagli intenti lenitivi.
È proprio vero: le vecchie abitudini sono dure a morire… E così, in maniera a dir vero inaspettata, spunta questa nuovissima raccolta di tracce sonore svolte ed elaborate dagli immaginifici fratelli Fabris, Franco alle tastiere e Maurizio alle percussioni, integrati, per volere di sincronico destino, dal polistrumentista Gianni Iardino, nonché dal tornito e solido basso del giovanissimo Pietro Liut. Come d’abitudine propria al navigato Franco, non a caso forgiatosi anche sui campi di calcio, anche in questa circostanza è stata data piena preminenza al gioco di squadra collettivo, in un contesto di perfetta parità all’interno dei singoli ruoli esecutivi, per quanto sei degli otto brani incisi siano nati dalla felice vena compositiva di Gianni Iardino, pianista d’estrazione accademica, ma saxofonista per immagamento timbrico, come ben si può cogliere dall’ascolto di questa manciata di acquarelli timbrico-armonici. Una musica, questa, veramente posta in (in)fusione), ove le sensazioni speziate delle sonorità riportano ad un mélange ricco di rimandi, ispirazioni, citazioni appena accennate, fondali sonori che in parte inducono alla nostalgia per gusti antichi, all’improvviso riaffiorati per via retronasale, di quelli celati negli anfratti più reconditi di memorie archiviate, ma mai del tutto sopite. Tutto può accadere, e tutto accade, entro le mura all’apparenza ordinate di questi brani. La celebrazione della post-post-modernità in musica? L’amore per il bricolage di generi, stili e prassi organizzative? Forse, può darsi: ma lungi dall’essere una musica preparata “a tavolino”, questi brani procedono lisci e senza alcuna forzatura proprio al pari d’una suadente e profumata tisana dai risvolti concilianti e dagli intenti lenitivi. E’ come se alla storia piacesse … shakerare e sperimentare, nel proprio scorrere, nuovi cocktail. L’alchimia è avvenuta con la musica del Brasile dove la cultura dei conquistadores portoghesi, mixata con “spezie” locali, ha plasmato uno specifico heritage generando forme come choro, maxixe e samba, così “distanti” da fado e fandango, a volerne sottolineare la distanza dall’eredità culturale della madrepatria. Con la quale peraltro il rapporto è continuato ad esistere e vive tuttora in Europa, Italia compresa, a causa dell’approdarvi di artisti brasiliani in analogia ad altri colleghi ispanoamericani. Canto Estrangeiro, album della Encore Music a firma della vocalist Tatiana Valle e del pianista Giovanni Guaccero, è una tela sonora e canora del Brasile fuori dal Brasile, un paese-doppio, un’immagine riflessa richiamata e ricamata da Guaccero sui versi di Luis Elòi Stein a partire da Lingua Minha che precede una dozzina di splendide composizioni. Ne ha scritto la musica da “straniero” che ha assimilato Jobim, de Hollanda, Nascimento, il poeta de Moraes….per un viaggio “di ritorno” verso il Rio Grande do Sul, dal Tevere, il cui “voucher” è un compact carioca curato in ogni particolare. Vi hanno partecipato il batterista Bruno Marcozzi, la flautista Barbara Piperno, il chitarrista-mandolinista Marco Ruviaro, con ospiti Giancarlo Bianchetti alla chitarra elettrica, Henrique Cazes al cavaquinho, Fred Martins al canto, Carlos Cèsar Motta alle percussioni e Francesco Maria Parazzoli al cello. Nell’insieme il Brasile di Guaccero-Stein e della Valle non risulta oleografico né saporifero di vintage bensì è partecipe dell’oggi in ruoli di protagonista fra le nuove correnti della musica tropicale ad influsso jazz che spirano forti oltre l’Atlantico.
E’ come se alla storia piacesse … shakerare e sperimentare, nel proprio scorrere, nuovi cocktail. L’alchimia è avvenuta con la musica del Brasile dove la cultura dei conquistadores portoghesi, mixata con “spezie” locali, ha plasmato uno specifico heritage generando forme come choro, maxixe e samba, così “distanti” da fado e fandango, a volerne sottolineare la distanza dall’eredità culturale della madrepatria. Con la quale peraltro il rapporto è continuato ad esistere e vive tuttora in Europa, Italia compresa, a causa dell’approdarvi di artisti brasiliani in analogia ad altri colleghi ispanoamericani. Canto Estrangeiro, album della Encore Music a firma della vocalist Tatiana Valle e del pianista Giovanni Guaccero, è una tela sonora e canora del Brasile fuori dal Brasile, un paese-doppio, un’immagine riflessa richiamata e ricamata da Guaccero sui versi di Luis Elòi Stein a partire da Lingua Minha che precede una dozzina di splendide composizioni. Ne ha scritto la musica da “straniero” che ha assimilato Jobim, de Hollanda, Nascimento, il poeta de Moraes….per un viaggio “di ritorno” verso il Rio Grande do Sul, dal Tevere, il cui “voucher” è un compact carioca curato in ogni particolare. Vi hanno partecipato il batterista Bruno Marcozzi, la flautista Barbara Piperno, il chitarrista-mandolinista Marco Ruviaro, con ospiti Giancarlo Bianchetti alla chitarra elettrica, Henrique Cazes al cavaquinho, Fred Martins al canto, Carlos Cèsar Motta alle percussioni e Francesco Maria Parazzoli al cello. Nell’insieme il Brasile di Guaccero-Stein e della Valle non risulta oleografico né saporifero di vintage bensì è partecipe dell’oggi in ruoli di protagonista fra le nuove correnti della musica tropicale ad influsso jazz che spirano forti oltre l’Atlantico. Ricorda a momenti le elucubrazioni fonetiche di Bobby McFerrin l’album di Aiòn Me Vs Myself (Giorgio Pinardi) edito da Alterjinga, per lo scavo, a livello di vocalizzazione, effettuato su realtà musicali remote. Non cambia l’approccio sia che provengano dall’Africa della tribù Dagara in “Yelbongura” o dal gaelico in “Scriob” o dal danese arcaico di “Hyggelig”. C’è, in genere, una “manipolazione” dei materiali musicali trattati – e questo accade ancora in “Leys” – che forse lo stesso Demetrio Stratos oggi non avrebbe disdegnato nelle proprie “investigazioni” tendenti a far “cantare la voce”. Il lavoro continua con “Waldeinsamkeit”, impronunciabile termine tedesco che non ha una diretta traduzione in inglese e che vuol dire essere in connessione con la natura (e con la musica) e con “Rwty” (Sfinge in antico egiziano) a riprova di come, in musica, la ricerca etimologica si possa coniugare con quella etnologica. Chiudono l’album il desertico “Kamtar” quindi “aPHaSIa” (stesso significato in italiano) e “Nèkya” ovverossia la discesa agli inferi dei greci, detta in termini psicanalitici il processo younghiano di scoperta dell’inconscio.
Ricorda a momenti le elucubrazioni fonetiche di Bobby McFerrin l’album di Aiòn Me Vs Myself (Giorgio Pinardi) edito da Alterjinga, per lo scavo, a livello di vocalizzazione, effettuato su realtà musicali remote. Non cambia l’approccio sia che provengano dall’Africa della tribù Dagara in “Yelbongura” o dal gaelico in “Scriob” o dal danese arcaico di “Hyggelig”. C’è, in genere, una “manipolazione” dei materiali musicali trattati – e questo accade ancora in “Leys” – che forse lo stesso Demetrio Stratos oggi non avrebbe disdegnato nelle proprie “investigazioni” tendenti a far “cantare la voce”. Il lavoro continua con “Waldeinsamkeit”, impronunciabile termine tedesco che non ha una diretta traduzione in inglese e che vuol dire essere in connessione con la natura (e con la musica) e con “Rwty” (Sfinge in antico egiziano) a riprova di come, in musica, la ricerca etimologica si possa coniugare con quella etnologica. Chiudono l’album il desertico “Kamtar” quindi “aPHaSIa” (stesso significato in italiano) e “Nèkya” ovverossia la discesa agli inferi dei greci, detta in termini psicanalitici il processo younghiano di scoperta dell’inconscio. Il Duende, per Garcia Lorca, è un imprecisato non so che proprio di alcuni toreri, pittori, poeti, musicisti, uno “stile vivo”, “creaciòn en acto”, fluido irresistibile che arriva al pubblico e che, nei “suoni neri” del jazz, è stato da alcuni associato alla Holiday ed a Miles Davis. Il ribattezzare Duende un progetto discografico, come hanno fatto la vocalist Rita Bincoletto, il chitarrista Diego Vio, il percussionista Max Trabucco e l’ospite Anais Drago, violinista, assume l’intento di traslare la cultura flamenca del poeta spagnolo ricercando le relazioni di quel “potere” nel pianeta liquido del Mediterraneo. La loro traversata geOnirica in un ondoso campo largo li porta fino alla Grecia del traditional “Amygdalaki Tsakisa” ed al Medio Oriente di “Isfahan Trip”; quindi, tramite “Desert Way”, eccoli incrociare figure reali (“Isola”) e mitologiche (“Tres Sirenas”). Un lavoro “waterworld” pubblicato da Abeat Records che consta di nove brani in tutto per la maggior parte scritti e/o arrangiati da Bincoletto, Vio e Trabucco, navigatori fra i suoni marini.
Il Duende, per Garcia Lorca, è un imprecisato non so che proprio di alcuni toreri, pittori, poeti, musicisti, uno “stile vivo”, “creaciòn en acto”, fluido irresistibile che arriva al pubblico e che, nei “suoni neri” del jazz, è stato da alcuni associato alla Holiday ed a Miles Davis. Il ribattezzare Duende un progetto discografico, come hanno fatto la vocalist Rita Bincoletto, il chitarrista Diego Vio, il percussionista Max Trabucco e l’ospite Anais Drago, violinista, assume l’intento di traslare la cultura flamenca del poeta spagnolo ricercando le relazioni di quel “potere” nel pianeta liquido del Mediterraneo. La loro traversata geOnirica in un ondoso campo largo li porta fino alla Grecia del traditional “Amygdalaki Tsakisa” ed al Medio Oriente di “Isfahan Trip”; quindi, tramite “Desert Way”, eccoli incrociare figure reali (“Isola”) e mitologiche (“Tres Sirenas”). Un lavoro “waterworld” pubblicato da Abeat Records che consta di nove brani in tutto per la maggior parte scritti e/o arrangiati da Bincoletto, Vio e Trabucco, navigatori fra i suoni marini. Chansons sous les doigts è una selezione di 19 canzoni francesi arrangiate per piano da Vincenzo Caruso che ci ricorda quanto ci siano vicini, in musica, i cugini transalpini. Sono tratteggiate, nell’album Dodicilune, in modo essenziale, scarnificate del testo con focus sulla melodia e l’armonizzazione con sensibilità moderna. Caruso se ne innamorò giovanissimo tramite gli spartiti inviatigli dallo zio Antonio Di Domenico, chansonnier ed editore a Parigi, coltivando nel tempo una passione pianistica che lo avrebbe portato a collaborare a Irma la Douce, la famosa commedia musicata da Marguerite Monnot, di cui ripropone nel disco la “Piccola Suite per Piano”. I temi proposti sono di nomi altisonanti come Henry Salvador (“Syracuse”), Gilbert Becaud (“Quand il est mort le poète”), Georges Brassens (“J’ai rendez vous avec vous”) … L’antologia rappresenta un omaggio alla chanson in cui il pianoforte contende lo scettro di strumento principe alla fisarmonica e, nel contempo, ne offre un’ampia gamma – “Le tango corse”, lo swing di “On est pas là pour se faire engueler”, l’incipit musorgskiano di “Comèdie”, il walzer di “Domani”, il distillar note alla Satie di “Le deserteur” – che ne saggia la tavolozza espressiva e coloristica. Il disco è chiuso da “Après l’ourage” che potrebbe, perche no, commentare un film di Méliès, muto, tanto la narrazione è affidata alle dieci dita, les doigts, sulla tastiera.
Chansons sous les doigts è una selezione di 19 canzoni francesi arrangiate per piano da Vincenzo Caruso che ci ricorda quanto ci siano vicini, in musica, i cugini transalpini. Sono tratteggiate, nell’album Dodicilune, in modo essenziale, scarnificate del testo con focus sulla melodia e l’armonizzazione con sensibilità moderna. Caruso se ne innamorò giovanissimo tramite gli spartiti inviatigli dallo zio Antonio Di Domenico, chansonnier ed editore a Parigi, coltivando nel tempo una passione pianistica che lo avrebbe portato a collaborare a Irma la Douce, la famosa commedia musicata da Marguerite Monnot, di cui ripropone nel disco la “Piccola Suite per Piano”. I temi proposti sono di nomi altisonanti come Henry Salvador (“Syracuse”), Gilbert Becaud (“Quand il est mort le poète”), Georges Brassens (“J’ai rendez vous avec vous”) … L’antologia rappresenta un omaggio alla chanson in cui il pianoforte contende lo scettro di strumento principe alla fisarmonica e, nel contempo, ne offre un’ampia gamma – “Le tango corse”, lo swing di “On est pas là pour se faire engueler”, l’incipit musorgskiano di “Comèdie”, il walzer di “Domani”, il distillar note alla Satie di “Le deserteur” – che ne saggia la tavolozza espressiva e coloristica. Il disco è chiuso da “Après l’ourage” che potrebbe, perche no, commentare un film di Méliès, muto, tanto la narrazione è affidata alle dieci dita, les doigts, sulla tastiera. Ci sono tre quarti d’ora buoni di musica nell’album TMR Tuscany Music Revolution, prodotto dalla label tedesca Aut Records, divisa in sette parti di durata varia che va dai due agli otto minuti. Ne è protagonista l’Improvvisazione con consonanze (II) e minimalismi (III), africanerie (IV) e simil-musica d’oggi (V)… Il parterre artistico internazionale (V. Sutera, v; M. Mazzini, cl; E. Novali, pf; A. Braida, pf; F. Calcagno, cl; A. Bolzoni, g; L. Pissavini, cb; S. Di Benedetto, cb; D. Koutè (perc); S. Scucces (vib.), G. Lattuada (perc); L. D’Erasmo (frame dr); S. Grasso (dr) non “inscena” un ritorno al postfree semmai si pone in termini di attualizzazione e “rivoluzionaria” evoluzione di quell’area creativa che l’ Europa, Italia compresa, ha espresso anche in anni recenti dall’asse anglo-olandese fin giù a scendere sulla cartina geomusicale. Il collettivo è un esempio di interazione democratica e paritaria che, al pari di stormi liberi ma coordinati, delinea impreviste dinamie sonore e traiettorie mutaforma, in un fluttuare a volte sincronico altre no comunque ancorato alla struttura dei vari insiemi che si avvicendano.
Ci sono tre quarti d’ora buoni di musica nell’album TMR Tuscany Music Revolution, prodotto dalla label tedesca Aut Records, divisa in sette parti di durata varia che va dai due agli otto minuti. Ne è protagonista l’Improvvisazione con consonanze (II) e minimalismi (III), africanerie (IV) e simil-musica d’oggi (V)… Il parterre artistico internazionale (V. Sutera, v; M. Mazzini, cl; E. Novali, pf; A. Braida, pf; F. Calcagno, cl; A. Bolzoni, g; L. Pissavini, cb; S. Di Benedetto, cb; D. Koutè (perc); S. Scucces (vib.), G. Lattuada (perc); L. D’Erasmo (frame dr); S. Grasso (dr) non “inscena” un ritorno al postfree semmai si pone in termini di attualizzazione e “rivoluzionaria” evoluzione di quell’area creativa che l’ Europa, Italia compresa, ha espresso anche in anni recenti dall’asse anglo-olandese fin giù a scendere sulla cartina geomusicale. Il collettivo è un esempio di interazione democratica e paritaria che, al pari di stormi liberi ma coordinati, delinea impreviste dinamie sonore e traiettorie mutaforma, in un fluttuare a volte sincronico altre no comunque ancorato alla struttura dei vari insiemi che si avvicendano. Il chitarrismo manouche, quello praticato a livelli alti di nomadismo dei polpastrelli, può talora lasciar trasparire una certa patina di “monadismo”, per così dire, quando vi si riscontra unità inclusiva del connotato stilistico di base. E’ il caso dell’album Gypsy Jazz Style di Pietro Lazazzara (Stradivarius), seconda uscita discografica a sua firma, con una dozzina di inediti eseguiti all’insegna della convergenza di varietà e contaminazioni. L’ ensemble annovera Antonio Solazzo al basso, Francesco Clemente e Sabrina Loforese al volino, Maria Pia Lazazzara al violoncello, Luigi Vania alla viola, Nicoletta Di Sabato al flauto e Giuseppe Magistro al tamburello. Campeggia sullo sfondo, sin dal primo brano “Mister Swing”, l’ologramma di Django. Poi la musica, strada facendo, si fa intima in “Precious”, intinta di classico in “La via di Pia”, melò in “Walk with Me”, walzer notturno in “The Tale of the Moon”, flamenco in “La tela di Picasso”, tarant(ell)a in “Puglia”, moderato swing in “Blue Night”, sostenuto in “La joie de vivre”, è balcanica in “Circus”, tutta coracon in “Spanish Boulevard”, infine tripudio di note in “Impro in D Minor” con il gruppo che si trasforma in Gypsy Jazz Style Kings.
Il chitarrismo manouche, quello praticato a livelli alti di nomadismo dei polpastrelli, può talora lasciar trasparire una certa patina di “monadismo”, per così dire, quando vi si riscontra unità inclusiva del connotato stilistico di base. E’ il caso dell’album Gypsy Jazz Style di Pietro Lazazzara (Stradivarius), seconda uscita discografica a sua firma, con una dozzina di inediti eseguiti all’insegna della convergenza di varietà e contaminazioni. L’ ensemble annovera Antonio Solazzo al basso, Francesco Clemente e Sabrina Loforese al volino, Maria Pia Lazazzara al violoncello, Luigi Vania alla viola, Nicoletta Di Sabato al flauto e Giuseppe Magistro al tamburello. Campeggia sullo sfondo, sin dal primo brano “Mister Swing”, l’ologramma di Django. Poi la musica, strada facendo, si fa intima in “Precious”, intinta di classico in “La via di Pia”, melò in “Walk with Me”, walzer notturno in “The Tale of the Moon”, flamenco in “La tela di Picasso”, tarant(ell)a in “Puglia”, moderato swing in “Blue Night”, sostenuto in “La joie de vivre”, è balcanica in “Circus”, tutta coracon in “Spanish Boulevard”, infine tripudio di note in “Impro in D Minor” con il gruppo che si trasforma in Gypsy Jazz Style Kings. “Voyager” è uno dei brani di punta del secondo album firmato dal batterista Giovanni Angelini dal titolo Freedom Rhythm, otto brani, scritti di proprio pugno, dal groove eclettico che mette assieme jazz funk afro soul e che non disdegna il guardare indietro, fino ai fab ’70. Ovviamente si tratta di un jazzista moderno ma con il piacere di far “viaggiare” la propria musica nello spaziotempo pilotandola da bandleader. Piace pensare che il “ritmo in libertà” sia anche quello del drummer che si svincola, crea, costruisce, si autointerpreta. Ed è infatti la veste di compositore quella che vi rispecchia le qualità di ideatore di strutture compless(iv)e caratterizzate da franca immediatezza e circolarità di un suono plasmato con Vince Abbracciante al piano, Dario Giacovelli al basso, Alberto Parmegiani alla chitarra, Gaetano Partipilo all’alto sax, Giuseppe Todisco alla tromba, Antonio Fallacara al trombone quindi Giovanni Astorino al cello. Ai quali si aggiunge il canto di Simona Severini con la “gemma” di “I Need Your Smile”. La sezione dei tre fiati assume un ruolo energico nello sviluppo dei temi (e nell’alternarsi improvvisativo) dalle linee melodiche che effettivamente rimangono impresse, un po’ tutte, da “Subway” fino a “Unity”, “Release The Monkey”, “Wuelva”, “Compass”, e nel contempo si muovono su scansioni metriche e schemi accordali nient’affatto scontati. Insomma ancora un bel prodotto del catalogo A.Ma Records!
“Voyager” è uno dei brani di punta del secondo album firmato dal batterista Giovanni Angelini dal titolo Freedom Rhythm, otto brani, scritti di proprio pugno, dal groove eclettico che mette assieme jazz funk afro soul e che non disdegna il guardare indietro, fino ai fab ’70. Ovviamente si tratta di un jazzista moderno ma con il piacere di far “viaggiare” la propria musica nello spaziotempo pilotandola da bandleader. Piace pensare che il “ritmo in libertà” sia anche quello del drummer che si svincola, crea, costruisce, si autointerpreta. Ed è infatti la veste di compositore quella che vi rispecchia le qualità di ideatore di strutture compless(iv)e caratterizzate da franca immediatezza e circolarità di un suono plasmato con Vince Abbracciante al piano, Dario Giacovelli al basso, Alberto Parmegiani alla chitarra, Gaetano Partipilo all’alto sax, Giuseppe Todisco alla tromba, Antonio Fallacara al trombone quindi Giovanni Astorino al cello. Ai quali si aggiunge il canto di Simona Severini con la “gemma” di “I Need Your Smile”. La sezione dei tre fiati assume un ruolo energico nello sviluppo dei temi (e nell’alternarsi improvvisativo) dalle linee melodiche che effettivamente rimangono impresse, un po’ tutte, da “Subway” fino a “Unity”, “Release The Monkey”, “Wuelva”, “Compass”, e nel contempo si muovono su scansioni metriche e schemi accordali nient’affatto scontati. Insomma ancora un bel prodotto del catalogo A.Ma Records! Con In Hora Mortis la ricerca musicale del percussionista Massimo Barbiero, ancora una volta al confine fra filosofia e psicanalisi, si ritrova ad investigare, per il tramite del suono inteso come elemento vitale primario, il momento terminale del vivere. Un argomento che da Platone a Epicuro a Freud ha appassionato e arrovellato il pensiero umano antico e moderno. Barbiero lo affronta con gli “strumenti” che gli sono più congeniali e cioè quelli del suo ricco set percussivo. Per l’occasione suddivide l’hora in più momenti temporali gradualizzandola secondo una scala emotiva augmentante che non tradisce pathos mortiferi o pianti greci. La musica “domina” la possibile angoscia, la esorcizza, prende atto che i minuti che preludono all’ultimo atto dell’esistenza sono vita tout court e come tali possono essere vissuti magari riprodotti e sonorizzati da gong campane ritmi… Barbiero materializza così la propria “fantasia di sparizione” (Fagioli) in un disco coraggioso per Il tema che affronta e offre una lettura del tutto originale del fine vita che va ad installarsi in un percorso artistico di sperimentata coerenza culturale.
Con In Hora Mortis la ricerca musicale del percussionista Massimo Barbiero, ancora una volta al confine fra filosofia e psicanalisi, si ritrova ad investigare, per il tramite del suono inteso come elemento vitale primario, il momento terminale del vivere. Un argomento che da Platone a Epicuro a Freud ha appassionato e arrovellato il pensiero umano antico e moderno. Barbiero lo affronta con gli “strumenti” che gli sono più congeniali e cioè quelli del suo ricco set percussivo. Per l’occasione suddivide l’hora in più momenti temporali gradualizzandola secondo una scala emotiva augmentante che non tradisce pathos mortiferi o pianti greci. La musica “domina” la possibile angoscia, la esorcizza, prende atto che i minuti che preludono all’ultimo atto dell’esistenza sono vita tout court e come tali possono essere vissuti magari riprodotti e sonorizzati da gong campane ritmi… Barbiero materializza così la propria “fantasia di sparizione” (Fagioli) in un disco coraggioso per Il tema che affronta e offre una lettura del tutto originale del fine vita che va ad installarsi in un percorso artistico di sperimentata coerenza culturale.



