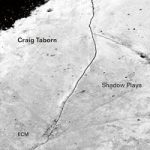da Gerlando Gatto | 18/Dic/2023 | I nostri CD, News, Primo piano, Recensioni
 Heinz Holliger, Anton Kernjak – “Eventail” – ECM New Series
Heinz Holliger, Anton Kernjak – “Eventail” – ECM New Series
Consentitemi di aprire questa rubrica in modo assolutamente nuovo, vale a dire con una sortita nel campo della musica classica. Lo faccio perché questo album mi ha semplicemente incantato e credo valga la pena di essere ascoltato soprattutto da quanti, come me, amano la musica francese dei primi anni del secolo scorso incentrata sull’oboe. In programma musiche di Messiaen, Koechlin, Jolivet, Ravel, Debussy, Milhaud, Saint-Saens, Casadeus. L’ oboista e compositore svizzero Heinz Holliger (classe 1939) è considerate uno dei migliori oboisti al mondo particolarmente versato nel genere che si ascolta in questo album; al suo fianco Anton Kernjak, che ebbe modo di collaborare con Holliger nell’album “Aschenmusik” del 2014, mentre l’arpista francese Alice Belugou l’ascoltiamo in un solo brano di Andre Jovilet “Controversia” per oboe e arpa. L’ascolto è impreziosito dal libretto che accompagna il CD in cui Holliger spiega perché ha scelto questi brani illustrandone la valenza storica e artistica.
 Veljo Tormis – “Reminiscentiae” – ECM New Series
Veljo Tormis – “Reminiscentiae” – ECM New Series
Un’altra prestigiosa realizzazione di ECM nella collana New Series. Protagonista la musica di Veljo Tormis (1930-2017) considerato a ragione uno dei più grandi compositori corali contemporanei nonché uno dei più importanti compositori del XX secolo in Estonia. Nell’album sono contenute memorie che evocano scene dell’infanzia di Tormis in un alternarsi di situazioni sonore che vedono protagonisti ora il coro e i due soprani più un recitativo, ora il coro e l’orchestra, ora il mezzo-soprano Iris Oja e l’orchestra, ora il coro, il soprano Maria Valdmaa ora alcuni solisti come Indrek Vanu alla tromba, Madis Metsamart alle percussioni e Linda Vood al flauto. L’album assume una particolare rilevanza anche perché è stato personalmente curato da Tõnu Kaljuste che per decadi è stato uno dei più stretti collaboratori di Tomis e che nell’occasione, oltre a dirigere la Tallinn Chamber Orchestra ha scelto personalmente il materiale da far ascoltare, ivi compreso quel ‘The Tower Bell in My Village’ che Tormis compose nel 1978 appositamente per un tour che Kaljuste effettuò di lì a poco. Insomma un album in cui Kaljuste riflette tutto il suo amore, la sua ammirazione verso il compositore scomparso la cui musica non può che affascinare ad onta degli anni che passano.
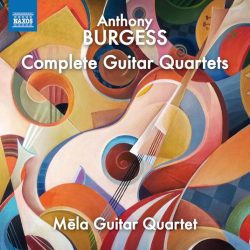 Anthony Burgess – “Complete Guitar Quartets” – Naxos
Anthony Burgess – “Complete Guitar Quartets” – Naxos
Il compositore inglese Anthony Burgess (1917-1993) fu personalità poliedrica, capace di eccellere sia nella letteratura sia nella musica. In quest’ultimo campo compose una serie di quartetti per chitarra che vengono qui presentati in edizione integrale, unitamente ad altre due composizioni, di cui una ‘traditional’ e le altre due dovute rispettivamente all’estro di Gustav Holst e Car Maria von Weber. Tornando ai quartetti di Burgess, composti negli anni ’80, la cosa strana è che Anthony mai ha suonato la chitarra eppure in molte sue novelle il protagonista principale è proprio un chitarrista. Il primo quartetto rilevante, “Quatuor pour Guitares”, completato nel 1986, fu scritto per l’ Aighetta Quartet, e fu eseguito per la prima volta presso l’ Academié Rainer III di Monaco; sottotitolato ‘Quatuor en hommage a Maurice Ravel’ evidenzia una forte influenza della musica francese. Come già accennato, oltre ai quartetti in questo album compare “Trois Morceaux Irlandais” ovvero tre trascrizioni e arrangiamenti di altrettante arie Irlandesi che evidenziano le grandi capacità di Burgess anche come arrangiatore. Un’ultima ma non secondaria notazione: nell’album a suonare la musica di Burgess è chiamato il Mēla Guitar Quartet ovvero Matthew Robinson, George Tarlton, Daniel Bovey e Jiva Housden.
Torniamo sempre con ECM sul terreno jazzistico
 Wolfgang Muthspiel – “Dance of the Elders” – ECM
Wolfgang Muthspiel – “Dance of the Elders” – ECM
Il chitarrista Wolfgang Muthspiel si ripresenta alla testa del suo trio con Scott Coley al contrabbasso e Brian Blade alla batteria per bissare il successo ottenuto con il precedente album “Angular Blues” del 2018. Ancora una volta la musica dell’artista presenta molteplici riferimenti sia alla musica folk sia alla musica classica solo che, in questa occasione, abbiamo ascoltato un Muthspiel più attratto dalle linee melodiche il più delle volte perfettamente riconoscibili. Di qui un fraseggio sempre originale, misurato, tecnicamente ineccepibile e sempre molto, molto elegante. Dei sette brani presentati nell’album (tutti a firma del leader eccezion fatta per “Liebeslied” di Kurt Weill e Berthold Brecht e “Amelia”) il brano che meglio esemplifica quanto fin qui detto è proprio il conclusivo “Amelia”: si tratta di una splendida ballad di Joni Mitchell che il trio reinterpreta con rara delicatezza e con un linguaggio prettamente jazzistico a conferma, se pur ce ne fosse bisogno, che il jazz si identifica non già per quel che si suona ma per come lo si suona.
 Maciej Obara Quartet – “Frozen Silence” – ECM
Maciej Obara Quartet – “Frozen Silence” – ECM
Maciej Obara è un sassofonista polacco (alto e tenore) che ha già alle spalle una fortunata carriera sia come leader sia come sideman in altri gruppi. Con questo nuovo album è alla sua terza realizzazione per ECM e si ripresenta alla testa del suo collaudato quartetto che ha già alle spalle una lunga storia. Al piano troviamo Dominik Wania anch’egli polacco, un altro grande talento che si è incontrato con Obara una decina di anni fa in un ensemble di Tomasz Stanko. Da 2012 i due sono stati raggiunti da una sezione ritmica norvegese composta dal bassista Ole Morten Vagan e dal percussionista Gard Nilssen. Sette delle otto composizioni dell’album sono state scritte durante il periodo della pandemia e quindi riflettono al meglio il lato interiore di Maciej Obara. Di qui un’atmosfera sempre assai meditativa, alle volte velata da una certa malinconia, il tutto declinato con un linguaggio pacato, mai sopra le righe, che non vuol affermare alcuna validità tecnica ma solo rispondere appieno a quelle che sono le intenzioni comunicative del leader. Molto interessante anche il gioco sulle dinamiche che esplicita al meglio l’empatia tra i membri del quartetto.
 Sinikka Langeland – “Wind And Sun” – ECM
Sinikka Langeland – “Wind And Sun” – ECM
Undici composizioni della vocalist norvegese Sinikka Langeland su testi del poeta Jon Fosse più un brano scritto sempre dalla Langelad ma questa volta in collaborazione con Geirr Tveitt. Ad accompagnare la leader un quartetto composto da Trygve Seim – già collaboratore della stessa Langeland – al sax tenore e soprano, Mathias Eick alla tromba, Mats Eilertssen al contrabbasso e Thomas Stronen alla batteria, musicisti tutti ben noti a chi segue il jazz nordico. L’album rispecchia ancora una volta quelle che sono le coordinate stilistiche della Langeland, vale a dire una musica essenziale, senza fronzoli, che trae i suoi motivi ispiratori il più delle volte direttamente dal ricco patrimonio folkloristico nonché dagli input che provengono direttamente dalla natura. Non è certo un caso che la vocalist abbia messo in musica i versi di uno dei più importanti poeti e drammaturghi contemporanei come Jon Fosse – anch’egli norvegese – conosciuto come “il nuovo Ibsen”. Ma chi si aspettasse un album dalle sonorità arcaiche rimarrebbe deluso in quanto il gruppo si muove invece su elementi di assoluta modernità sorretti da grande preparazione tecnica e da un idem sentire con la vocalist. Sentite, ad esempio, come il sax (ora soprano ora tenore) di Seim sottolinei alcuni passaggi che il kantele di Sinikka continua ad eseguire in sottofondo con una stratificazione di suoni tutt’altro che banale.
Restiamo in Norvegia con le produzioni Losen
 Sara Calvanelli, Virginia Sutera – “Ejadira” – Losen
Sara Calvanelli, Virginia Sutera – “Ejadira” – Losen
La Losen si va caratterizzando sempre più per la presenza nel suo catalogo di musicisti non norvegesi tra cui parecchi italiani. Questa volta è il caso di un duo al femminile composto da Sara Calvanelli, accordeon, indian harmonium, loops, cojo, voce e Virginia Sutera, violino. Davvero strana la genesi di questo album per cui vale la pena raccontarla brevemente. La Calvanelli è fisarmonicista arguta che ama sia la scrittura sia la libera improvvisazione; dal canto suo Virginia Sutera è violinista anch’essa attenta all’improvvisazione ma soprattutto all’interazione tra la musica e le altre arti. Siamo nell’autunno del 2020, tempo di lock-down. Le due musiciste decidono di incontrarsi seppure solo per corrispondenza: di qui uno scambio di idee, di prove, di registrazioni fino a quando chiuso il periodo del lock-down, le due si incontrano personalmente dando vita all’album in oggetto. Date le premesse tutto il disco si basa su un libero gioco improvvisativo tra le due che dimostrano di avere un’ottima intesa passando da sonorità che richiamano il barocco a momenti folk fino ad atmosfere più “moderne”.
 Sudeshna Bhattacharya & Somnath Roy –“Mousson de Calcutta” – Losen
Sudeshna Bhattacharya & Somnath Roy –“Mousson de Calcutta” – Losen
Ancora una sortita fuori dai confini nazionali da parte di questa coraggiosa etichetta che si è spinta sino a considerare la musica indiana…anche se poi la registrazione è stata effettuata a Oslo. Anche di questo album è protagonista un duo ben lontano, come si accennava, dalle terre e dalle atmosfere nordiche: Sudeshna Bhattacharya e Somnath Roy. Si tratta di un connubio apparentemente improbabile: Sudeshna è infatti uno dei migliori specialisti di sarod, lo strumento a corde tipico della tradizione musicale dell’Hindustan mentre Somnath è conosciuto per la sua straordinaria abilità nel percuotere il ghatam, strumento tipico della musica carnatica indiana. E’ possibile far coesistere questi due generi sulla carta così diversi? Secondo gli esperti di musica indiana assolutamente no: viceversa i due artisti, con questo album, hanno dimostrato che sì, è possibile, basta intendersi su ciò che si vuole esprimere, basta possedere una straordinaria tecnica di base e il gioco è fatto. In repertorio tre composizioni create da Bhattacharya che durano ben sei, 13 e 38 minuti; in tutte e tre spicca il meraviglioso canto della già citata Somnath Roy che riesce ad emozionare ogni ascoltatore al di là di qualsivoglia barriera di terra e di lingua.
Benvenuta alla Ipogeo Records
E’ con vero piacere che salutiamo questa nuova etichetta discografica Ipogeo Records fondata di recente da Filippo Cosentino, uno dei principali compositori e musicisti jazz contemporanei.
Come sottolineano i responsabili dell’etichetta, fondamentale è la solidità del team di produzione. Da un lato il gruppo di lavoro, che nelle figure chiave è formato da Filippo Cosentino, fondatore, producer e direttore artistico; Federico Mollo, fonico e assistente di produzione; Adriana Riccomagno, ufficio stampa e coordinamento team di distribuzione; Fabrizia Gar e Carlotta Vacchetti, team grafico. Particolare attenzione viene dedicata alla cura del catalogo musicale assicurato dalla casa editrice Cose Note Edizioni. Le sezioni del catalogo sono: jazz music, songwriting e cantautorato; musica contemporanea; early music; soundtrack.
In jazz music e musica contemporanea, tre progetti sono stati ammessi al primo turno di ballottaggio dei Grammy® Awards in due differenti edizioni: 65th Recording Academy / GRAMMYs for the Grammy® Awards Heros, Filippo Cosentino feat. Danilo Mineo e Daniele Bertone, nella categoria Best New Artist; Carlotta The Musical, James David Spellman / Filippo Cosentino, nella categoria Best Theatre Music essendo in effetti la colonna sonora di uno spettacolo teatrale; e quest’anno alla 66th Recording Academy / GRAMMYs for the Grammy® Awards Ask, Filippo Cosentino, nella categoria Best Instrumental Contemporary Music mentre Leeway, singolo tratto da Ask, Filippo Cosentino & Marc Copland feat. Daniele Bertone, nella categoria Best Jazz Performance.
 Nella categoria Jazz i primi due lavori pubblicato sono stati “Multiverse” solo in versione digitale e quindi “Heros” di Filippo Cosentino. In quest’ultimo album la formazione è il trio in cui il leader, chitarrista, è accompagnato dal formidabile pianista Marc Copland, per moltissimi anni componente della formazione di John Abercrombie, e Daniele Bertone alla batteria e percussioni. In programma sette composizioni del leader in cui si evidenzia da un lato le capacità strumentali di tutti e tre i musicisti, dall’altro le ottime capacità compositive di Cosentino che di certo non scopriamo oggi. Le atmosfere predilette sono un mix di jazz, folk e country anche se qua e là riemerge l‘anima mediterranea del leader.
Nella categoria Jazz i primi due lavori pubblicato sono stati “Multiverse” solo in versione digitale e quindi “Heros” di Filippo Cosentino. In quest’ultimo album la formazione è il trio in cui il leader, chitarrista, è accompagnato dal formidabile pianista Marc Copland, per moltissimi anni componente della formazione di John Abercrombie, e Daniele Bertone alla batteria e percussioni. In programma sette composizioni del leader in cui si evidenzia da un lato le capacità strumentali di tutti e tre i musicisti, dall’altro le ottime capacità compositive di Cosentino che di certo non scopriamo oggi. Le atmosfere predilette sono un mix di jazz, folk e country anche se qua e là riemerge l‘anima mediterranea del leader.
In Italia scendono in campo anche i grossi calibri
 Amato Jazz Trio – “Keep Straight On” – abeat
Amato Jazz Trio – “Keep Straight On” – abeat
Elio Amato piano, Alberto Amato contrabbasso e Loris Amato batteria sono i componenti dell’Amato Jazz Trio, una delle formazioni più longeve he a storia del jazz italiano conosca. Una storia costellata di successi straordinari colti in tutto il mondo tanto che non a caso l’amico Franco Faienz li aveva definiti uno dei più originali trii d’Europa e oltre”. La storia del Trio comincia nel 1979 in Sicilia, a Canicattini Bagni, dove i tre fratellini Elio, Alberto e Sergio si divertono a suonare assieme. Ben presto si fanno notare a livello locale e arrivano i primi ingaggi, i primi concerti. Nel periodo che va dal 1985 al 1987 la svolta: il gruppo viene chiamato per aprire i concerti di stelle quali Betty Carter, Muhual Richard Abrams e Wynton Marsalis. Nel 1988 il gruppo vince a Milano il concorso indipendenti per l’allora celebre rivista Fare Musica e subito dopo il jazz contest della Dire. ottenendo come premio la possibilità di incidere il loro primo disco intitolato ‘Jazz Contest 88’. Da quel momento l’Amato Jazz trio incide una serie di album sempre di grande successo e soprattutto ottiene il plauso indiscriminato di pubblico e di critica mantenendo il suo standard qualitativo sempre molto elevato. Cosa che si ripete anche in quest’ultimo album in cui i tre fratelli convincono sempre di più. La loro è davvero una musica ‘universale’ nel senso che nel stessa confluiscono input assai diversi provenienti ovviamente dal bop, dal free jazz, dalla tradizione classica e dalle straordinarie armonizzazioni proprie della musica dei primo del ‘900, il tutto senza dimenticare le origini mediterranee del trio che trova in ognuno dei componenti l’interprete ideale per quel che in quel momento si sta eseguendo. Di qui la difficoltà di segnalare un brano piuttosto che un altro…anche se qualche parola in più desideriamo spenderla per “Arvo” scritto da Alberto Amato: si tratta di un sentito omaggio al compositore estone Arvo Pärt contenuto in poco meno di quattro minuti in cui le influenze minimaliste la fanno da padrone trasportando l’ascoltatore in un mondo “altro”, ben lontano dalle nefandezze di quello odierno.
 Claudio Angeleri – “Concerto feat. Gianluigi Trovesi” – Dodicilune
Claudio Angeleri – “Concerto feat. Gianluigi Trovesi” – Dodicilune
Si intitola semplicemente “Concerto” il nuovo album firmato Claudio Angeleri e registrato live in occasione del Bergamo/Brescia Capitale della Cultura Italiana il 20 maggio 2023 presso l’Auditorium Modernissimo Nembro. Nella versione live i quadri di Gianni Bergamelli si intrecciano con le composizioni musicali di Claudio Angeleri, i testi narrativi di Maurizio Franco e le animazioni di Adriano Merigo che danzano in tempo reale con le improvvisazioni dei diversi solisti. Il CD che vi presentiamo è quindi un album a tema in cui il pianista e compositore bergamasco desidera omaggiare i grandi della cultura lombarda. Per affrontare questo difficile compito Angeleri ha chiamato accanto a sé una schiera di eccellenti musicisti quali Gianluigi Trovesi (clarinetto), Giulio Visibelli (sax soprano e flauto), Gabriele Comeglio (sax alto), Marco Esposito (basso elettrico), Matteo Milesi (batteria), Paola Milzani (impegnata sia come solista vocale sia come direttrice del coro), il giovane talento Nicholas Lecchi (sax tenore) e il coro The Golden Guys. In programma otto brani tutti scritti dallo stesso Angeleri eccezion fatta per “Lacrimosa” tratto dalla Messa da Requiem op. 73 di Gaetano Donizetti, mentre le liriche di “Light and Dark” e “Armida” sono state scritte da Alessia Marcassoli. Cercando di mantenersi in un difficilissimo equilibrio tra antico e attuale, Angeleri mette in campo tutta la sua sapienza musicale scrivendo partiture in cui echi di gospel si mescolano a input di chiara influenza “jazz contemporary” nonché classica in cui l’improvvisazione gioca un ruolo di primissimo piano grazie all’interplay che si è costituito tra i musicisti. Al riguardo eccellente il contributo degli artisti citati in precedenza con un Trovesi che sembra non sentire minimamente il peso degli anni che passano anche per lui. Per la cronaca i protagonisti cui sono dedicate le varie performance sono Caravaggio, Arturo Benedetti Michelangeli, Giacomo Costantino Beltrami, Niccolò Tartaglia, Giacomo Quarenghi, Torquato Tasso e le donne della Resistenza. Infine un elemento su cui interviene lo steso Angeleri: la musica, come si accennava, è tratta da uno spettacolo multimediale, procedimento sempre piuttosto rischioso. Di qui la domanda: è possibile gustare la valenza della musica prescindendo da tutto il resto? “Suggerisco afferma Angeleri – di dedicarsi ad un primo ascolto esclusivamente sonoro senza guardare e leggere il booklet: solo pura suggestione uditiva. Gli ascolti e le letture successive offriranno così la possibilità di cambiare prospettiva e replicare più volte le emozioni. Il disco, in questo modo, assume una dimensione plurale e condivisa che lo rende ancora oggi, nel terzo millennio, un mezzo vivo e stimolante per i musicisti di jazz – uso volutamente un termine così ampio – che si esprimono nel tempo reale e per il pubblico che ne fruisce. Anche per questo motivo è stata scelta una versione live di Concerto per catturare una versione unica e irripetibile».
 Dino Betti Van Der Noot – “Let Us Recount Our Dreams” – Audissea
Dino Betti Van Der Noot – “Let Us Recount Our Dreams” – Audissea
Mi onoro di conoscere Dino Betti oramai da qualche decennio ma posso tranquillamente affermare che ben difficilmente ho visto un jazzista conservare un entusiasmo, una lucidità, una positività che sempre riscontro quando parlo con lui. E queste qualità si ritrovano puntualmente negli album che, in questi ultimi tempi Dino licenzia producendo sempre musica di altissima qualità. Ovviamente a questa regola non fa eccezione “Let Us Recount Our Dreams” (“Raccontiamoci i nostri sogni”) chiaramente ispirato da una delle più belle e suggestive pagine di William Shakespeare. A parte l’originalità delle composizioni, è straordinario il modo in cui Betti gioca con le note: lui le fa ruotare, rimbalzare, rincorrere a formare un caleidoscopio che poi, fatalmente va a sfociare in un disegno unitario che evidentemente è lì, nella mente del leader. Ovviamente per raggiungere risultati del genere, è indispensabile poter contare su musicisti che ben conoscono il modo di operare del compositore: non è quindi un caso che anche questa volta Dino Betti Van Der Noot abbia chiamato accanto a sé i ventidue musicisti con i quali ha lavorato negli ultimi anni, in particolare nel precedente “The Silence of the Broken Lute”, con l’aggiunta del trombettista Tiziano Codoro, mentre a scrivere le lunghe note di copertina è stato incaricato il critico statunitense Thomas Conrad le cui considerazioni sono, a mio avviso, condivisibili dalla prima all’ultima riga. Venendo alle nostre personalissime considerazioni, anche in questo album abbiamo ritrovato quelle caratteristiche elencate in apertura con una attenzione maggiore verso certi suoni orientaleggianti che amplificano lo spettro sonoro di cui si serve Dino. Non a caso si è servito di strumenti quali l’arpa, il dizi e il flauto cinese poco usuali nelle orchestre jazz. A Conferma della sua straordinaria conoscenza dell’universo musicale nel suo insieme, non mancano accenni al progressive, accenni sempre misurati e comunque assolutamente pertinenti. Tutto Ciò, agendo allo stesso tempo con l’incrociare delle linee melodiche, con il flusso dinamico che varia in modo straordinario, con il variare delle atmosfere proposte fa sì che l’album mai perda una sola oncia di omogeneità. Insomma un gran bell’album che vale la pena ascoltare più di una volta per capirne ogni più remota sfumatura.
 Maria Pia De Vito – “This Woman’s Work” – PMR
Maria Pia De Vito – “This Woman’s Work” – PMR
Se ci dichiarassimo stupiti dall’ascolto di questo nuovo album di Maria Pia De Vito non saremmo sinceri fino in fondo: in effetti seguiamo la straordinaria carriera della vocalist napoletana da tanti anni e l’abbiamo sempre ammirata per quel suo mai adagiarsi sugli allori di un successo più che meritato, ma continuare a ricercare, ad andare avanti ad esplorare nuovi terreni. Questa volta l’obiettivo è veramente importante e per chi scrive è un piacere sottolinearlo dal momento che proprio a questo argomento ha dedicato un libro: riflessione sulla condizione femminile e su quali strategie sono state attuate dalle donne per resistere in questi lunghi lassi di tempo. Per farlo la De Vito si è avvalsa innanzitutto di un nuovo gruppo senza pianoforte composto da Mirco Rubegni tromba, Giacomo Ancillotto chitarre ed electronics, Matteo Bortone basso ed electroncis, Evita Polidoro batteria. I pezzi in repertorio provengono dal jazz di Tony Williams, Ornette Coleman, dal cantautorato di Elvis Costello e Kate Bush, fino a elementi del folk cui si aggiungono tre pezzi composti a quattro mani dalla leader con Matteo Bortone. L’ispirazione, per esplicita ammissione della stessa De Vito, proviene dalle opere di autrici quali Virginia Woolf, Rebecca Solnit, Margaret Atwood. Il risultato? Assolutamente convincente. La De Vito è del tutto credibile quando affronta la questione femminile anche perché, come si accennava in apertura, ha speso tutta la vita al servizio della musica senza cedere a compromessi e andando sempre dritto per la sua strada. Prescindendo dalle più che lodevoli intenzioni della leader, l’album si segnala per la sua intrinseca valenza artistica: i brani sono tutti significativi, interpretati ora con vigore ora con dolcezza dalla De Vito la cui voce sembra più chiara rispetto ad altre occasioni. More solito la De Vito improvvisa con disinvoltura chiamando in causa la sua profonda conoscenza della musica non solo jazz, ma anche rock, folk e classica. Ovviamente per affrontare una tematica così complessa non solo dal punto di vista musicale, la De Vito si è affidata ad un gruppo di musicisti non solo collaudati ma anche sulla rampa di lancio come la bravissima batterista Evita Polidoro. Al riguardo occorre sottolineare come la scelta si stata più che felice dal momento che il gruppo ha funzionato semplicemente alla perfezione.
 Claudio Fasoli NeXt 4et – “Ambush” – abeat–
Claudio Fasoli NeXt 4et – “Ambush” – abeat–
Conosco Fasoli oramai da parecchi anni e quindi posso affermare, senza tema di smentite, che Claudio è uomo intelligente, spiritoso, cordiale e originale. Queste doti il sassofonista le trasporta nella sua musica che di conseguenza risulta sempre straordinariamente nuova, affascinante, coinvolgente. Ascoltando uno dopo l’altro i vari suoi dischi si rimane davvero stupefatti di come l’artista abbia saputo trovare una chiave sempre nuova per le sue composizioni. Così anche questo “Ambush” presenta una sua spiccata originalità che lo distingue nettamente dai precedenti album, originalità che può farsi risalire ad un uso più spregiudicato e intenso dell’elettronica che trova nella chitarra di Simone Massaron un interprete fondamentale. Le note sembrano quasi rimbalzare da un lato all’altro del pentagramma senza soluzione di continuità con il leader che guida il gruppo con mano ferma anche se le parti improvvisate paiono davvero tante. Il tutto senza che mai il discorso narrativo perda la sua logica: Fasoli è sempre perfettamente a suo agio qualunque strumento imbracci ( sax tenore o sax soprano) e qualunque ruolo rivesta in quello specifico momento. E al riguardo non si può non rilevare la grandezza di Fasoli come compositore, un musicista che conosce benissimo il linguaggio musicale anche al di là del jazz, che sa perfettamente da dove partire e dove arrivare e che soprattutto riesce sempre ad esprimere i propri sentimenti all’interno di una scrittura che sa valutare assai bene anche il valore del silenzio, l’importanza del respiro nella musica, nell’universo sonoro. Non a caso Nat Hentoff ha scritto di lui “che non lo si può confondere con nessun’altro”. Molto ben studiato anche il repertorio in cui a brani veloci si alternano atmosfere più riflessive e intimistiche. Che portano l’ascoltatore a chiedersi con curiosità ‘cosa ascolterò adesso?’. Come ci piace sottolineare sempre in occasioni del genere, quando un album riesce così bene certo il merito va alle composizioni, al leader…ma anche al resto del gruppo che per l’occasione è costituito dal già citato Simone Massaron chitarra elettrica, Tito Mangialajo Rantzer contrabbasso e Stefano Grasso percussioni.
 Nicola Mingo – “My Sixties in Jazz” – Alfa Music
Nicola Mingo – “My Sixties in Jazz” – Alfa Music
Come si è forse già capito dalle mie note, i jazzisti italiani che hanno più di 50 anni praticamente li conosco tutti…o quasi. Ma coloro i quali posso definire “amici” sono ovviamente pochi, molto pochi. Ecco, Nicola Mingo è uno di questi anni. L’ho conosco da tempo e tra di noi si è instaurato un bellissimo rapporto fatto di reciproca stima ed amicizia. Stima ed amicizia che però non mi impediscono di valutare con tutta l’oggettività di cui sono capace le sue ‘imprese’ musicali. E proprio partendo da tale presupposto non ho alcun timore di essere smentito affermando che quest’ultima produzione del chitarrista napoletano è fra le cose migliori da lui incise nel corso degli anni. Nicola è uno dei musicisti più coerenti che abbia conosciuto: lui è u amante del bop e a questo linguaggio rimane fortemente ancorato nonostante i boppers in esercizio permanente effettivo siano rimasti veramente pochi ed è questa una considerazione imprescindibile nel valutare l’album. Lo stesso si pone, infatti, come un esplicito omaggio da un canto ai 60 anni di jazz di Mingo in senso autobiografico e, dall’altro esplicita il chitarrista “a quegli anni Sessanta che hanno prodotto fenomeni musicali come l’hard bop, Art Blakey and Jazz Messengers e tutte le derivazioni chitarristiche come Grant Green, Wes Montgomery, Kenny Burrell, Barney Kessel, Tal Farlow, Joe Pass, Pat Martino, George Benson, miei punti di riferimento stilistici”. M per essere ancora più chiari Mingo aggiunge che “questo progetto rappresenta un contributo personale, moderno ed innovativo al linguaggio del bebop e al suo fraseggio, nato con Charlie Parker e Dizzie Gillespie e ulteriormente sviluppatosi in una continua evoluzione fino ad approdare alla nostra contemporaneità”. Obiettivo centrato? A mio avviso assolutamente sì. La modernità di Mingo nell’approcciare uno dei linguaggi più complessi del jazz è sotto gli occhi (o meglio le orecchie) di tutti e può rappresentare, soprattutto per i più giovani, un momento di attenta rilettura di uno dei periodi più gloriosi nella storia del jazz, un momento che, specie negli ultimi anni, non tutti hanno saputo interpretare, nel modo più giusto facendolo apparire vecchio e superato. Ottimo, è anche questo è un grande pregio, il rivolgersi a compagni di viaggio che hanno saputo ben interpretare gli intendimenti del leader: Francesco Marziani piano, Pietro Ciancaglini contrabbasso e Pietro Iodice batteria sono risultati perfetti, assolutamente inseriti nel progetto studiato da Mingo.
 Modern Art Trio – “Modern Art Trio” – Gleam Records
Modern Art Trio – “Modern Art Trio” – Gleam Records
Franco D’Andrea pianoforte, piano elettrico e sax soprano, Franco Tonani batteria e tromba, Bruno Tommaso contrabbasso sono gli artefici di una registrazione che è rimasta iconica, una registrazione che ha spinto la Gleam Records a ristampare per la quarta volta il disco in oggetto. Questa ulteriore ripresentazione dell’album è il frutto di una importante opera di restauro audio voluta dal produttore Angelo Mastronardi e realizzata grazie al fortuito ritrovamento del nastro originale da parte dell’editore Luca Sciascia e accuratamente restaurato e masterizzato dal fonico Jeremy Loucas negli Stati Uniti. L’album è disponibile in edizione limitata su Vinile 180 gr. (bauletto con inedito booklet) e su CD (formato gatefold con booklet arricchito), dal 10 novembre 2023 e distribuito da IRD International Distribution. Ciò detto vediamo più da vicino i contenuti musicali (e non solo) di questo “Modern Art Trio”. Siamo nell’aprile del 1970 a Roma e già da qualche anno (per la precisione dal 1967) è attivo il Il Modern Art Trio che rimarrà in attività fino al 1972. La prima formazione vedeva al contrabbasso Marcello Melis che lascerà il posto l’anno successivo a Giovanni Tommaso, il quale a sua volta nel 1969 sarà sostituito da Bruno Tommaso. Il primo e unico disco del trio riporta sulla copertina la sigla “Progressive Jazz”, un chiaro riferimento alla musica suonata. L’album fece scalpore in quanto si trattava di un primo tentativo di mettere ordine in un linguaggio che di ordine non voleva sentir parlare come ricorderanno chi quegli anni ha vissuto in prima persona. E che il tentativo fosse già di per sé piuttosto ambizioso se non addirittura velleitario lo evidenzia lo stesso D’Andrea quando nel libro dedicato a Gato Barbieri da Andrea Polinelli afferma: Quando con Gato facemmo ‘Ultimo tango’ io venivo fuori da questa cosa terribile che era il MAT nel quale come linguaggio musicale stavo completamente da un’altra parte”. Comunque a parte le sensazioni che i componenti il trio possono esprimere oggi, resta il fatto che il disco rappresentò una grossa novità specie per il panorama italico dal momento che in ogni modo rappresenta una sorta di dichiarazioni di intenti, un documento in cui Tonani e compagni illustrano le ricerche che in quel momento stavano portando avanti, ricerche che come dimostrerà un attento ascolto del disco, avevano, hanno e avranno un loro perché.
 Roberto Ottaviano – “A che punto è la notte”, “Astrolabio mistico” – Dodicilune
Roberto Ottaviano – “A che punto è la notte”, “Astrolabio mistico” – Dodicilune
Credo di aver speso tutte le aggettivazioni possibili parlando di Roberto Ottaviano che considero in assoluto uno degli artisti più innovativi, immaginifici, tecnicamente superlativi, coerenti con alcuni inderogabili principi di fondo quale in primo luogo l’onestà intellettuale, che calchino le scene del jazz internazionale. E ciò che si abbia riguardo sia ai concerti sia alle registrazioni. A quest’ultimo riguardo due sono le perle che il sassofonista barese Roberto Ottaviano ha deciso di regalarci nel corso di questo 2023 che ci sta salutando: la prima – “Roberto Ottaviano & Pinturas – A che punto è la notte” – è un progetto interamente pugliese in cui il gruppo guidato da Ottaviano è completato dalla chitarra di Nando di Modugno, dal contrabbasso di Giorgio Vendola e dalla batteria e dalle percussioni di Pippo D’Ambrosio. Il progetto è dedicato alla memoria del chitarrista pugliese Rino Arbore prematuramente scomparso nel 2021. Per chi ama leggere “A che puto è la notte” avrà sicuramente richiamato il titolo di un racconto di Fruttero e Lucentini ma Ottaviano spiega chiaramente che la frase è stata usata strumentalmente solo perché “può racchiudere in sé molte altre atmosfere e richiami, come quelli contenuti in diversa letteratura”. Ciò premesso, l’album si snoda minuto dopo minuto, attimo dopo attiamo, scoprendo di volta in volta le sue innumerevoli sfaccettature. Ecco quindi trapelare nelle composizioni originali il profondo radicamento dei musicisti nella realtà mediterranea bilanciato in qualche modo dai due brani che aprono e chiudono il disco, di “O Silencio das Estrellas” della cantante e compositrice brasiliana Fatima Guedes e “Avalanche”, del cantautore canadese Leonard Cohen. Ma a parte queste citazioni quel che colpisce è soprattutto l’empatia che si avverte tra i musicisti e la loro capacità improvvisativa che emerge magari laddove non te l’aspetti.
Il secondo volume in realtà è a firma doppia – “Michel Godard, Roberto Ottaviano – Astrolabio mistico – Dodicilune” e racconta la vita di Bianca Lancia, «l’unica donna che l’imperatore Federico II di Svevia abbia mai amato». Per questa non facile impresa l’ 11 e 12 settembre scorsi al Castello Normanno-Svevo di Gioia del Colle (Ba), si sono dati appuntamento il serpentone e il basso elettrico di Michel Godard, il sax soprano di Roberto Ottaviano, il canto di Ninfa Giannuzzi, la tiorba di Luca Tarantino, i testi e la voce recitante di Anita Piscazzi. In programma quattordici brani originali scritti dai musicisti, con testi di Anita Piscazzi e arrangiamenti di Michel Godard e Luca Tarantino. In perfetta coerenza con la storia raccontata, l’album è pervaso da una a volte struggente malinconia come nel bellissimo brano d’apertura firmato da Roberto Ottaviano. E questo tono soffuso, raccolto si avverte per tutta la durata dell’album che acquisisce così una propria personalità ben distinta dal clamore della sperimentazione ad ogni costo o dalla riproposizione sic et simpliciter di modelli usati e abusati. Insomma una originalità di esposizione che caratterizza non già da oggi le produzioni dei due leader; ad ulteriore conferma si ascolti il terzo brano, “Light the Earth”, per l’appunto scritto da Godard.
Gerlando Gatto
da Amedeo Furfaro | 23/Feb/2023 | I nostri CD, News, Primo piano, Recensioni
Il 4et, nel jazz, è una formazione intermedia fra solisti/ combo e gruppi più nutriti nonché ensembles ed orchestre. Una “centralità” che garantisce sia snellezza che ricchezza di suoni oltre comunque ad una completezza che dipende dalla gamma strumentale e dalle caratteristiche dei musicisti. A seguire segnaliamo una sestina di nuovi dischi di “band dei quattro” dai quali emerge varietà di proposte e combinazioni. Il 4 non sarà un numero perfetto ma a guardare la storia del jazz verrebbe da pensare che certi postulati sulla presunta imperfezione sono … imperfetti. Oltretutto il quattro in numerologia simboleggia realtà concretezza solidità nonché la precisione del quadrato e il senso del moto che dà il quadrilatero; ed ancora i quattro punti cardinali est ovest nord sud i quali orientano tanto jazz in circolazione.
 Del Piano/Olivieri/Mazza/Marini, Double 3, Caligola Records
Del Piano/Olivieri/Mazza/Marini, Double 3, Caligola Records
L’album Double 3 (Caligola) è a nome di quattro musicisti in quanto trattasi per così dire di un disco-matrioska. Dalla quaterna di jazzisti che vi concorrono infatti vengon fuori due trii avant-garde dalla stessa asse (più che sezione) ritmica, con Roberto Del Piano al basso elettrico e Alberto Olivieri alla batteria nonché all’ alto e voce Cristina Mazza nei brani “Cane di sabbia”, “Forgotten Names”, “Beauty is A Rare Thing” di Ornette Coleman e “Double Moon”nonché il baritono/flauto/piano di Bruno Marini in “Endemic”, “Yogi”, “Brazz!”, “Flute and Cats”, “Sunset Enigma”. Nelle esecuzioni non si avverte più di tanto l’alternanza dei cambi che non vanno a mutare l’ossatura dell’insieme. C’è poi che le composizioni sono firmate da chi vi partecipa. Verrebbe quasi da pensare che tre più tre potrebbe fare quattro se non ci fosse la matematica ad ostacolarne l’addizione e l’opinione. O più semplicemente che non c’è 3 senza 4et in questo lavoro di frammischi fra volute (in)esattezze infiorate dagli sminuzzamenti metrici della batteria e dai voli di calabrone del baritono, dalle acrobazie del basso e dai volteggi vocali della sassofonista.
 Canova Trio feat. Fulvio Sigurtà, Agata, Filibusta Records
Canova Trio feat. Fulvio Sigurtà, Agata, Filibusta Records
Agata, pietra della famiglia dei quarzi, è l’azzeccato nome di battesimo scelto per l’album del Canova Trio. Secondo la pianista e vocalist Elisa Marangon tale minerale ha qualità vicine alla musica grazie a geometrie e tonalità che spaziano dal bianco al verde, dal muschiato al pizzo blu. E’ così pensando che lei leviga un iridato e irradiato intaglio jazzistico assieme alla bassista Roberta Brighi ed al batterista Massimiliano Salina. Al trio si aggiunge talora il trombettista Fulvio Sigurtà in qualità di ospite, apprezzato da chi scrive in “Circles in the Sand” di Svensson e Castle. Altri pezzi – “Very Early” di Bill Evans e “Footprints” di Shorter – sono eseguiti utilizzando, della tavolozza timbrica, le marcature più calde e brillanti. Due composizioni di Jobim – “Chovendo na roseira” e “Falando de Amor” – valorizzano la trasparenza della voce della Marangon che dà il massimo, a livello di scrittura, in “Les Trois Soeurs à la plage”, uno degli originals (su undici complessivi) di cui quattro da lei firmati e due cofirmati con i colleghi del trio (plus guest). La folgorazione deriva dal dipinto “Las Tres Hermanas en la playa” del pittore spagnolo Joachim Sorolla, impressionista dal tratto luminista. Per una musica che, nel riprodurne i lineamenti, si insinua, nei contrasti ombra-luce, en plein air.
 Giovanni Benvenuti , An Hour Of Existence, AMP Music & Records
Giovanni Benvenuti , An Hour Of Existence, AMP Music & Records
Il tenorista senese Giovanni Benvenuti nell’album An Hour Of Existence (AMP) coinvolge la propria band composta di altri tre musicisti: il pianista tedesco Christian Pabst, il contrabbassista Francesco Pierotti e il batterista Dario Rossi. Il lavoro discografico si rifà ad un racconto di fantascienza in cui uno dei protagonisti, non più in vita, si materializza per un’ora all’anno. In quel breve lasso di tempo deve scegliere come muoversi, se viverlo semplicemente o imprimervi in qualche modo una svolta. Un po’ come nel film “Momenti di trascurabile felicità” di Daniele Luchetti in cui Pif torna sulla terra, dal paradiso, per poco più di un’ora, per risolvere le pendenze sospese ovvero riassaporare momenti felici. Dal canto suo Benvenuti, in un’ora circa di musica, si gioca bene le carte a disposizione. I sette brani originati da questa visione fra new age e science fiction, per quanto immaginifici siano – come “King’s Mustache” o “General Krottendorf” – e per quanto risentano di influssi extrajazzistici – le scale arabeggianti del n.5, quello che dà titolo al cd – si muovono in un contemporary che malassa materiali vari dallo svolgimento ritmico mosso e plurilineare nella modulazione melodica del sax. Il disco avvicina storia e fantascienza sul terreno jazzistico per come già emerso nel precedente album Paolina and The Android, accolto favorevolmente dalla critica. Lì due androidi avveravano il mancato incontro di un paio di secoli prima fra il poeta Keats e la Bonaparte. Nel nuovo album i personaggi sono vari come la narrazione. Così come la musica del 4et.
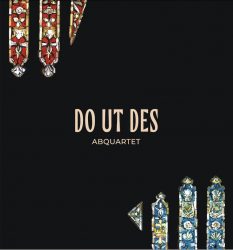 ABQuartet, Do Ut Des, Red & Blue.
ABQuartet, Do Ut Des, Red & Blue.
Guido D’Arezzo, dopo aver inventato attorno al Mille la moderna notazione musicale, nell’assegnare i nomi alle note, non avrebbe immaginato che nel 1972 un gruppo di rock progressivo come i New Trolls avrebbe chiamato un proprio l.p. Ut, termine che, oltre all’avverbio affinché, indica il Do nell’ars musica. Ancor meno il teorico avrebbe pensato che, nel terzo millennio, un quartetto jazz come l’ABQuartet avrebbe approntato un album con sostrato latino (non latin, si badi bene) intitolandolo Do Ut Des per indicare non tanto il significato comune di interscambio bensì il Do Do Re bemolle (traduzione del detto in gradi della scala temperata in base alla denominazione latino-germanica). La frase, volendo, potrebbe riferirsi al rapporto fra i musicisti che “donano” invenzioni allo spettatore che li ricambia con il proprio (ap)plauso. Od anche potrebbe simboleggiare il “contratto” che i musicisti stipulano nel formare un gruppo o addirittura rimandare ad un’idea di interplay come “obbligazione” e cioè musica praticata in forma pattizia in cui ogni strumento “dà il la” ad un altro aspettando una risposta per generare nell’insieme un’armonia complessiva. Il pianista Antonio Bonazzo, il clarinettista Francesco Chiapperini, il contrabbassista Cristiano Da Ros e il batterista/percussionista Fabrizio Carriero hanno realizzato sette brani circondati da tale aura medievale già a partire da titoli come “Ut Queant Laxis” dove la prima sillaba Ut è la prima delle note di un metà verso (emistichio, non metaverso) seguita da Resonare Fibris/Mira gestorum/Famili tuorum/Solve polluti/ Labii reatum/Sancte/Iohannes (Ut/Re/Mi/Fa/Sol/La/S/I). Da altri brani come “Lux Originis” e “Dies Irae” si percepiscono i frequenti cambi di registro acustico e di gamma modale che i “trovieri” adattano, girellando fra l’alleluiatico ed il melismatico, compenetrando, in tal guisa, la storia della musica all’attuale vita artistica “mondana”.
 Zhu Quartet, GINKGO, Workin’ Label.
Zhu Quartet, GINKGO, Workin’ Label.
Il ricordo di una pianta di ginkgo biloba che Alberto Zuanon, contrabbassista, osserva oramai cresciuta, nella stagione dell’autunno, fa da stimolo iniziale all’album Ginkgo, inciso per Workin’ Label con lo Zhu Quartet: Michele Polga, saxtenorista, Paolo Vianello, pianista, Stefano Cosi, batterista e ovviamente il leader contrabbassista. Piant’antica, la ginkgo biloba, che ha infuso di sé il title-track del cd, brano dalla forma-canzone che sa espandere un’idea di serenità. In “Creative Process” la mente dell’Autore (e quella degli Interpreti) procede, nel ristrutturare dati e impulsi di partenza, a trasformarli in flusso sonoro. “Sabato pomeriggio con Tommaso” è composizione delicata dedicata ad un allievo che nel confronto col maestro rivela tutta la propria curiosità e devozione. “Agitato” guarda al navigante che affronta il mare tempestoso, il che in musica è rappresentato dagli strumenti che alzano il livello e l’altezza delle proprie onde sonore, amplificando certi contrasti ritmica-piano/sax già ascoltati in “Costante”. Il più placido “2022” è un personalissimo “Le Quattro Stagioni” in sunto jazz impresse nell’anno che è appena tramontato. Chiudono la decade di titoli il nostalgico “Altri tempi”, l’atrabile “ Prima del sonno” e “Laguna”, ispirato dalla visione di quella veneta. Un lavoro, insomma, che si annuncia invitante già a partire dall’”Intro”, meritevole di essere diffuso anche in circùiti, ove attivati, di “disc/crossing”.
 Marco Vavassori feat. Lincetto/Smiderle/Uliana, Walking with Bob, Caligola Records.
Marco Vavassori feat. Lincetto/Smiderle/Uliana, Walking with Bob, Caligola Records.
Buone nuove dal North East jazzistico italiano. Ed è ancora Caligola Records a consegnarci novità discografiche che denotano l’ indubbia vitalità musicale in quell’area. E’ la volta del contrabbassista-compositore jesolano Marco Vavassori, con alle spalle brillanti studi al Conservatorio di Rovigo, che pubblica Walking with Bob, il suo primo album da leader.
Accanto a lui ben figurano tre musicisti legati da solido legame di amicizia e cioè il clarinettista Michele Uliana, il pianista Alberto Lincetto e il batterista Enrico Smiderle. Un quartetto, dunque, che fa già le dovute presentazioni con il primo degli otto brani in tracklist, il lirico “Hocking”, mettendo in scena un sound che impasta idee permeate di solare cantabilità. Il successivo “Sognando” ma ancor più l’alveo mediterraneo di “Shukran” e quello balcanico in “Kurkuma”, lasciano trasparire una certa sensibilità verso le arie folk. “Hare” si caratterizza perché a un certo punto contrabbasso e piano si dispongono a sezione “ritmica” nel supportare batteria e clarinetto mentre “InContra” ha tema ed impro insistenti su un giro di accordi iterante e crescente in intensità graduale nei circa otto e passa minuti di musica fiondante. In “J. Be Blues” il gruppo pare indossare un visore virtuale che guarda al passato, al tempo di Jimmy Blanton, antesignano di tanti contrabbassisti. Il conclusivo “Francesco’s Smile” ha risvolti nordeste, per rimanere al termine geografico già nominato. Insomma un walking, quello del contrabbasso, verso gli itinerari sonori più svariati ed imprevedibili.
Amedeo Furfaro
da Gerlando Gatto | 09/Nov/2022 | I nostri CD, Primo piano, Recensioni

I Nostri Cd by Gerlando Gatto
 Giulia Barba – “Sonoro” – BNC
Giulia Barba – “Sonoro” – BNC
Non amiamo vantare primogeniture ma siamo stati tra i primi in assoluto a presentare al pubblico italiano questa brava clarinettista dopo il suo ritorno dall’Olanda. In questo suo secondo album possiamo ascoltare 6 sue composizioni, tra cui due brani con testo di W.B. Yeats (“The Everlasting Voices” e “To an isle in the water”), e 8 pezzi di improvvisazione totalmente libera. Il testo di “Bassorilievo” e “Game Over” è stato scritto dalla stessa compositrice. Accanto alla Barba troviamo Marta Raviglia, voce, Daniele D’Alessandro, clarinetto e Andrea Rellini, violoncello. Probabilmente sono sufficienti queste poche indicazioni per capire il contesto in cui si muove Giulia: un terreno irto di difficoltà in cui la maggiore preoccupazione della leader è quella di raggiungere una raffinata qualità sonora grazie ad una accurata ricerca timbrica supportata da un’altrettanto accurata ricerca dei collaboratori. Di qui la scelta della vocalist Marta Raviglia il cui apporto risulta molto importante essendo la sua voce adoperata alle volte in modo consueto altre volte in funzione meramente strumentale e di Daniele D’Alessandro, ottimo nel ruolo di seconda voce. Parimenti determinante il ruolo di Andrea Rellini al violoncello che nella difficile opera di cucire il tutto riesce a non far sentire la mancanza di uno strumento percussivo. Comunque il merito principale della buona riuscita dell’album è senza dubbio alcuno di Giulia Barba di cui attendiamo altre prove ancora più significative.
 Francesco Branciamore – “Skies of Sea” – Caligola
Francesco Branciamore – “Skies of Sea” – Caligola
Musicista a 360 gradi, Francesco Branciamore si è costruita una solida reputazione come batterista avendo avuto l’opportunità di lavorare con alcuni grandi del jazz come Enrico Rava, Michel Godard, Lee Konitz, Evan Parker, Barre Philips, Ray Mantilla, Keith Tippet, Wim Mertens… e l’elenco potrebbe continuare a lungo. Ma Francesco mai si è adagiato sugli allori: così ha dedicato questi ultimi anni ad approfondire da un lato la tecnica pianista, dall’altro le sue capacità compositive e di arrangiatore. Non a caso nel 2018 uscì “Aspiciens Pulchritudinem” suo primo album in piano solo ottenendo unanimi consensi, preceduto nel 2013 da “Remembering B. E. – A Tribute to Bill Evans” in cui Branciamore non suona alcuno strumento ma omaggia Bill Evans dirigendo un sestetto cameristico in cui l’improvvisazione non ha diritto di cittadinanza mentre la pianista Marina Gallo esegue le trascrizioni integrali degli assoli di Evans fatta da Branciamore, autore anche di tutti gli arrangiamenti. In questo “Skies of Sea” Francesco presenta una sorte di suite in quattordici bozzetti di breve durata, tutti di sua composizione, a disegnare atmosfere le più variegate, dall’ipnotica title track al trascinante “The Remaining Time” passando attraverso brani tutti gradevoli tra cui degno di particolare attenzione ci è parso il riuscito omaggio a Chick Corea, “A Prayer for Chick”.
 Maniscalco, Bigoni, Solborg – “Canto” – ILK Music
Maniscalco, Bigoni, Solborg – “Canto” – ILK Music
Album di spessore questo proposto dal trio italo-danese composto da Emanuele Maniscalco pianoforte, piano elettrico e tastiere, Francesco Bigoni sax tenore e clarinetto e Mark Solborg chitarra elettrica. La cosa non stupisce più di tanto ove si tenga conto che il combo ha già all’attivo altri due album e che la collaborazione fra i tre risale al 2015. Quali le caratteristiche della formazione? Innanzitutto una scrittura che consente di coniugare perfettamente parti scritte e improvvisazione; in secondo luogo una costante attenzione alle dinamiche e quindi al suono; in terzo luogo la capacità di frequentare con assoluta disinvoltura un territorio di confine tra il jazz e le musiche “altre” che rende quanto mai difficile una precisa classificazione della performance…ammesso che ciò sia necessario, cosa di cui personalmente dubitiamo e non poco. Il tutto sorretto da altri due elementi assolutamente necessari: la bravura tecnica ed espressiva di tutti e tre i musicisti e una profonda empatia che consente loro di suonare in assoluta scioltezza sicuri che il compagno di strada saprà cogliere ogni minimo riferimento. Di qui una musica rarefatta, di chiara impronta cameristica che sicuramente soddisferà gli ascoltatori dal palato più raffinato.
 Mauro Mussoni – “Follow The Flow” –WOW
Mauro Mussoni – “Follow The Flow” –WOW
Mauro Mussoni (contrabbasso, composizione e arrangiamenti), Simone La Maida (sax/flauto), Massimo Morganti (trombone), Massimo Morganti (trombone), Andrea Grillini (batteria), Davide Di Iorio (flauto solo nella traccia Levante) sono i responsabili di questo album registrato a Riccione nel 2020. Si tratta del secondo CD a firma di Mauro Mussoni (dopo “Lunea”) il quale si ripresenta anche come compositore dal momento che i nove bani in programma sono sue composizioni. Il titolo è significativo delle intenzioni di Mussoni il quale vuole “seguire il flusso”, un flusso che – secondo le espresse volontà del contrabbassista – è quello dell’ispirazione. Di qui una musica che trova nella gioia dell’esecuzione la sua principale ragion d’essere declinata attraverso una significativa empatia di volta in volta tra i fiati e fra i componenti del trio piano-contrabbasso-batteria senza trascurare, ovviamente, l’intesa che intercorre tra tutti i componenti del gruppo, intesa cementata da precedenti collaborazioni. E’ infatti lo stesso leader a dichiarare come la musica sia arrivata in maniera spontanea seguendo l’ispirazione del momento piuttosto che idee preesistenti. Tra i vari brani particolarmente interessanti la title track impreziosita da sontuosi assolo di Simone La Maida e Massimiliano Rocchetta, il dolcemente ballabile “Freeda” e “Latina” con un convincente assolo del leader.
 Ivano Nardi – “Excursions” –
Ivano Nardi – “Excursions” –
Ivano Nardi è sicuramente uno dei musicisti più rappresentativi della scena jazzistica romana. Artista tra i più coerenti, profondamente ancorato alla sua terra, profondamente attaccato al valore dell’amicizia –in primo luogo quella con Massimo Urbani – mai si è discostato dal solco di un free senza se e senza ma, un free in cui dare sfogo alla propria immaginazione, al proprio modo di vedere e sentire la musica. Ovviamente, per scelte di questo tipo, risulta fondamentare circondarsi di compagni d’avventura con cui si abbia un idem sentire. E il ‘batterista’ Nardi è stato, anche in questo senso, del tutto coerente avendo condiviso le sue esperienze con artisti del calibro del già citato Urbani, Don Cherry, Lester Bowie… Adesso ritorna a farsi sentire con un altro album dedicato a Massimo Urbani, “Excursions”, in cui a coadiuvarlo sono Giancarlo Schiaffini al trombone, Marco Colonna ai fiati, Igor Legari alla batteria, un quartetto molto affiatato che si muove con estrema disinvoltura all’interno dell’unico brano in programma, lungo 32:50. Ovviamente cercare di descrivere questa performance è impresa quanto mai ardua e forse inutile; basti sottolineare come le atmosfere sono mutevoli proponendo degli improvvisi slarghi (come al minuto 12,30 circa) quasi a voler in certo senso smorzare l’andamento tumultuoso e incalzante del quartetto, o avventurandosi in atmosfere indiane e arabeggianti (come al minuto 24 all’incirca).
 NewStrikers – “The Songs Album” – Alfa Music Vinile 180 gr. Tiratura limitata
NewStrikers – “The Songs Album” – Alfa Music Vinile 180 gr. Tiratura limitata
Questo album esce ad ampliamento dell’album “Musiche Insane”, ottimo esempio di come anche il free riesca a trovare nel nostro Paese interpreti degni di rilievo. Il gruppo guidato dal multistrumentista Antonio Apuzzo (compositore e arrangiatore anche di quasi tutti i brani) e completato da Marta Colombo (vocale, percussioni), Valerio Apuzzo (tromba, cornetta, flicorno), Luca Bloise (marimba, percussioni), Sandro Lalla (contrabbasso) e Michele Villetti (batteria, duduk), ripresenta un repertorio in buona parte già conosciuto in cui la musica si staglia come unica e vera protagonista, una musica ben lontana da stilemi formali e da un qualsivoglia mainstream consolatorio. Quindi un jazz graffiante, originale, fluido in cui si stagliano alcune individualità come quelle di Antonio Apuzzo e della vocalist Marta Colombo. Tra i brani non presenti nel precedente “Musiche Insane”, What Reason Could I Give” e “All My Life “ di Ornette Coleman interpretate con bella sicurezza mentre il conclusivo “Four Women” è un sentito omaggio a Nina Simone che scrisse questo brano in segno di protesta contro l’ennesimo atto di sopraffazione consumato dai bianchi nei confronti della popolazione di colore. Un consiglio non richiesto: se avete tempo andate a cercare i testi della canzone e leggeteli con attenzione.
 Helga Plankensteiner – “Barionda” – JW
Helga Plankensteiner – “Barionda” – JW
Baritonista di spessore, la Plankensteiner si è oramai imposta all’attenzione generale non solo come strumentista ma anche come vocalist, compositrice, arrangiatrice e leader di gruppi non proprio banali. E’ questo il caso di “Barionda” un ensemble formato da quattro baritonisti (la leader, Rossano Emili, Massimiliano Milesi e Giorgio Beberi) più un batterista che nella maggiorparte dei casi è Mauro Beggio sostituito in tre brani da Zeno De Rossi. In repertorio una serie di brani che ricordano i grandi baritonisti del jazz; ecco quindi “Hora Decubitus” di Mingus (legato alla memoria di Pepper Adams), “Sophisticated Lady” (di Ellington, nelle esecuzioni della cui orchestra spiccava Harry Carney) o “Bernie’s Tune”, cavallo di battaglia di Mulligan. Il gruppo si muove con padronanza all’interno di arrangiamenti tutt’altro che semplici in cui i quattro sassofonisti evidenziano le loro abilità ben sostenuti dai due batteristi che a turno sorreggono il tutto con un timing preciso seppur fantasioso, sicché non si avverte la carenza del contrabasso. E’ interessante sottolineare come, nonostante i quattro strumenti di base siano gli stessi, si riesce egualmente ad ottenere significative variazioni di sound a seconda di chi esegue l’assolo e di chi tali assolo accompagna. Ferma restando la valenza di tutti i musicisti coinvolti, è innegabile che il peso maggiore dell’impresa grava sulle spalle della leader che nelle brevi parole che accompagnano l’album dichiara esplicitamente il proprio amore verso il suo strumento, il sax baritono..
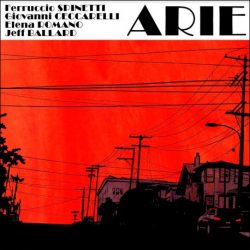 Ferruccio Spinetti – “Arie” – Via Veneto, Indo Jazz
Ferruccio Spinetti – “Arie” – Via Veneto, Indo Jazz
Ferruccio Spinetti è contrabbassista che si è guadagnato una solida reputazione lavorando per lungo tempo con Musica Nuda, Avion Travel e InventaRio. Adesso si presenta con il primo progetto a suo nome che lo vede alla testa di un gruppo all stars comprendente la cantante Elena Romano, il pianista Giovanni Ceccarelli, il batterista Jeff Ballard e, come unica guest, la sempre straordinaria pianista Rita Marcotulli in due brani. L’album è in buona sostanza una sorta di omaggio al jazz italiano in quanto il repertorio è composto in massima parte da brani scritti da alcuni dei migliori jazzisti italiani tra cui Enrico Rava , Bruno Tommaso , Rita Marcotulli, Paolo Fresu , Enrico Pieranunzi , Luca Flores , Paolino Dalla Porta …, con l’aggiunta di brani originali di Spinetti e Ceccarelli. E di questi autori sono stati scelti brani in cui è di tutta evidenza la ricerca della linea melodica, rinvigorita sia dalle centrate interpretazioni di Elena Romano sia dai testi, scritti appositamente dalla Romano, da Peppe Servillo e dallo stesso Spinetti, sia dagli arrangiamenti che hanno messo in evidenza le caratteristiche di tutti i musicisti tra cui una menzione particolare la merita senza dubbio alcuno Jeff Ballard, sicuramente uno dei batteristi migliori oggi in esercizio. Ovviamente un merito particolare va a Ferruccio Spinetti che ha saputo guidare il gruppo con mano sicura e piena consapevolezza.
 Ivan Vicari – “Afrojazz project – Il ritorno”
Ivan Vicari – “Afrojazz project – Il ritorno”
Entusiasmante, trascinante, coinvolgente: queste le parole che ci sorgono spontanee dopo aver ascoltato un paio di volte questo album. Conosciamo e apprezziamo Ivan Vicari oramai da molti anni; tra i pochissimi specialisti dell’organo Hammond nel nostro Paese, è uno dei pochi artisti in Italia capaci di raccogliere e divulgare l’eredità di Jimmy Smith, vera e propria leggenda dell’Hammond. Nel suo stile si ritrovano echi provenienti dai più grandi esponenti dell’organo jazz, dal già citato Jimmy Smith, a Larry Young, da Rhoda Scott fino Joey De Francesco purtroppo recentemente scomparso. E quanto sopra detto si ritrova in questa sua recente fatica discografica. Ivan guida, con mano sicura e con tecnica superlativa, un quartetto completato da Fabrizio Aiello alle percussioni, Mauro Salvatore alla batteria, Alberto D’Alfonso sax e flauto, Luca Tozzi chitarra. Il titolo recita “Afrojazz project – Il ritorno” e fotografa bene la musica che Vicari ci propone. Una musica che si ispira all’afro ma non solo dal momento che Vicari dimostra ancora una volta di conoscere assai bene sia il jazz nell’accezione più completa del termine, sia il blues. Da sottolineare ancora che Vicari si mette in gioco anche come compositore dal momento che nel CD figurano alcuni suoi original. Un tocco di umanità che mai guasta: per esplicita dichiarazione dello stesso Vicari l’album è dedicato a due “amici musicisti” scomparsi, Karl Potter e Nunzio Barraco.
Gerlando Gatto
da Alessandro Fadalti | 13/Ott/2022 | Guide all'ascolto, News, Primo piano
Per cosa ci piacerebbe essere ricordati dopo la nostra morte? Solo a sentire questa domanda si materializzano ambienti rumorosi di bocche che in un flusso infinito recitano un monologo adornato di fantasticherie intime ed infinite, oppure risme di fogli bianchi che vengono incisi da penne fino a finire l’inchiostro, sfogliandoli freneticamente fino a creare una sorta di testamento immaginario da dedicare al mondo; o magari nessuna risposta, una pausa a cui non seguirà alcuna nota: il vuoto. Pensare all’oltre mondo è umanamente comune, l’abbiamo fatto tutti e immaginare quale memoria lasceremo di noi è un tema caldo. Una volta che si spengono le luci del nostro palco gli spettatori si alzano, cominciano a mettersi in fila i tuoi dolci affetti, conoscenti, colleghi, amici e parenti che non vedono l’ora di scrivere un epitaffio d’amore da dedicarti. L’unico dispiacere è che qualunque discorso propinato finisce in una damigiana da cui tracannano i provetti poeti fino ad affogare. Tutti alzano il gomito in questo rituale di auto terapia per affrontare la morte, mentre tu, che dovresti essere il diretto destinatario di ogni poesia recitata al brindisi, non potrai mai ascoltare quello che gli altri hanno da raccontare di te stesso. Quindi ha davvero senso spedire una lettera a un morto? No, meglio scrivere per quelli che restano, perché creare memoria è più importante che rispondere agli ipotetici capricci di un defunto, difatti lui non può nemmeno ribattere e dir la sua a meno che i medium non diventino avvocati e notai degli spiriti dell’aldilà.
Questo preambolo ci pone nell’ottica di ricercare quale sia l’approccio migliore per raccontare post mortem una vita musicale così intensa di significati ed eterogenea come quella di Pharoah Sanders. Un musicista del suo calibro è un poliedro complesso, in ogni angolo si rispecchia una storia che differisce per prospettiva ma si interseca per eventi. Immaginando di voler camminare sopra questa gigantesca forma geometrica ci si renderebbe presto conto che per coglierne il centro, quindi il nucleo e la sua anima, non si può solo camminare a zonzo senza farsi domande, serve un aiuto. Un album potrebbe essere la grande guida che ci serve per non perderci.
La guida che voglio proporre è un  Lost Record del Live in Paris del 1975, pubblicato e restaurato dall’etichetta discografica Transversales Disques. Sébastien Rosat, co-fondatore dell’etichetta, mi ha spiegato in un breve scambio di mail che l’album è stato come ritrovare un tesoro; già dal primo ascolto si capiva quanto fosse una performance straordinaria. La Transversales Disques ha compiuto in primis un lavoro di restauro sul materiale ritrovato nel 2017 nel caveau di Radio France e a impreziosire l’esperienza c’è la minuzia per la ricerca di fotografie scattate per quella performance. Proprio quando le ricerche stavano per arrivare a un punto morto ci ha pensato la fortuna a fargli ritrovare una foto del concerto in “Jazz Hot” Magazine per mano della fotocamera di Christian Rose che ha fornito un rullino pieno di splendide istantanee dell’evento, arricchendo un’edizione discografica rara e unica; sicuramente realizzata con quel tipo di passione che solo gli amanti del jazz riescono a mettere in ciò che fanno nella vita. Questa storia ci catapulta in una prospettiva romantica nei confronti dell’album, ma diventa un antipasto ricco di proteine per affrontare il viaggio che propongo, ma soprattutto è funzionale a un piccolo gioco di prestigio: usare l’album del concerto come incipit, cercando di rovesciare la classica prospettiva della biografia al servizio della musica, seguendo piuttosto il flusso sonoro del live e quello degli eventi in ordine cronologico. Questo processo permette di trasformare quel poliedro di cui parlavo, attraverso la scomposizione e ricomposizione in una nuova forma, quella plasmata dalle note del sassofono di Sanders il 17 novembre del 1975 al Grand Auditorium nello studio 105 della Maison de la Radio.
Lost Record del Live in Paris del 1975, pubblicato e restaurato dall’etichetta discografica Transversales Disques. Sébastien Rosat, co-fondatore dell’etichetta, mi ha spiegato in un breve scambio di mail che l’album è stato come ritrovare un tesoro; già dal primo ascolto si capiva quanto fosse una performance straordinaria. La Transversales Disques ha compiuto in primis un lavoro di restauro sul materiale ritrovato nel 2017 nel caveau di Radio France e a impreziosire l’esperienza c’è la minuzia per la ricerca di fotografie scattate per quella performance. Proprio quando le ricerche stavano per arrivare a un punto morto ci ha pensato la fortuna a fargli ritrovare una foto del concerto in “Jazz Hot” Magazine per mano della fotocamera di Christian Rose che ha fornito un rullino pieno di splendide istantanee dell’evento, arricchendo un’edizione discografica rara e unica; sicuramente realizzata con quel tipo di passione che solo gli amanti del jazz riescono a mettere in ciò che fanno nella vita. Questa storia ci catapulta in una prospettiva romantica nei confronti dell’album, ma diventa un antipasto ricco di proteine per affrontare il viaggio che propongo, ma soprattutto è funzionale a un piccolo gioco di prestigio: usare l’album del concerto come incipit, cercando di rovesciare la classica prospettiva della biografia al servizio della musica, seguendo piuttosto il flusso sonoro del live e quello degli eventi in ordine cronologico. Questo processo permette di trasformare quel poliedro di cui parlavo, attraverso la scomposizione e ricomposizione in una nuova forma, quella plasmata dalle note del sassofono di Sanders il 17 novembre del 1975 al Grand Auditorium nello studio 105 della Maison de la Radio.
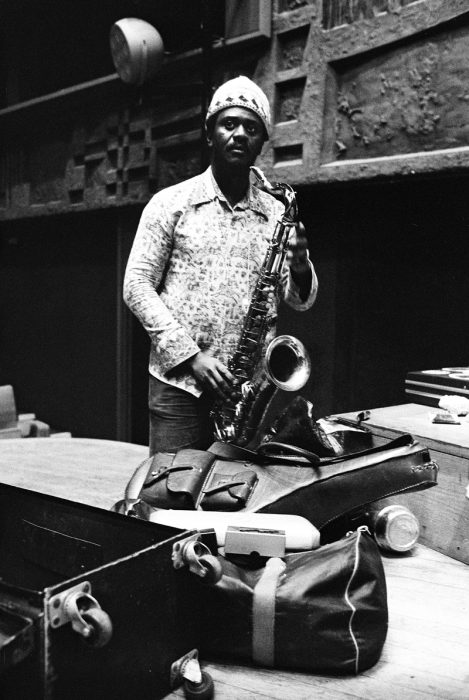 Love is Here part I/part II
Love is Here part I/part II
Il seguente brano potrebbe essere tanto un inedito quanto un arrangiamento improvvisato estremamente articolato di Love is Here To Stay, fatto sta che troverà pubblicazione per la prima volta in un album del 1978 Love Will Find a Way, accompagnato dalla splendida voce della cantante Phyllis Hyman. Il fatto che sia stato eseguito nel 1975 a Parigi, per venir poi pubblicato solo tre anni dopo, lo rende un esempio calzante del processo creativo del faraone. Sanders non è il tipico musicista con la matita pronta in mano a calcare il pentagramma, il punto di partenza è sempre quello dell’improvvisazione da cui si generano idee e motivi, dispiegandosi in una cosiddetta forma estesa (approccio tipico nell’estetica free), ma in questo caso è più corretto chiamarla Suite, come lui la concepiva: improvvisazioni molto lunghe ma divise in due parti. Andando oltre il contesto, quello che sentiamo di primo impatto è un forte senso energico da parte di tutto il gruppo a partire dal pianismo percussivo di Danny Mixon, alla batteria serrata di Greg Bandy in cui si inserisce l’ostinato basso di Calvin Hill, talmente intenso che sembra di poter sentire le dita della pelle levigarsi su quelle corde e infine il sassofono tenore di Sanders, che comincia con un lirismo e una dolcezza ingannevole nell’eseguire il tema. Un inganno perché nei primi minuti qualcuno potrebbe soltanto dire che è molto bravo, ha una tecnica solida ma non fuori dal comune al suo strumento; tuttavia, man mano che passano le battute ci si accorge presto di cos’abbia di così particolare da catturare ogni orecchio. La sensazione è che l’ancia venga strozzata e la campana d’ottone vibri ad altissima magnitudo, con un fluire rapidissimo di raggruppamenti di note in scala che assomigliano quasi a un glissando, altre volte si sofferma su ritmi irregolari arrivando fino a dei sovracuti urlanti, lo screaming come lo definivano alcuni, che però in Sanders si fonde a uno stile che è in parte erede del sassofonismo di Coltrane. A partire dall’album Soultrane (1958), il critico Ira Gelter in un articolo su Down Beat dello stesso anno, chiama Sheets of Sound questo approccio al sassofono. Viene da stupirsi pensando a come Sanders sia un musicista in grado di essere così aggressivo e dolce allo stesso tempo mentre suona, ma in questa duplicità passano in mezzo molti stati d’animo, ci si rende conto abbastanza in fretta di quanto la sua palette espressiva sia più complessa e variegata rispetto a quella manciata di note del tema all’inizio del brano. L’effetto è seducente, ci sentiamo lentamente magnetizzati, solo dopo solo, brano dopo brano mentre veniamo accompagnati dalla direzione di queste energie in gioco. La forza è talmente trascinante anche nel solo di pianoforte per fare un esempio, in cui ascoltiamo giochi di simili intenzioni gestuale tra registri e intensità esecutiva; percepiamo quindi una coesione tipica di quei musicisti che riescono a entrare nella misteriosa dimensione dell’Interplay.

Udin&Jazz 2008 – ph Luca A.d’Agostino
Farrell Tune
Se quella sera tra il pubblico ci fosse stato un ascoltatore casuale di jazz, trascinato di peso in quell’auditorium da un amico a sentire per la prima volta un concerto di Sanders, potrebbe essersi chinato di lato durante i primi applausi per sussurrare con stupore ed entusiasmo al suo vicino di posto: “Che figata oh! Ma scusa, chi è questo Sanders?”. Farrell “Pharoah” Sanders rientra tra quei jazzisti che in quegli anni hanno vissuto storie di vita simili tra esordi e scelte intraprese, curiosamente tutti sono arrivati ad incontrarsi e a collaborare nell’ambito della cosiddetta new thing: sono nati e cresciuti in ambienti di ghetto delle grandi città o negli stati periferici dell’America, hanno scoperto l’amore per il jazz o attraverso la musica della messa afroamericana o con la band delle High School, infine hanno creato una propria formazione o hanno tentato di piazzarsi a fianco di qualche nome grosso. La città natale di Sanders è Little Rock in Arkansas, uno stato dove i locali per suonare sono divisi come in una scacchiera, quelli per i bianchi e quelli per i neri, in questi ultimi era il rhythm and blues con i suoi ritmi molto ballabili e le note piacenti a far da padrone, un genere che ha fatto da palestra negli anni giovanili di molti jazzisti dell’epoca. Questa condivisione di destini simili è forse uno dei motivi per cui tutti questi musicisti free riuscivano a entrare così fortemente in connessione gli uni con gli altri; mi riferisco a persone del calibro di Archie Shepp, Albert Ayler, Ornette Coleman, Billy Higgins, Don Cherry e Cecil Taylor… Però, volendo scavare più a fondo su chi sia Farrell Sanders dovremmo allontanarci un minimo da meri dati storiografici e rivolgerci al diretto interessato. In merito è interessante quello che emerge in una delle interviste più semplici e umane che lui abbia mai fatto, quella realizzata da Nathaniel Friedman per il New Yorker nel gennaio 2020. Le risposte di Sanders non sono prolisse, arrivano dritte al punto. Quello che emerge è una persona perfezionista nel suo esperire la musica. Nel suo periodo di grande attività con la Impulse! capitava di rifare dei take, nonostante nelle registrazioni di musica a improvvisazione libera è piuttosto raro, in quanto la direzione sonora che si stava creando non gli piaceva tanto. Scherzo beffardo però vuole che poi, andando a riascoltare quei take appena interrotti, si divorava le mani quando si accorgeva -troppo tardi – di quanto fosse bello ciò che stava succedendo. Anche ad album completato la storia non cambiava, riascoltava le sue stesse opere già pubblicate e trovava continuamente passaggi e note al loro interno dove poter redarguirsi esclamando “potevo farlo meglio”. Con Impulse! Gli capitava di dover registrare anche due o tre album all’anno, però questo non frenava il suo perfezionismo, perché esso si lega anche alla ricerca di novità: si nota infatti come in ogni album di quel periodo c’è un perenne tentativo di rinnovarsi. Non passava molto tempo prima che considerasse invecchiata un’idea musicale, a tal punto che quando alla veneranda età di 79 anni parla della ricerca di un suono che lo renda soddisfatto, ammette di non averlo ancora trovato. Arriva a confessare come in realtà non sia mai esistito un singolo album dove fosse pienamente compiaciuto del suono ottenuto. In un altro aneddoto racconta un dettaglio che ci fa capire quanto fosse esasperato questo atteggiamento nei confronti della ricerca del suono: consumava scatole e scatole di ance, le provava tutte scegliendole e buttando via quelle che non suonavano giuste. Questa ricerca ossessiva del nuovo spiega come mai la sua discografia sia stilisticamente variegata, non sopporta l’idea di doversi ripetere quando suona, non vuole mantenere quell’approccio burocratico nei confronti della musica tipico di certi suoi colleghi… Il paradosso, però, è che quando ascolta la musica di questi ultimi ne rimane affascinato dalla bellezza e si chiede cosa stiano usando per suonare così bene. Ulteriore dettaglio che ci fa capire al meglio chi è e la sua musica è certamente la sua attrazione per i paesaggi sonori, sin da piccolo gli piaceva sentire il rumore delle cose e cita alcuni esempi come il cigolio delle macchine vecchie per strada, il rumore delle onde, i treni che sfrecciano sulla ferrovia, gli aeroplani che decollano. Questo atteggiamento lo ha portato sempre a cercare di trasformare i suoni brutti, che lo ammaliavano, in belli in qualche modo. Il tassello mancante a questa sintesi della sua umanità sta in un’altra intervista; quella del 1995 per la rete televisiva BBC, dove ci fa capire come lui suonerebbe qualsiasi cosa cercando di trasformarla in qualcosa di bello, spiegando come lui sia una persona che non ha scopi al di fuori di voler semplicemente esprimersi. Questo brano lo rappresenta al meglio, pensandoci, un semplice tema porta in stile Rhythm and Blues dove la sua ripetitività diventa invisibile in quanto non più un centro d’attrazione musicale grazie ai musicisti che improvvisano con grande libertà e tutto suona così fresco e nuovo ad ogni passaggio; un trucco apparentemente semplice, ma in realtà molto difficile da padroneggiare.
The Creator Has a Masterplan / I Want To Talk About You 
The Creator Has a Masterplan è quasi certamente il brano più iconico di Pharoah, in questo live possiamo sentirlo in una versione ridotta con un taglio dell’introduzione e della prima sezione dal carattere lento e contemplativo. Comincia direttamente dalla seconda sezione, la più rapida, mantenendo quello scambio tra momenti frenetici e feroci con lo stile aggressivo di Sanders. A questo segue uno dei più classici degli standard jazz come I Want To Talk About You di Billy Eckstine. Sembra strano che questi due brani possano essere messi vicini, ma restituiscono un’immagine della sua visione musicale ed estetica di vita, ci permettono di capire quanto due persone con cui ha collaborato negli anni ’60 lo abbiano segnato e influenzato nel mestiere del musicante: Sun Ra e John Coltrane. Sanders nel 1962 arriva a New York, una metà che ha lo stesso sapore italiano del classico “vai a Milano, lì c’è tutto”. Sempre nell’intervista per il New Yorker spiega come sia arrivato nella grande mela facendo l’autostop, con un portafoglio vuoto di verdoni ma pieno di verde… speranza, cimentandosi in una vita da senzatetto pur di respirare l’ossigeno dei quartieri dove si suonava il jazz più sperimentale e spinto. Inizialmente cerca di arraffare i soldi per poter mangiare in ogni modo, addirittura donando il sangue per appena diciassette dollari, ma il flusso degli eventi lo trasporta nel luogo giusto al momento giusto. Uno dei lavori più stabili che ha avuto era il cuoco e una sera al Greenwich Village viene notato da Sun Ra che lo vorrà nella sua Arkestra, questa fu l’occasione per compiere il primo balzo da sogno americano del jazzista. Suonare nel 1964 con l’Arkestra, sicuramente una formazione così folle e rivoluzionaria come il suo capo, non poteva che ispirarlo nelle sue avventure seguenti. Ci sarebbe un sacco da scrivere su come Sun Ra abbia praticamente gettato le basi per l’estetica cosmica e meditativa del jazz che verrà di lì in poi, ma tralasciando discorsi su possessioni aliene rivelatrici di verità sull’esistenza dei terrestri e del cosmo, basti sapere un dettaglio utile a questa narrazione, Sun Ra era affascinato sin da piccolo alla cultura egizia, da quando in televisione aveva assistito al ritrovamento della tomba di Tutankhamon. Proprio attraverso la cultura egizia una buona fetta degli afroamericani di quell’epoca cominciano il cosiddetto esodo di ritorno verso la Madre Africa e l’Islam. Questo ci porta a capire come mai Sun Ra rinominerà Faraone il suo amico e collega Farrell Sanders, è quindi impossibile slegare questa esperienza quando pensiamo all’immagine di Pharoah con il suo vestiario che ci fa intendere come quell’eredità dell’Arkestra sia diventata parte di lui. Il Creatore ha un piano superiore, riprendendo il concetto islamico di unicità del Tawhid e questa idea spiega come il flusso abbia guidato Pharoah fino a quel punto. Questo piano superiore però non è di certo ancora arrivato alla sua realizzazione, perché l’anno dopo la storia di Sanders si incrocia con quella di Coltrane nell’album Ascension. I due già avevano stretto amicizia quando si erano incontrati in California nel 1959. Nel ’58 Sanders si iscrive all’Oakland Junior College in California per studiare arte e musica, portando avanti la sua passione per la pittura, tuttavia non smette di suonare. Porta a termine un affarone, baratta il suo clarinetto con un sassofono d’argento che a sua volta scambierà con un vecchio modello di tenore come ha sempre voluto. In quella California, dove per suonare nessuno fa questioni sul colore della pelle, incontra John Coltrane. Il loro rapporto viene spesso condito da grandi discorsi mistici, ma sia Coltrane sia Sanders ne parlano con la semplicità di due migliori amici che raccontano l’uno dell’altro. Erano entrambi molto silenziosi, non avevano molto da dirsi, ma quando erano vicini si capivano con qualche sguardo o frase breve. Un episodio che spiega al meglio la profondità del loro rapporto sta di nuovo in quel perfezionismo a volte assillante di Sanders, chiedeva spesso durante le sessioni se il suo suono andasse bene, se le sue note erano giuste o cozzassero, ma Coltrane non rispondeva quasi mai. A furia di insistere però un giorno Coltrane esordì con un semplice “Sì va bene così, tu continua a soffiare”. Poche parole, a dimostrazione di quanto John conoscesse bene l’indole di Sanders. Nelle note di copertina dell’album Live At Village Vanguard Again, leggiamo invece un discorso più lungo – ripreso da Nat Hentoff – di Trane che recita: «Pharoah è un uomo di grandi risorse spirituali. È sempre alla ricerca della verità. Cerca di permettere al suo spirito di guidare le sue azioni. È un uomo che ha, oltre al resto, energia, onestà mentale e che va dritto all’essenza delle cose. Mi piace moltissimo la forza con cui suona. Inoltre, è uno degli innovatori e io mi considero fortunato per il fatto che si sia dimostrato disposto ad aiutarmi, a far parte del nostro gruppo». Hanno due personalità simili nella vita, ma si colmano nelle loro differenze, questo punto sfugge spesso quando si parla erroneamente di come e cosa Sanders abbia ereditato del sassofonismo di Coltrane. La verità è che le loro sonorità sono complementari ed è per questo che assieme suonavano così bene, si inseriscono in un rapporto dialettico, infatti, Sanders è tra i pochi musicisti che sono rimasti fissi nel quintetto di Trane fino alla morte nel ‘67. Tutto questo discorso ci fa capire come in fondo non c’è nulla di così mistico nel rapporto tra loro due, è vero che erano delle persone profondamente spirituali ma ciò non vuol dire che fossero dei santoni invasati di parole ispiratrici e religiose come spesso li si dipinge. Da un lato Coltrane arrivava a chiudersi in camera e disegnare linee nel circolo delle quinte o creare scale usando sequenze numeriche matematiche, mentre Sanders aveva un poderoso istinto a guidarlo quando imboccava l’ancia, tuttavia, dopo ore e ore a fare improvvisazioni libere, come racconta lo stesso Sanders, i due si concedevano di divertirsi suonando qualche standard e alcune ballad. In tal senso, a mio parere, un pezzo come I Want to Talk About You, ci rivela molto sull’influenza di Coltrane su Sanders, più di quanto non lo facciano album come Tauhid, Karma, Summun Bukmun Umyun, Jewels of Thought o andando più in là negli anni, Elevation.
Love is Everywhere

Pharoah Sanders – Udin&Jazz 2008 – ph Luca A. d’Agostino
L’ultimo brano riporta alla memoria una frase che disse un altro dei suoi amici con cui collaborò per anni, il pianista Lonnie Liston Smith, che in un’intervista con Chris Parkin racconta cosa significasse suonare con Sanders: «Sembrava che cantasse più note contemporaneamente e proprio in quel periodo stavo cercando di tirar fuori nuove potenzialità dal mio pianoforte a coda, suonando con l’avambraccio per ottenere un suono più potente. Ho chiesto a Pharoah: “Come fai ad avere questo suono?” Lui mi ha risposto; “Ma anche tu suoni come se avessi più di dieci dita!”. A lui piaceva spingersi sempre oltre il limite». Questo discorso di spingersi oltre il limite mi ha sempre ispirato e fa riflettere su quello che è il discorso che voglio portare in chiusura di quest’album. È innegabile e stupefacente come in dieci anni e una dozzina di album Pharoah Sanders sia diventato un musicista completo già a metà degli anni ’70. Quel bisogno di ricercare la verità e rinnovarsi non gli permettono di frenarsi, non è sufficiente ciò che ha già fatto e la sua spinta creatrice lo porta in più direzioni negli anni a venire. Per un periodo, sul finire degli anni ’70, torna indietro nella musica, abbandonando l’estetica spirituale, riabbracciando musiche più vicine alla tradizione blues come l’Hard Bop o riesplorando il Modal stile West Coast. Arriva nel 1994 a viaggiare in Marocco dove conoscerà la musica Gnawa e registrerà The Trance of Seven Colors con Mahmoud Guinia. Sanders cambia spesso etichetta nel corso della sua carriera, incidendo per dieci etichette diverse, suonando con ogni musicista di ogni estrazione in virtù di quel processo di trasformazione di cui abbiamo parlato. Non si può non restare affascinati da una spinta propulsiva alla creazione come la sua, talmente potente che nel 2021 ritorna in studio dopo lungo tempo registrando Promises, un album con il producer britannico Floating Points e la London Shymphony Orchestra. Il suo sassofono ha ormai raggiunto gli ottant’anni suonati, ascoltandolo riconosciamo subito il suo stile; eppure, ci appare un’altra volta come qualcosa di nuovo mentre veniamo trasportati nel suo mondo con quei nove movimenti attorno allo stesso motivo, racchiudendo forse il migliore album del jazz del ventunesimo secolo. Mi piace pensare che alla fine della sua vita sia riuscito a trovare almeno in quell’album quella sonorità perfetta, senza macchie, quella che con certezza può affermare che gli piace, senza rimuginarci sopra, quella che, in sintesi, ha sempre voluto trovare, ma quanta ironia se pensiamo come un anno prima in quella intervista con Friedman dice di non aver ancora trovato! Questo “ancora” è carico di significato ora che ci ripenso. Il suo voler superare certi limiti e andare oltre è d’obbligo per compiere un viaggio musicale come il suo, si potrebbe pensare che questi continui cambiamenti, che di lustro in lustro ha fatto, derivino da una forza di spirito, ma questa voglia di superare i limiti da sola non basta a spiegare la sua anima. Orientarci alla ricerca di essa facendo una lista di questi cambiamenti nella sua vita ci porta verso l’infinito, fino a diventare un oceano dove, da qualunque parte indichi la bussola, navigheremmo senza ritrovare più la terra ferma. Bisogna prendere fiato, fare il punto e trarre una conclusione prima di disorientarsi. Love is Everywhere mi ha permesso proprio di fare questo: gettare l’ancora in una destinazione precisa. Questo pezzo ha all’interno un chant (caratteristica che manterrà in molti suoi brani, specie dalla collaborazione con il cantante Leon Thomas in poi) e invita il pubblico a recitare con lui questo canto, come in una messa. Questo rituale ci permette di trascendere dal sentiero che abbiamo percorso ascoltando l’album. Vediamo finalmente il poliedro nella sua nuova forma e abbiamo scavato abbastanza da trovarne il nucleo? Forse sì! L’anima che guida questa voglia di sfondare muri e superarsi sta in un dettaglio solo apparentemente trascurabile, rileggendo la sua discografia e soffermandoci sui titoli di alcuni brani possiamo notarlo abbastanza in fretta. Love is Here, Love is Everywhere, o brani con titoli omonimi all’album come Love in Us All (1974), Love will find a way (1977), Welcome to Love (1991), Crescent with Love (1994)… in cui l’amore viene suonato come qualcosa di energico e movimentato dandoci una visione allegra e positiva del sentimento o, al massimo, dove manca l’elemento del ritmo incalzante c’è quello contemplativo; in netto contrasto con il dolore e il lamento perpetuo che troviamo nel resto del mondo jazz, catapultandoci in una dimensione più drammatica, melensa, nostalgica, enigmatica e ignota: What is this thing called love, You don’t know what love is, In a Sentimental Mood, There will never be another you e tanti altri. La domanda iniziale dell’articolo trova risposta, ecco che il nucleo si disvela davanti ai nostri occhi: ciò che Sanders ci ha lasciato è amore, che si esprime da noi stessi verso tutte le cose che ci circondano e da esse fa ritorno a noi. Oserei dire che avendo superato certi limiti sia addirittura un amore ancora più supremo di quello che Coltrane cantava nel 1960 in A Love Supreme. Quanto meno, questa è la forma dello spirito che ho visto io esplorando il mondo di Farrell Pharoah Sanders.
Alessandro Fadalti
da Gerlando Gatto | 31/Mag/2022 | I nostri libri, Primo piano, Recensioni

Ted Gioia – “Storia del Jazz” – EDT – pgg. 614 – € 35,00
 Non molto tempo fa discutevo con un amico musicista (ma anche scrittore e più in generale attento osservatore della realtà) se nell’attuale situazione fosse o meno giustificata la pubblicazione di una nuova storia del jazz. Trovare un punto di intesa non è stato difficile: certo oramai molto si è scritto sulla storia della musica afro-americana ma molto resta ancora da scrivere, da scoprire, da chiarire. In buona sostanza una storia del jazz oggi si giustifica se risponde ad alcuni ben precisi requisiti: innanzitutto che sul passato ci dica qualcosa di nuovo rispetto a quanto finora scritto, sul presente che ci illumini su quanto sta accadendo sulla scena internazionale, sul futuro che vengano lumeggiate le nuove linee di tendenza. Il tutto accompagnato da una fluidità di racconto che eviti il più possibile incorniciati e box che finiscono con il distrarre e far perdere il filo del discorso.
Non molto tempo fa discutevo con un amico musicista (ma anche scrittore e più in generale attento osservatore della realtà) se nell’attuale situazione fosse o meno giustificata la pubblicazione di una nuova storia del jazz. Trovare un punto di intesa non è stato difficile: certo oramai molto si è scritto sulla storia della musica afro-americana ma molto resta ancora da scrivere, da scoprire, da chiarire. In buona sostanza una storia del jazz oggi si giustifica se risponde ad alcuni ben precisi requisiti: innanzitutto che sul passato ci dica qualcosa di nuovo rispetto a quanto finora scritto, sul presente che ci illumini su quanto sta accadendo sulla scena internazionale, sul futuro che vengano lumeggiate le nuove linee di tendenza. Il tutto accompagnato da una fluidità di racconto che eviti il più possibile incorniciati e box che finiscono con il distrarre e far perdere il filo del discorso.
Ebbene questi requisiti sono tutti presenti nella nuova edizione della “Storia del Jazz” di Ted Gioia pubblicata dalla EDT in collaborazione con Fondazione Siena Jazz – Accademia nazionale del jazz Centro di attività e formazione musicale, che si avvale della precisa traduzione di Francesco Martinelli il quale, com’è suo costume, scrive in maniera fluida, scattante, priva di qualsiasi autocompiacimento letterario sicché lo spirito dell’autore viene pienamente rispettato.
Il volume è diviso in undici capitoli (da “La preistoria del jazz” a “La resurrezione del jazz”) con l’aggiunta di quattro Note dedicate rispettivamente a “Letture consigliate”, “Ascolti consigliati”, “Ringraziamenti” e il sempre indispensabile “Indice analitico”. Da questa partizione si capisce come l’Autore parta dalle origini della musica afro-americana per giungere sino ai nostri giorni. Così, nella narrazione di Gioia, ritroviamo tutte le figure più importanti del jazz – da Jelly Roll Morton a Louis Armstrong, da Duke Ellington al Cotton Club, ai giganti del cool come Gerry Mulligan, Stan Getz, e Lester Young, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Ornette Coleman…fino ai postmodernisti della scena downtown – inseriti in una cornice politica e socio-economica che costituisce uno dei punti di forza delle opere di Gioia. In effetti la musica non nasce spontaneamente come una sorta di fungo ma è il portato di tutta una serie di esperienze: di qui fondamentale comprendere il contesto in cui un certo linguaggio nasce e si sviluppa. E Gioia è davvero un maestro nel descrivere tutto ciò, nel farci capire – ad esempio – che cosa significò per i musicisti di colore negli States rivolgersi al be-bop mentre la seconda guerra mondiale volgeva al termine.
Ma è nella seconda parte del libro che a nostro avviso troviamo le notazioni più interessanti. Sono le pagine in cui l’Autore esamina “La resurrezione del jazz” partendo dalla “Resurrezione del cantante di jazz”.
Convincente la tesi sostenuta da Gioia per cui, in questi ultimissimi decenni, il jazz ha riscoperto in qualche modo le sue radici di musica del popolo avviando un dialogo nuovo e non programmato con la cultura di massa. E il ponte che ha permesso tutto ciò è stato varato da artisti quali Kamasi Washington, Robert Glasper, Esperanza Spalding i quali – sono parole di Gioia – “hanno dimostrato che possono utilizzare tutta la gamma stilistica delle canzoni odierne senza perdere le proprie radici jazzistiche”. Una visione, come si nota, assolutamente rivoluzionaria che rende finalmente obsoleto il dibattito circa la presunta “morte del jazz”. In tale quadro anche i cantanti hanno svolto un ruolo di primissimo piano tenendo strettamente collegato il jazz alla musica commerciale. Quasi inutile sottolineare come accanto alle notazioni di carattere sociale, Gioia mai dimentica di indicare le registrazioni che meglio possono corroborare il suo discorso.
Di grande utilità pratica le letture consigliate e gli ascolti consigliati che possono costituire una guida sia per chi voglia approfondire la materia sia per chi ad essa si avvicini per la prima volta
Insomma un volume che non può mancare nella libreria di chi ama la musica.
Amedeo Furfaro, Lionello Pogliani – “Musiche in mente” – The Writer – pgg. 127 – € 12,00
 Scritto a due mani dal nostro collaboratore Amedeo Furfaro e da Lionello Pogliani, rispettivamente giornalista e critico musicale il primo, e collaboratore scientifico dell’Università di Valencia, il secondo, il volume affronta il problema del linguaggio musicale sotto il profilo sia delle cosiddette scienze sociali e umane sia delle scienze strettamente intese. Di qui una lettura interessante in quanto si intersecano due tipi di logica in un momento in cui, viceversa, si tende a parcellizzare ogni discorso e quindi a esaltare il ruolo della specializzazione sempre e comunque. In buona sostanza obiettivo del lavoro, perfettamente centrato, è mettere in campo una concezione organica della musica che viene ricondotta in un unico arco culturale combinando idee che in genere non sono messe in correlazione fra di loro. In particolare, nella prima parte Pogliani, avvalendosi anche della collaborazione di Michel Villaz e Laurent Vercueil, si muove tra fisica, chimica, astronomia, biologia, acustica, medicina, mentre nella seconda parte Furfaro, partendo dalla sua formazione storico-politologica e antroposociale oltre che musicale, illustra le sue idee traendo ispirazione dalle occasioni più disparate come una lettura, una serata al cinema, una foto, una ricorrenza, un’intervista tutte su filo del discorso musicale.
Scritto a due mani dal nostro collaboratore Amedeo Furfaro e da Lionello Pogliani, rispettivamente giornalista e critico musicale il primo, e collaboratore scientifico dell’Università di Valencia, il secondo, il volume affronta il problema del linguaggio musicale sotto il profilo sia delle cosiddette scienze sociali e umane sia delle scienze strettamente intese. Di qui una lettura interessante in quanto si intersecano due tipi di logica in un momento in cui, viceversa, si tende a parcellizzare ogni discorso e quindi a esaltare il ruolo della specializzazione sempre e comunque. In buona sostanza obiettivo del lavoro, perfettamente centrato, è mettere in campo una concezione organica della musica che viene ricondotta in un unico arco culturale combinando idee che in genere non sono messe in correlazione fra di loro. In particolare, nella prima parte Pogliani, avvalendosi anche della collaborazione di Michel Villaz e Laurent Vercueil, si muove tra fisica, chimica, astronomia, biologia, acustica, medicina, mentre nella seconda parte Furfaro, partendo dalla sua formazione storico-politologica e antroposociale oltre che musicale, illustra le sue idee traendo ispirazione dalle occasioni più disparate come una lettura, una serata al cinema, una foto, una ricorrenza, un’intervista tutte su filo del discorso musicale.
In conclusione un volume che vuole essere uno stimolo ad una riflessione complessiva su come lo sviluppo dell’arte musicale abbia interessato ed investito tutto l’arco dello scibile umano.
Amedeo Furfaro – “Pasolini – Luoghi, incontri, suoni” – The Writer – pgg. 103 – € 12,00
 In questo ulteriore volume, pubblicato nei primi mesi di quest’anno, Furfaro raccoglie i suoi scritti dedicati a Pasolini e riguardanti essenzialmente tre aspetti, luoghi, incontri e suoni. Di particolare importanza, per quanto concerne “A proposito di jazz”, la terza tranche in cui si tenta una panoramica del rapporto di Pasolini con la musica. L’Autore esamina quindi i vari aspetti delle relazioni di Pasolini con la musica partendo dalle colonne sonore dei suoi film per passare ad una discografia essenziale (jazz escluso) che copre gli anni dal 1960 al 1975 in cui sono elencati brani che vedono Pasolini nella veste di paroliere. Negli anni ’80 si collocano alcuni lavori discografici che hanno il merito di ripercorrere tappe importanti dell’excursus creativo pasoliniano, come “La musica nel cinema di Pasolini” (General Music 1984) in cui Morricone riassume le sue musiche per cinque pellicole firmate Pasolini. Interessante anche un altro lavoro, sempre dell’84, “Pour Pier Paolo, Poèmes de Pier Paolo Pasolini mis en musique par Giovanna Marini (Le Chant du monde). Negli anni seguenti Pasolini continua ad ispirare molte pagine musicali, dagli omaggi espliciti di cantanti e gruppi come Pino Marino, Massimiliano Larocca, Radio Dervish fino a compositori come Nicola Piovani e a registi come Nanni Moretti.
In questo ulteriore volume, pubblicato nei primi mesi di quest’anno, Furfaro raccoglie i suoi scritti dedicati a Pasolini e riguardanti essenzialmente tre aspetti, luoghi, incontri e suoni. Di particolare importanza, per quanto concerne “A proposito di jazz”, la terza tranche in cui si tenta una panoramica del rapporto di Pasolini con la musica. L’Autore esamina quindi i vari aspetti delle relazioni di Pasolini con la musica partendo dalle colonne sonore dei suoi film per passare ad una discografia essenziale (jazz escluso) che copre gli anni dal 1960 al 1975 in cui sono elencati brani che vedono Pasolini nella veste di paroliere. Negli anni ’80 si collocano alcuni lavori discografici che hanno il merito di ripercorrere tappe importanti dell’excursus creativo pasoliniano, come “La musica nel cinema di Pasolini” (General Music 1984) in cui Morricone riassume le sue musiche per cinque pellicole firmate Pasolini. Interessante anche un altro lavoro, sempre dell’84, “Pour Pier Paolo, Poèmes de Pier Paolo Pasolini mis en musique par Giovanna Marini (Le Chant du monde). Negli anni seguenti Pasolini continua ad ispirare molte pagine musicali, dagli omaggi espliciti di cantanti e gruppi come Pino Marino, Massimiliano Larocca, Radio Dervish fino a compositori come Nicola Piovani e a registi come Nanni Moretti.
Ovviamente anche il mondo del jazz ha omaggiato Pasolini; Furfaro ricorda al riguardo la performance del Roberto Gatto in “Accattone” e la “Suite per Pierpaolo” a cura di Glauco Venier con Alba Nacicovitch. Ma è in “Appunti per un’Orestiade Africana” che la relazione fra Pasolini e il jazz trova il suo baricentro; ciò in ragione del fatto che buona parte della colonna sonora è affidata a jazzisti quali Gato Barbieri, Marcello Melis e Famoudou Don Moye. A seguire una discografia in cui il jazz “latu sensu” tiene a sottolineare Amedeo, compare a fianco della figura di Pasolini.
Guido Michelone – “Il jazz e i mondi” – Arcana – pgg. 390 – € 24,00
 Davvero infaticabile Guido Michelone, didatta, studioso, giornalista e scrittore tra i più prolifici che il mondo del jazz italiano conosca. Ecco, quindi, una sua nuova fatica editoriale significativamente intitolata “Il jazz e i mondi”. Un titolo che può esplicativo non potrebbe essere. Nelle circa 400 pagine del volume, l’Autore, grazie ai numerosi viaggi compiuti tra Usa, Brasile, Giappone, Canada, Nord Africa e Medioriente, ci racconta, in maniera chiara ed esplicita com’è suo costume, il come e perché il jazz ha trovato diritto di cittadinanza in tutti questi Paesi
Davvero infaticabile Guido Michelone, didatta, studioso, giornalista e scrittore tra i più prolifici che il mondo del jazz italiano conosca. Ecco, quindi, una sua nuova fatica editoriale significativamente intitolata “Il jazz e i mondi”. Un titolo che può esplicativo non potrebbe essere. Nelle circa 400 pagine del volume, l’Autore, grazie ai numerosi viaggi compiuti tra Usa, Brasile, Giappone, Canada, Nord Africa e Medioriente, ci racconta, in maniera chiara ed esplicita com’è suo costume, il come e perché il jazz ha trovato diritto di cittadinanza in tutti questi Paesi
Si tratta di una narrazione a tratti affascinante in quanto si capisce finalmente come il jazz abbia potuto perdere le sue caratteristiche originarie per assumere le connotazioni di una musica universale senza più confini ma specchio della civiltà di ogni singolo Paese, come risultato necessario di quella contaminazione tra le diverse culture di ogni angolo del mondo. Di qui una sorta di viaggio straordinario, suddiviso in 29 capitoli dedicati ognuno ad una parte del mondo, elencate in ordine alfabetico, per cui si parte dall’Afghanistan per chiudere con “Zingari in jazz” dedicato alla musica manouche. Nel libro, accanto a nome e cognome di ogni jazzman, viene indicato lo strumento musicale mentre alla fine di ogni capitolo è riportata tra parentesi la data, grosso modo compresa tra il 2001 e il 2022, ad indicare il periodo in cui viene redatto il resoconto musicale del viaggio compiuto nella nazione indicata.
Ogni capitolo è impreziosito da una accurata discografia mentre il volume nel suo insieme è completato da una sempre utile bibliografia. Purtroppo manca quell’indice analitico che in un volume del genere sarebbe risultato particolarmente importante.
Renzo Ruggeri – “Elementi di Musica Jazz: CORSO BASE per fisarmonica” – Voglia d’Arte Production – pgg.165 – € 25,00
 “Questo lavoro di Ruggieri – condotto con serietà e competenza – è un avvenimento per la fisarmonica.” Gianni Coscia
“Questo lavoro di Ruggieri – condotto con serietà e competenza – è un avvenimento per la fisarmonica.” Gianni Coscia
Con queste parole il grande patriarca della fisarmonica jazz italiana ha tenuto a battesimo l’uscita della prima versione del testo, circa 25 anni fa, quando esso rappresentava il primo libro internazionale per questo strumento con elementi di jazz moderno.
Ruggieri – da esperto didatta – affronta la materia in maniera profonda proponendo una suddivisione razionale dei capitoli, non lesinando esercizi pratici di grande efficacia. La nuova versione si propone una riscrittura del testo, un ampliamento degli argomenti in base alle esperienze degli anni di utilizzo, una razionalizzazione degli schemi e degli esercizi. Sicuramente è stato il primo testo ad introdurre in maniera approfondita dei “policordi” ovvero la pressione di più tasti contemporaneamente nella mano sinistra, tecnica che lo stesso Ruggieri definisce imperfetta ma molto efficace.
La vera novità è rappresentata, comunque, dalle “backing tracks” dei brani del metodo (nuove composizioni sulle strutture armoniche di famosi standard) suonate da affermati professionisti: Maurizio Rolli (contrabbasso), Mauro De Federicis (chitarra), Niki Barulli (batteria). Quest’ultime tutte disponibili gratuitamente sui circuiti online sia in versione completa che “minus bass”, o “minus harmony”, o “minus drums” a simulare le diverse situazioni che lo studente incontrerà.
Da sottolineare la sempre “elegante ed efficace” vena melodica di Ruggieri che si manifesta anche negli esercizi.
Di prossima uscita la versione inglese e nei prossimi anni quella INTERMEDIA e AVANZATA.
Distribuito in tutto il mondo da AMAZON è possibile acquistarlo direttamente su:
https://www.amazon.it/dp/B095GD37SN
Le basi sono disponibili gratuitamente su:
SPOTIFY
https://open.spotify.com/album/3gupaPMqTIuQekv9J8cwzL?si=NG6oHNIfTKa9eGMQQDIyXA
YOUTUBE
https://youtu.be/r0EVSxyEOB4
Vincenzo Staiano – “Solid – Quel diavolo di Scott LaFaro” – Arcana – pgg. 174 – € 16,00
 Ecco un volume che sarà ben accolto da tutti gli appassionati di jazz, in special modo dai pianisti e dai contrabbassisti. Racconta, infatti, la storia di un connubio assolutamente straordinario, un incontro che ha cambiato la storia del jazz in relazione al classico combo pianoforte, batteria, contrabbasso. Ci si riferisce ovviamente alla straordinaria intesa che nell’arco di pochissimo tempo si costituì tra Bill Evans e Scott LaFaro, un’intesa che sconvolse definitivamente la gerarchia degli strumenti nel trio (completato all’epoca da Paul Motian) cosicché il pianoforte perse il ruolo di guida per essere affiancato, a pari condizioni, da batteria e contrabbasso. Certo, a dirlo oggi, sembra qualcosa di scontato ma se si risale all’epoca in cui Evans e LaFaro si incontrarono, vale a dire il 1959, si scoprirà come la musica proposta dal trio fosse assolutamente rivoluzionaria. In questo suo scritto Staiano pone l’accento sulla figura del contrabbassista prematuramente scomparso nel 1961, offrendone un ritratto illuminante anche perché ci fa comprendere come, già prima di incontrare Bill Evans, fosse artista in possesso di una propria ben specifica cifra stilistica. Particolare attenzione viene, così, dedicata al periodo che va dal 1955, quando Scott lascia l’università di Itaca per iniziare il suo primo tour come professionista, sino a quel tragico incidente che il 6 luglio del 1961 gli costa la vita. Grazie ad un racconto ben articolato, sorretto da una prosa che conosce l’italiano, il volume si legge quasi tutto d’un fiato arricchito da una serie di contributi originali. In effetti in Italia pochissimo era stato scritto su LaFaro per cui il libro di Vincenzo Staiano assume un’importanza particolare. L’autore, per questa sua prima pregevole monografia, si è avvalso della biografia di Scotty (con questo nomignolo era noto LaFaro e questo si utilizza nel libro) redatta dalla sorella Helene, nonché di una grande quantità di contributi sull’artista, come l’intervista di Martin Williams apparsa sul periodico “Jazz Review”, un articolo del 1968 di Jean-Pierre Binchet su “Jazz Magazine”, un sito web a lui dedicato nel 1998 da Charles A. Ralston, nonché di moltissimi altri contributi elencati nella ricca appendice bibliografica e webgrafica, cui si affianca una discografia.
Ecco un volume che sarà ben accolto da tutti gli appassionati di jazz, in special modo dai pianisti e dai contrabbassisti. Racconta, infatti, la storia di un connubio assolutamente straordinario, un incontro che ha cambiato la storia del jazz in relazione al classico combo pianoforte, batteria, contrabbasso. Ci si riferisce ovviamente alla straordinaria intesa che nell’arco di pochissimo tempo si costituì tra Bill Evans e Scott LaFaro, un’intesa che sconvolse definitivamente la gerarchia degli strumenti nel trio (completato all’epoca da Paul Motian) cosicché il pianoforte perse il ruolo di guida per essere affiancato, a pari condizioni, da batteria e contrabbasso. Certo, a dirlo oggi, sembra qualcosa di scontato ma se si risale all’epoca in cui Evans e LaFaro si incontrarono, vale a dire il 1959, si scoprirà come la musica proposta dal trio fosse assolutamente rivoluzionaria. In questo suo scritto Staiano pone l’accento sulla figura del contrabbassista prematuramente scomparso nel 1961, offrendone un ritratto illuminante anche perché ci fa comprendere come, già prima di incontrare Bill Evans, fosse artista in possesso di una propria ben specifica cifra stilistica. Particolare attenzione viene, così, dedicata al periodo che va dal 1955, quando Scott lascia l’università di Itaca per iniziare il suo primo tour come professionista, sino a quel tragico incidente che il 6 luglio del 1961 gli costa la vita. Grazie ad un racconto ben articolato, sorretto da una prosa che conosce l’italiano, il volume si legge quasi tutto d’un fiato arricchito da una serie di contributi originali. In effetti in Italia pochissimo era stato scritto su LaFaro per cui il libro di Vincenzo Staiano assume un’importanza particolare. L’autore, per questa sua prima pregevole monografia, si è avvalso della biografia di Scotty (con questo nomignolo era noto LaFaro e questo si utilizza nel libro) redatta dalla sorella Helene, nonché di una grande quantità di contributi sull’artista, come l’intervista di Martin Williams apparsa sul periodico “Jazz Review”, un articolo del 1968 di Jean-Pierre Binchet su “Jazz Magazine”, un sito web a lui dedicato nel 1998 da Charles A. Ralston, nonché di moltissimi altri contributi elencati nella ricca appendice bibliografica e webgrafica, cui si affianca una discografia.
La figura di LaFaro assume così una valenza particolare sottolineata anche dal titolo del libro, “Solid”, che come ci spiega lo stesso Staiano richiama l’essenza di un messaggio inviato a Scott da Miles Davis, un messaggio con cui il trombettista gli faceva capire di volerlo nella sua formazione come contrabbassista.
da Gerlando Gatto | 08/Nov/2021 | I nostri CD, Primo piano, Recensioni

ACT
Nils Landgren Funk Unit – “Funk is my Religion” – ACT
Nils Landgren – “Nature Boy” – ACT
 Nils Landgren, personaggio di punta del jazz, è ben noto anche ai lettori di queste note avendo in passato recensito alcune sue significative produzioni. Adesso lo riascoltiamo in due differenti contesti: nel primo album Nils è alla testa della suo celebrata “Funk Unit” mentre nel secondo abbiamo modo di apprezzarlo come arrangiatore e strumentista dal momento che suona da solo.
Nils Landgren, personaggio di punta del jazz, è ben noto anche ai lettori di queste note avendo in passato recensito alcune sue significative produzioni. Adesso lo riascoltiamo in due differenti contesti: nel primo album Nils è alla testa della suo celebrata “Funk Unit” mentre nel secondo abbiamo modo di apprezzarlo come arrangiatore e strumentista dal momento che suona da solo.
Ma procediamo con ordine. “Funk is my Religion” è l’undicesimo album registrato dalla pregiata ditta “Funk Unit” da quando venne creata nel 1994 ed ha avuto una vita piuttosto travagliata per vedere la luce: in effetti tutto era pronto per essere registrato nell’isola di Maiorca ma la cosa non fu possibile a causa del Covid; allora si virò verso il distretto di Redhorn in Bad Meinberg ma anche questa volta, sempre a causa del virus, non se ne fece alcunché. Ultima ratio l’Ingrid Studio di Stoccolma in cui l’album venne effettivamente registrato dal 3 al 7 novembre del 2020 per uscire in Germania il 28 maggio scorso. Come spesso sottolineato, capita raramente che il titolo di un album abbia un qualche effettivo collegamento con la musica che propone: in questo caso non poteva esserci titolo più azzeccato dal momento che effettivamente oramai da anni Nils Landgren va predicando questa sua passione per il Funk. Così, anche questa volta, il sestetto si muove sulle coordinate di una musica piacevole, orecchiabile, spesso trascinante in cui se è vero che non si avverte alcuna novità è altresì vero che non sempre nuova musica equivale a buona musica…e viceversa. All’interno dei dieci brani proposti, particolarmente riuscita l’interpretazione di “Play Funk” disegnata dalla bella voce di Magnum Coltrane Price.
 Del tutto diverso “Nature Boy”; abbandonate le tinte forti del Funk, Lindgren si concede un esperimento tanto ardito quanto affascinante: presentare ben quattordici brani in solitudine. L’album prende il nome da un brano famoso, quel “Nature Boy” scritto da Eden Ahbez e registrato per la prima volta da Nat King Cole con l’orchestra diretta da Frank DeVol il 22 agosto del 1947. Ma, a parte questo brano, l’album è incentrato sulla musica tradizionale del proprio paese, una strada già percorsa da Landgren quando alla fine degli anni ’90 in duo con il pianista Esbjörn Svensson incise due album incentrati sulla folk music , “Swedish Folk Modern” e “Layers Of Light”. Questa volta la prova è più difficile in quanto Landgren si trova ad affrontare un repertorio oggettivamente ostico da solo con il proprio trombone. Risultato: viste le premesse si può ben dire che l’artista svedese si conferma musicista di prim’ordine, in grado di eseguire con sincera partecipazione partiture che molto si allontanano dal linguaggio prettamente jazzistico. Ottima, infine, la resa sonora grazie anche all’acustica della Ingelstorps Church dove è stato registrato l’album nel febbraio di questo 2021.
Del tutto diverso “Nature Boy”; abbandonate le tinte forti del Funk, Lindgren si concede un esperimento tanto ardito quanto affascinante: presentare ben quattordici brani in solitudine. L’album prende il nome da un brano famoso, quel “Nature Boy” scritto da Eden Ahbez e registrato per la prima volta da Nat King Cole con l’orchestra diretta da Frank DeVol il 22 agosto del 1947. Ma, a parte questo brano, l’album è incentrato sulla musica tradizionale del proprio paese, una strada già percorsa da Landgren quando alla fine degli anni ’90 in duo con il pianista Esbjörn Svensson incise due album incentrati sulla folk music , “Swedish Folk Modern” e “Layers Of Light”. Questa volta la prova è più difficile in quanto Landgren si trova ad affrontare un repertorio oggettivamente ostico da solo con il proprio trombone. Risultato: viste le premesse si può ben dire che l’artista svedese si conferma musicista di prim’ordine, in grado di eseguire con sincera partecipazione partiture che molto si allontanano dal linguaggio prettamente jazzistico. Ottima, infine, la resa sonora grazie anche all’acustica della Ingelstorps Church dove è stato registrato l’album nel febbraio di questo 2021.
ATS
Raphael Kafers Constellation Project – “Retrospection” – ATS
 Album d’esordio nella scuderia ATS per il giovane chitarrista austriaco Raphael Käfer che nell’occasione si presenta sotto l’insegna “Raphael Käfer’s Constellation Project”. A coadiuvarlo nella non facile impresa alcuni tra i migliori jazzisti austriaci come Tobias Pustelnik sax, Urs Hager piano, Philipp Zarfl basso e Matheus Jardim batteria. In programma sei brani originali del leader più il celebre standard “How Deep Is The Ocean” di Irving Berlin. L’album si fa apprezzare particolarmente per l’eccellente equilibrio raggiunto tra i cinque: il leader non si ritaglia alcuno spazio in più rispetto ai “colleghi” e nei suoi brani (tutti ben scritti e altrettanto ben arrangiati) c’è posto per tutti. Così ognuno ha un proprio spazio per evidenziare le proprie potenzialità, che non sono di poco conto. Per quanto concerne il linguaggio, siamo nell’ambito di un jazz mainstream contemporaneo – se mi consentite il termine – vale a dire un jazz nell’alveo della tradizione, ma al contempo attuale che pur senza alcuna pretesa di sperimentare alcunché di nuovo esprime la consapevolezza di raccontare compiutamente il proprio essere. Di qui la godibilità della musica che interessa tutto l’album cosicché riesce davvero difficile segnalare un singolo brano. Comunque qualche parola mi sento di spenderla sull’unico standard: presentare un brano celebrato come “How Deep Is The Ocean” non è facile anche perché i modelli con cui confrontarsi sono molti ed eccelsi; ebbene Käfer e compagni se la sono cavata egregiamente con una esecuzione pienamente rispettosa delle originali caratteristiche del brano.
Album d’esordio nella scuderia ATS per il giovane chitarrista austriaco Raphael Käfer che nell’occasione si presenta sotto l’insegna “Raphael Käfer’s Constellation Project”. A coadiuvarlo nella non facile impresa alcuni tra i migliori jazzisti austriaci come Tobias Pustelnik sax, Urs Hager piano, Philipp Zarfl basso e Matheus Jardim batteria. In programma sei brani originali del leader più il celebre standard “How Deep Is The Ocean” di Irving Berlin. L’album si fa apprezzare particolarmente per l’eccellente equilibrio raggiunto tra i cinque: il leader non si ritaglia alcuno spazio in più rispetto ai “colleghi” e nei suoi brani (tutti ben scritti e altrettanto ben arrangiati) c’è posto per tutti. Così ognuno ha un proprio spazio per evidenziare le proprie potenzialità, che non sono di poco conto. Per quanto concerne il linguaggio, siamo nell’ambito di un jazz mainstream contemporaneo – se mi consentite il termine – vale a dire un jazz nell’alveo della tradizione, ma al contempo attuale che pur senza alcuna pretesa di sperimentare alcunché di nuovo esprime la consapevolezza di raccontare compiutamente il proprio essere. Di qui la godibilità della musica che interessa tutto l’album cosicché riesce davvero difficile segnalare un singolo brano. Comunque qualche parola mi sento di spenderla sull’unico standard: presentare un brano celebrato come “How Deep Is The Ocean” non è facile anche perché i modelli con cui confrontarsi sono molti ed eccelsi; ebbene Käfer e compagni se la sono cavata egregiamente con una esecuzione pienamente rispettosa delle originali caratteristiche del brano.
Upper Austrian Jazz Orchestra – “Crazy Days: UAJO Plays The Music Of Ed Puddick” – ATS
 Di carattere completamente diverso il secondo album targato ATS che vede all’opera la Big Band Upper Austrian Jazz Orchestra (UAJO). In effetti l’album è la risultante di una visita in Austria del trombonista, compositore e arrangiatore inglese Ed Puddick poco tempo prima del lockdown nei primi giorni del gennaio 2020. La UAJO nei suoi 28 anni di attività si è affermata sulla scena europea grazie alla sua duttilità che le consente di collaborare con musicisti di estrazione assai diversa passando così da Kenny Wheeler, a Johnny Griffin, da Mike Gibbs a Maria Joao… a Slide Hampton. In questo nuovo album il cui repertorio è firmato e arrangiato da Ed Puddick, c’è la conferma di quanto detto in precedenza: l’orchestra si adatta perfettamente sia a quegli arrangiamenti in cui Puddick si rifà esplicitamente ad un jazz più tradizionale sia a quei pezzi in cui la musica dell’inglese vira decisamente verso lidi più moderni evidenziando una diretta discendenza da Mike Gibbs. Seguendo questo schema si può affermare che i primi tre pezzi “Crazy Days”, “An Ocean of Air” e “Forum Internum”, appartengono alla prima categoria con in evidenza le sezioni di ottoni e di sassofoni. Di converso l’influenza di Mike Gibbs è particolarmente evidente in “Slow News Day” e “New Familiar” con il chitarrista Primus Sitter in primo piano. Tra gli altri solisti occorre ricordare il pianista Herman Hill, i sassofonisti Andreas See e Christian Maurer e il trombettista Manfred Weinberger.
Di carattere completamente diverso il secondo album targato ATS che vede all’opera la Big Band Upper Austrian Jazz Orchestra (UAJO). In effetti l’album è la risultante di una visita in Austria del trombonista, compositore e arrangiatore inglese Ed Puddick poco tempo prima del lockdown nei primi giorni del gennaio 2020. La UAJO nei suoi 28 anni di attività si è affermata sulla scena europea grazie alla sua duttilità che le consente di collaborare con musicisti di estrazione assai diversa passando così da Kenny Wheeler, a Johnny Griffin, da Mike Gibbs a Maria Joao… a Slide Hampton. In questo nuovo album il cui repertorio è firmato e arrangiato da Ed Puddick, c’è la conferma di quanto detto in precedenza: l’orchestra si adatta perfettamente sia a quegli arrangiamenti in cui Puddick si rifà esplicitamente ad un jazz più tradizionale sia a quei pezzi in cui la musica dell’inglese vira decisamente verso lidi più moderni evidenziando una diretta discendenza da Mike Gibbs. Seguendo questo schema si può affermare che i primi tre pezzi “Crazy Days”, “An Ocean of Air” e “Forum Internum”, appartengono alla prima categoria con in evidenza le sezioni di ottoni e di sassofoni. Di converso l’influenza di Mike Gibbs è particolarmente evidente in “Slow News Day” e “New Familiar” con il chitarrista Primus Sitter in primo piano. Tra gli altri solisti occorre ricordare il pianista Herman Hill, i sassofonisti Andreas See e Christian Maurer e il trombettista Manfred Weinberger.
ECM
Andrew Cyrille – “The News” – ECM
 Gli anni passano ma sembrano non incidere più di tanto sull’arte del veterano Andrew Cyrille (classe 1939). Ecco quindi il terzo album prodotto dal celebre batterista per la casa tedesca, un “The News” che, manco a dirlo, non tradisce le attese. Ben completato da Bill Frisell alla chitarra, David Virelles piano e sin e Ben Street contrabbasso, il quartetto si muove in maniera empatica dimostrando di aver ben assorbito la perdita di Richard Teitelbaum venuto a mancare nel 2020. Il sostituto David Virelles si è perfettamente integrato nella logica del gruppo anzi è riuscito in un tempo relativamente breve a costituire una straordinaria intesa con il leader ché i due costituiscono adesso l’asse portante della formazione. Certo Frisell e Ben Street non sono dei comprimari e il loro ruolo è di assoluta importanza per la riuscita del tutto. Al riguardo non si può non sottolineare ancora una volta la straordinaria personalità di Cyrille che superata la soglia degli 80 resta validamente in sella non solo come insuperabile strumentista ma anche come compositore originale. Non è certo un caso che in repertorio figurino tre suoi brani di cui uno, “Dance of the Nuances”, scritto in collaborazione con Virelles. Gli altri pezzi sono opera di Bill Frisell, di David Virelles e di Adegoke Steve Colson (“Leaving East of Java”) brano tra i meglio riusciti grazie alla perfetta intesa evidenziata dal gruppo che alterna con assoluta naturalezza parti scritte a parti improvvisate.
Gli anni passano ma sembrano non incidere più di tanto sull’arte del veterano Andrew Cyrille (classe 1939). Ecco quindi il terzo album prodotto dal celebre batterista per la casa tedesca, un “The News” che, manco a dirlo, non tradisce le attese. Ben completato da Bill Frisell alla chitarra, David Virelles piano e sin e Ben Street contrabbasso, il quartetto si muove in maniera empatica dimostrando di aver ben assorbito la perdita di Richard Teitelbaum venuto a mancare nel 2020. Il sostituto David Virelles si è perfettamente integrato nella logica del gruppo anzi è riuscito in un tempo relativamente breve a costituire una straordinaria intesa con il leader ché i due costituiscono adesso l’asse portante della formazione. Certo Frisell e Ben Street non sono dei comprimari e il loro ruolo è di assoluta importanza per la riuscita del tutto. Al riguardo non si può non sottolineare ancora una volta la straordinaria personalità di Cyrille che superata la soglia degli 80 resta validamente in sella non solo come insuperabile strumentista ma anche come compositore originale. Non è certo un caso che in repertorio figurino tre suoi brani di cui uno, “Dance of the Nuances”, scritto in collaborazione con Virelles. Gli altri pezzi sono opera di Bill Frisell, di David Virelles e di Adegoke Steve Colson (“Leaving East of Java”) brano tra i meglio riusciti grazie alla perfetta intesa evidenziata dal gruppo che alterna con assoluta naturalezza parti scritte a parti improvvisate.
Mathias Eick – “When We Leave” – ECM
 Non sono certo molti i musicisti che suonano bene sia il pianoforte sia la tromba. In Italia abbiamo l’eccellente Dino Rubino; in Norvegia c’è questo Mathias Eick che oltre ai due su citati strumenti si fa apprezzare anche al basso, al vibrafono e alla chitarra. Nato in una famiglia in cui la musica è di casa (i due fratelli Johannes e Trude sono anch’essi musicisti) Mathias ancora non è troppo noto dalle nostre parti anche se può già vantare un curriculum di tutto rispetto avendo già collaborato, tra gli altri, con Chick Corea, Iro Haarla, Manu Katché e Jacob Young. In questa sua nuova fatica discografica, Eick suona con Håkon Aase al violino, Andreas Ulvo al piano, Audun Erlien al basso, i due batteristi Torstein Lofthus e Helge Norbakken nonché Stian Casrtensen alla pedal steel guitar. Eick appartiene di diritto a quella folta schiera di musicisti nordici che pur suonando jazz si rifanno in modo più o meno esplicito alle radici folk della loro musica. Ecco quindi, in organico, un eccellente violinista quale Håkon Aase che il leader inserisce nei suoi brani proprio per dare alle esecuzioni quella particolare coloratura cui si accennava. Così Aase divide con il leader e con il pianista Andreas Ulvo il ruolo di prim’attore in un repertorio declinato attraverso sette brani
Non sono certo molti i musicisti che suonano bene sia il pianoforte sia la tromba. In Italia abbiamo l’eccellente Dino Rubino; in Norvegia c’è questo Mathias Eick che oltre ai due su citati strumenti si fa apprezzare anche al basso, al vibrafono e alla chitarra. Nato in una famiglia in cui la musica è di casa (i due fratelli Johannes e Trude sono anch’essi musicisti) Mathias ancora non è troppo noto dalle nostre parti anche se può già vantare un curriculum di tutto rispetto avendo già collaborato, tra gli altri, con Chick Corea, Iro Haarla, Manu Katché e Jacob Young. In questa sua nuova fatica discografica, Eick suona con Håkon Aase al violino, Andreas Ulvo al piano, Audun Erlien al basso, i due batteristi Torstein Lofthus e Helge Norbakken nonché Stian Casrtensen alla pedal steel guitar. Eick appartiene di diritto a quella folta schiera di musicisti nordici che pur suonando jazz si rifanno in modo più o meno esplicito alle radici folk della loro musica. Ecco quindi, in organico, un eccellente violinista quale Håkon Aase che il leader inserisce nei suoi brani proprio per dare alle esecuzioni quella particolare coloratura cui si accennava. Così Aase divide con il leader e con il pianista Andreas Ulvo il ruolo di prim’attore in un repertorio declinato attraverso sette brani
tutti scritti dal leader e tutti accomunati da quella struggente malinconia che spesso caratterizza le composizioni dei musicisti del Nord Europa, in special modo norvegesi.
Marc Johnson – “Overpass” – ECM
 Gli album per contrabbasso solo non sono frequenti e la cosa è perfettamente spiegabile dal momento che lo strumento è nato e si è sviluppato in funzione di accompagnamento del gruppo. Certo, nel corso degli anni, proprio nel jazz, il contrabbasso ha trovato la possibilità di elevarsi, da strumento di mero accompagnamento e sostegno armonico, a vero e proprio strumento solista, ma di qui ad essere il protagonista solitario di un concerto o di un disco ce ne corre. Non stupisce quindi, come si diceva in apertura, che gli album per solo contrabbasso siano relativamente pochi: tra questi si ricorda “Journal violone” di Barre Phillips del ’68 (probabilmente il primo del genere), e poi nel corso degli anni, tanto per citare qualche nome, Larry Grenadier, Larry Ronald, Lars Danielsson, John Patitucci, Daniel Studer… mentre in Italia si sono misurati con questa pratica, tra gli altri, Jacopo Ferrazza, Roberto Bonati, Furio Di Castri e Enzo Pietropaoli. Adesso arriva questo album di Marc Johnson e si tratta di un CD davvero strepitoso. Marc Johnson è in gran forma e d’altronde non è certo una sorpresa dato tutto ciò che questo artista ha già realizzato.Gli appassionati di jazz lo conoscono e con questo “Overpass” Marc si ripropone come uno dei principali artefici della modernizzazione che ha interessato il linguaggio contrabbassistico. L’album è declinato attraverso otto brani di cui cinque composti dallo stesso Marc cui si affiancano “Freedom Jazz Dance” di Eddie Harris, “Nardis” di Miles Davis e il tema d’amore della colonna sonora del film “Spartacus” di Alex North. Marc affronta questo impegnativo repertorio con assoluta padronanza del proprio strumento evidenziando la solita cavata possente, la consueta maestria tecnica sia al pizzicato sia con l’archetto, la ben nota capacità di valorizzare i contenuti tematici del pezzo come accade, ad esempio, in “Samurai Fly”, composizione che dall’inizio con archetto riprende il tema di “Samurai Hee Haw” tratto dall’album “Bass Desires” che il contrabbassista registrò nel 2018 con Bill Frisell, John Scofield e Peter Erskine.
Gli album per contrabbasso solo non sono frequenti e la cosa è perfettamente spiegabile dal momento che lo strumento è nato e si è sviluppato in funzione di accompagnamento del gruppo. Certo, nel corso degli anni, proprio nel jazz, il contrabbasso ha trovato la possibilità di elevarsi, da strumento di mero accompagnamento e sostegno armonico, a vero e proprio strumento solista, ma di qui ad essere il protagonista solitario di un concerto o di un disco ce ne corre. Non stupisce quindi, come si diceva in apertura, che gli album per solo contrabbasso siano relativamente pochi: tra questi si ricorda “Journal violone” di Barre Phillips del ’68 (probabilmente il primo del genere), e poi nel corso degli anni, tanto per citare qualche nome, Larry Grenadier, Larry Ronald, Lars Danielsson, John Patitucci, Daniel Studer… mentre in Italia si sono misurati con questa pratica, tra gli altri, Jacopo Ferrazza, Roberto Bonati, Furio Di Castri e Enzo Pietropaoli. Adesso arriva questo album di Marc Johnson e si tratta di un CD davvero strepitoso. Marc Johnson è in gran forma e d’altronde non è certo una sorpresa dato tutto ciò che questo artista ha già realizzato.Gli appassionati di jazz lo conoscono e con questo “Overpass” Marc si ripropone come uno dei principali artefici della modernizzazione che ha interessato il linguaggio contrabbassistico. L’album è declinato attraverso otto brani di cui cinque composti dallo stesso Marc cui si affiancano “Freedom Jazz Dance” di Eddie Harris, “Nardis” di Miles Davis e il tema d’amore della colonna sonora del film “Spartacus” di Alex North. Marc affronta questo impegnativo repertorio con assoluta padronanza del proprio strumento evidenziando la solita cavata possente, la consueta maestria tecnica sia al pizzicato sia con l’archetto, la ben nota capacità di valorizzare i contenuti tematici del pezzo come accade, ad esempio, in “Samurai Fly”, composizione che dall’inizio con archetto riprende il tema di “Samurai Hee Haw” tratto dall’album “Bass Desires” che il contrabbassista registrò nel 2018 con Bill Frisell, John Scofield e Peter Erskine.
Craig Taborn – “Shadow Plays” – ECM
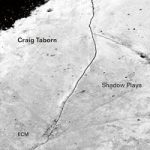 Ecco un’altra preziosa incisione di Craig Taborn registrato in splendida solitudine durante un concerto tenuto nel marzo del 2020 alla Wiener Konzerthaus. L’album si articola su sette brani tutti composti dallo stesso Taborn cha ha da poco superato la soglia dei 50 anni. La cifra stilistica del pianista, organista, tastierista e compositore statunitense è oramai ben nota: un pianismo assolutamente originale, spesso improvvisato (come nell’album qui proposto) in cui suono e silenzi scandiscono un trascorrere del tempo caratterizzato dal fatto che fantasia e preparazione tecnica, dinamiche perfettamente controllate, intrecci poliritmici, ricorso sapiente al contrappunto, improvvise cascate di note coesistono a formare una musica sempre nuova, affascinante, spesso trascinante. Taborn è assolutamente padrone della materia; non c’è un solo momento in cui si avverte la pur minima sensazione che l’artista non sia in grado di padroneggiare ciò che sta suonando: tutto resta ancorato ad una visione che l’artista svela all’ascoltatore man mano che il concerto procede. E nel prosieguo dell’ascolto si può avvertire come l’arte di Taborn affondi le proprie radici nella migliore tradizione del piano jazz, riconoscendo tra i suoi numi ispiratori i nomi di Ellington, Monk, Cecil Taylor, Sun Ra, Abdullah Ibrahim, Ahmad Jamal in un perfetto connubio tra modernità e classicismo. Ma non basa ché tra le fonti ispiratrici di Craig bisogna annoverare anche il cinema, la pittura e tornando alla musica una folta schiera di musicisti che non appartengono al jazz quali Debussy, Glass, Ligeti.
Ecco un’altra preziosa incisione di Craig Taborn registrato in splendida solitudine durante un concerto tenuto nel marzo del 2020 alla Wiener Konzerthaus. L’album si articola su sette brani tutti composti dallo stesso Taborn cha ha da poco superato la soglia dei 50 anni. La cifra stilistica del pianista, organista, tastierista e compositore statunitense è oramai ben nota: un pianismo assolutamente originale, spesso improvvisato (come nell’album qui proposto) in cui suono e silenzi scandiscono un trascorrere del tempo caratterizzato dal fatto che fantasia e preparazione tecnica, dinamiche perfettamente controllate, intrecci poliritmici, ricorso sapiente al contrappunto, improvvise cascate di note coesistono a formare una musica sempre nuova, affascinante, spesso trascinante. Taborn è assolutamente padrone della materia; non c’è un solo momento in cui si avverte la pur minima sensazione che l’artista non sia in grado di padroneggiare ciò che sta suonando: tutto resta ancorato ad una visione che l’artista svela all’ascoltatore man mano che il concerto procede. E nel prosieguo dell’ascolto si può avvertire come l’arte di Taborn affondi le proprie radici nella migliore tradizione del piano jazz, riconoscendo tra i suoi numi ispiratori i nomi di Ellington, Monk, Cecil Taylor, Sun Ra, Abdullah Ibrahim, Ahmad Jamal in un perfetto connubio tra modernità e classicismo. Ma non basa ché tra le fonti ispiratrici di Craig bisogna annoverare anche il cinema, la pittura e tornando alla musica una folta schiera di musicisti che non appartengono al jazz quali Debussy, Glass, Ligeti.
Marcin Wasilewski Trio – “En Attendant” – ECM 2677
 La ECM ci ripropone una delle formazioni europee più significative degli ultimi anni. Il trio polacco del pianista Marcin Wasilewski con Sławomir Kurkiewicz al contrabbasso e Michał Miśkiewicz alla batteria. Tanto per sottolineare la cifra artistica del gruppo, basti considerare che i tre hanno talmente entusiasmato il trombettista Tomasz Stańko da collaborare assieme per oltre 20 anni. Il fatto è che i tre suonano in trio dall’oramai lontano 1993 per cui hanno sviluppato un idem sentire, una fluidità di suono, una compattezza non facilmente riscontrabile in altri gruppi seppur di chiara fama. Tutti questi elementi li ritroviamo nell’album in oggetto che accanto alle composizioni del leader e del trio ci presenta una rivisitazione di “Variation 25” tratta dalle “Godberg Variations” di Bach, “Vashka” di Carla Bley e “Riders On The Storm” dei Doors. Evidenziare un brano piuttosto che un altro è impresa quanto mai ardua, comunque se si volesse avere un’idea ben chiara di come i tre siano davvero accomunati da una intesa speciale suggeriremmo di ascoltare le tre improvvisazioni del trio (“In Motion Part I,II,III”): sarà facile capire come Wasilewski e compagni non si adagino su pattern o punti di riferimento precostituiti, ma si avventurino su terreni totalmente improvvisati in cui i tre strumenti cambiano di ruolo, giocando anche su dinamiche spesso inattese. A chiudere forse non è inutile
La ECM ci ripropone una delle formazioni europee più significative degli ultimi anni. Il trio polacco del pianista Marcin Wasilewski con Sławomir Kurkiewicz al contrabbasso e Michał Miśkiewicz alla batteria. Tanto per sottolineare la cifra artistica del gruppo, basti considerare che i tre hanno talmente entusiasmato il trombettista Tomasz Stańko da collaborare assieme per oltre 20 anni. Il fatto è che i tre suonano in trio dall’oramai lontano 1993 per cui hanno sviluppato un idem sentire, una fluidità di suono, una compattezza non facilmente riscontrabile in altri gruppi seppur di chiara fama. Tutti questi elementi li ritroviamo nell’album in oggetto che accanto alle composizioni del leader e del trio ci presenta una rivisitazione di “Variation 25” tratta dalle “Godberg Variations” di Bach, “Vashka” di Carla Bley e “Riders On The Storm” dei Doors. Evidenziare un brano piuttosto che un altro è impresa quanto mai ardua, comunque se si volesse avere un’idea ben chiara di come i tre siano davvero accomunati da una intesa speciale suggeriremmo di ascoltare le tre improvvisazioni del trio (“In Motion Part I,II,III”): sarà facile capire come Wasilewski e compagni non si adagino su pattern o punti di riferimento precostituiti, ma si avventurino su terreni totalmente improvvisati in cui i tre strumenti cambiano di ruolo, giocando anche su dinamiche spesso inattese. A chiudere forse non è inutile
sottolineare come questo album sia il primo, dopo 10 anni, registrato dal trio in studio (La Buissonne, nel sud della Francia), senza ospiti, e il settimo pubblicato dalla etichetta discografica di Manfred Eicher.
LOSEN RECORDS
La norvegese Losen Records, proseguendo nelle sue proposte di qualità, ci presenta due trii, il primo guidato dal batterista tedesco Frederik Villmow coadiuvato da due norvegesi: il pianista Vigleik Storaas e il bassista Bjørn Marius Hegge; il secondo dal pianista Christian Jormin con Magnus Bergström basso e Adam Ross batteria.
Frederik Villmow Trio – “Motion” – Losen Records
 L’album comprende oltre a quattro original, tre standard, scelti ognuno dai componenti del trio: “A Lovely Way to Spend an Evening” di Jimmy McHugh, “Blame It On My Youth” di Oscar Levant e “Like Someone In Love” di Jimmy Van Heusen. Un repertorio, quindi, abbastanza variegato ma capace di farci apprezzare da un lato anche le capacità compositive del leader, dall’altro le possibilità esecutive del combo che si muove perfettamente a proprio agio anche sui terreni così battuti come quelli rappresentati dai citati standard. In effetti i tre possono contare su una ottima intesa cementata da precedenti esperienze e il tutto viene declinato attraverso un giusto equilibrio tra parti improvvisate e parti scritte. Insomma siamo sul terreno del classico jazz-trio che, ad onta di qualsivoglia sperimentazione, rimane sempre un organico di tutto rispetto…sempre che, ovviamente, sia composto da musicisti di livello come questi che si ascoltano nel CD in oggetto. In particolare Willmow pur essendo nato a Colonia ha studiato e sviluppato la sua attività in Norvegia dove ha avuto modo di collaborare con alcuni prestigiosi jazzisti del Nord Europa e non solo tra cui Vigleik Storaas (NO), Bjørn Alterhaug (NO), Tore Brunborg (NO), Bendik Hofseth (NO), Alan Skidmore (UK), Cappella Amsterdam (NL), Mats Holmquist Big Band (SWE), Metropole Orkest Academy diretta da Vince Mendoza (NL). Ma è proprio all’interno del trio presente in “Motion” che sembra aver trovato la giusta collocazione. Comunque lo si attende a prove ancora più impegnative.
L’album comprende oltre a quattro original, tre standard, scelti ognuno dai componenti del trio: “A Lovely Way to Spend an Evening” di Jimmy McHugh, “Blame It On My Youth” di Oscar Levant e “Like Someone In Love” di Jimmy Van Heusen. Un repertorio, quindi, abbastanza variegato ma capace di farci apprezzare da un lato anche le capacità compositive del leader, dall’altro le possibilità esecutive del combo che si muove perfettamente a proprio agio anche sui terreni così battuti come quelli rappresentati dai citati standard. In effetti i tre possono contare su una ottima intesa cementata da precedenti esperienze e il tutto viene declinato attraverso un giusto equilibrio tra parti improvvisate e parti scritte. Insomma siamo sul terreno del classico jazz-trio che, ad onta di qualsivoglia sperimentazione, rimane sempre un organico di tutto rispetto…sempre che, ovviamente, sia composto da musicisti di livello come questi che si ascoltano nel CD in oggetto. In particolare Willmow pur essendo nato a Colonia ha studiato e sviluppato la sua attività in Norvegia dove ha avuto modo di collaborare con alcuni prestigiosi jazzisti del Nord Europa e non solo tra cui Vigleik Storaas (NO), Bjørn Alterhaug (NO), Tore Brunborg (NO), Bendik Hofseth (NO), Alan Skidmore (UK), Cappella Amsterdam (NL), Mats Holmquist Big Band (SWE), Metropole Orkest Academy diretta da Vince Mendoza (NL). Ma è proprio all’interno del trio presente in “Motion” che sembra aver trovato la giusta collocazione. Comunque lo si attende a prove ancora più impegnative.
Christian Jormin Trio – “See The Unseen” – Losen Records
 “See The Unseen” vede all’opera lo svedese Christian Jormin al piano con i già citati Magnus Bergström e Adam Ross. Si tratta del debutto di Jormin da leader in casa Losen e l’esordio è più che positivo. Registrato il 22 e 23 luglio 2020, quindi in pieno lockdown, presso la Concert Hall Sjostromsalen at Artisten in Gothenburg, l’album presenta dieci composizioni firmate dal leader e scritte appositamente per il trio. In realtà il nocciolo duro del combo era costituito da Jormin e Bergstrom che, incontratisi con Adam Ross, hanno pensato bene di allargare il duo costituendo il trio che stiamo ascoltando. L’album prende spunto dal fatto di voler reagire, in qualche modo, all’isolamento che ci era stato imposto. Così, attraverso, la musica le distanze sono abolite e l’interazione è assicurata. In effetti, anche in questo caso, una delle maggiori qualità del trio è proprio l’intesa che si avverte: i tre si muovono in modo spontaneo ma perfettamente consapevole che i compagni d’avventura non solo seguiranno lungo il percorso scelto ma saranno in grado di proseguire il discorso in maniera coerente e consapevole. Le dieci tracce sono tutte innervate da armonie ben congegnate e da un certo minimalismo all’interno di strutture molto ben disegnate, strutture che consentono a tutti e tre i musicisti di esporre compiutamente il proprio potenziale. Tutti godibili i brani con una preferenza per “Mola Mola”.
“See The Unseen” vede all’opera lo svedese Christian Jormin al piano con i già citati Magnus Bergström e Adam Ross. Si tratta del debutto di Jormin da leader in casa Losen e l’esordio è più che positivo. Registrato il 22 e 23 luglio 2020, quindi in pieno lockdown, presso la Concert Hall Sjostromsalen at Artisten in Gothenburg, l’album presenta dieci composizioni firmate dal leader e scritte appositamente per il trio. In realtà il nocciolo duro del combo era costituito da Jormin e Bergstrom che, incontratisi con Adam Ross, hanno pensato bene di allargare il duo costituendo il trio che stiamo ascoltando. L’album prende spunto dal fatto di voler reagire, in qualche modo, all’isolamento che ci era stato imposto. Così, attraverso, la musica le distanze sono abolite e l’interazione è assicurata. In effetti, anche in questo caso, una delle maggiori qualità del trio è proprio l’intesa che si avverte: i tre si muovono in modo spontaneo ma perfettamente consapevole che i compagni d’avventura non solo seguiranno lungo il percorso scelto ma saranno in grado di proseguire il discorso in maniera coerente e consapevole. Le dieci tracce sono tutte innervate da armonie ben congegnate e da un certo minimalismo all’interno di strutture molto ben disegnate, strutture che consentono a tutti e tre i musicisti di esporre compiutamente il proprio potenziale. Tutti godibili i brani con una preferenza per “Mola Mola”.
*****
B.I.T. – Danielle Di Majo e Manuela Pasqui – “Come Again” – Filibusta
 E’ un duo al femminile quello che ci propone la Filibusta Records in questo album: protagoniste Danielle Di Maio ai sassofoni e Manuela Pasqui al pianoforte. La sassofonista avevamo già avuto modo di apprezzarla, tra l’altro, negli album di Ajugada Quartet e della vocalist Antonella Vitale mentre la Pasqui ha già firmato un album come leader (“Il filo dell’aquilone”) oltre ad aver collaborato con numerosi jazzisti di vaglia. Questo per dire che le due artiste sono ben note nell’ambiente del jazz, godendo di una meritata stima. Stima che viene confermata dall’album in oggetto che si articola su nove brani declinati sia sul versante prettamente jazzistico grazie a due original firmati rispettivamente dalla sassofonista (“Cagnaccio”) e dalla pianista (“Della mancanza e dell’amore”) sia, soprattutto, sulla rielaborazione di brani tratti dal repertorio “colto”, arrangiati dalla Pasqui che da sempre si caratterizza per questa sua capacità di attingere dal repertorio classico per rivitalizzarlo con il linguaggio dell’improvvisazione. Ecco quindi in scaletta Thibaut, John Dowland, Claudio Monteverdi, Franz Schubert, Johann Pachelbel. A mio avviso il pregio maggiore dell’album consiste nel fatto che, ascoltando i brani (tutti eseguiti magistralmente), non si avverte nessuno iato tra pezzi che traggono ispirazione da due mondi così diversi, eppure così vicini nella considerazione dell’Amore quale elemento, forse l’unico, che può aiutarci a vivere.
E’ un duo al femminile quello che ci propone la Filibusta Records in questo album: protagoniste Danielle Di Maio ai sassofoni e Manuela Pasqui al pianoforte. La sassofonista avevamo già avuto modo di apprezzarla, tra l’altro, negli album di Ajugada Quartet e della vocalist Antonella Vitale mentre la Pasqui ha già firmato un album come leader (“Il filo dell’aquilone”) oltre ad aver collaborato con numerosi jazzisti di vaglia. Questo per dire che le due artiste sono ben note nell’ambiente del jazz, godendo di una meritata stima. Stima che viene confermata dall’album in oggetto che si articola su nove brani declinati sia sul versante prettamente jazzistico grazie a due original firmati rispettivamente dalla sassofonista (“Cagnaccio”) e dalla pianista (“Della mancanza e dell’amore”) sia, soprattutto, sulla rielaborazione di brani tratti dal repertorio “colto”, arrangiati dalla Pasqui che da sempre si caratterizza per questa sua capacità di attingere dal repertorio classico per rivitalizzarlo con il linguaggio dell’improvvisazione. Ecco quindi in scaletta Thibaut, John Dowland, Claudio Monteverdi, Franz Schubert, Johann Pachelbel. A mio avviso il pregio maggiore dell’album consiste nel fatto che, ascoltando i brani (tutti eseguiti magistralmente), non si avverte nessuno iato tra pezzi che traggono ispirazione da due mondi così diversi, eppure così vicini nella considerazione dell’Amore quale elemento, forse l’unico, che può aiutarci a vivere.
Enzo Favata – “The Crossing “ – Niafunken
 Conosco Enzo favata da molti anni e credo di poter dire che questo è uno dei migliori album da lui realizzato nel corso di una oramai lunga e prestigiosa carriera. Il musicista sardo, in questa occasione al sax, theremin, samples è coadiuvato da Pasquale Mirra al vibrafono, marimba midi e Fender Rhodes, Rosa Brunello al Fender Bass, Marco Frattini, batteria e percussioni, cui si aggiungono in qualità di ospiti Ilaria Pilar Patassini voce, Salvatore Maiore cello, Maria Vicentini violino e viola e il chitarrista Marcello Peghin, già accanto a Favata in numerose avventure. Una tantum il titolo dell’album così come dei vari brani non è occasionale ma deriva compiutamente dalla musica proposta. Così, ad esempio, “The Crossing” (“Attraversamento, incrocio”) sta a significare proprio l’intenzione di Favata di proporre una musica che testimoni l’incrocio di più culture. Non a caso il brano d’apertura, “Roots”, di Jan Carr dei Nucleus, segnala una profonda attenzione verso il jazz-rock così come “Salt Way” dello stesso Favata ci riporta alla mente quella via del sale che attraversava il deserto della Dancalia grazie ad una musica orientaleggiante, ricca di umori, sapori così sapientemente speziati mentre particolarmente toccante è “Black Lives Matter”. Il brano, composto a più mani da Favata, Brunello, Mirra e Frattini vuole esprimere lo sdegno presente ancora in tutti noi per un episodio inaccettabile, con il sax di Favata a enfatizzare il clima del pezzo, su un tappeto sonoro che sembra richiamare i grandi paladini, musicisti e non, dell’eguaglianza dei neri negli States…e non solo; particolarmente adatto il campionamento delle voci di Steve Biko, Fela Kuti e Malcom X.
Conosco Enzo favata da molti anni e credo di poter dire che questo è uno dei migliori album da lui realizzato nel corso di una oramai lunga e prestigiosa carriera. Il musicista sardo, in questa occasione al sax, theremin, samples è coadiuvato da Pasquale Mirra al vibrafono, marimba midi e Fender Rhodes, Rosa Brunello al Fender Bass, Marco Frattini, batteria e percussioni, cui si aggiungono in qualità di ospiti Ilaria Pilar Patassini voce, Salvatore Maiore cello, Maria Vicentini violino e viola e il chitarrista Marcello Peghin, già accanto a Favata in numerose avventure. Una tantum il titolo dell’album così come dei vari brani non è occasionale ma deriva compiutamente dalla musica proposta. Così, ad esempio, “The Crossing” (“Attraversamento, incrocio”) sta a significare proprio l’intenzione di Favata di proporre una musica che testimoni l’incrocio di più culture. Non a caso il brano d’apertura, “Roots”, di Jan Carr dei Nucleus, segnala una profonda attenzione verso il jazz-rock così come “Salt Way” dello stesso Favata ci riporta alla mente quella via del sale che attraversava il deserto della Dancalia grazie ad una musica orientaleggiante, ricca di umori, sapori così sapientemente speziati mentre particolarmente toccante è “Black Lives Matter”. Il brano, composto a più mani da Favata, Brunello, Mirra e Frattini vuole esprimere lo sdegno presente ancora in tutti noi per un episodio inaccettabile, con il sax di Favata a enfatizzare il clima del pezzo, su un tappeto sonoro che sembra richiamare i grandi paladini, musicisti e non, dell’eguaglianza dei neri negli States…e non solo; particolarmente adatto il campionamento delle voci di Steve Biko, Fela Kuti e Malcom X.
Karima – “No Filter” – Parco della Musica
 E’ da molto tempo che seguo Karima la cui carriera, a mio avviso, non è stata finora adeguata alle sue effettive possibilità. Ma andiamo indietro nel tempo. Karima è stata, a mio sommesso avviso, l’unico vero talento che sia emerso dalla trasmissione “Amici”. Quell’anno, però, non vinse e la cosa mi fece talmente arrabbiare che smisi di vedere il programma. Adesso di anni ne sono passati, ma Karima stenta ad emergere nonostante il suo talento sia stato riconosciuto da personaggi di assoluto livello come Burt Bacharach, che ha scritto per lei dei brani e prodotto, nel 2010, il suo primo album dal titolo “Karima”. Questo nuovo album, che arriva dopo sei anni dall’ultima fatica discografica, rende giustizia, anche se non del tutto, delle due qualità: bellissima voce, ottime dosi interpretative, capacità di affrontare con sapienza un repertorio certo non facile. In effetti la vocalist presenta in rapida successione tutta una serie di successi della musica internazionale, per la precisione ben undici, tra cui i celebri “Walk on the Wild Side” di Lou Reed prima traccia del disco e anche primo singolo accompagnato dal videoclip che narra la recording session dell’album pubblicato come anticipazione sulla pagina Facebook di Karima, “Feel Like Making Love” di George Benson e Roberta Flack, “Come Together” e “Blackbyrd” dei Beatles. Ad accompagnare Karima, Gabriele Evangelista al basso, Piero Frassi al pianoforte e arrangiamenti, e la Piemme Orchestra diretta da Marcello Sirignano.
E’ da molto tempo che seguo Karima la cui carriera, a mio avviso, non è stata finora adeguata alle sue effettive possibilità. Ma andiamo indietro nel tempo. Karima è stata, a mio sommesso avviso, l’unico vero talento che sia emerso dalla trasmissione “Amici”. Quell’anno, però, non vinse e la cosa mi fece talmente arrabbiare che smisi di vedere il programma. Adesso di anni ne sono passati, ma Karima stenta ad emergere nonostante il suo talento sia stato riconosciuto da personaggi di assoluto livello come Burt Bacharach, che ha scritto per lei dei brani e prodotto, nel 2010, il suo primo album dal titolo “Karima”. Questo nuovo album, che arriva dopo sei anni dall’ultima fatica discografica, rende giustizia, anche se non del tutto, delle due qualità: bellissima voce, ottime dosi interpretative, capacità di affrontare con sapienza un repertorio certo non facile. In effetti la vocalist presenta in rapida successione tutta una serie di successi della musica internazionale, per la precisione ben undici, tra cui i celebri “Walk on the Wild Side” di Lou Reed prima traccia del disco e anche primo singolo accompagnato dal videoclip che narra la recording session dell’album pubblicato come anticipazione sulla pagina Facebook di Karima, “Feel Like Making Love” di George Benson e Roberta Flack, “Come Together” e “Blackbyrd” dei Beatles. Ad accompagnare Karima, Gabriele Evangelista al basso, Piero Frassi al pianoforte e arrangiamenti, e la Piemme Orchestra diretta da Marcello Sirignano.
Roberto Magris – “Suite!” – 2 CD JMOOD
Roberto Magris, Eric Hochberg – “Shuffling Ivories“ JMOOD
 Roberto Magris è uno dei non moltissimi jazzisti italiani che abbia oramai acquisito una statura effettivamente internazionale come dimostrano i due album in oggetto.
Roberto Magris è uno dei non moltissimi jazzisti italiani che abbia oramai acquisito una statura effettivamente internazionale come dimostrano i due album in oggetto.
Il primo – “Suite”- è il diciassettesimo album in studio registrato negli Stati Uniti da Roberto Magris per la casa discografica JMood di Kansas City. È il primo disco inciso da Magris a Chicago, assieme a musicisti della scena jazz Chicagoana, per la cronaca Eric Jacobson tromba, Mark Colby tenor sax, Eric Hochberg basso, Greg Artry batteria, Pj Aubree Collins voce, con l’aggiunta di Spoken word in alcuni brani, e con alcuni pezzi incisi in piano solo, provenienti da una successiva session discografica tenutasi a Miami. Il programma è prevalentemente basato su brani e testi originali, con alcune rivisitazioni di standard del jazz e due brani pop degli anni ‘70 come “In the Wake of Poseidon” dei King Crimson e “One with the Sun” dei Santana con la ripresa di “Imagine” di John Lennon. Da evidenziare come sotto molti aspetti si tratti di un coincept album dal momento che nei pezzi scritti dallo stesso Magris è molto presente il richiamo alla pace, alla fratellanza. In altre parole con questa splendida realizzazione il pianista triestino vuole veicolare un messaggio di speranza e lo fa con i mezzi a sua disposizione. Di qui un linguaggio che è una sorta di summa delle più significative correnti che hanno attraversato il jazz degli ultimi decenni mentre nei brani per piano solo ritroviamo il Magris sensibile, introspettivo che abbiamo imparato a conoscere in questi anni.
 Pubblicato nel 2021 sempre per la JMood di Chicago, il secondo album – “Shuffling Ivories“- presenta il pianista triestino in duo con il contrabbassista Eric Hochberg in un programma dedicato interamente da un canto al piano jazz, da Eubie Blacke ad Andrew Hill, dall’altro alle più profonde radici del jazz statunitense da cui provengono echi di blues e ragtime, di gospel, di free. Il tutto intervallato da original dello stesso Magris. Quasi inutile dirlo, ma il pianista ancora una volta fa centro, grazie ad una sorta di ispirazione che pervade ogni sua esibizione. Il suo pianismo, anche in questo caso scevro da qualsivoglia tentativo di stupire l’ascoltatore, si sofferma sulla necessità espressiva di creare un fitto dialogo con il suo partner, dialogo che venga recepito appieno dall’ascoltatore. E così accade anche perché il contrabbassista dimostra di condividere appieno gli intendimenti del compagno di strada. Di qui un dialogo che si sviluppa fitto, impegnativo, mai banale con i due impegnati ad ascoltarsi e rispondersi sull’onda di un’intesa che non conosce tentennamenti. Ad avvalorare quanto sin qui detto, citiamo alcuni dei titoli contenuti nell’album: “Memories of You” di Blake, “Laverne” di Hill”, “I’ve Found A New Baby” di Palmer e Williams, “The Time Of This World Is At Hand” scritto dal pianista e compositore Billy Gault, “Quiet Dawn” di Cal Massey vero e proprio cavallo di battaglia di Archie Shepp che lo incluse nel celebre album “Attica Blues” del ’72.
Pubblicato nel 2021 sempre per la JMood di Chicago, il secondo album – “Shuffling Ivories“- presenta il pianista triestino in duo con il contrabbassista Eric Hochberg in un programma dedicato interamente da un canto al piano jazz, da Eubie Blacke ad Andrew Hill, dall’altro alle più profonde radici del jazz statunitense da cui provengono echi di blues e ragtime, di gospel, di free. Il tutto intervallato da original dello stesso Magris. Quasi inutile dirlo, ma il pianista ancora una volta fa centro, grazie ad una sorta di ispirazione che pervade ogni sua esibizione. Il suo pianismo, anche in questo caso scevro da qualsivoglia tentativo di stupire l’ascoltatore, si sofferma sulla necessità espressiva di creare un fitto dialogo con il suo partner, dialogo che venga recepito appieno dall’ascoltatore. E così accade anche perché il contrabbassista dimostra di condividere appieno gli intendimenti del compagno di strada. Di qui un dialogo che si sviluppa fitto, impegnativo, mai banale con i due impegnati ad ascoltarsi e rispondersi sull’onda di un’intesa che non conosce tentennamenti. Ad avvalorare quanto sin qui detto, citiamo alcuni dei titoli contenuti nell’album: “Memories of You” di Blake, “Laverne” di Hill”, “I’ve Found A New Baby” di Palmer e Williams, “The Time Of This World Is At Hand” scritto dal pianista e compositore Billy Gault, “Quiet Dawn” di Cal Massey vero e proprio cavallo di battaglia di Archie Shepp che lo incluse nel celebre album “Attica Blues” del ’72.
Sade Farina Mangiaracina – “Madiba” – Tuk Music
 La pianista siciliana (in un brano anche al Fender Rhodes) si ripresenta in trio con il bassista Marco Bardosica e il batterista Gianluca Brugnano cui si aggiunge Zid Trablesi al loud in tre pezzi. E già quindi da questo organico si può comprendere quali siano le intenzioni di Sade, intenzioni rese ancora più esplicite dal titolo dell’album. In buona sostanza l’artista intende dedicare questa musica ad un eroe dei nostri tempi, Nelson Mandela, del quale narrare la storia. Impresa ovviamente al limite del possibile data l’annosa polemica sulla semanticità o meno della musica. Comunque, a parte queste considerazioni, non c’è dubbio che questo album riesce a far riflettere chi lo ascolta, dipingendo un contesto in cui la storia di Mandela può trovare giusta collocazione. La Mangiaracina sfoggia ancora una volta un pianismo oramai maturo che esprime compiutamente le sue idee. Così, ad esempio, in “Winnie”, dedicato alla moglie del leader sudafricano, il ritmo si fa incandescente come a voler sottolineare le difficoltà incontrate dalla donna nello stare accanto a Nelson. Ma questo è solo un episodio ché in tutti i brani si ritrova qualcosa di interessante non disgiunta dal tema centrale. Ecco quindi, per fare un altro esempio, la ripresa del brano “Letter From A Prison”, una splendida ballad con Bardoscia in grande spolvero. Ma, citato Bardoscia, non si possono dimenticare gli altri componenti il gruppo, tutti perfettamente all’altezza di un compito certo non facile.
La pianista siciliana (in un brano anche al Fender Rhodes) si ripresenta in trio con il bassista Marco Bardosica e il batterista Gianluca Brugnano cui si aggiunge Zid Trablesi al loud in tre pezzi. E già quindi da questo organico si può comprendere quali siano le intenzioni di Sade, intenzioni rese ancora più esplicite dal titolo dell’album. In buona sostanza l’artista intende dedicare questa musica ad un eroe dei nostri tempi, Nelson Mandela, del quale narrare la storia. Impresa ovviamente al limite del possibile data l’annosa polemica sulla semanticità o meno della musica. Comunque, a parte queste considerazioni, non c’è dubbio che questo album riesce a far riflettere chi lo ascolta, dipingendo un contesto in cui la storia di Mandela può trovare giusta collocazione. La Mangiaracina sfoggia ancora una volta un pianismo oramai maturo che esprime compiutamente le sue idee. Così, ad esempio, in “Winnie”, dedicato alla moglie del leader sudafricano, il ritmo si fa incandescente come a voler sottolineare le difficoltà incontrate dalla donna nello stare accanto a Nelson. Ma questo è solo un episodio ché in tutti i brani si ritrova qualcosa di interessante non disgiunta dal tema centrale. Ecco quindi, per fare un altro esempio, la ripresa del brano “Letter From A Prison”, una splendida ballad con Bardoscia in grande spolvero. Ma, citato Bardoscia, non si possono dimenticare gli altri componenti il gruppo, tutti perfettamente all’altezza di un compito certo non facile.
Germano Mazzocchetti Ensemble – “Muggianne” – Alfa Music
 Germano Mazzocchetti è uno di quei pochi musicisti che mai delude; questo grazie anche al fatto che entra in sala di incisione solo quando ritiene di avere qualcosa di importante e di nuovo da dire. E quest’ultimo suo CD non fa eccezione alla regola. “Muggianne” è un album che si ascolta con interesse dalla prima all’ultima nota, soffuso com’è, specie nei primi brani, da un sottile velo di malinconia. Il tutto eseguito magistralmente da un gruppo coeso dalla lunga militanza e che comprende Francesco Marini al sassofono e ai clarinetti, Paola Emanuele alla viola, Marco Acquarelli alla chitarra, Luca Pirozzi al contrabbasso e Valerio Vantaggio alla batteria. E già la struttura dell’organico e i nomi dei musicisti dicono molto circa la statura artistica di Mazzocchetti: il fisarmonicista e compositore abruzzese, nel suo personalissimo bagaglio culturale, può vantare una passione per il jazz, una conoscenza approfondita della musica colta nelle sue varie declinazioni, nonché una approfondita conoscenza del musical e una ricca frequentazione del teatro di prosa: non a caso Germano è anche uno dei più apprezzati autori di musiche di scena. Questa miscela la si ritrova compiutamente nella sua musica che quindi risulta difficilissima da classificare, ammesso poi che la cosa sia importante! Quel che viceversa risulta importante è la qualità di ciò che propone, sempre originale, mai banale e soprattutto sempre coinvolgente. Un’ultima notazione: molti si saranno chiesti che significa ‘Muggianne’; la risposta ce la fornisce lo stesso Mazzocchetti: ”Il titolo Muggianne è una parola che nel dialetto del mio paese significa ‘Sta zitto e non parlare più’” come a dire, forse (ma questa è una nostra personalissima interpretazione) che la musica non ha bisogno di essere spiegata per entrare nei nostri cuori.
Germano Mazzocchetti è uno di quei pochi musicisti che mai delude; questo grazie anche al fatto che entra in sala di incisione solo quando ritiene di avere qualcosa di importante e di nuovo da dire. E quest’ultimo suo CD non fa eccezione alla regola. “Muggianne” è un album che si ascolta con interesse dalla prima all’ultima nota, soffuso com’è, specie nei primi brani, da un sottile velo di malinconia. Il tutto eseguito magistralmente da un gruppo coeso dalla lunga militanza e che comprende Francesco Marini al sassofono e ai clarinetti, Paola Emanuele alla viola, Marco Acquarelli alla chitarra, Luca Pirozzi al contrabbasso e Valerio Vantaggio alla batteria. E già la struttura dell’organico e i nomi dei musicisti dicono molto circa la statura artistica di Mazzocchetti: il fisarmonicista e compositore abruzzese, nel suo personalissimo bagaglio culturale, può vantare una passione per il jazz, una conoscenza approfondita della musica colta nelle sue varie declinazioni, nonché una approfondita conoscenza del musical e una ricca frequentazione del teatro di prosa: non a caso Germano è anche uno dei più apprezzati autori di musiche di scena. Questa miscela la si ritrova compiutamente nella sua musica che quindi risulta difficilissima da classificare, ammesso poi che la cosa sia importante! Quel che viceversa risulta importante è la qualità di ciò che propone, sempre originale, mai banale e soprattutto sempre coinvolgente. Un’ultima notazione: molti si saranno chiesti che significa ‘Muggianne’; la risposta ce la fornisce lo stesso Mazzocchetti: ”Il titolo Muggianne è una parola che nel dialetto del mio paese significa ‘Sta zitto e non parlare più’” come a dire, forse (ma questa è una nostra personalissima interpretazione) che la musica non ha bisogno di essere spiegata per entrare nei nostri cuori.
Enrico Rava – “Edizione Speciale” – ECM
 Siamo nell’estate del 2019 e si festeggiano due compleanni importanti: i 50 anni della ECM e gli 80 di Enrico Rava. Il gruppo del trombettista e flicornista si esibisce ad Antwerp, Belgio, con l’abituale organico completato da Francesco Diodati alla chitarra elettrica, Gabriele Evangelista al contrabbasso ed Enrico Morello alla batteria, cui si aggiungono due ospiti “eccellenti” quali Francesco Bearzatti al sax tenore e Giovanni Guidi al pianoforte. Il concerto viene registrato ed eccolo qui a disposizione di tutti noi. Rava è universalmente riconosciuto come uno dei musicisti più creativi ed originali che il jazz europeo abbia conosciuto, grazie ad una versatilità che nel corso di una carriera oramai molto lunga gli ha permesso sia di restare fedele alla tradizione, sia di elaborare un linguaggio melodico consono alla tradizione italica, il tutto senza trascurare le innovazioni dettate dal free di Ornette Coleman e le suggestioni ritmiche della musica sud americana nelle sue varie declinazioni. A ciò si aggiunga il fatto che Rava ha lanciato diversi giovani musicisti come quelli che compongono il suo attuale quartetto. Per questa “Edizione speciale” Rava ha voluto ripercorrere il suo repertorio proponendo pezzi che vanno dal 1978 al 2015, anno di pubblicazione di “Wild Dance”, più nuove versioni di “ Once Upon A Summertime” , un classico di Michel Legrand e di “Quizás, Quizás, Quizás”, celebre brano di musica cubana. Come suo solito Rava si ritaglia spazi solistici ma lascia ampia libertà d’azione ai compagni di viaggio e così in particolare Diodati, Guidi e Bearzatti hanno modo di evidenziare ancora una volta quel talento che tutti riconosciamo loro. Insomma un disco davvero da “Edizione speciale”.
Siamo nell’estate del 2019 e si festeggiano due compleanni importanti: i 50 anni della ECM e gli 80 di Enrico Rava. Il gruppo del trombettista e flicornista si esibisce ad Antwerp, Belgio, con l’abituale organico completato da Francesco Diodati alla chitarra elettrica, Gabriele Evangelista al contrabbasso ed Enrico Morello alla batteria, cui si aggiungono due ospiti “eccellenti” quali Francesco Bearzatti al sax tenore e Giovanni Guidi al pianoforte. Il concerto viene registrato ed eccolo qui a disposizione di tutti noi. Rava è universalmente riconosciuto come uno dei musicisti più creativi ed originali che il jazz europeo abbia conosciuto, grazie ad una versatilità che nel corso di una carriera oramai molto lunga gli ha permesso sia di restare fedele alla tradizione, sia di elaborare un linguaggio melodico consono alla tradizione italica, il tutto senza trascurare le innovazioni dettate dal free di Ornette Coleman e le suggestioni ritmiche della musica sud americana nelle sue varie declinazioni. A ciò si aggiunga il fatto che Rava ha lanciato diversi giovani musicisti come quelli che compongono il suo attuale quartetto. Per questa “Edizione speciale” Rava ha voluto ripercorrere il suo repertorio proponendo pezzi che vanno dal 1978 al 2015, anno di pubblicazione di “Wild Dance”, più nuove versioni di “ Once Upon A Summertime” , un classico di Michel Legrand e di “Quizás, Quizás, Quizás”, celebre brano di musica cubana. Come suo solito Rava si ritaglia spazi solistici ma lascia ampia libertà d’azione ai compagni di viaggio e così in particolare Diodati, Guidi e Bearzatti hanno modo di evidenziare ancora una volta quel talento che tutti riconosciamo loro. Insomma un disco davvero da “Edizione speciale”.
Santi Scarcella – “Da Manhattan a Cefalù” –
 Il più jazzista dei cantautori italiani. Così è stato definito Santi Scarcella, definizione da condividere in toto dopo aver ascoltato l’album “Da Manhattan a Cefalù”, dedicato alla memoria di Nick La Rocca, un emigrante siciliano a cui, per convenzione, si deve la registrazione del primo disco di jazz nel 1917. Partendo da un repertorio di quattordici brani di cui ben dodici scritti dallo stesso Scarcella da solo o in compagnia di Viscuso o Mesolella, con l’aggiunta del traditional “Vitti na crozza” di Li Causi e lo standard di chiusura “Some Day My Prince Will Come”, Scarcella sfodera uno stile tanto arguto quanto personale. Mescolando il dialetto siciliano con l’italiano ma anche con lo spagnolo e l’inglese, nonché differenti stili come il samba, il mambo, passando attraverso il rag time, lo ska, Santi prepara una ricetta assolutamente fruibile…anche se farà storcere la bocca ai puristi del jazz. Tuttavia a beneficio di questi ultimi forse non è inutile sottolineare in primo luogo che il progetto di Scarcella, partito dai canti di lavoro siciliani, è riuscito a trovare elementi in comune con il blues americano e, proprio per questo, è stato approvato dalla statunitense Uconn University e in secondo luogo che sotto la veste dell’allegria, l’album tratta temi molto ma molto seri come l’emigrazione, l’integrazione, il glocalismo, patologie gravi come l’Asperger.
Il più jazzista dei cantautori italiani. Così è stato definito Santi Scarcella, definizione da condividere in toto dopo aver ascoltato l’album “Da Manhattan a Cefalù”, dedicato alla memoria di Nick La Rocca, un emigrante siciliano a cui, per convenzione, si deve la registrazione del primo disco di jazz nel 1917. Partendo da un repertorio di quattordici brani di cui ben dodici scritti dallo stesso Scarcella da solo o in compagnia di Viscuso o Mesolella, con l’aggiunta del traditional “Vitti na crozza” di Li Causi e lo standard di chiusura “Some Day My Prince Will Come”, Scarcella sfodera uno stile tanto arguto quanto personale. Mescolando il dialetto siciliano con l’italiano ma anche con lo spagnolo e l’inglese, nonché differenti stili come il samba, il mambo, passando attraverso il rag time, lo ska, Santi prepara una ricetta assolutamente fruibile…anche se farà storcere la bocca ai puristi del jazz. Tuttavia a beneficio di questi ultimi forse non è inutile sottolineare in primo luogo che il progetto di Scarcella, partito dai canti di lavoro siciliani, è riuscito a trovare elementi in comune con il blues americano e, proprio per questo, è stato approvato dalla statunitense Uconn University e in secondo luogo che sotto la veste dell’allegria, l’album tratta temi molto ma molto seri come l’emigrazione, l’integrazione, il glocalismo, patologie gravi come l’Asperger.
Giovanni e Jasmine Tommaso – “As Time Goes By” – Parco della Musica
 Non è inusuale che membri della stessa famiglia collaborino nella realizzazione di un album ma ciò non ci impedisce di salutare con simpatia questo album che vede l’uno accanto all’altra il papà Giovanni Tommaso e la figlia Jasmine Tommaso in quintetto con Claudio Filippini al piano e Fender Rhodes, Andrea Molinari alla chitarra e Alessandro “Pacho” Rossi alla batteria. Sgombriamo subito il campo da qualsivoglia equivoco: Jasmine non è solo la figlia di un gigante del jazz quale Giovanni Tommaso, ma è una vocalist che ha tutte le carte in regola per intraprendere una brillante carriera; da anni stabilita a Los Angeles, può vantare un intenso percorso accademico speso tra la School of the Arts di South Orange e l’Università della California e gli studi in ambito jazz presso il Berklee College of Music di Boston. A ciò si aggiungono collaborazioni di rilievo con Stefano Bollani, Danilo Rea, Tia Fueller, Kim Thompson e Fabrizio Bosso. Questo album arriva al momento giusto per certificare l’avvenuta maturazione dell’artista. Jasmine interpreta bene un repertorio variegato in cui accanto a brani dal sapore prettamente jazzistico quali “Once Upon A Dream” di Sammy Fain e Jack Lawrence, “Lullaby Of Birdland” di George Shearing e la successiva “Someone To Watch Over Me” di George Gershwin, possiamo ascoltare una suggestiva versione di “Marinella” di Fabrizio De André nonché alcuni original scritti dalla stessa Jasmine con Lorenzo Grassi e dallo stesso leader.
Non è inusuale che membri della stessa famiglia collaborino nella realizzazione di un album ma ciò non ci impedisce di salutare con simpatia questo album che vede l’uno accanto all’altra il papà Giovanni Tommaso e la figlia Jasmine Tommaso in quintetto con Claudio Filippini al piano e Fender Rhodes, Andrea Molinari alla chitarra e Alessandro “Pacho” Rossi alla batteria. Sgombriamo subito il campo da qualsivoglia equivoco: Jasmine non è solo la figlia di un gigante del jazz quale Giovanni Tommaso, ma è una vocalist che ha tutte le carte in regola per intraprendere una brillante carriera; da anni stabilita a Los Angeles, può vantare un intenso percorso accademico speso tra la School of the Arts di South Orange e l’Università della California e gli studi in ambito jazz presso il Berklee College of Music di Boston. A ciò si aggiungono collaborazioni di rilievo con Stefano Bollani, Danilo Rea, Tia Fueller, Kim Thompson e Fabrizio Bosso. Questo album arriva al momento giusto per certificare l’avvenuta maturazione dell’artista. Jasmine interpreta bene un repertorio variegato in cui accanto a brani dal sapore prettamente jazzistico quali “Once Upon A Dream” di Sammy Fain e Jack Lawrence, “Lullaby Of Birdland” di George Shearing e la successiva “Someone To Watch Over Me” di George Gershwin, possiamo ascoltare una suggestiva versione di “Marinella” di Fabrizio De André nonché alcuni original scritti dalla stessa Jasmine con Lorenzo Grassi e dallo stesso leader.
 Heinz Holliger, Anton Kernjak – “Eventail” – ECM New Series
Heinz Holliger, Anton Kernjak – “Eventail” – ECM New Series Veljo Tormis – “Reminiscentiae” – ECM New Series
Veljo Tormis – “Reminiscentiae” – ECM New Series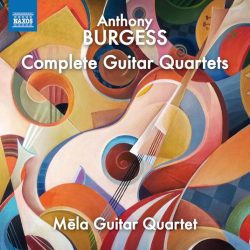 Anthony Burgess – “Complete Guitar Quartets” – Naxos
Anthony Burgess – “Complete Guitar Quartets” – Naxos Wolfgang Muthspiel – “Dance of the Elders” – ECM
Wolfgang Muthspiel – “Dance of the Elders” – ECM Maciej Obara Quartet – “Frozen Silence” – ECM
Maciej Obara Quartet – “Frozen Silence” – ECM Sinikka Langeland – “Wind And Sun” – ECM
Sinikka Langeland – “Wind And Sun” – ECM Sara Calvanelli, Virginia Sutera – “Ejadira” – Losen
Sara Calvanelli, Virginia Sutera – “Ejadira” – Losen Sudeshna Bhattacharya & Somnath Roy –“Mousson de Calcutta” – Losen
Sudeshna Bhattacharya & Somnath Roy –“Mousson de Calcutta” – Losen  Nella categoria Jazz i primi due lavori pubblicato sono stati “Multiverse” solo in versione digitale e quindi “Heros” di Filippo Cosentino. In quest’ultimo album la formazione è il trio in cui il leader, chitarrista, è accompagnato dal formidabile pianista Marc Copland, per moltissimi anni componente della formazione di John Abercrombie, e Daniele Bertone alla batteria e percussioni. In programma sette composizioni del leader in cui si evidenzia da un lato le capacità strumentali di tutti e tre i musicisti, dall’altro le ottime capacità compositive di Cosentino che di certo non scopriamo oggi. Le atmosfere predilette sono un mix di jazz, folk e country anche se qua e là riemerge l‘anima mediterranea del leader.
Nella categoria Jazz i primi due lavori pubblicato sono stati “Multiverse” solo in versione digitale e quindi “Heros” di Filippo Cosentino. In quest’ultimo album la formazione è il trio in cui il leader, chitarrista, è accompagnato dal formidabile pianista Marc Copland, per moltissimi anni componente della formazione di John Abercrombie, e Daniele Bertone alla batteria e percussioni. In programma sette composizioni del leader in cui si evidenzia da un lato le capacità strumentali di tutti e tre i musicisti, dall’altro le ottime capacità compositive di Cosentino che di certo non scopriamo oggi. Le atmosfere predilette sono un mix di jazz, folk e country anche se qua e là riemerge l‘anima mediterranea del leader. Amato Jazz Trio – “Keep Straight On” – abeat
Amato Jazz Trio – “Keep Straight On” – abeat Claudio Angeleri – “Concerto feat. Gianluigi Trovesi” – Dodicilune
Claudio Angeleri – “Concerto feat. Gianluigi Trovesi” – Dodicilune Dino Betti Van Der Noot – “Let Us Recount Our Dreams” – Audissea
Dino Betti Van Der Noot – “Let Us Recount Our Dreams” – Audissea Maria Pia De Vito – “This Woman’s Work” – PMR
Maria Pia De Vito – “This Woman’s Work” – PMR Claudio Fasoli NeXt 4et – “Ambush” – abeat–
Claudio Fasoli NeXt 4et – “Ambush” – abeat–  Nicola Mingo – “My Sixties in Jazz” – Alfa Music
Nicola Mingo – “My Sixties in Jazz” – Alfa Music Modern Art Trio – “Modern Art Trio” – Gleam Records
Modern Art Trio – “Modern Art Trio” – Gleam Records Roberto Ottaviano – “A che punto è la notte”, “Astrolabio mistico” – Dodicilune
Roberto Ottaviano – “A che punto è la notte”, “Astrolabio mistico” – Dodicilune
 Del Piano/Olivieri/Mazza/Marini, Double 3, Caligola Records
Del Piano/Olivieri/Mazza/Marini, Double 3, Caligola Records Canova Trio feat. Fulvio Sigurtà, Agata, Filibusta Records
Canova Trio feat. Fulvio Sigurtà, Agata, Filibusta Records Giovanni Benvenuti , An Hour Of Existence, AMP Music & Records
Giovanni Benvenuti , An Hour Of Existence, AMP Music & Records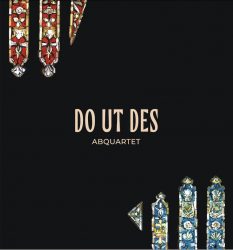 ABQuartet, Do Ut Des, Red & Blue.
ABQuartet, Do Ut Des, Red & Blue. Zhu Quartet, GINKGO, Workin’ Label.
Zhu Quartet, GINKGO, Workin’ Label. Marco Vavassori feat. Lincetto/Smiderle/Uliana, Walking with Bob, Caligola Records.
Marco Vavassori feat. Lincetto/Smiderle/Uliana, Walking with Bob, Caligola Records.
 Giulia Barba – “Sonoro” – BNC
Giulia Barba – “Sonoro” – BNC Francesco Branciamore – “Skies of Sea” – Caligola
Francesco Branciamore – “Skies of Sea” – Caligola Maniscalco, Bigoni, Solborg – “Canto” – ILK Music
Maniscalco, Bigoni, Solborg – “Canto” – ILK Music Mauro Mussoni – “Follow The Flow” –WOW
Mauro Mussoni – “Follow The Flow” –WOW Ivano Nardi – “Excursions” –
Ivano Nardi – “Excursions” – NewStrikers – “The Songs Album” – Alfa Music Vinile 180 gr. Tiratura limitata
NewStrikers – “The Songs Album” – Alfa Music Vinile 180 gr. Tiratura limitata Helga Plankensteiner – “Barionda” – JW
Helga Plankensteiner – “Barionda” – JW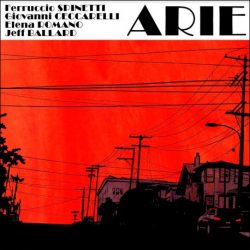 Ferruccio Spinetti – “Arie” – Via Veneto, Indo Jazz
Ferruccio Spinetti – “Arie” – Via Veneto, Indo Jazz Ivan Vicari – “Afrojazz project – Il ritorno”
Ivan Vicari – “Afrojazz project – Il ritorno” Lost Record del Live in Paris del 1975, pubblicato e restaurato dall’etichetta discografica Transversales Disques. Sébastien Rosat, co-fondatore dell’etichetta, mi ha spiegato in un breve scambio di mail che l’album è stato come ritrovare un tesoro; già dal primo ascolto si capiva quanto fosse una performance straordinaria. La Transversales Disques ha compiuto in primis un lavoro di restauro sul materiale ritrovato nel 2017 nel caveau di Radio France e a impreziosire l’esperienza c’è la minuzia per la ricerca di fotografie scattate per quella performance. Proprio quando le ricerche stavano per arrivare a un punto morto ci ha pensato la fortuna a fargli ritrovare una foto del concerto in “Jazz Hot” Magazine per mano della fotocamera di Christian Rose che ha fornito un rullino pieno di splendide istantanee dell’evento, arricchendo un’edizione discografica rara e unica; sicuramente realizzata con quel tipo di passione che solo gli amanti del jazz riescono a mettere in ciò che fanno nella vita. Questa storia ci catapulta in una prospettiva romantica nei confronti dell’album, ma diventa un antipasto ricco di proteine per affrontare il viaggio che propongo, ma soprattutto è funzionale a un piccolo gioco di prestigio: usare l’album del concerto come incipit, cercando di rovesciare la classica prospettiva della biografia al servizio della musica, seguendo piuttosto il flusso sonoro del live e quello degli eventi in ordine cronologico. Questo processo permette di trasformare quel poliedro di cui parlavo, attraverso la scomposizione e ricomposizione in una nuova forma, quella plasmata dalle note del sassofono di Sanders il 17 novembre del 1975 al Grand Auditorium nello studio 105 della Maison de la Radio.
Lost Record del Live in Paris del 1975, pubblicato e restaurato dall’etichetta discografica Transversales Disques. Sébastien Rosat, co-fondatore dell’etichetta, mi ha spiegato in un breve scambio di mail che l’album è stato come ritrovare un tesoro; già dal primo ascolto si capiva quanto fosse una performance straordinaria. La Transversales Disques ha compiuto in primis un lavoro di restauro sul materiale ritrovato nel 2017 nel caveau di Radio France e a impreziosire l’esperienza c’è la minuzia per la ricerca di fotografie scattate per quella performance. Proprio quando le ricerche stavano per arrivare a un punto morto ci ha pensato la fortuna a fargli ritrovare una foto del concerto in “Jazz Hot” Magazine per mano della fotocamera di Christian Rose che ha fornito un rullino pieno di splendide istantanee dell’evento, arricchendo un’edizione discografica rara e unica; sicuramente realizzata con quel tipo di passione che solo gli amanti del jazz riescono a mettere in ciò che fanno nella vita. Questa storia ci catapulta in una prospettiva romantica nei confronti dell’album, ma diventa un antipasto ricco di proteine per affrontare il viaggio che propongo, ma soprattutto è funzionale a un piccolo gioco di prestigio: usare l’album del concerto come incipit, cercando di rovesciare la classica prospettiva della biografia al servizio della musica, seguendo piuttosto il flusso sonoro del live e quello degli eventi in ordine cronologico. Questo processo permette di trasformare quel poliedro di cui parlavo, attraverso la scomposizione e ricomposizione in una nuova forma, quella plasmata dalle note del sassofono di Sanders il 17 novembre del 1975 al Grand Auditorium nello studio 105 della Maison de la Radio.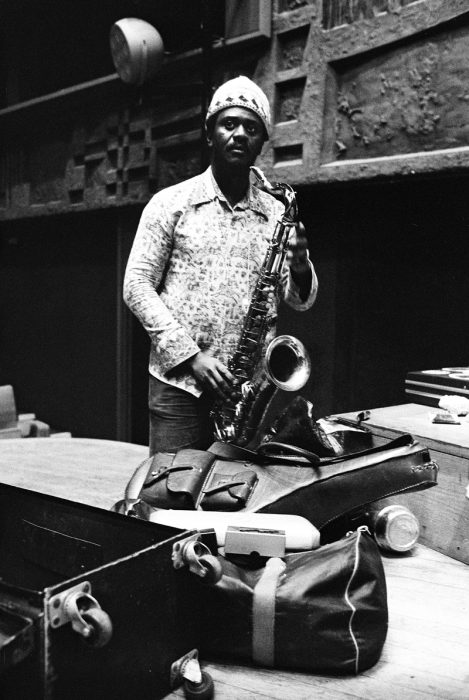 Love is Here part I/part II
Love is Here part I/part II