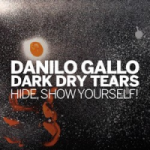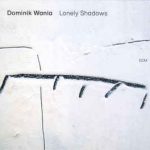da Gerlando Gatto | 30/Set/2021 | I nostri libri, Primo piano, Recensioni
Quanti seguono con un minimo di attenzione ”A Proposito di Jazz” si saranno resi conto di come questa testata abbia nel tempo dedicato la massima attenzione a tutte le forme attraverso cui si manifesta, si sviluppa la musica jazz. Quindi, ovviamente, anche la fotografia che anzi si è posta come elemento fondamentale per cogliere meglio l’evoluzione di questa musica. Si pensi, ad esempio, cosa ha significato per gli studiosi riuscire a carpire alcuni momenti dell’arte jazzistica quando ancora non esistevano o non erano così diffusi i filmati. Un solo esempio credo sia sufficiente a meglio spiegare quanto fin qui detto: nell’estate del 1958 venne scattata una delle foto più famose nel mondo del jazz, quella foto che ritrae, uno accanto all’altro, cinquantasette tra i migliori jazzisti di tutti i tempi in una strada di Harlem. Non musicisti qualsiasi, ma veri e propri “giganti” che hanno fatto la storia del jazz quali Armstrong, Duke Ellington, Count Basie, Dizzy Gillespie, Miles Davis, Sonny Rollins, Monk, Charlie Mingus, Coleman Hawkins.
Anche in Italia l’arte della foto-jazz, grazie all’opera appassionata di molti fotografi-artisti, ha raggiunto ottimi risultati di cui su questi spazi è stata fornita ampia documentazione. Tra quanti hanno contribuito in maniera determinante allo sviluppo di quest’arte nel nostro Paese c’è sicuramente Roberto Masotti che conosco bene oramai da tanti anni e i cui scatti mi hanno sempre appassionato e stupito per la carica di verità che contengono. Tracciare una biografia di Masotti in questa sede è tutto sommato inutile; basti sottolineare alcune tappe fondamentali: nel 1973 inizia una lunga e proficua collaborazione con ECM Records di cui è stato responsabile della comunicazione per l’Italia, oltre a veicolare nel mondo l’immagine della casa tedesca; dal 1979 al 1996 è il fotografo ufficiale del Teatro alla Scala di Milano con Silvia Lelli; nel 2005 viene realizzato un programma televisivo a lui dedicato per SKY/Leonardo nella serie Click… nel corso degli anni le sue fotografie sono state esposte in numerose città italiane ed europee. E proprio a questa sorta di “categoria” appartiene il primo dei due volumi che presentiamo in questa sede.
 “Jazz Area – seipersei – Pgg.160 ” trae origine dalla mostra “Jazz Area la mia storia con il jazz in 25 quadri” commissionata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pavia nel 1999, e poi esposta una decina di volte. Come sottolinea lo stesso Masotti, l’opera andrebbe considerata come “la mia storia attraverso il jazz più che con il jazz”. Insomma una sorta di viaggio autobiografico il cui tragitto viene ripercorso attraverso una serie di immagini mai banali. Il libro si apre con la formazione “Detroit Free Jazz”, con Art Fletcher, Don Moye e Ron Miller al Conservatorio di Bologna nel 1968, e si chiude con un fotomontaggio relativo a Sun Ra.
“Jazz Area – seipersei – Pgg.160 ” trae origine dalla mostra “Jazz Area la mia storia con il jazz in 25 quadri” commissionata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pavia nel 1999, e poi esposta una decina di volte. Come sottolinea lo stesso Masotti, l’opera andrebbe considerata come “la mia storia attraverso il jazz più che con il jazz”. Insomma una sorta di viaggio autobiografico il cui tragitto viene ripercorso attraverso una serie di immagini mai banali. Il libro si apre con la formazione “Detroit Free Jazz”, con Art Fletcher, Don Moye e Ron Miller al Conservatorio di Bologna nel 1968, e si chiude con un fotomontaggio relativo a Sun Ra.
 Le foto sono impaginate in modo assai particolare: una stampa a colore argento su una carta spessa e nera, associate a titoli, didascalie, brevi testi, per cui, evidenzia ancora Masotti, è “più un progetto di mostra che un risultato fissato per sempre, più una riflessione sul jazz filtrata dalla mia personale esperienza che una storia del jazz per immagini per forza di cose limitata e parziale”. Così si susseguono una serie di istantanee accomunate da un filo rosso: l’intenzione di Masotti di non presentare una galleria di ritratti ma, in qualche modo, di interpretare il soggetto che viene ripreso in un momento di verità. Quindi nessuna posa ma scatti che colgono i musicisti o sul palco o in un momento di pausa. Le foto sono organizzate per aree tematiche tra cui: blues; blowers sassofoni; canto; Miles Davis; Sam Rivers – Archie Shepp, Jazz & Polities; Steve Lacy; Drums – drummers; Gruppi; Dave Holland big-band; Brotherhood of Breath; Jazz italiano; Jazz Rock; Chitarristi; ECM, Keith Jarrett… I protagonisti di questa galleria sono quindi tantissimi e sarebbe inutile citarli tutti; valga comunque qualche nome: Miles Davis, Gato Barbieri, Steve Lacy, Max Roach, Ornette Coleman, Sonny Rollins, Archie Shepp, Carla Bley, Sam Rivers, Cecil Taylor, Charles Mingus, e, tra gli italiani, Stefano Bollani, Antonello Salis, Roberto Ottaviano, Gianluca Petrella.
Le foto sono impaginate in modo assai particolare: una stampa a colore argento su una carta spessa e nera, associate a titoli, didascalie, brevi testi, per cui, evidenzia ancora Masotti, è “più un progetto di mostra che un risultato fissato per sempre, più una riflessione sul jazz filtrata dalla mia personale esperienza che una storia del jazz per immagini per forza di cose limitata e parziale”. Così si susseguono una serie di istantanee accomunate da un filo rosso: l’intenzione di Masotti di non presentare una galleria di ritratti ma, in qualche modo, di interpretare il soggetto che viene ripreso in un momento di verità. Quindi nessuna posa ma scatti che colgono i musicisti o sul palco o in un momento di pausa. Le foto sono organizzate per aree tematiche tra cui: blues; blowers sassofoni; canto; Miles Davis; Sam Rivers – Archie Shepp, Jazz & Polities; Steve Lacy; Drums – drummers; Gruppi; Dave Holland big-band; Brotherhood of Breath; Jazz italiano; Jazz Rock; Chitarristi; ECM, Keith Jarrett… I protagonisti di questa galleria sono quindi tantissimi e sarebbe inutile citarli tutti; valga comunque qualche nome: Miles Davis, Gato Barbieri, Steve Lacy, Max Roach, Ornette Coleman, Sonny Rollins, Archie Shepp, Carla Bley, Sam Rivers, Cecil Taylor, Charles Mingus, e, tra gli italiani, Stefano Bollani, Antonello Salis, Roberto Ottaviano, Gianluca Petrella.
Insomma un volume che sicuramente interesserà tutti gli appassionati di jazz.
 “Keith Jarrett a portrait – seipersei – Pgg. 112” è invece di impostazione completamente diversa. Si tratta di un vero e proprio omaggio, o se volete un atto d’amore, che il fotografo dedica ad uno dei più grandi pianisti del jazz. Le foto sono accompagnate da testi di Geoff Dyer, Franco Fabbri e dello stesso Masotti il quale afferma esplicitamente che “In questa lunga serie di fotografie che osservo retrospettivamente, si gioca decisamente sulla presenza, quella del corpo e dello strumento, che compaiono nell’immagine. Le foto sono il risultato di una intima e oggettiva attenzione nei confronti di un artista a lungo seguito e ammirato, ma anche di una sua risposta che è consapevole accettazione, e soprattutto, partecipazione. Suo, solo suo, è il suono di una musica inconfondibile che la serie di fotografie ambisce di evocare e far risuonare.” In effetti Masotti ha assistito ad un centinaio di suoi concerti avendo così moltissime occasioni per estrinsecare la sua arte. Il libro si apre con una foto molti importante nella vita di Roberto: siamo nel 1969 e Keith Jarrett si esibisce al Teatro Comunale di Bologna nell’ambito del locale jazz Festival. Masotti non è ancora un professionista; fotografa con la Rolleiflex del padre, ma il risultato è talmente soddisfacente da indurlo a proseguire lungo la via delle foto. Dopo questa prima foto, gli scatti, esclusivamente in bianco e nero, sono organizzati in ordine cronologico fino al 2009… ed è davvero straniante constatare come l’aspetto del pianista sia cambiato con lo scorrere del tempo e come Masotti sia riuscito a cogliere gli aspetti più intimi della personalità dell’artista…anche perché è stato per lungo tempo l’unico fotografo ammesso alle prove di Jarrett. Ecco quindi il pianista impegnato durante un concerto… o in un momento di riposo accomodato in poltrona… o ancora seduto dietro una batteria o intento a suonare il sax soprano. E ammirando queste foto si ha quasi l’impressione di sentire le dita di Jarrett scorrere sulla tastiera per quelle straordinarie improvvisazioni che ci hanno deliziato fino al 2018 anno che ha segnato il definitivo abbandono delle scene da parte del pianista colpito da due ictus.
“Keith Jarrett a portrait – seipersei – Pgg. 112” è invece di impostazione completamente diversa. Si tratta di un vero e proprio omaggio, o se volete un atto d’amore, che il fotografo dedica ad uno dei più grandi pianisti del jazz. Le foto sono accompagnate da testi di Geoff Dyer, Franco Fabbri e dello stesso Masotti il quale afferma esplicitamente che “In questa lunga serie di fotografie che osservo retrospettivamente, si gioca decisamente sulla presenza, quella del corpo e dello strumento, che compaiono nell’immagine. Le foto sono il risultato di una intima e oggettiva attenzione nei confronti di un artista a lungo seguito e ammirato, ma anche di una sua risposta che è consapevole accettazione, e soprattutto, partecipazione. Suo, solo suo, è il suono di una musica inconfondibile che la serie di fotografie ambisce di evocare e far risuonare.” In effetti Masotti ha assistito ad un centinaio di suoi concerti avendo così moltissime occasioni per estrinsecare la sua arte. Il libro si apre con una foto molti importante nella vita di Roberto: siamo nel 1969 e Keith Jarrett si esibisce al Teatro Comunale di Bologna nell’ambito del locale jazz Festival. Masotti non è ancora un professionista; fotografa con la Rolleiflex del padre, ma il risultato è talmente soddisfacente da indurlo a proseguire lungo la via delle foto. Dopo questa prima foto, gli scatti, esclusivamente in bianco e nero, sono organizzati in ordine cronologico fino al 2009… ed è davvero straniante constatare come l’aspetto del pianista sia cambiato con lo scorrere del tempo e come Masotti sia riuscito a cogliere gli aspetti più intimi della personalità dell’artista…anche perché è stato per lungo tempo l’unico fotografo ammesso alle prove di Jarrett. Ecco quindi il pianista impegnato durante un concerto… o in un momento di riposo accomodato in poltrona… o ancora seduto dietro una batteria o intento a suonare il sax soprano. E ammirando queste foto si ha quasi l’impressione di sentire le dita di Jarrett scorrere sulla tastiera per quelle straordinarie improvvisazioni che ci hanno deliziato fino al 2018 anno che ha segnato il definitivo abbandono delle scene da parte del pianista colpito da due ictus.
Gerlando Gatto
da Redazione | 09/Ago/2021 | News, Primo piano, Recensioni
di Flaviano Bosco –
Concepire, progettare e realizzare una rassegna musicale nei mesi passati poteva sembrare una follia assoluta, un azzardo, un vero colpo di dadi. Qualche volta però anche la pazzia è necessaria ed è proprio vero quello che dicevano gli antichi: “La fortuna aiuta gli audaci” o un po’ più volgarmente: “Chi non risica non rosica”; non sempre è vero ma questa volta si! E non è stato solo il favore della dea bendata.

In lingua friulana si dicono bonariamente “Cjastrons” i testardi irriducibili, quelli che contro tutto e contro tutti continuano dritti per la loro strada, a qualunque costo, anche se sembra che non abbiano alcuna possibilità di riuscire. Preferiscono continuare a sbattere la testa contro gli ostacoli pur di non cedere ai compromessi e soprattutto osano perdere e piuttosto di genuflettersi si spezzano.
“Cjastrons” di successo, in questo senso, sono sicuramente Giancarlo Velliscig e i suoi collaboratori di Euritmica che da 31 anni organizzano Udin&Jazz, la manifestazione che da tre anni ha partorito Grado Jazz che si aggiunge ad altre stagioni musicali e teatrali (Onde Mediterranee, Borghi Swing, Teatro Pasolini di Cervignano, Note Nuove, MusiCarnia ecc.)
In tutti questi anni gli è di certo capitato di sbattere il capo ma la scommessa è stata davvero vincente e i numeri e la qualità di quest’ultima edizione di Grado Jazz lo dimostrano. In accordo con la lungimirante amministrazione comunale dell’Isola d’oro è stato approntato e portato a termine un programma davvero succulento che ha fatto divertire, commuovere, emozionare, rilassare, eccitare gli spettatori spesso tutto nello stesso momento.
Ecco di seguito una mia selezione dei momenti più significativi, tra i tanti del festival, che ho seguito dalla seconda serata alla fine.
-

-
Claudio Cojaniz – ph Luca A. d’Agostino/Phocus Agency©
-

-
Claudio Cojaniz – ph Luca A. d’Agostino/Phocus Agency©
-

-
Claudio Cojaniz – ph Luca A. d’Agostino/Phocus Agency©
-

-
Bandakadabra – ph Angelo Salvin©
-

-
Bandakadabra – ph Luca A. d’Agostino/Phocus Agency©
-

-
Bandakadabra – ph Angelo Salvin©
Claudio Cojaniz “Black Water Music”. Quella dei concerti all’alba è diventata ormai una piacevole consuetudine di festival e rassegne, è un modo per riappropriarsi o per esplorare in musica momenti della giornata che normalmente non consideriamo. Accompagnare l’alba con le note del pianoforte di fronte all’orizzonte marino con il sole che sorge direttamente dalla laguna nel silenzio di una città che ancora dorme è un’esperienza quasi religiosa, un rito pagano. Se poi a suscitare le note sono le dita di un pianista come Cojaniz capace di un grande lirismo e sconfinati orizzonti non si può sbagliare. Provare per credere!
Bandakadabra: all’insegna del divertimento stradaiolo più verace e disimpegnato i “ragazzi” di Torino sanno davvero come far sorridere la gente e non c’è niente di più divertente che il vedere una band scatenata in mezzo alla folla che la segue in processione per tutta la città al ritmo del tamburo. Frizzanti, scoppiettanti, leggeri, clowneschi, saltimbanchi del jazz, una street marching band senza troppe pretese se non l’allegria propria e del pubblico. Momenti come questo contribuiscono a fare della rassegna una festa per tutta la città e non solo un evento elitario per i tanti appassionati. Bene hanno fatto gli organizzatori a voler disseminare in giro per la città balneare alcune iniziative, il grande favore riscontrato dal pubblico significa che la strada è quella giusta.
-

-
Dee Dee Bridgewater – ph Luca A. d’Agostino/Phocus Agency©
-

-
Dee Dee Bridgewater – ph Luca A. d’Agostino/Phocus Agency©
-

-
Dee Dee Bridgewater – ph Luca A. d’Agostino/Phocus Agency ©
-

-
Dee Dee Bridgewater – ph Luca A. d’Agostino/Phocus Agency©
-

-
Dee Dee Bridgewater – ph Angelo Salvin©
-

-
Dee Dee Bridgewater – ph Angelo Salvin©
Dee Dee Bridgewater. Una vera Lady con la voce intatta nonostante non sia più una fanciulla in fiore. Con un gruppo di giovani musicisti italiani tra i quali spiccavano la contrabbassista Rosa Brunello e la batterista Evita Polidoro. La cantante ha proposto dal suo sconfinato song book soprattutto brani del periodo con Stanley Clarke e Chick Corea; alla memoria di quest’ultimo era dedicato l’intero concerto. Visibilmente divertita, la Bridgewater ha “giocato” con la propria voce e con i musicisti, ridendo, ballando, raccontando gustosi aneddoti sulla sua lunga carriera fatta di incontri straordinari ma soprattutto incantando il pubblico con le sue doti canore strabilianti in grado di passare in un battito di ciglia dai toni più gravi, sporchi e bluesy fino ai più verticali acuti con estrema naturalezza e senza artifici accademici.
Daniele D’Agaro con i suoi sax e i suoi clarinetti ha saputo intrattenere i passanti proprio nel cuore della città lagunare in un luogo dalle architetture straordinarie e dalle antichissime testimonianze: il sagrato comune tra due basiliche paleocristiane, una a fianco dell’altra (Santa Eufemia e Santa Maria delle Grazie). Le sue ance sembravano riempire il balzo temporale tra quell’estrema antichità e il “presente fatto di attimi e settimane enigmistiche” come dice il poeta. D’Agaro sa essere evocativo e immaginifico sulle sue chiavi ma spesso risulta meditativo e distante, per un sassofonista non sono certo difetti. La sua performance solitaria è stata affascinante ma anche piacevolmente ermetica e astratta.
-

-
Brad Mehldau Trio – ph Luca A. d’Agostino/Phocus Agency©
-

-
Brad Mehldau Trio – ph Luca A. d’Agostino/Phocus Agency©
-

-
Brad Mehldau Trio – ph Luca A. d’Agostino/Phocus Agency©
-

-
Brad Mehldau Trio – ph Luca A. d’Agostino/Phocus Agency©
-

-
Daniele D’Agaro – ph Luca A. d’Agostino/Phocus Agency©
-

-
Daniele D’Agaro – ph Luca A. d’Agostino/Phocus Agency©
Brad Mehldau trio. Molti musicisti tra gli spettatori, il gotha dei jazzisti locali e di oltre confine con l’aggiunta di moltissimi appassionati, critici e giornalisti che aspettavano l’apparizione di quello che ormai è considerato un gigante della musica contemporanea senza definizioni di genere. L’attesa non è stata vana, Mehldau ha presentato il suo ultimo lavoro con un’esibizione convincente e maiuscola nonostante una piccola ferita al pollice che si era procurato tagliando un limone a poche ore dal concerto. Romantico e lirico, lontano dalle iper-virtuosistiche prestazioni di inizio carriera, mantiene una certa predisposizione ad un pop colto e “pettinato” che gli permette gli usuali sconfinamenti e crossover musicali appropriandosi, come in questo caso, di canzoni del tutto eterodosse come “Friends” dei Beach Boys. Ottimo l’interplay con i propri musicisti Grenadier al contrabbasso e Ballard alla batteria.
Mirko Cisilino: Tromba, trombone, Tuba in fa e una moltitudine di sordine, con queste armi si è presentato il trombettista in una delle vie centrali dello “struscio” serale di Grado. La sua esibizione ha colpito e affascinato molti ma ha ugualmente reso perplessi e forse anche indifferenti altri. Non è facile improvvisare davanti ad un pubblico a passeggio. Di recente anche Paolo Fresu travestito da barbone è stato completamente ignorato in un concerto improvvisato in piazza Navona a Roma, era successo alcuni anni fa anche a Joshua Bell, genio del violino, in una stazione della metropolitana a New York. Spesso siamo troppo distratti e non poniamo sufficientemente attenzione a ciò che ci circonda, a volte ci impediamo di scoprire autentici tesori come quelli che Cisilino soffiava nei propri labiofoni, da improvvisazioni su melodie classiche a quelle free form e rumoristiche. Tra gli spettatori più attenti, due bambini che leccavano il loro gelatone guardavano divertiti e perplessi qualcosa che forse non capivano del tutto ma che destava la loro curiosità. E’ proprio quello l’atteggiamento che tutti dovremmo sforzarci di avere. La vera musica è sempre Bellezza e Mistero.
-

-
Danilo Rea&Luciano Biondini – ph Angelo Salvin ©
-

-
Danilo Rea&Luciano Biondini – ph Luca A. d’Agostino/Phocus Agency ©
-

-
Danilo Rea&Luciano Biondini – ph Luca A. d’Agostino/Phocus Agency ©
-

-
Danilo Rea&Luciano Biondini – ph Luca A. d’Agostino/Phocus Agency ©
-

-
Danilo Rea&Luciano Biondini – ph Luca A. d’Agostino/Phocus Agency ©
-

-
Danilo Rea&Luciano Biondini – ph Angelo Salvin ©
Danilo Rea&Luciano Biondini: intrattenimento elegante fatto di classici della canzone italiana rivisitati in jazz in un’atmosfera da piano bar; c’è da chiedersi se abbia ancora senso un progetto del genere dopo che il revival jazzato sulle canzoni “leggerissime” della tradizione anni ‘60 si fa da decenni in tutte le salse e dopo che l’ottimo pianista Bollani ci ha costruito sopra una carriera trentennale. Anche il progetto che i due da anni portano in scena (Cosa sono le nuvole) che rivisita i brani più famosi della canzone italiana comincia ad essere una replica di se stesso, nostalgia di nostalgia. Certo entrambi sono ottimi musicisti, al pubblico continuano a piacere moltissimo, lo si è visto al Parco delle Rose e non si può certo rimproverare nessuno, il jazz cinquant’anni fa era fatto anche di questo.
Jazz Portraits. Fotografo ufficiale del festival e di tante altre avventure, Luca A. D’Agostino con i propri collaboratori segue il festival da trentun’anni. Una splendida esposizione, da egli stesso curata, con significativi scatti suoi e di altri eccellenti fotografi AFIJ (Associazione Fotografi Italiani di Jazz) per ciascuna edizione faceva bella mostra di sé nel centro della cittadina balneare durante la rassegna. Tra le tante meravigliose immagini, tutte in un rigoroso, evocativo bianco e nero di veri e propri giganti della musica ospitati dalla manifestazione (Elvin Jones, Ornette Coleman, B.B King ecc.) ne spiccava uno del presente che è già proiettato nell’immediato futuro. Shabaka Hutchings, il geniale tenor sassofonista, che fu a Udine nel 2017 con i suoi The Ancestors, è immortalato in chiaroscuro nella cornice di una porta proprio mentre si sta accingendo a entrare in palcoscenico, imbracciando il proprio strumento. E’ un attimo sospeso in perfetto equilibrio tra quello che non c’è ancora e quello che sarà che da l’idea di che cosa sia oggi la musica dentro e intorno il jazz.
-

-
Mostra Jazz Portraits – Foto Luca A. d’Agostino/Phocus Agency ©
-

-
Mostra Jazz Portraits – Foto Luca A. d’Agostino/Phocus Agency ©
-

-
Mostra Jazz Portraits – Foto Luca A. d’Agostino/Phocus Agency ©
-

-
Mostra Jazz Portraits – ph Alessandra Freguja ©
-

-
Mostra Jazz Portraits – ph Alessandra Freguja©
-

-
Mostra Jazz Portraits – ph Luca A. d’Agostino/Phocus Agency ©
A Proposito di Jazz ringrazia i fotografi Luca A. d’Agostino Phocus Agency, Alessandra Freguja, Angelo Salvin (AFIJ) e l’ufficio stampa di GradoJazz/Euritmica
da Gerlando Gatto | 15/Lug/2021 | I nostri CD, Primo piano, Recensioni

Cari amici, prima di andare in vacanza, “A proposito di jazz” vi propone una serie di album, italiani e stranieri, che vale la pena ascoltare. E si comincia con tre eccellenti CD dedicati al cinema.
Stefano Di Battista – “Morricone stories” – Warner
 Questo del sassofonista Stefano Di Battista è il primo dei tre album dedicati al cinema che viene ospitato nella nostra abituale rassegna discografica. L’album è particolare in quanto Di Battista, ben coadiuvato da Fred Nardin al pianoforte, Daniele Sorrentino al contrabbasso e il fantastico André Ceccarelli alla batteria, dedica questa sua ultima impresa discografica a Ennio Morricone, uno dei più grandi musicisti italiani degli ultimi tempi, al quale era legato da profonda e sincera amicizia. E lo fa nel modo migliore, vale a dire tralasciando i brani più noti, quelli che tutti conosciamo, per far ricorso ad alcune vere e proprie perle del Maestro che purtroppo non sempre godono di grande popolarità. Così l’unico brano universalmente conosciuto è “Metti una sera a cena” dall’omonimo film del 1969 diretto da Giuseppe Patroni Griffi, con Lino Capolicchio e Florinda Bolkan magnifici interpreti. Di Battista ce lo ripropone in una versione swingante in cui il sassofonista si produce in uno degli assolo più riusciti dell’intero album, che nulla toglie all’originaria bellezza del pezzo. Toccante, così come l’originale, “Tema di Deborah” da “C’era una volta in America” mentre in “Gabriel’s Oboe” da “Mission” Di Battista sostituisce il suo sax soprano all’originario oboe, con risultati straordinari nel mantenere sempre e comunque l’originaria bellezza della scrittura ‘morriconiana’. E questa sorta di devozione si avverte anche nel modo in cui la musica viene eseguita: niente muscolose esibizioni di bravura, niente arrangiamenti particolarmente sofisticati, insomma nessun escamotage per stupire l’ascoltatore, ma solo il piacere di suonare una musica evidentemente amata e profondamente vissuta. Splendida, e come poteva essere diversamente, anche l’interpretazione di “Flora” un pezzo che Morricone scrisse appositamente per Di Battista. Il disco è stato preceduto dai tre singoli “Peur sur la ville” (uscito il 29 gennaio), “Cosa avete fatto a Solange?” (uscito il 26 febbraio) e “Gabriel’s Oboe” (uscito il 19 marzo).
Questo del sassofonista Stefano Di Battista è il primo dei tre album dedicati al cinema che viene ospitato nella nostra abituale rassegna discografica. L’album è particolare in quanto Di Battista, ben coadiuvato da Fred Nardin al pianoforte, Daniele Sorrentino al contrabbasso e il fantastico André Ceccarelli alla batteria, dedica questa sua ultima impresa discografica a Ennio Morricone, uno dei più grandi musicisti italiani degli ultimi tempi, al quale era legato da profonda e sincera amicizia. E lo fa nel modo migliore, vale a dire tralasciando i brani più noti, quelli che tutti conosciamo, per far ricorso ad alcune vere e proprie perle del Maestro che purtroppo non sempre godono di grande popolarità. Così l’unico brano universalmente conosciuto è “Metti una sera a cena” dall’omonimo film del 1969 diretto da Giuseppe Patroni Griffi, con Lino Capolicchio e Florinda Bolkan magnifici interpreti. Di Battista ce lo ripropone in una versione swingante in cui il sassofonista si produce in uno degli assolo più riusciti dell’intero album, che nulla toglie all’originaria bellezza del pezzo. Toccante, così come l’originale, “Tema di Deborah” da “C’era una volta in America” mentre in “Gabriel’s Oboe” da “Mission” Di Battista sostituisce il suo sax soprano all’originario oboe, con risultati straordinari nel mantenere sempre e comunque l’originaria bellezza della scrittura ‘morriconiana’. E questa sorta di devozione si avverte anche nel modo in cui la musica viene eseguita: niente muscolose esibizioni di bravura, niente arrangiamenti particolarmente sofisticati, insomma nessun escamotage per stupire l’ascoltatore, ma solo il piacere di suonare una musica evidentemente amata e profondamente vissuta. Splendida, e come poteva essere diversamente, anche l’interpretazione di “Flora” un pezzo che Morricone scrisse appositamente per Di Battista. Il disco è stato preceduto dai tre singoli “Peur sur la ville” (uscito il 29 gennaio), “Cosa avete fatto a Solange?” (uscito il 26 febbraio) e “Gabriel’s Oboe” (uscito il 19 marzo).
Marco Fumo – “Il mio Morricone” – Oradek
 Ecco il secondo album dedicato a Morricone, firmato da Marco Fumo che more solito si esprime in solitudine. Anche questa volta la scelta dei brani è ben meditata: per la successione dei brani è stato scelto l’ordine cronologico mentre per i contenuti è lo stesso Fumo a venirci incontro nelle note che accompagnano l’album. Così i quattro preludi (“Cane bianco”, “Star System”, “Metti una sera a cena”, “Indagine”) e le quattro canzoni (“Il deserto dei tartari”, “Le due stagioni della vita”, “Got mit Uns” “Il potere degli angeli”) più “Nuovo cinema Paradiso” sono stati scelti in quanto da sempre fanno parte del repertorio di Fumo così come “scelta obbligata” è stata anche quella di “Rag in frantumi”, scritto da Morricone nel lontano febbraio 1986 ed espressamente dedicato proprio a Marco Fumo. Interessante sottolineare come Fumo mai abbia inciso le musiche di Morricone avendole, invece, eseguite spesso dal vivo (eccezion fatta per il già citato “Rag in frantumi” presente in vari album del pianista). Insomma un CD profondamente sentito, a dimostrazione di come Morricone fosse amato anche dai suoi colleghi e di quanto profondo, in particolare, fosse il legame che intercorreva tra Morricone e Fumo. “Questo – conclude le sue note Marco Fumo – è quello che sento e posso fare, dal cuore”. Dal punto di vista prettamente musicale, lo stile di Fumo è oramai riconoscibile: una assoluta conoscenza della letteratura pianistica – in particolar modo jazzistica – un sound fresco ma incisivo frutto di una solida preparazione di base, doti interpretative non comuni. Così, sotto le sue sapienti mani, i brani di Morricone rivivono letteralmente imponendosi all’attenzione anche dell’ascoltatore più distratto.
Ecco il secondo album dedicato a Morricone, firmato da Marco Fumo che more solito si esprime in solitudine. Anche questa volta la scelta dei brani è ben meditata: per la successione dei brani è stato scelto l’ordine cronologico mentre per i contenuti è lo stesso Fumo a venirci incontro nelle note che accompagnano l’album. Così i quattro preludi (“Cane bianco”, “Star System”, “Metti una sera a cena”, “Indagine”) e le quattro canzoni (“Il deserto dei tartari”, “Le due stagioni della vita”, “Got mit Uns” “Il potere degli angeli”) più “Nuovo cinema Paradiso” sono stati scelti in quanto da sempre fanno parte del repertorio di Fumo così come “scelta obbligata” è stata anche quella di “Rag in frantumi”, scritto da Morricone nel lontano febbraio 1986 ed espressamente dedicato proprio a Marco Fumo. Interessante sottolineare come Fumo mai abbia inciso le musiche di Morricone avendole, invece, eseguite spesso dal vivo (eccezion fatta per il già citato “Rag in frantumi” presente in vari album del pianista). Insomma un CD profondamente sentito, a dimostrazione di come Morricone fosse amato anche dai suoi colleghi e di quanto profondo, in particolare, fosse il legame che intercorreva tra Morricone e Fumo. “Questo – conclude le sue note Marco Fumo – è quello che sento e posso fare, dal cuore”. Dal punto di vista prettamente musicale, lo stile di Fumo è oramai riconoscibile: una assoluta conoscenza della letteratura pianistica – in particolar modo jazzistica – un sound fresco ma incisivo frutto di una solida preparazione di base, doti interpretative non comuni. Così, sotto le sue sapienti mani, i brani di Morricone rivivono letteralmente imponendosi all’attenzione anche dell’ascoltatore più distratto.
Renzo Ruggieri, Mauro De Federicis – “Ciak” – Vap
 Il terzo album in qualche modo dedicato al cinema è questo “Ciak” che vede impegnati Renzo Ruggieri alla fisarmonica e Marino De Federicis alla chitarra. Si tratta di un duo ampiamente collaudato che ha già inciso un album, “Terre” (2008), e che si è esibito con successo in Finlandia e Austria, oltre che in diversi festival italiani. Adesso tornano a presentarsi al pubblico del jazz con questo nuovo album composto da cinque brani per un totale di circa ventisette minuti di musica comunque di eccellente qualità. Il fatto è che Renzo Ruggieri si è oramai imposto all’attenzione del pubblico internazionale come uno dei migliori fisarmonicisti non solo italiani e può vantare una certa parsimonia nell’entrare in sala di registrazione: tutti i suoi album conservano uno standard qualitativo molto elevato grazie al fatto che Renzo decide di incidere un disco solo se ha qualcosa da dire. Dal canto suo Mauro De Federicis può esibire una preparazione di base di assoluto rispetto e una continua frequentazione con l’olimpo del jazz testimoniato dalle collaborazioni con nomi prestigiosi quali Dee Dee Bridgewater, Paolo Fresu, Bob Mintzer, tanto per fare qualche esempio. In questo album, dedicato al cinema, i due hanno scelto di eseguire due composizioni originali e tre brani di assoluto spessore come “Il postino” di Luis Bacalov, Riccardo Del Turco e Paolo Margheri, “La gita in barca” di Piero Piccioni e “Speak Softly Love” di Rota tratto da “Il Padrino”. Una scelta coraggiosa non fosse altro che per aver tralasciato quel Morricone cui viceversa sono dedicati i due precedenti album. Particolarmente interessante il modo in cui i due attualizzano le atmosfere proprie di giganti del cinema dedicando loro due brani, “De Niro” (Marino De Federicis) e “Fellini” (Ruggieri). Comunque il pezzo che più mi ha toccato è stato “Il Postino” il cui originario pathos è stato perfettamente riproposto. E devo dire che in questo tipo di riletture Ruggieri è davvero un maestro: basti dire che ogni qualvolta lo ascolto eseguire “Caruso” mi è difficile contenere la commozione.
Il terzo album in qualche modo dedicato al cinema è questo “Ciak” che vede impegnati Renzo Ruggieri alla fisarmonica e Marino De Federicis alla chitarra. Si tratta di un duo ampiamente collaudato che ha già inciso un album, “Terre” (2008), e che si è esibito con successo in Finlandia e Austria, oltre che in diversi festival italiani. Adesso tornano a presentarsi al pubblico del jazz con questo nuovo album composto da cinque brani per un totale di circa ventisette minuti di musica comunque di eccellente qualità. Il fatto è che Renzo Ruggieri si è oramai imposto all’attenzione del pubblico internazionale come uno dei migliori fisarmonicisti non solo italiani e può vantare una certa parsimonia nell’entrare in sala di registrazione: tutti i suoi album conservano uno standard qualitativo molto elevato grazie al fatto che Renzo decide di incidere un disco solo se ha qualcosa da dire. Dal canto suo Mauro De Federicis può esibire una preparazione di base di assoluto rispetto e una continua frequentazione con l’olimpo del jazz testimoniato dalle collaborazioni con nomi prestigiosi quali Dee Dee Bridgewater, Paolo Fresu, Bob Mintzer, tanto per fare qualche esempio. In questo album, dedicato al cinema, i due hanno scelto di eseguire due composizioni originali e tre brani di assoluto spessore come “Il postino” di Luis Bacalov, Riccardo Del Turco e Paolo Margheri, “La gita in barca” di Piero Piccioni e “Speak Softly Love” di Rota tratto da “Il Padrino”. Una scelta coraggiosa non fosse altro che per aver tralasciato quel Morricone cui viceversa sono dedicati i due precedenti album. Particolarmente interessante il modo in cui i due attualizzano le atmosfere proprie di giganti del cinema dedicando loro due brani, “De Niro” (Marino De Federicis) e “Fellini” (Ruggieri). Comunque il pezzo che più mi ha toccato è stato “Il Postino” il cui originario pathos è stato perfettamente riproposto. E devo dire che in questo tipo di riletture Ruggieri è davvero un maestro: basti dire che ogni qualvolta lo ascolto eseguire “Caruso” mi è difficile contenere la commozione.
*****
Claudio Angeleri – “Music from the Castle of Crossed Destinies” – Dodicilune
 Conosco e apprezzo oramai da molti anni Claudio Angeleri e non credo di sbagliare di molto se affermo che questo album è uno dei migliori che il pianista bergamasco abbia prodotto nel corso della sua oramai lunga carriera. A coadiuvarlo in questa ennesima fatica un gruppo di eccellenti musicisti: Giulio Visibelli (sax soprano, flauto), Paola Milzani (voce), Virginia Sutera (violino), Michele Gentilini (chitarra elettrica), Marco Esposito (basso elettrico), Luca Bongiovanni (batteria, percussioni) e, nel brano “Two or three stories”, Gabriele Comeglio (sax alto). Oltre al celebrato “Round about Midnight” di Monk, l’album consta di otto composizioni dello stesso Angeleri liberamente tratti dal breve romanzo fantastico “Il castello dei destini incrociati” di Italo Calvino. “L’idea di realizzare un nuovo progetto intorno alla letteratura di Italo Calvino – afferma lo stesso Angeleri – scaturisce da un invito del MIT Jazz Festival di Musica Oggi al Piccolo Teatro di Milano nello scorso novembre 2019. Lo spettacolo è stato poi replicato a gennaio al Blue Note, per essere messo in scena a luglio alla rassegna che ha significato la ripresa dal vivo dopo il lockdown a Bergamo”. E di certo bisogna avere una fervida immaginazione e soprattutto molto coraggio per trasporre in musica la scrittura non facile e mai banale di Italo Calvino. Di qui una musica ricca di colori in cui non sempre è facile distinguere le parti improvvisate da quelle scritte. Una musica in cui i vari strumenti diventano essi stessi voci narranti sì da rappresentare, – spiega ancora Angeleri – “per il loro carattere sonoro specifici personaggi”. Come si evince da queste poche note un compito davvero difficile che solo un musicista maturo, perfettamente consapevole dei propri mezzi espressivi, in possesso di una solida preparazione non solo come strumentista, poteva pensare di intraprendere e di traghettare alla meta con successo.
Conosco e apprezzo oramai da molti anni Claudio Angeleri e non credo di sbagliare di molto se affermo che questo album è uno dei migliori che il pianista bergamasco abbia prodotto nel corso della sua oramai lunga carriera. A coadiuvarlo in questa ennesima fatica un gruppo di eccellenti musicisti: Giulio Visibelli (sax soprano, flauto), Paola Milzani (voce), Virginia Sutera (violino), Michele Gentilini (chitarra elettrica), Marco Esposito (basso elettrico), Luca Bongiovanni (batteria, percussioni) e, nel brano “Two or three stories”, Gabriele Comeglio (sax alto). Oltre al celebrato “Round about Midnight” di Monk, l’album consta di otto composizioni dello stesso Angeleri liberamente tratti dal breve romanzo fantastico “Il castello dei destini incrociati” di Italo Calvino. “L’idea di realizzare un nuovo progetto intorno alla letteratura di Italo Calvino – afferma lo stesso Angeleri – scaturisce da un invito del MIT Jazz Festival di Musica Oggi al Piccolo Teatro di Milano nello scorso novembre 2019. Lo spettacolo è stato poi replicato a gennaio al Blue Note, per essere messo in scena a luglio alla rassegna che ha significato la ripresa dal vivo dopo il lockdown a Bergamo”. E di certo bisogna avere una fervida immaginazione e soprattutto molto coraggio per trasporre in musica la scrittura non facile e mai banale di Italo Calvino. Di qui una musica ricca di colori in cui non sempre è facile distinguere le parti improvvisate da quelle scritte. Una musica in cui i vari strumenti diventano essi stessi voci narranti sì da rappresentare, – spiega ancora Angeleri – “per il loro carattere sonoro specifici personaggi”. Come si evince da queste poche note un compito davvero difficile che solo un musicista maturo, perfettamente consapevole dei propri mezzi espressivi, in possesso di una solida preparazione non solo come strumentista, poteva pensare di intraprendere e di traghettare alla meta con successo.
Nik Bärtsch – “Entendre” – ECM
 Per chi ancora non conoscesse questo straordinario pianista e compositore svizzero, ecco un’ottima occasione per colmare questa lacuna. Nel panorama jazzistico internazionale oggi Bärtsch è personaggio imprescindibile tale e tanta è l’importanza che man mano va assumendo grazie anche ad alcune produzioni discografiche di eccellente livello. E’ questo il caso di “Entendre” declinato attraverso sei originali tutti composti da Nik e tutti eseguiti al piano solo. Lo stile dell’artista è assolutamente personale in quanto risultato da molti anni di continue sperimentazioni in cui Bärtsch ha cercato – e trovato – una soddisfacente sintesi tra jazz, minimalismo, poliritmie. Molti dei brani (quasi tutti intitolati Modul + numero, secondo consuetudine di Bärtsch) sono già stati presentati in altri album ma il pianista li rivisita apportando modifiche non di poco conto. Così ora tralascia precedenti climi jazz-rock per affidarsi unicamente alle sonorità dello strumento, ora si affida al giuoco minimalista alla ricerca con grande personalità di sottili variazioni timbriche. Il tutto completato da straordinarie capacità interpretative che portano l’artista a misurarsi anche sul piano dell’espressività. Si ascolti con attenzione l’apertura di “Modul 5” già proposto in “Llyrìa” (2010): la ricerca spazio-temporale in cui Bärtsch inserisce il suo pianismo è assolutamente straordinaria e mai conosce un attimo di stanca pur articolandosi su poche note che comunque delineano un quadro ben preciso. L’album si chiude con lo splendido “Déjà-vu, Vienna”, il pezzo più breve di “Entendre” (5:15), dal vago sapore impressionistico e dalla riconoscibile linea melodica elemento non certo usuale nelle concezioni di Bärtsch.
Per chi ancora non conoscesse questo straordinario pianista e compositore svizzero, ecco un’ottima occasione per colmare questa lacuna. Nel panorama jazzistico internazionale oggi Bärtsch è personaggio imprescindibile tale e tanta è l’importanza che man mano va assumendo grazie anche ad alcune produzioni discografiche di eccellente livello. E’ questo il caso di “Entendre” declinato attraverso sei originali tutti composti da Nik e tutti eseguiti al piano solo. Lo stile dell’artista è assolutamente personale in quanto risultato da molti anni di continue sperimentazioni in cui Bärtsch ha cercato – e trovato – una soddisfacente sintesi tra jazz, minimalismo, poliritmie. Molti dei brani (quasi tutti intitolati Modul + numero, secondo consuetudine di Bärtsch) sono già stati presentati in altri album ma il pianista li rivisita apportando modifiche non di poco conto. Così ora tralascia precedenti climi jazz-rock per affidarsi unicamente alle sonorità dello strumento, ora si affida al giuoco minimalista alla ricerca con grande personalità di sottili variazioni timbriche. Il tutto completato da straordinarie capacità interpretative che portano l’artista a misurarsi anche sul piano dell’espressività. Si ascolti con attenzione l’apertura di “Modul 5” già proposto in “Llyrìa” (2010): la ricerca spazio-temporale in cui Bärtsch inserisce il suo pianismo è assolutamente straordinaria e mai conosce un attimo di stanca pur articolandosi su poche note che comunque delineano un quadro ben preciso. L’album si chiude con lo splendido “Déjà-vu, Vienna”, il pezzo più breve di “Entendre” (5:15), dal vago sapore impressionistico e dalla riconoscibile linea melodica elemento non certo usuale nelle concezioni di Bärtsch.
Enzo Carniel, Filippo Vignato – “Aria” – Menace
 E’ davvero un piacere presentare questi due giovani straordinari musicisti che ancora non sono molto conosciuti dal pubblico italiano, ma la cui collaborazione era forse scritta negli astri dal momento che ambedue sono nati nel 1987. Enzo Carniel è un pianista francese dedito allo studio dello strumento sin da giovanissimo; sale agli onori della cronaca nel 2019 quando incide, con il gruppo House Of Echo, l’album ‘Wallsdown’. Filippo Vignato è a ben ragione considerato l‘astro nascente del trombonismo jazz italiano; anch’egli ha cominciato a studiare musica sin da bambino (a dieci anni) e oggi può vantare uno stile e una tecnica assolutamente personali. Ad onta delle difficoltà notoriamente insite in un duo, soprattutto se due artisti si cimentano per la prima volta in un organico del genere, questo “Aria” evidenzia una profonda empatia, un’intesa che trova la sua ragion d’essere nell’idem sentire dei due musicisti. Così il dialogo si svolge su binari sicuri anche se non banali, mai dando così all’ascoltatore l’impressione del ‘già sentito’ o peggio ancora di moduli predefiniti. Il risultato è un sound del tutto particolare determinato anche dall’uso del Fender Rhodes e dei sintetizzatori, la visione di un universo musicale multicolore, in cui i due artisti improvvisano continuamente essendo perfettamente in grado l’uno di capire le intenzioni dell’altro, in un susseguirsi si input, di stimoli, di processi creativi che si susseguono senza soluzione di continuità. Il tutto impreziosito da una riuscita ricerca sulle linee melodiche che costituiscono l’ossatura stessa dell’intero repertorio, otto brani tra cui spicca per intensità emotiva “Aria” la composizione che apre l’album in acustica per chiuderlo in versione elettronica. L’album, uscito il 16 aprile scorso per l’etichetta franco-giapponese Menace è stato anticipato da due singoli: la title-track Aria uscito il 5 febbraio e Babele uscito il 10 marzo.
E’ davvero un piacere presentare questi due giovani straordinari musicisti che ancora non sono molto conosciuti dal pubblico italiano, ma la cui collaborazione era forse scritta negli astri dal momento che ambedue sono nati nel 1987. Enzo Carniel è un pianista francese dedito allo studio dello strumento sin da giovanissimo; sale agli onori della cronaca nel 2019 quando incide, con il gruppo House Of Echo, l’album ‘Wallsdown’. Filippo Vignato è a ben ragione considerato l‘astro nascente del trombonismo jazz italiano; anch’egli ha cominciato a studiare musica sin da bambino (a dieci anni) e oggi può vantare uno stile e una tecnica assolutamente personali. Ad onta delle difficoltà notoriamente insite in un duo, soprattutto se due artisti si cimentano per la prima volta in un organico del genere, questo “Aria” evidenzia una profonda empatia, un’intesa che trova la sua ragion d’essere nell’idem sentire dei due musicisti. Così il dialogo si svolge su binari sicuri anche se non banali, mai dando così all’ascoltatore l’impressione del ‘già sentito’ o peggio ancora di moduli predefiniti. Il risultato è un sound del tutto particolare determinato anche dall’uso del Fender Rhodes e dei sintetizzatori, la visione di un universo musicale multicolore, in cui i due artisti improvvisano continuamente essendo perfettamente in grado l’uno di capire le intenzioni dell’altro, in un susseguirsi si input, di stimoli, di processi creativi che si susseguono senza soluzione di continuità. Il tutto impreziosito da una riuscita ricerca sulle linee melodiche che costituiscono l’ossatura stessa dell’intero repertorio, otto brani tra cui spicca per intensità emotiva “Aria” la composizione che apre l’album in acustica per chiuderlo in versione elettronica. L’album, uscito il 16 aprile scorso per l’etichetta franco-giapponese Menace è stato anticipato da due singoli: la title-track Aria uscito il 5 febbraio e Babele uscito il 10 marzo.
Vittorio Cuculo Quartet – “Ensemble” – Wow Records
 Lo stato di maturità del jazz italiano è dimostrato, seppur ce ne fosse ancora bisogno, dal proliferare di nuovi talenti. Tra questi c’è senza dubbio alcuno il ventisettenne sassofonista romano (alto e soprano) Vittorio Cuculo al suo secondo album. Il titolo è determinato dal fatto che il quartetto capitanato da Cuculo incontra i sassofoni della Filarmonica Sabina “Foronovana” con risultati eccellenti ma di cui parleremo tra poco. Il quartetto comprende, altre al leader, Danilo Blaiotta al pianoforte, Enrico Mianulli al contrabbasso, Gegè Munari alla batteria e in veste di special guest Lucia Filaci che interpreta con coraggio e bravura la cover di “Brava”, il pezzo di Bruno Canfora portato al successo da Mina. Il resto del repertorio è costituito da sei brani standard appartenenti alla tradizione jazz frutto della verve compositiva di alcuni grandi quali Charlie Parker, Errol Garner, Juan Tizol, Thelonius Monk, Rogers & Hart e due composizioni originali di Roberto Spadoni. Ciò detto vediamo più da vicino la musica proposta. Si tratta di un jazz mainstream che si rifà chiaramente agli stilemi del bop e dell’hard-bop interpretato con efficacia dal gruppo nel suo complesso che ben si amalgama con i fiati della Filarmonica, dando vita ad un sound particolare. Ovviamente sempre in primo piano il leader che data la scelta del repertorio comunica apertamente l’intento di volersi confrontare con un certo tipo di jazz sebbene avvalendosi di nuovi arrangiamenti, firmati da Riccardo Nebbiosi, Mario Corvini, Roberto Spadoni e Massimo Valentini. Ora che un giovane musicista scelga di suonare bop, ci sta tutto…ci mancherebbe altro. Solo che ci piacerebbe ascoltare Cuculo anche in contesti diversi in cui magari le eccelse capacità tecniche non sono poi così fondamentali.
Lo stato di maturità del jazz italiano è dimostrato, seppur ce ne fosse ancora bisogno, dal proliferare di nuovi talenti. Tra questi c’è senza dubbio alcuno il ventisettenne sassofonista romano (alto e soprano) Vittorio Cuculo al suo secondo album. Il titolo è determinato dal fatto che il quartetto capitanato da Cuculo incontra i sassofoni della Filarmonica Sabina “Foronovana” con risultati eccellenti ma di cui parleremo tra poco. Il quartetto comprende, altre al leader, Danilo Blaiotta al pianoforte, Enrico Mianulli al contrabbasso, Gegè Munari alla batteria e in veste di special guest Lucia Filaci che interpreta con coraggio e bravura la cover di “Brava”, il pezzo di Bruno Canfora portato al successo da Mina. Il resto del repertorio è costituito da sei brani standard appartenenti alla tradizione jazz frutto della verve compositiva di alcuni grandi quali Charlie Parker, Errol Garner, Juan Tizol, Thelonius Monk, Rogers & Hart e due composizioni originali di Roberto Spadoni. Ciò detto vediamo più da vicino la musica proposta. Si tratta di un jazz mainstream che si rifà chiaramente agli stilemi del bop e dell’hard-bop interpretato con efficacia dal gruppo nel suo complesso che ben si amalgama con i fiati della Filarmonica, dando vita ad un sound particolare. Ovviamente sempre in primo piano il leader che data la scelta del repertorio comunica apertamente l’intento di volersi confrontare con un certo tipo di jazz sebbene avvalendosi di nuovi arrangiamenti, firmati da Riccardo Nebbiosi, Mario Corvini, Roberto Spadoni e Massimo Valentini. Ora che un giovane musicista scelga di suonare bop, ci sta tutto…ci mancherebbe altro. Solo che ci piacerebbe ascoltare Cuculo anche in contesti diversi in cui magari le eccelse capacità tecniche non sono poi così fondamentali.
Joe Debono Quintet – “Acquapazza” – Anaglyphos
 Dino Rubino alla tromba e al flicorno, Rino Cirinnà al sax tenore, Joe Debono al pianoforte, Nello Toscano al contrabbasso e Paolo Vicari alla batteria sono i componenti del Joe Debono Quintet. Prodotto dall’etichetta discografica Anaglyphos Records e supportato da Malta Arts Fund – Arts Council Malta, la tracklist del CD è formata da otto composizioni originali del pianista, e da “Innu Lil San Guzepp”, un inno di San Giuseppe composto dal compositore maltese Carlo Diacono all’inizio del ventesimo secolo. In un momento come l’attuale, in cui il jazz si sta praticamente frammentando in moltissimi rivoli, in cui non sempre è facile trovare tracce di un passato anche se non remoto, questo album ci riporta in piena atmosfera jazz, senza equivoci di sorta. Il linguaggio di tutti è perfettamente in linea con le migliori tradizioni della musica afro-americana senza per ciò peccare di pedissequa imitazione. Ottima la ricerca sul sound come dimostra l’impasto sonoro determinato dalle parti suonate all’unisono da sassofono e tromba, sempre ben sostenute da una eccellente sezione ritmica. E al riguardo non si può non sottolineare da un canto la conferma a livelli straordinari di un musicista come Dino Rubino (che forse molti non lo sanno ma suona benissimo anche il pianoforte) e la rapida ascesa di Paolo Vicari batterista giovane ma già in possesso di una buona tecnica. Ovviamente più che positivo l’apporto di Rino Cirinnà sassofonista di vaglia e di Nello Toscano contrabbassista siciliano tra i più validi a livello nazionale. Bisogna comunque dare atto a Joe Debono, pianista e compositore maltese, di aver saputo costituire un quintetto capace di produrre un jazz elegante, raffinato, con un repertorio assolutamente confacente alle caratteristiche dei singoli musicisti. Si ascolti al riguardo “Gigi”, brano dolcissimo introdotto dallo stesso Debono e ben sviluppato dai fiati.
Dino Rubino alla tromba e al flicorno, Rino Cirinnà al sax tenore, Joe Debono al pianoforte, Nello Toscano al contrabbasso e Paolo Vicari alla batteria sono i componenti del Joe Debono Quintet. Prodotto dall’etichetta discografica Anaglyphos Records e supportato da Malta Arts Fund – Arts Council Malta, la tracklist del CD è formata da otto composizioni originali del pianista, e da “Innu Lil San Guzepp”, un inno di San Giuseppe composto dal compositore maltese Carlo Diacono all’inizio del ventesimo secolo. In un momento come l’attuale, in cui il jazz si sta praticamente frammentando in moltissimi rivoli, in cui non sempre è facile trovare tracce di un passato anche se non remoto, questo album ci riporta in piena atmosfera jazz, senza equivoci di sorta. Il linguaggio di tutti è perfettamente in linea con le migliori tradizioni della musica afro-americana senza per ciò peccare di pedissequa imitazione. Ottima la ricerca sul sound come dimostra l’impasto sonoro determinato dalle parti suonate all’unisono da sassofono e tromba, sempre ben sostenute da una eccellente sezione ritmica. E al riguardo non si può non sottolineare da un canto la conferma a livelli straordinari di un musicista come Dino Rubino (che forse molti non lo sanno ma suona benissimo anche il pianoforte) e la rapida ascesa di Paolo Vicari batterista giovane ma già in possesso di una buona tecnica. Ovviamente più che positivo l’apporto di Rino Cirinnà sassofonista di vaglia e di Nello Toscano contrabbassista siciliano tra i più validi a livello nazionale. Bisogna comunque dare atto a Joe Debono, pianista e compositore maltese, di aver saputo costituire un quintetto capace di produrre un jazz elegante, raffinato, con un repertorio assolutamente confacente alle caratteristiche dei singoli musicisti. Si ascolti al riguardo “Gigi”, brano dolcissimo introdotto dallo stesso Debono e ben sviluppato dai fiati.
Alessandro Deledda – “La linea del vento” – Le Vele
 Undici brani originali declinati attraverso una interpretazione per piano solo. Con questo album Alessandro Deledda, jazzista sardo che abita a Perugia, abbandona la strada tracciata in precedenza sia con l’elettro-jazz di “Conception & Contamination” del 2011 assieme a Simone Alessandrini, sax e Mirko Ferrantini, dj, ritmiche, sia con il CD del 2014, “Morbid Dialogues” in cui era alla guida di un quartetto di chiara impronta jazzistica con Francesco Bearzatti al sassofono, Silvia Bolognesi al contrabbasso e Ferdinando Faraò alla batteria. Infatti questa volta si presenta al pubblico nella duplice veste di compositore (il repertorio è tutto da lui scritto) ed esecutore. Il risultato è apprezzabile: le composizioni sono ben strutturate, con una bella linea melodica, e inserite in un ambito in cui le sensazioni più intimiste sembrano prevalere sul resto. Non a caso alcuni titoli – “Ginevra”, “Sulla strada di casa tua”, “L’Aquilone”, “Gino e l’ulivo” – sembrano riferirsi ad esperienze direttamente vissute dal musicista. Così ad esempio “Madreterra” è un esplicito omaggio alla terra natia mentre “Ginevra”, afferma Deledda, “è la storia di una cagnolina, chiamata Ginevra che ritrova nella sua nuova famiglia il suo sorriso, abbandonato nel bosco con le sue fragilità, per andare a vivere fedele una nuova melodia”. Dal punto di vista esecutivo lo stile pianistico di Deledda rifugge sia da qualsivoglia sperimentazione sia da passaggi particolarmente complessi e arditi per frequentare terreni più aperti alla comprensione, in cui i riferimenti al jazz si mescolano con quelli alla popular music.
Undici brani originali declinati attraverso una interpretazione per piano solo. Con questo album Alessandro Deledda, jazzista sardo che abita a Perugia, abbandona la strada tracciata in precedenza sia con l’elettro-jazz di “Conception & Contamination” del 2011 assieme a Simone Alessandrini, sax e Mirko Ferrantini, dj, ritmiche, sia con il CD del 2014, “Morbid Dialogues” in cui era alla guida di un quartetto di chiara impronta jazzistica con Francesco Bearzatti al sassofono, Silvia Bolognesi al contrabbasso e Ferdinando Faraò alla batteria. Infatti questa volta si presenta al pubblico nella duplice veste di compositore (il repertorio è tutto da lui scritto) ed esecutore. Il risultato è apprezzabile: le composizioni sono ben strutturate, con una bella linea melodica, e inserite in un ambito in cui le sensazioni più intimiste sembrano prevalere sul resto. Non a caso alcuni titoli – “Ginevra”, “Sulla strada di casa tua”, “L’Aquilone”, “Gino e l’ulivo” – sembrano riferirsi ad esperienze direttamente vissute dal musicista. Così ad esempio “Madreterra” è un esplicito omaggio alla terra natia mentre “Ginevra”, afferma Deledda, “è la storia di una cagnolina, chiamata Ginevra che ritrova nella sua nuova famiglia il suo sorriso, abbandonato nel bosco con le sue fragilità, per andare a vivere fedele una nuova melodia”. Dal punto di vista esecutivo lo stile pianistico di Deledda rifugge sia da qualsivoglia sperimentazione sia da passaggi particolarmente complessi e arditi per frequentare terreni più aperti alla comprensione, in cui i riferimenti al jazz si mescolano con quelli alla popular music.
Massimo Donà – “Magister Puck” – Caligola
 A solo un anno da “Iperboliche distanze”, ecco tornare sulle scene discografiche il filosofo–trombettista Massimo Donà (nell’occasione anche chitarrista e rapper), alla testa di un ampio organico in cui spiccano i nomi del sassofonista Michele Polga e del batterista Davide Ragazzoni, quest’ultimo unico musicista presente, insieme al leader, in ogni traccia del Cd; in un solo brano (“E chi no”) è possibile ascoltare anche Francesco Bearzatti. Questo nuovo album, “Magister Puck”, si sostanzia, quindi, di colori, atmosfere assai diversificate pur mantenendo una sua coerenza di fondo. Ecco, quindi, in apertura “Topi in terrazza” di chiara impronta funky così come “Tagology” che non a caso presenta quasi lo stesso organico del pezzo di apertura con, oltre al leader, Michele Polga al sax tenore, Maurizio Trionfo alla chitarra, Stefano Olivato basso e clavinet, Davide Ragazzoni batteria, assente, quindi, Bebo Baldan al sintetizzatore. Più influenzato dal pop, seppure di classe, “I’m in Love” impreziosito dalla voce di Paola Donà e con un bell’assolo, vagamente davisiano, del leader. Anche “Magister Puck’s Theory” sembra seguire le orme del precedente “I’m in Love” prima di trasformarsi in un incalzante rap dal testo significativamente ironico. Nel brano decisamente più lungo dell’intero album, “E chi no”, si rinnova la collaborazione tra Massimo Donà e David Riondino che frutti succosi aveva già dato nel precedente album dello stesso trombettista, “Iperboliche distanze”, dedicato alla figura del grande filosofo veneto Andrea Emo. Il disco si chiude con una registrazione del 1989, “Irrisoluzione cromatica”, ad opera di un sestetto di chiara derivazione davisiana post ’69.
A solo un anno da “Iperboliche distanze”, ecco tornare sulle scene discografiche il filosofo–trombettista Massimo Donà (nell’occasione anche chitarrista e rapper), alla testa di un ampio organico in cui spiccano i nomi del sassofonista Michele Polga e del batterista Davide Ragazzoni, quest’ultimo unico musicista presente, insieme al leader, in ogni traccia del Cd; in un solo brano (“E chi no”) è possibile ascoltare anche Francesco Bearzatti. Questo nuovo album, “Magister Puck”, si sostanzia, quindi, di colori, atmosfere assai diversificate pur mantenendo una sua coerenza di fondo. Ecco, quindi, in apertura “Topi in terrazza” di chiara impronta funky così come “Tagology” che non a caso presenta quasi lo stesso organico del pezzo di apertura con, oltre al leader, Michele Polga al sax tenore, Maurizio Trionfo alla chitarra, Stefano Olivato basso e clavinet, Davide Ragazzoni batteria, assente, quindi, Bebo Baldan al sintetizzatore. Più influenzato dal pop, seppure di classe, “I’m in Love” impreziosito dalla voce di Paola Donà e con un bell’assolo, vagamente davisiano, del leader. Anche “Magister Puck’s Theory” sembra seguire le orme del precedente “I’m in Love” prima di trasformarsi in un incalzante rap dal testo significativamente ironico. Nel brano decisamente più lungo dell’intero album, “E chi no”, si rinnova la collaborazione tra Massimo Donà e David Riondino che frutti succosi aveva già dato nel precedente album dello stesso trombettista, “Iperboliche distanze”, dedicato alla figura del grande filosofo veneto Andrea Emo. Il disco si chiude con una registrazione del 1989, “Irrisoluzione cromatica”, ad opera di un sestetto di chiara derivazione davisiana post ’69.
Cettina Donato, Ninni Bruschetta – “I siciliani – Vero succo di poesia” – Alfa Music
 Pochi anni fa ero stato fin troppo facile profeta nel prevedere che Cettina Donato sarebbe divenuta una delle punte di diamante del jazz mady in Italy. Ciò perché sin dall’inizio l’artista messinese mostrava una completezza straordinaria essendo allo stesso tempo, pianista preparata, compositrice assai feconda, capace direttrice anche di grosse formazioni. Il tutto è ben compendiato in questo ultimo album in cui si fortifica quella stretta collaborazione che oramai va avanti da qualche tempo tra Cettina e l’attore, regista anch’egli siciliano, Ninni Bruschetta. I due sono reduci dai successi teatrali de “Il mio nome è Caino” di Claudio Fava, i quali, dopo aver interpretato un testo di impegno civile servendosi solo di voce e pianoforte presentano adesso il volto poetico e letterario dell’isola. Di qui l’album “I siciliani”: otto pezzi originali scritti dalla Donato con testi dello scrittore siciliano Antonio Caldarella scomparso nel 2008, interpretati da un gruppo con Dario Cecchini (clarinetto basso, sax soprano e baritono), Dario Rosciglione (contrabbasso e basso elettrico), Mimmo Campanale (batteria e percussioni) con l’aggiunta degli archi della B.I.M. Orchestra e dell’attrice e cantante Celeste Gugliandolo (che interpreta “Le siciliane”). Tutti gli altri brani sono affidati alla voce spesso roca e graffiante di Bruschetta che si amalgama in maniera straordinaria con il pianismo della Donato e più in generale con il sound dell’ensemble. Come sottolineato in apertura, la Donato trova quindi terreno fertile per evidenziare tutte le sue capacità, di strumentista, di compositrice, di arrangiatrice e di direttrice d’orchestra, in un alternarsi di atmosfere che forse solo un siciliano doc può capire sino in fondo. Una musica che sottolinea alcune peculiarità di una terra tanto straordinaria quanto ancora oggi ben difficile da vivere.
Pochi anni fa ero stato fin troppo facile profeta nel prevedere che Cettina Donato sarebbe divenuta una delle punte di diamante del jazz mady in Italy. Ciò perché sin dall’inizio l’artista messinese mostrava una completezza straordinaria essendo allo stesso tempo, pianista preparata, compositrice assai feconda, capace direttrice anche di grosse formazioni. Il tutto è ben compendiato in questo ultimo album in cui si fortifica quella stretta collaborazione che oramai va avanti da qualche tempo tra Cettina e l’attore, regista anch’egli siciliano, Ninni Bruschetta. I due sono reduci dai successi teatrali de “Il mio nome è Caino” di Claudio Fava, i quali, dopo aver interpretato un testo di impegno civile servendosi solo di voce e pianoforte presentano adesso il volto poetico e letterario dell’isola. Di qui l’album “I siciliani”: otto pezzi originali scritti dalla Donato con testi dello scrittore siciliano Antonio Caldarella scomparso nel 2008, interpretati da un gruppo con Dario Cecchini (clarinetto basso, sax soprano e baritono), Dario Rosciglione (contrabbasso e basso elettrico), Mimmo Campanale (batteria e percussioni) con l’aggiunta degli archi della B.I.M. Orchestra e dell’attrice e cantante Celeste Gugliandolo (che interpreta “Le siciliane”). Tutti gli altri brani sono affidati alla voce spesso roca e graffiante di Bruschetta che si amalgama in maniera straordinaria con il pianismo della Donato e più in generale con il sound dell’ensemble. Come sottolineato in apertura, la Donato trova quindi terreno fertile per evidenziare tutte le sue capacità, di strumentista, di compositrice, di arrangiatrice e di direttrice d’orchestra, in un alternarsi di atmosfere che forse solo un siciliano doc può capire sino in fondo. Una musica che sottolinea alcune peculiarità di una terra tanto straordinaria quanto ancora oggi ben difficile da vivere.
Ganelin, Kruglov, Yudanov – “Access Point” –Losen Records
 Ecco un trio di assoluto livello internazionale composto da Slava Ganelin al pianoforte, tastiere, live electronics e percussioni, Alexey Kruglov sax alto e soprano, Oleg Yudanov batteria e percussioni, vale a dire tre dei migliori esponenti del free jazz russo. Quindi un organico non usuale caratterizzato dalla mancanza del contrabbasso, impegnato in un repertorio di sei brani interamente scritto dai tre. Registrato il 13 novembre del 2017, l’album rappresenta uno dei migliori esempi di free jazz realizzato in Europa in quest’ultimo decennio. La cosa non stupisce più di tanto ove si consideri la statura artistica del russo Ganelin già noto al pubblico del jazz per il suo fantastico trio con Tarasov e Chekasin. Questa volta a completare il trio sono due altri jazzisti ma il risultato finale non cambia granché. Nato nel 2012 il trio frequenta il terreno della libera improvvisazione in cui non esistono strutture predefinite che viceversa si creano nel momento stesso in cui si suona, quindi in quello strettissimo lasso di tempo che passa dall’idea musicale all’esecuzione. Quasi inutile sottolineare come la musica sia caratterizzata da una forte energia creativa che trova in Ornette Coleman il suo nume tutelare e che mai conosce un attimo di stanca con i tre musicisti che riescono a ritagliarsi spazi appropriati alle loro grandi possibilità. Il clima generale dell’album è perfettamente disegnato sin dal primo brano, quando dopo una sorta di introduzione a tempo lento il sassofonista prende in mano le redini del gruppo e si lancia in una trascinante improvvisazione, seguito a ruota da Ganelin mentre Yudanov sorregge il tutto con precisione; a circa 2:40 Ganelin si sostituisce a Kruglov mantenendo un clima incandescente che non muta quando a circa tre quarti dell’esecuzione Kruglov passa al sax soprano. E sarà poi questa l’atmosfera che si respirerà durante tutto l’arco dell’album.
Ecco un trio di assoluto livello internazionale composto da Slava Ganelin al pianoforte, tastiere, live electronics e percussioni, Alexey Kruglov sax alto e soprano, Oleg Yudanov batteria e percussioni, vale a dire tre dei migliori esponenti del free jazz russo. Quindi un organico non usuale caratterizzato dalla mancanza del contrabbasso, impegnato in un repertorio di sei brani interamente scritto dai tre. Registrato il 13 novembre del 2017, l’album rappresenta uno dei migliori esempi di free jazz realizzato in Europa in quest’ultimo decennio. La cosa non stupisce più di tanto ove si consideri la statura artistica del russo Ganelin già noto al pubblico del jazz per il suo fantastico trio con Tarasov e Chekasin. Questa volta a completare il trio sono due altri jazzisti ma il risultato finale non cambia granché. Nato nel 2012 il trio frequenta il terreno della libera improvvisazione in cui non esistono strutture predefinite che viceversa si creano nel momento stesso in cui si suona, quindi in quello strettissimo lasso di tempo che passa dall’idea musicale all’esecuzione. Quasi inutile sottolineare come la musica sia caratterizzata da una forte energia creativa che trova in Ornette Coleman il suo nume tutelare e che mai conosce un attimo di stanca con i tre musicisti che riescono a ritagliarsi spazi appropriati alle loro grandi possibilità. Il clima generale dell’album è perfettamente disegnato sin dal primo brano, quando dopo una sorta di introduzione a tempo lento il sassofonista prende in mano le redini del gruppo e si lancia in una trascinante improvvisazione, seguito a ruota da Ganelin mentre Yudanov sorregge il tutto con precisione; a circa 2:40 Ganelin si sostituisce a Kruglov mantenendo un clima incandescente che non muta quando a circa tre quarti dell’esecuzione Kruglov passa al sax soprano. E sarà poi questa l’atmosfera che si respirerà durante tutto l’arco dell’album.
Vijay Iyer – “Uneasy” – ECM
 Nato ad Albany da genitori indiani di etnia dravidica Tamil, Vijay a cinquant’anni viene giustamente considerato uno dei migliori pianisti jazz oggi in esercizio. Considerazione conquistata grazie ad un talento cristallino e ad una personalità molto forte che è riuscita a coniugare un profondo sapere extra-musicale (è laureato in matematica e fisica alla Yale, insegnante ad Harvard, esperto in psicologia cognitiva con specifico riferimento alla capacità psico-fisica di relazionarsi ai vari linguaggi musicali) con una straordinaria dedizione alla musica essendo giunto al ventiquattresimo disco da leader, senza considerare le moltissime composizioni eseguite anche da formazioni non jazzistiche. In questo “Uneasy” Vijay suona in trio con Linda May Han Oh, contrabbassista di origine malese ma cresciuta in Australia e poi negli States e Tyshawn Sorey alla batteria, personaggio ben apprezzato sia nella musica classica sia nel jazz. In repertorio dieci composizioni tutte scritte dal pianista eccezion fatta per “Night and Day” di Cole Porter e “Drummer’s Song” di Gery Allen. Il clima nel cui ambito si muove Iyer è quello bop e post-bop, quindi un jazz sanguigno che si rifà alle radici più autentiche della musica afro-americana e che proprio per questo necessita di una profonda conoscenza della materia. Conoscenza che sicuramente non manca nel bagaglio dell’artista, il cui pianismo si svolge solido per tutta la durata dell’album validamente supportato da batteria e contrabbasso precisi e propositivi nella loro costante azione. Non si esagera affermando che tutti i brani meritano un attento ascolto anche se lo standard “Night and Day” si fa particolarmente apprezzare per come l’artista riesce a personalizzare il brano senza alcunché perdere né dell’originaria riconoscibilità né tanto meno della sua splendida linea melodica. Particolarmente interessante anche “Entrustment, brano di profonda suggestione, intimista, a chiudere nel modo migliore un album assolutamente consigliato.
Nato ad Albany da genitori indiani di etnia dravidica Tamil, Vijay a cinquant’anni viene giustamente considerato uno dei migliori pianisti jazz oggi in esercizio. Considerazione conquistata grazie ad un talento cristallino e ad una personalità molto forte che è riuscita a coniugare un profondo sapere extra-musicale (è laureato in matematica e fisica alla Yale, insegnante ad Harvard, esperto in psicologia cognitiva con specifico riferimento alla capacità psico-fisica di relazionarsi ai vari linguaggi musicali) con una straordinaria dedizione alla musica essendo giunto al ventiquattresimo disco da leader, senza considerare le moltissime composizioni eseguite anche da formazioni non jazzistiche. In questo “Uneasy” Vijay suona in trio con Linda May Han Oh, contrabbassista di origine malese ma cresciuta in Australia e poi negli States e Tyshawn Sorey alla batteria, personaggio ben apprezzato sia nella musica classica sia nel jazz. In repertorio dieci composizioni tutte scritte dal pianista eccezion fatta per “Night and Day” di Cole Porter e “Drummer’s Song” di Gery Allen. Il clima nel cui ambito si muove Iyer è quello bop e post-bop, quindi un jazz sanguigno che si rifà alle radici più autentiche della musica afro-americana e che proprio per questo necessita di una profonda conoscenza della materia. Conoscenza che sicuramente non manca nel bagaglio dell’artista, il cui pianismo si svolge solido per tutta la durata dell’album validamente supportato da batteria e contrabbasso precisi e propositivi nella loro costante azione. Non si esagera affermando che tutti i brani meritano un attento ascolto anche se lo standard “Night and Day” si fa particolarmente apprezzare per come l’artista riesce a personalizzare il brano senza alcunché perdere né dell’originaria riconoscibilità né tanto meno della sua splendida linea melodica. Particolarmente interessante anche “Entrustment, brano di profonda suggestione, intimista, a chiudere nel modo migliore un album assolutamente consigliato.
Sinikka Langeland – “Wolf Rune” – ECM
 Il Kantele è lo strumento tipico della musica folkloristica finlandese e Sinikka Langeland è specialista di questo strumento nonché cantante folk di Finnskogen, la « foresta finlandese » norvegese. In questo sesto album targato ECM, Sinikka, diversamente da altri album, si appalesa in splendida solitudine utilizzando ben tre tipi di kantele, a cinque, a quindici e a trentanove corde, facendoci così apprezzare le innumerevoli sfaccettature dello strumento. Nella maggior parte dei brani Sinikka si esprime anche vocalmente, il tutto ad elaborare un’espressività che questa volta nulla ha da spartire con il linguaggio jazzistico, restando, comunque, sulla scorta di un’estetica che nella ECM ha trovato la sua più completa estrinsecazione. Insomma una musica tutta giocata su melodie ampie, ariose, spesso evocative, alle volte venate da quella sorta di dolce malinconia che attraversa le atmosfere nordiche. Una profondità d’ispirazione che caratterizza oramai le realizzazioni della Langeland, ispirazione che specie se, come chi scrive, conosci quei luoghi, non può non toccarti nel profondo. Dal punto di vista testuale, Sinikka ha tratto ispirazione da molte fonti: ecco quindi il drammaturgo Jon Fosse accanto al filosofo e mistico del tredicesimo secolo Meister Eckhart… e ancora il poeta norvegese Olav H. Hauge. In tale contesto suggerire un brano in particolare è impresa quanto mai ardua anche se la title track appare degna di particolare attenzione: brano molto delicato ed intimista racconta l’inverno, ovvero quello stato della natura in cui tutto pare fermarsi prima del risveglio primaverile. Per raccontarci tutto ciò l’artista alterna l’archetto al pizzichio delle dita sullo strumento e chiude il brano con la sua voce che si alza stentorea sull’accompagnamento strumentale.
Il Kantele è lo strumento tipico della musica folkloristica finlandese e Sinikka Langeland è specialista di questo strumento nonché cantante folk di Finnskogen, la « foresta finlandese » norvegese. In questo sesto album targato ECM, Sinikka, diversamente da altri album, si appalesa in splendida solitudine utilizzando ben tre tipi di kantele, a cinque, a quindici e a trentanove corde, facendoci così apprezzare le innumerevoli sfaccettature dello strumento. Nella maggior parte dei brani Sinikka si esprime anche vocalmente, il tutto ad elaborare un’espressività che questa volta nulla ha da spartire con il linguaggio jazzistico, restando, comunque, sulla scorta di un’estetica che nella ECM ha trovato la sua più completa estrinsecazione. Insomma una musica tutta giocata su melodie ampie, ariose, spesso evocative, alle volte venate da quella sorta di dolce malinconia che attraversa le atmosfere nordiche. Una profondità d’ispirazione che caratterizza oramai le realizzazioni della Langeland, ispirazione che specie se, come chi scrive, conosci quei luoghi, non può non toccarti nel profondo. Dal punto di vista testuale, Sinikka ha tratto ispirazione da molte fonti: ecco quindi il drammaturgo Jon Fosse accanto al filosofo e mistico del tredicesimo secolo Meister Eckhart… e ancora il poeta norvegese Olav H. Hauge. In tale contesto suggerire un brano in particolare è impresa quanto mai ardua anche se la title track appare degna di particolare attenzione: brano molto delicato ed intimista racconta l’inverno, ovvero quello stato della natura in cui tutto pare fermarsi prima del risveglio primaverile. Per raccontarci tutto ciò l’artista alterna l’archetto al pizzichio delle dita sullo strumento e chiude il brano con la sua voce che si alza stentorea sull’accompagnamento strumentale.
Giovanni Maier, Massimo De Mattia – “Tilt – Improvised Concerto for Flute and Chamber Orchestra” – Artesuono
 Ecco una preziosa realizzazione della Artesuono concepita per festeggiare la sua duecentesima produzione discografica: un cofanetto in edizione limitata di 300 copie, numerate a mano, contenente un CD audio, le tavole con le partiture pittoriche realizzate da Giovanni Maier, e le foto delle registrazioni scattate da Luca D’Agostino.
Ecco una preziosa realizzazione della Artesuono concepita per festeggiare la sua duecentesima produzione discografica: un cofanetto in edizione limitata di 300 copie, numerate a mano, contenente un CD audio, le tavole con le partiture pittoriche realizzate da Giovanni Maier, e le foto delle registrazioni scattate da Luca D’Agostino.
L’album è stato registrato dal vivo al teatro Revoltella di Trieste il 19 e 20 giugno 2019 durante il festival “Le Nuove Rotte del Jazz 2019”. Ora, al di là della bellissima confezione, la musica che viene proposta è di altissimo livello essendo stata concepita ed eseguita da due dei nostri migliori improvvisatori quali il flautista Massimo De Mattia e Giovanni Maier quest’ultimo nelle vesti anche di conduttore dell’organico comprendente musicisti e allievi del Conservatorio ‘G. Tartini’ di Trieste: Angelica Groppi, Rachele Castellano e Giovanni Dalle Aste (Viola), Simone Lanzi (Contrabbasso), Iva Bobanović (Chitarra classica), Piercarlo Favro (Chitarra), Anna Talbot (Arpa), Luigi Vitale (Vibrafono, Percussioni). Qui siamo nel campo della totale improvvisazione: la prassi esecutiva è quella della “conduction” per cui Maier fornisce agli esecutori una serie di comandi che fanno evolvere il flusso musicale in un senso piuttosto che in un altro. Certo questa tecnica produrrebbe frutti amari se non ci fossero artisti in grado di ben interpretarla: ecco Massimo De Mattia credo che sia in senso assoluto uno dei migliori del nostro Paese; improvvisatore dotato di una eccezionale musicalità è in grado di assorbire nella propria musica (e gliel’ho sentito fare personalmente) l’inaspettato cinguettio di un uccello così come il risuonare delle campane. Notevole anche il ruolo del vibrafonista Luigi Vitale che alterna un ruolo da solista a quello di rinforzo dell’orchestra. Partendo da queste premesse è facile capire come l’album, per chi sa ascoltare con orecchie e mente ben aperte, è da gustare nella sua interezza.
Michael Mantler – Coda, Orchestra Suite – ECM
 Album davvero particolare questo di Michael Mantler, che si inserisce nel solco tracciato dal precedente album “Jazz Composer’s Orchestra Update” osannato dalla critica internazionale. Questa volta Mantler compie un’operazione ancora più audace; sceglie, nell’ambito della sua larga produzione, alcuni brani che considera particolarmente significativi e li riarrangia in forma di suite per farli eseguire da un’orchestra comprendente musicisti jazz e classici. Così i brani che ascoltiamo provengono dai seguenti album: “13 and ¾”, “Cerco un paese innocente”, “Alien”, “Folly Seeing All This”, “For Two” e “Hide And Seek”. Il risultato è semplicemente spettacolare grazie anche ai solisti di vaglia presenti in orchestra: Maximilian Kanzler acclamato come uno dei migliori giovani percussionisti e vibrafonisti del momento; il chitarrista Bjarne Roupé, membro fondamentale della Mantler’s Chamber Music and Songs Ensemble; il pianista austriaco David Helbock che a soli 37 anni è già un’icona della scena jazz europea… per non parlare dello stesso leader che si fa apprezzare, more solito, come eccellente trombettista. A tutto ciò si aggiunga la preziosa opera dell’Orchestra nel suo insieme (ben 26 elementi) e si avrà un quadro più preciso del perché si è definito spettacolare l’esecuzione di questa compagine. Tra i membri dell’orchestra da segnalare la presenza della croata violoncellista Asja Valcic che aveva già collaborato con Mantler nell’incisione dell’album “Jazz Composer’s Orchestra Update”. Coda è stato registrato al “Vienna’s Porgy & Bess Studio” nel settembre del 2019, e missato presso gli studi La Buissonne in Francia.
Album davvero particolare questo di Michael Mantler, che si inserisce nel solco tracciato dal precedente album “Jazz Composer’s Orchestra Update” osannato dalla critica internazionale. Questa volta Mantler compie un’operazione ancora più audace; sceglie, nell’ambito della sua larga produzione, alcuni brani che considera particolarmente significativi e li riarrangia in forma di suite per farli eseguire da un’orchestra comprendente musicisti jazz e classici. Così i brani che ascoltiamo provengono dai seguenti album: “13 and ¾”, “Cerco un paese innocente”, “Alien”, “Folly Seeing All This”, “For Two” e “Hide And Seek”. Il risultato è semplicemente spettacolare grazie anche ai solisti di vaglia presenti in orchestra: Maximilian Kanzler acclamato come uno dei migliori giovani percussionisti e vibrafonisti del momento; il chitarrista Bjarne Roupé, membro fondamentale della Mantler’s Chamber Music and Songs Ensemble; il pianista austriaco David Helbock che a soli 37 anni è già un’icona della scena jazz europea… per non parlare dello stesso leader che si fa apprezzare, more solito, come eccellente trombettista. A tutto ciò si aggiunga la preziosa opera dell’Orchestra nel suo insieme (ben 26 elementi) e si avrà un quadro più preciso del perché si è definito spettacolare l’esecuzione di questa compagine. Tra i membri dell’orchestra da segnalare la presenza della croata violoncellista Asja Valcic che aveva già collaborato con Mantler nell’incisione dell’album “Jazz Composer’s Orchestra Update”. Coda è stato registrato al “Vienna’s Porgy & Bess Studio” nel settembre del 2019, e missato presso gli studi La Buissonne in Francia.
Mike Melillo – “In Free Association” – Notami
 Il pianista americano Mike Melillo pubblica il suo nuovo album “In Free Association”, tratto da un radio-concerto effettuato nella primavera del 1974 in quartetto con Roy Cumming (contrabbasso), Glenn Davis (batteria) e Harry Leahey (chitarra). Essendo oggi impossibile ammirare ancora questo gruppo data la dipartita di Harry Leahey, l’ascolto di queste registrazioni, finora inedite, risulta ancora più interessante. La genesi del combo viene riassunta brevemente dallo stesso Melillo nelle note che accompagnano l’album. Apprendiamo, così, che inizialmente si trattava di un trio (senza Leahey) per cui Melillo componeva pezzi orchestrali e da camera sperimentali, Nel ’71, con l’arrivo di Leahey, il trio è diventato un quartetto che ha avuto un buon successo grazie alla qualità della musica proposta e che ritroviamo in questo album. In repertorio sei brani di cui tre scritti dal leader e gli altri tre vere e proprie perle del jazz come “Criss Cross” di Thelonious Monk, “Mimi” di Rodgers e Hart e “What’ll I Do” di Irving Berlin. Il tutto a costituire un insieme omogeneo e di grande livello. In effetti quello proposto dal gruppo è un Jazz senza se e senza ma, un jazz che si rifà agli stilemi del bop e dell’hard-bop con un Melillo che mette in evidenza le sue doti migliori. Un pianismo sorretto da una formidabile tecnica di base, che affronta con eguale bravura sia temi particolarmente complessi e sorretti da un ritmo veloce come “Criss Cross” e “See Hunt and Liddy” in cui si fa apprezzare anche la chitarra di Harry Leahey, sia brani più melodici come “A Little Piece” dello stesso Melillo e “What’ll I Do”. Impeccabile la sezione ritmica. Infine una notazione di carattere tecnico: nonostante si tratti di una ripresa da trasmissione radiofonica, la resa complessiva è più che accettabile.
Il pianista americano Mike Melillo pubblica il suo nuovo album “In Free Association”, tratto da un radio-concerto effettuato nella primavera del 1974 in quartetto con Roy Cumming (contrabbasso), Glenn Davis (batteria) e Harry Leahey (chitarra). Essendo oggi impossibile ammirare ancora questo gruppo data la dipartita di Harry Leahey, l’ascolto di queste registrazioni, finora inedite, risulta ancora più interessante. La genesi del combo viene riassunta brevemente dallo stesso Melillo nelle note che accompagnano l’album. Apprendiamo, così, che inizialmente si trattava di un trio (senza Leahey) per cui Melillo componeva pezzi orchestrali e da camera sperimentali, Nel ’71, con l’arrivo di Leahey, il trio è diventato un quartetto che ha avuto un buon successo grazie alla qualità della musica proposta e che ritroviamo in questo album. In repertorio sei brani di cui tre scritti dal leader e gli altri tre vere e proprie perle del jazz come “Criss Cross” di Thelonious Monk, “Mimi” di Rodgers e Hart e “What’ll I Do” di Irving Berlin. Il tutto a costituire un insieme omogeneo e di grande livello. In effetti quello proposto dal gruppo è un Jazz senza se e senza ma, un jazz che si rifà agli stilemi del bop e dell’hard-bop con un Melillo che mette in evidenza le sue doti migliori. Un pianismo sorretto da una formidabile tecnica di base, che affronta con eguale bravura sia temi particolarmente complessi e sorretti da un ritmo veloce come “Criss Cross” e “See Hunt and Liddy” in cui si fa apprezzare anche la chitarra di Harry Leahey, sia brani più melodici come “A Little Piece” dello stesso Melillo e “What’ll I Do”. Impeccabile la sezione ritmica. Infine una notazione di carattere tecnico: nonostante si tratti di una ripresa da trasmissione radiofonica, la resa complessiva è più che accettabile.
Stephan Micus – “Winter’s End” – ECM
 Ascoltare la musica del tedesco Stephan Micus (classe 1953) è come addentrarsi in una foresta incantata, impreziosita da episodi di rara bellezza. Episodi determinati dalle sorprese che in ogni sua avventura questo personaggio ci propone. In qualunque contesto si abbia la fortuna di incontrare l’arte di Micus, la mente vaga ben al di là del contingente, alla ricerca di un approdo che mai risulta facile trovare, e ciò indipendentemente dalla preparazione musicale di ciascuno. Siamo trasportati in un mondo “altro” in cui le certezze vacillano alla ricerca di un qualche appiglio sonoro che ci restituisca punti fermi, conoscenze a cui rifarsi. In effetti la musica di Micus non ammette di essere incasellata in un genere ben preciso per cui si mantiene ben lontana da qualsivoglia proposta commercialmente allettante. Più sopra si accennava alle sorprese che ogni volta il musicista ci riserva: questa volta la novità consiste nell’utilizzo di due strumenti presentati da Micus per la prima volta: il chikulo e il tongue drum. Il primo, come spiega lo stesso Micus nelle note di copertina, è uno xilofono basso del Mozambico utilizzato in gruppi che solitamente comprendono una dozzina di xilofoni, mentre il tongue drum è una scatola di legno originaria dell’Africa che può essere suonata con le mani o con le bacchette. Ora detta così non ci sarebbe alcunché di strano … salvo il fatto che Micus non è solo un compositore e un sorprendente polistrumentista ma un etnomusicologo costantemente in evoluzione e in viaggio, soprattutto in Asia e in Africa, con l’intento di scovare e studiare strumenti desueti, talvolta addirittura dimenticati. Una volta trovati, li modifica con nuove accordature prima di adoperarli, con risultati strabilianti. È impressionante il numero di strumenti che padroneggia, strumenti che si ascoltano nelle musiche originali di tutti i continenti. Ciò detto risulta facile immaginare la musica di quest’ultimo album in cui Micus, come al solito in assoluta solitudine, ci racconta a modo suo il fluire della vita attraverso il succedersi delle stagioni. Un album sicuramente impegnativo ma altrettanto certamente di sicuro interesse.
Ascoltare la musica del tedesco Stephan Micus (classe 1953) è come addentrarsi in una foresta incantata, impreziosita da episodi di rara bellezza. Episodi determinati dalle sorprese che in ogni sua avventura questo personaggio ci propone. In qualunque contesto si abbia la fortuna di incontrare l’arte di Micus, la mente vaga ben al di là del contingente, alla ricerca di un approdo che mai risulta facile trovare, e ciò indipendentemente dalla preparazione musicale di ciascuno. Siamo trasportati in un mondo “altro” in cui le certezze vacillano alla ricerca di un qualche appiglio sonoro che ci restituisca punti fermi, conoscenze a cui rifarsi. In effetti la musica di Micus non ammette di essere incasellata in un genere ben preciso per cui si mantiene ben lontana da qualsivoglia proposta commercialmente allettante. Più sopra si accennava alle sorprese che ogni volta il musicista ci riserva: questa volta la novità consiste nell’utilizzo di due strumenti presentati da Micus per la prima volta: il chikulo e il tongue drum. Il primo, come spiega lo stesso Micus nelle note di copertina, è uno xilofono basso del Mozambico utilizzato in gruppi che solitamente comprendono una dozzina di xilofoni, mentre il tongue drum è una scatola di legno originaria dell’Africa che può essere suonata con le mani o con le bacchette. Ora detta così non ci sarebbe alcunché di strano … salvo il fatto che Micus non è solo un compositore e un sorprendente polistrumentista ma un etnomusicologo costantemente in evoluzione e in viaggio, soprattutto in Asia e in Africa, con l’intento di scovare e studiare strumenti desueti, talvolta addirittura dimenticati. Una volta trovati, li modifica con nuove accordature prima di adoperarli, con risultati strabilianti. È impressionante il numero di strumenti che padroneggia, strumenti che si ascoltano nelle musiche originali di tutti i continenti. Ciò detto risulta facile immaginare la musica di quest’ultimo album in cui Micus, come al solito in assoluta solitudine, ci racconta a modo suo il fluire della vita attraverso il succedersi delle stagioni. Un album sicuramente impegnativo ma altrettanto certamente di sicuro interesse.
Mirabassi – Di Modugno – Balducci – “Tabacco e caffè” – Dodicilune
 Così come nello sport non basta assemblare ottimi giocatori per fare una buona squadra, così nella musica non è detto che tre pur bravi musicisti riescano a produrre qualcosa di buono. Certo che se poi i tre musicisti rispondono ai nomi di Gabriele Mirabassi al clarinetto, Nando Di Modugno alla chitarra e Pierluigi Balducci alla chitarra basso le probabilità di ascoltare dell’ottima musica aumentano… e di tanto. Ed in effetti ottima musica è quella che si ascolta in questo “Tabacco e caffè” registrato sei anni dopo “Amori sospesi” che vedeva impegnato lo stesso trio. La linea ispirativa rimane sostanzialmente la stessa: una sorta di viaggio sulla rotta Mediterraneo, America del Sud attraverso un linguaggio originale in cui coesistono jazz, folk, tradizione classica. E non è certo un caso che in repertorio figurino nove brani di cui quattro composizioni originali rispettivamente di Mirabassi (“Espinha de truta”), Di Modugno (“Salgado”) e Balducci (“Tobaco y cafè” e “La ballata dei giorni piovosi”) e cinque riletture di brani più o meno celebri di Toninho Horta (“Party in Olinda”), Henry Mancini (“Two for the road”), Egberto Gismonti (“Frevo”), Guinga (“Ellingtoniana”) e della conclusiva “Choro bandido” firmata da Edu Lobo e Chico Buarque. Indipendentemente dal pezzo affrontato, l’interpretazione rimane calda, oseremmo dire intimista, con i tre che dialogano piacevolmente, in piena rilassatezza senza un solo momento in cui il trio sembra spinto verso lidi che non siano comuni ai tre. Interessanti le note di copertina di Gabriele Mirabassi in cui il clarinettista illustra l’importanza del tabacco e del caffè considerati vizi ma che in realtà “più di tutto sono modi di stare insieme. In Italia poi, veri fondamenti della cultura nazionale”.
Così come nello sport non basta assemblare ottimi giocatori per fare una buona squadra, così nella musica non è detto che tre pur bravi musicisti riescano a produrre qualcosa di buono. Certo che se poi i tre musicisti rispondono ai nomi di Gabriele Mirabassi al clarinetto, Nando Di Modugno alla chitarra e Pierluigi Balducci alla chitarra basso le probabilità di ascoltare dell’ottima musica aumentano… e di tanto. Ed in effetti ottima musica è quella che si ascolta in questo “Tabacco e caffè” registrato sei anni dopo “Amori sospesi” che vedeva impegnato lo stesso trio. La linea ispirativa rimane sostanzialmente la stessa: una sorta di viaggio sulla rotta Mediterraneo, America del Sud attraverso un linguaggio originale in cui coesistono jazz, folk, tradizione classica. E non è certo un caso che in repertorio figurino nove brani di cui quattro composizioni originali rispettivamente di Mirabassi (“Espinha de truta”), Di Modugno (“Salgado”) e Balducci (“Tobaco y cafè” e “La ballata dei giorni piovosi”) e cinque riletture di brani più o meno celebri di Toninho Horta (“Party in Olinda”), Henry Mancini (“Two for the road”), Egberto Gismonti (“Frevo”), Guinga (“Ellingtoniana”) e della conclusiva “Choro bandido” firmata da Edu Lobo e Chico Buarque. Indipendentemente dal pezzo affrontato, l’interpretazione rimane calda, oseremmo dire intimista, con i tre che dialogano piacevolmente, in piena rilassatezza senza un solo momento in cui il trio sembra spinto verso lidi che non siano comuni ai tre. Interessanti le note di copertina di Gabriele Mirabassi in cui il clarinettista illustra l’importanza del tabacco e del caffè considerati vizi ma che in realtà “più di tutto sono modi di stare insieme. In Italia poi, veri fondamenti della cultura nazionale”.
Dino Plasmati, Antonio Tosques, Guitar Quartet – “On Air” – Caligola
 Dino Plasmati chitarra, Antonio Tosques chitarra, Bruno Montrone organo e Marcello Nisi batteria sono i protagonisti di questa nuova produzione firmata Caligola. Particolarmente impegnativo il programma dal momento che comprende una serie di brani ‘storici’ con un solo pezzo originale scritto da Plasmati, “Boundless Energy”. Come recita il nome del gruppo, a indirizzare il tutto sono le due chitarre di Plasmati e Tosques suonate con tecnica tradizionale, senza cioè l’ausilio dell’elettronica, e questa “guida” si avverte ben certa per tutta la durata dell’album anche se non mancano, ovviamente, momenti in cui in primo piano sale l’Organo Hammond nelle sapienti mani di Bruno Montone; è il caso dell’original cui si faceva riferimento. Per il resto i due leader guidano il gruppo con mano sicura per nell’affrontare temi che sulla carta mal si prestano ad interpretazioni chitarristiche: è il caso ad esempio del brano d’apertura, “Airegin”, scritto da Sonny Rollins. Ma da questo punto di vista le sorprese non mancano: ecco quindi la convincente disinvoltura con cui eseguono “Your own Sweet Way” di Dave Brubeck o la delicatezza con cui cesellano “I’ve Accustomed to Her Face” di Loewe Lerner complice anche il bel lavoro di Montrone all’Hammond. O ancora la pertinenza di linguaggio con i ritmi sudamericani di “When Sunny Gets Blue” di Fisher-Segal, in cui si apprezza anche l’eccellente supporto di Nisi alla batteria. A chiudere una convincente interpretazione del colemaniano “Turnaround” eseguito dai due chitarristi senza sezione ritmica.
Dino Plasmati chitarra, Antonio Tosques chitarra, Bruno Montrone organo e Marcello Nisi batteria sono i protagonisti di questa nuova produzione firmata Caligola. Particolarmente impegnativo il programma dal momento che comprende una serie di brani ‘storici’ con un solo pezzo originale scritto da Plasmati, “Boundless Energy”. Come recita il nome del gruppo, a indirizzare il tutto sono le due chitarre di Plasmati e Tosques suonate con tecnica tradizionale, senza cioè l’ausilio dell’elettronica, e questa “guida” si avverte ben certa per tutta la durata dell’album anche se non mancano, ovviamente, momenti in cui in primo piano sale l’Organo Hammond nelle sapienti mani di Bruno Montone; è il caso dell’original cui si faceva riferimento. Per il resto i due leader guidano il gruppo con mano sicura per nell’affrontare temi che sulla carta mal si prestano ad interpretazioni chitarristiche: è il caso ad esempio del brano d’apertura, “Airegin”, scritto da Sonny Rollins. Ma da questo punto di vista le sorprese non mancano: ecco quindi la convincente disinvoltura con cui eseguono “Your own Sweet Way” di Dave Brubeck o la delicatezza con cui cesellano “I’ve Accustomed to Her Face” di Loewe Lerner complice anche il bel lavoro di Montrone all’Hammond. O ancora la pertinenza di linguaggio con i ritmi sudamericani di “When Sunny Gets Blue” di Fisher-Segal, in cui si apprezza anche l’eccellente supporto di Nisi alla batteria. A chiudere una convincente interpretazione del colemaniano “Turnaround” eseguito dai due chitarristi senza sezione ritmica.
Emanuele Sartoris, Daniele Di Bonaventura – “Notturni” – Caligola
 Ancora un duo e ancora bella musica. Protagonisti Emanuele Sartoris al pianoforte e Daniele Di Bonaventura al bandoneon. Vista la struttura dell’organico, si poteva temere una certa staticità dell’album a discapito del possibile interesse dell’ascoltatore. Pericolo assolutamente evitato dai due artisti che invece sfoggiano una verve fantastica dando vita a otto composizioni originali scritte dai due singolarmente o in cooperazione, che tengono desta l’attenzione dalla prima all’ultima nota. Merito da un canto della bellezza dei temi tutti caratterizzati da un’accurata ricerca melodica, dall’altro dalla perizia strumentale dei due che pur non sfoggiando alcuna particolare ricercatezza tecnica, suonano comunque con grande partecipazione e intensità. Doti che non si affievoliscono – anzi – quando decidono di reinterpretare due notturni di Chopin vale a dire il Notturno op.9 n.1 e il Notturno op.9 n.2, che non a caso aprono e chiudono l’album. Insomma un disco più che interessante scaturito dall’incontro tra il pianoforte di Emanuele Sartoris, musicista che ben conosce anche la musica classica, e il bandoneon di Daniele di Bonaventura, uno dei maggiori interpreti internazionali dello strumento. Un disco che sembra quasi invitarci ad una sorta di viaggio interiore alla scoperta di ciò che è veramente importante. E ci piace chiudere questa breve presentazione citando le parole con cui il violoncellista di fama internazionale Mario Brunello conclude le sue preziose note di copertina: “Un viaggio slow, un cammino nel vissuto della musica, a cui si aggiungono le improvvisazioni e l’ispirazione di due formidabili e coraggiosi musicisti che hanno il talento sincero per avvicinarsi ed addentrarsi nella magica atmosfera dei Notturni”.
Ancora un duo e ancora bella musica. Protagonisti Emanuele Sartoris al pianoforte e Daniele Di Bonaventura al bandoneon. Vista la struttura dell’organico, si poteva temere una certa staticità dell’album a discapito del possibile interesse dell’ascoltatore. Pericolo assolutamente evitato dai due artisti che invece sfoggiano una verve fantastica dando vita a otto composizioni originali scritte dai due singolarmente o in cooperazione, che tengono desta l’attenzione dalla prima all’ultima nota. Merito da un canto della bellezza dei temi tutti caratterizzati da un’accurata ricerca melodica, dall’altro dalla perizia strumentale dei due che pur non sfoggiando alcuna particolare ricercatezza tecnica, suonano comunque con grande partecipazione e intensità. Doti che non si affievoliscono – anzi – quando decidono di reinterpretare due notturni di Chopin vale a dire il Notturno op.9 n.1 e il Notturno op.9 n.2, che non a caso aprono e chiudono l’album. Insomma un disco più che interessante scaturito dall’incontro tra il pianoforte di Emanuele Sartoris, musicista che ben conosce anche la musica classica, e il bandoneon di Daniele di Bonaventura, uno dei maggiori interpreti internazionali dello strumento. Un disco che sembra quasi invitarci ad una sorta di viaggio interiore alla scoperta di ciò che è veramente importante. E ci piace chiudere questa breve presentazione citando le parole con cui il violoncellista di fama internazionale Mario Brunello conclude le sue preziose note di copertina: “Un viaggio slow, un cammino nel vissuto della musica, a cui si aggiungono le improvvisazioni e l’ispirazione di due formidabili e coraggiosi musicisti che hanno il talento sincero per avvicinarsi ed addentrarsi nella magica atmosfera dei Notturni”.
Thomas Strønen, Ayumi Tanaka, Marthe Lea – “Bayou” – ECM
 Album d’esordio per questo trio composto dal batterista Thomas Strønen, dalla pianista Ayumi Tanaka e dalla clarinettista, vocalist, percussionista Marthe Lea. L’album si inserisce in quella corrente che a partire dagli anni ’70 ha portato il jazz norvegese ai massimi livelli delle scene jazzistiche internazionali. Vale a dire una musica che si rifà al patrimonio folkloristico delle popolazioni nordiche (in particolare norvegesi) declinata attraverso un linguaggio che incorpora elementi tratti dal jazz, dalla musica classica e ovviamente dal folk. Non a caso in programma ci sono dieci brani tutti scritti dai tre musicisti ma tutti basati sul folk norvegese. Quindi una musica delicata, intimista, che affronta spazi aperti quali sono quelli che si aprono alla nostra mente quando pensiamo ai paesaggi nordici. Ascoltare l’intero album è un’esperienza singolare tanto che ad un certo punto è come se il concetto spazio-temporale si perda per assorbici totalmente nell’atmosfera creata dai tre musicisti che denotano, improvvisando costantemente, un affiatamento non comune. D’altro canto la genesi del gruppo spiega la ragione di tale empatia: dapprima si trattava di un duo composto da pianista e batterista cui in un secondo tempo si è aggiunta Marthe Lea. I tre si sono, quindi, trovati assieme alla “Oslo’s Royal Academy of Music” dove per ben due anni hanno provato assieme ogni settimana alla ricerca di un quid che permettesse loro di suonare musica improvvisata. Evidentemente questo quid l’hanno trovato e così è nato questo “Bayou” frutto come afferma lo stesso Strønen di quelle esperienze: “Noi suonavamo sempre liberamente – afferma – mescolando elementi di musica classica contemporanea, folk, jazz, a seconda di come ciascuno di noi era ispirato al momento. Alle volte la musica era molto calma, delicata e minimalista: suonando assieme si sono generate alcune speciali esperienze”: Quelle stesse esperienze che si avvertono ascoltando l’album.
Album d’esordio per questo trio composto dal batterista Thomas Strønen, dalla pianista Ayumi Tanaka e dalla clarinettista, vocalist, percussionista Marthe Lea. L’album si inserisce in quella corrente che a partire dagli anni ’70 ha portato il jazz norvegese ai massimi livelli delle scene jazzistiche internazionali. Vale a dire una musica che si rifà al patrimonio folkloristico delle popolazioni nordiche (in particolare norvegesi) declinata attraverso un linguaggio che incorpora elementi tratti dal jazz, dalla musica classica e ovviamente dal folk. Non a caso in programma ci sono dieci brani tutti scritti dai tre musicisti ma tutti basati sul folk norvegese. Quindi una musica delicata, intimista, che affronta spazi aperti quali sono quelli che si aprono alla nostra mente quando pensiamo ai paesaggi nordici. Ascoltare l’intero album è un’esperienza singolare tanto che ad un certo punto è come se il concetto spazio-temporale si perda per assorbici totalmente nell’atmosfera creata dai tre musicisti che denotano, improvvisando costantemente, un affiatamento non comune. D’altro canto la genesi del gruppo spiega la ragione di tale empatia: dapprima si trattava di un duo composto da pianista e batterista cui in un secondo tempo si è aggiunta Marthe Lea. I tre si sono, quindi, trovati assieme alla “Oslo’s Royal Academy of Music” dove per ben due anni hanno provato assieme ogni settimana alla ricerca di un quid che permettesse loro di suonare musica improvvisata. Evidentemente questo quid l’hanno trovato e così è nato questo “Bayou” frutto come afferma lo stesso Strønen di quelle esperienze: “Noi suonavamo sempre liberamente – afferma – mescolando elementi di musica classica contemporanea, folk, jazz, a seconda di come ciascuno di noi era ispirato al momento. Alle volte la musica era molto calma, delicata e minimalista: suonando assieme si sono generate alcune speciali esperienze”: Quelle stesse esperienze che si avvertono ascoltando l’album.
Trøen, Arbesen Quartet – “Tread Lightly” – Losen
 La sassofonista norvegese Elisabeth Lid Trøen (eccellente anche al flauto) si presenta alla testa di un quartetto con Dag Arnesen al piano, Ole Marius Sandberg al basso e Sigurd Steinkopf alla batteria. Il repertorio è costituito da dieci brani di cui otto scritti dalla leader e due dal pianista. Due le linee direttrici dell’album: da un canto la ricerca della linea melodica, dall’altro la capacità di improvvisare sulla stessa. Per rendersi conto, ad esempio, della capacità dei quattro di tener fede a quanto sopra detto basta ascoltare “Just Thinking”: il brano si apre su tempo lento con una linea perfettamente riconoscibile ma dopo l’esposizione del tema con la Trøen al flauto ecco un assolo di pianoforte che si avventura nelle pieghe del brano per scoprirne e lumeggiarne ogni più nascosto anfratto mentre sul finale si riascolta il flauto della leader. “Sarah’s Bounce” si apre a tempo di marcia sospinta dalla batteria di Steinkopf il quale, nello scorrere del brano, dimostra di poter avere anche un approccio melodico allo strumento. In ogni caso il pallino resta nelle mani di sassofonista e pianista che dimostrano di essere complementari nel loro linguaggio dato che le sortite solistiche dell’una vengono riprese ed rilanciate a tutto tondo dall’altro. Altro brano particolarmente interessante “Partysvensken” che si distacca piuttosto nettamente dalle atmosfere degli altri brani data la sua vicinanza, in alcuni momenti, agli stilemi del free jazz. L’album si chiude con “Denne” il pezzo che maggiormente richiama le atmosfere nordiche grazie soprattutto ad un meditativo assolo del pianista; di rilievo anche l’assolo del bassista Ole Marius Sandberg. Ma a proposito di atmosfere nordiche, l’ascoltatore più attento non potrà non rilevare qua e là, spiccate influenze della musica popolare norvegese che tanta importanza ha avuto sulla musica di quel Paese grazie ad artisti quali Jan Garbarek e Terje Rypdal.
La sassofonista norvegese Elisabeth Lid Trøen (eccellente anche al flauto) si presenta alla testa di un quartetto con Dag Arnesen al piano, Ole Marius Sandberg al basso e Sigurd Steinkopf alla batteria. Il repertorio è costituito da dieci brani di cui otto scritti dalla leader e due dal pianista. Due le linee direttrici dell’album: da un canto la ricerca della linea melodica, dall’altro la capacità di improvvisare sulla stessa. Per rendersi conto, ad esempio, della capacità dei quattro di tener fede a quanto sopra detto basta ascoltare “Just Thinking”: il brano si apre su tempo lento con una linea perfettamente riconoscibile ma dopo l’esposizione del tema con la Trøen al flauto ecco un assolo di pianoforte che si avventura nelle pieghe del brano per scoprirne e lumeggiarne ogni più nascosto anfratto mentre sul finale si riascolta il flauto della leader. “Sarah’s Bounce” si apre a tempo di marcia sospinta dalla batteria di Steinkopf il quale, nello scorrere del brano, dimostra di poter avere anche un approccio melodico allo strumento. In ogni caso il pallino resta nelle mani di sassofonista e pianista che dimostrano di essere complementari nel loro linguaggio dato che le sortite solistiche dell’una vengono riprese ed rilanciate a tutto tondo dall’altro. Altro brano particolarmente interessante “Partysvensken” che si distacca piuttosto nettamente dalle atmosfere degli altri brani data la sua vicinanza, in alcuni momenti, agli stilemi del free jazz. L’album si chiude con “Denne” il pezzo che maggiormente richiama le atmosfere nordiche grazie soprattutto ad un meditativo assolo del pianista; di rilievo anche l’assolo del bassista Ole Marius Sandberg. Ma a proposito di atmosfere nordiche, l’ascoltatore più attento non potrà non rilevare qua e là, spiccate influenze della musica popolare norvegese che tanta importanza ha avuto sulla musica di quel Paese grazie ad artisti quali Jan Garbarek e Terje Rypdal.
Blues Connection – “Italian Way to Feel Blues” – Notami
 E’ con vero piacere che vi segnalo questo “Italian Way to Feel Blues” non solo per la validità del progetto ma anche perché è presente un musicista a cui sono legato da particolari legami affettivi, un organista che ho conosciuto quando ancora abitavo in Sicilia (quindi primissimi anni ’70) e che ancora a mio avviso non ha ottenuto i riconoscimenti che merita. Sto parlando di Pippo Guarnera nell’occasione non solo all’organo Hammond ma anche al pianoforte. Oltre a lui e ovviamente al leader Vince Vallicelli alle percussioni, troviamo Nahuel Schiumarini alla chitarra elettrica, Andrea Valeri alla chitarra acustica, Roberto Luti al dobro e Felice Del Gaudio al basso. Come si può facilmente intuire da quanto sin qui detto, la musica è trascinante con tutti gli artisti in grado di ritagliarsi importanti spazi di improvvisazione. Ecco quindi Pippo Guarnera primeggiare all’organo in “Art” di Vallicelli, per lasciare successivamente spazio alle chitarre di Schiumarini e Valeri nonché al dobro di Roberto Luti, il tutto sorretto da una metronomica sezione ritmica con batteria e basso che non sbagliano un colpo. Insomma musica che fa battere il classico piedino sia che si affrontino temi originali (ben sette sui nove proposti dall’album) sia che si rileggano pagine importanti come “After Hours” di Avery Parrish standard jazz tra i più eseguiti che venne registrato per la prima volta dal suo stesso autore con la Erskine Hawkins Orchestra, il 10 giugno 1940 o “Windy e Warm” di John D. Loudermilk considerato a ben ragione un classico del fingerstyle, ripreso da artisti di assoluto livello quali Chet Atkins, Doc Watson e Tommy Emmanuel.
E’ con vero piacere che vi segnalo questo “Italian Way to Feel Blues” non solo per la validità del progetto ma anche perché è presente un musicista a cui sono legato da particolari legami affettivi, un organista che ho conosciuto quando ancora abitavo in Sicilia (quindi primissimi anni ’70) e che ancora a mio avviso non ha ottenuto i riconoscimenti che merita. Sto parlando di Pippo Guarnera nell’occasione non solo all’organo Hammond ma anche al pianoforte. Oltre a lui e ovviamente al leader Vince Vallicelli alle percussioni, troviamo Nahuel Schiumarini alla chitarra elettrica, Andrea Valeri alla chitarra acustica, Roberto Luti al dobro e Felice Del Gaudio al basso. Come si può facilmente intuire da quanto sin qui detto, la musica è trascinante con tutti gli artisti in grado di ritagliarsi importanti spazi di improvvisazione. Ecco quindi Pippo Guarnera primeggiare all’organo in “Art” di Vallicelli, per lasciare successivamente spazio alle chitarre di Schiumarini e Valeri nonché al dobro di Roberto Luti, il tutto sorretto da una metronomica sezione ritmica con batteria e basso che non sbagliano un colpo. Insomma musica che fa battere il classico piedino sia che si affrontino temi originali (ben sette sui nove proposti dall’album) sia che si rileggano pagine importanti come “After Hours” di Avery Parrish standard jazz tra i più eseguiti che venne registrato per la prima volta dal suo stesso autore con la Erskine Hawkins Orchestra, il 10 giugno 1940 o “Windy e Warm” di John D. Loudermilk considerato a ben ragione un classico del fingerstyle, ripreso da artisti di assoluto livello quali Chet Atkins, Doc Watson e Tommy Emmanuel.
da Amedeo Furfaro | 07/Mag/2021 | I nostri CD, Recensioni

Stefano Bollani – “El Chakracanta” –
 Se allo Steinway e Sons siede Stefano Bollani ed al suo cospetto sta un’orchestra “tipica” come la Sin Fin diretta da Exequeil Mantega, non si sa se aspettarsi un’atmosfera più jazz o più classica avendo ben nota la versatilità del musicista a destreggiarsi in più ambiti e “ambienti”. Se si guarda al “Concerto Azzurro” che impegna e impregna una buona mezzora dell’album Alobar “El Chakracanta, Live in Buenos Aires”, commissionatogli da Kristjan Järvi e dalla MDR – Leipzig Radio Symphony di Lipsia, se ne constata la struttura classica di base in tempi allegro, adagio ed allegro molto. Una suddivisione che peraltro lascia ampio spazio alla libertà ed all’improvvisazione dell’interprete-compositore Bollani nello schema orchestrale disegnato da Paolo Silvestri. La risposta data dall’ascolto ha due facce che diventano una poiché sin dalle prime note se ne evidenzia l’impasto ibrido che coniuga latin tinge e mood nordamericano, emisferi coesi da una tastiera cosparsa di riflessi timbrici di quel nuovo mondo che incuriosí Debussy, Poulenc, Ravel…misti a spirito contemporaneo. L’azzurro è il colore del quinto chakra, della gola, ed è quello, come osserva lo stesso pianista in un web/video del Centro Culturale Kirchner di Baires “che sovraintende alla espressione”. Per farlo “star bene” è utile che si dica quello che si ha da dire e si esprima ciò che si vuole esprimere in un dato momento della vita. Ed il jazzista, in questa particolare fase della propria carriera artistica, sta denudando sempre più un’anima spanish che va ad infonderne sia la vis compositiva che la pratica esecutiva. Lavoro di ampio respiro melodico è quindi “Concerto Verde” dove il pigmento bollaniano, intinto nel quarto Chakra del Cuore e dell’Amore, si cimenta in un saliscendi di sincopi e contrattempi di tanghi e milonghe collocate in quel suolo in cui il pianista ha esportato, oltre ad un certo estro mozartiano, una valigia zeppa di suoni ed armonie. Il disco è completato da due brani arrangiati ed orchestrati da Diego Schissi, il piazzolliano “Libertango”, doveroso omaggio all’ideatore del Nuevo Tango e “Don Agustín Bardi”, di Horacio Salgán, che la performance con l’orchestra trasforma in rito collettivo di tributo ad un altro grande musicista argentino.
Se allo Steinway e Sons siede Stefano Bollani ed al suo cospetto sta un’orchestra “tipica” come la Sin Fin diretta da Exequeil Mantega, non si sa se aspettarsi un’atmosfera più jazz o più classica avendo ben nota la versatilità del musicista a destreggiarsi in più ambiti e “ambienti”. Se si guarda al “Concerto Azzurro” che impegna e impregna una buona mezzora dell’album Alobar “El Chakracanta, Live in Buenos Aires”, commissionatogli da Kristjan Järvi e dalla MDR – Leipzig Radio Symphony di Lipsia, se ne constata la struttura classica di base in tempi allegro, adagio ed allegro molto. Una suddivisione che peraltro lascia ampio spazio alla libertà ed all’improvvisazione dell’interprete-compositore Bollani nello schema orchestrale disegnato da Paolo Silvestri. La risposta data dall’ascolto ha due facce che diventano una poiché sin dalle prime note se ne evidenzia l’impasto ibrido che coniuga latin tinge e mood nordamericano, emisferi coesi da una tastiera cosparsa di riflessi timbrici di quel nuovo mondo che incuriosí Debussy, Poulenc, Ravel…misti a spirito contemporaneo. L’azzurro è il colore del quinto chakra, della gola, ed è quello, come osserva lo stesso pianista in un web/video del Centro Culturale Kirchner di Baires “che sovraintende alla espressione”. Per farlo “star bene” è utile che si dica quello che si ha da dire e si esprima ciò che si vuole esprimere in un dato momento della vita. Ed il jazzista, in questa particolare fase della propria carriera artistica, sta denudando sempre più un’anima spanish che va ad infonderne sia la vis compositiva che la pratica esecutiva. Lavoro di ampio respiro melodico è quindi “Concerto Verde” dove il pigmento bollaniano, intinto nel quarto Chakra del Cuore e dell’Amore, si cimenta in un saliscendi di sincopi e contrattempi di tanghi e milonghe collocate in quel suolo in cui il pianista ha esportato, oltre ad un certo estro mozartiano, una valigia zeppa di suoni ed armonie. Il disco è completato da due brani arrangiati ed orchestrati da Diego Schissi, il piazzolliano “Libertango”, doveroso omaggio all’ideatore del Nuevo Tango e “Don Agustín Bardi”, di Horacio Salgán, che la performance con l’orchestra trasforma in rito collettivo di tributo ad un altro grande musicista argentino.
Francesco Chiapperini – “On The Bare Rocks and Glaciers” – Caligola Records.
 Ogni montagna è, a modo suo, incantata. Sarà la maestosità, sarà il senso di infinito che ispira il contemplarla, sarà la magia che la ricopre… la montagna ha dei suoni; ed ha degli echi, oltre quelli naturali, che le provengono dal passato, dalla storia che ne ha attraversato rocce, valichi, passi, sentieri, versanti, ghiacciai… Il clarinettista Francesco Chiapperini ha inteso dedicare l’album “On The Bare Rocks and Glaciers” (Caligola Records) al mondo alpino riprendendo il titolo del lavoro dalla “Preghiera degli Alpini” di Giovanni Veneri recitata in chiusura dall’ospite Maurizio Arena. Con un sestetto di taglio cameristico, formato da un “coro” di fiati (Vito Emanuele Galante, tromba; Mario Mariotti, cornet; Roger Roota, bassoon, Andrea Ferrari, sax baritono) e un violino (Virginia Sutera) ha inteso ricreare una particolare coralità che consentisse la rappresentazione musicale di un ambiente che è stato testimone di vicende umane, anche quelle più tragiche come la guerra. La sensazione che si avverte nelle diciotto tracce, tutte in tema, alcune tradizionali altre di autori come Steve Swallow (“The Green Mountains”), Pergolesi (“Stabat Mater”), Grieg (“I Dovregubbens Hall”) oltre che di Chiapperini, Bregani, Malatesta, De Marzi, è di una pervadente wilderness tutta spirituale. L’ incontaminata “altezza” è “scalata” da note musicali che quasi paiono arrampicarsi in cordata per trasmetterci l’ebbrezza dell’altitudine. Un’impressione che viene interrotta a volte da valanghe di suoni per poi rientrare nell’atmosfera composta di un sempre millenario, fra i deserti d’alta quota di una montagna bella impossibile.
Ogni montagna è, a modo suo, incantata. Sarà la maestosità, sarà il senso di infinito che ispira il contemplarla, sarà la magia che la ricopre… la montagna ha dei suoni; ed ha degli echi, oltre quelli naturali, che le provengono dal passato, dalla storia che ne ha attraversato rocce, valichi, passi, sentieri, versanti, ghiacciai… Il clarinettista Francesco Chiapperini ha inteso dedicare l’album “On The Bare Rocks and Glaciers” (Caligola Records) al mondo alpino riprendendo il titolo del lavoro dalla “Preghiera degli Alpini” di Giovanni Veneri recitata in chiusura dall’ospite Maurizio Arena. Con un sestetto di taglio cameristico, formato da un “coro” di fiati (Vito Emanuele Galante, tromba; Mario Mariotti, cornet; Roger Roota, bassoon, Andrea Ferrari, sax baritono) e un violino (Virginia Sutera) ha inteso ricreare una particolare coralità che consentisse la rappresentazione musicale di un ambiente che è stato testimone di vicende umane, anche quelle più tragiche come la guerra. La sensazione che si avverte nelle diciotto tracce, tutte in tema, alcune tradizionali altre di autori come Steve Swallow (“The Green Mountains”), Pergolesi (“Stabat Mater”), Grieg (“I Dovregubbens Hall”) oltre che di Chiapperini, Bregani, Malatesta, De Marzi, è di una pervadente wilderness tutta spirituale. L’ incontaminata “altezza” è “scalata” da note musicali che quasi paiono arrampicarsi in cordata per trasmetterci l’ebbrezza dell’altitudine. Un’impressione che viene interrotta a volte da valanghe di suoni per poi rientrare nell’atmosfera composta di un sempre millenario, fra i deserti d’alta quota di una montagna bella impossibile.
Luca DalPozzo Quintet – “Rust” – Nusica.org
 Luca DalPozzo, contrabbassista leader del 5et che annovera Frank Martino alla chitarra, Manuel Caliumi all’alto sax, Giulio Stermieri al piano e Marco Frattini alla batteria, ha concepito l’album “Rust” dopo essere rimasto folgorato, durante una visita in una mostra bolognese nel 2018, dalle opere di Hiroshige e di Hokusai. La pittura di quest’ultimo, in particolare, ispirata a “immagini del mondo fluttuante” nel Giappone di inizio ottocento, consta di vedute dall’alto, contorni dettagliati, ed è antesignana di prospettiva. Dal canto suo, l’incisore Hiroshige, suo contemporaneo, fu un grande “paesaggista” il cui tratto figurativo venne apprezzato dagli stessi impressionisti in Europa. Si intende allora l’input di questo disco il cui titolo lo si può riferire al noto videogioco od all’omologo linguaggio di programmazione, certamente Rust non starà per ruggine a volerne seguire la traduzione letterale. All’origine vi sono due figure simbolo del movimento “Ukiyo-E” a cui è dedicato l’incipit fra le sette tracce del cd. E già lì la musica del 5et appare di ondulata viralità ed eclissante circolarità nell’iniettarsi lo spirito di quell’antica arte nipponica ed applicarla al contemporary. Che diventa fusion in “Alamar” per rientrare, dopo la soffusa “Day a Dream”, al guscio di suggestioni dettate da Ligeti in “Gyorgy Cluster Dance”: grappoli di acciaccature a sovraintendere le iterazioni in chiave di basso e di violino verso un effetto d’insieme scioccante e talora stralunante. Ancora. “Swirl” è caratterizzata da un tempo increspato, indistinto, fuzzy, con progressioni armoniche libere un pò alla Ornette Coleman. “Upward Drop” è un brano pregno di riverberazioni e riflessi siamo cioè ancora nel grembo di una musica in qualche modo “di rappresentazione”. Carattere che il conclusivo “Blues for Larry (going ballistic)” non fa che confermare per capacità traslativa di idee in note musicali.
Luca DalPozzo, contrabbassista leader del 5et che annovera Frank Martino alla chitarra, Manuel Caliumi all’alto sax, Giulio Stermieri al piano e Marco Frattini alla batteria, ha concepito l’album “Rust” dopo essere rimasto folgorato, durante una visita in una mostra bolognese nel 2018, dalle opere di Hiroshige e di Hokusai. La pittura di quest’ultimo, in particolare, ispirata a “immagini del mondo fluttuante” nel Giappone di inizio ottocento, consta di vedute dall’alto, contorni dettagliati, ed è antesignana di prospettiva. Dal canto suo, l’incisore Hiroshige, suo contemporaneo, fu un grande “paesaggista” il cui tratto figurativo venne apprezzato dagli stessi impressionisti in Europa. Si intende allora l’input di questo disco il cui titolo lo si può riferire al noto videogioco od all’omologo linguaggio di programmazione, certamente Rust non starà per ruggine a volerne seguire la traduzione letterale. All’origine vi sono due figure simbolo del movimento “Ukiyo-E” a cui è dedicato l’incipit fra le sette tracce del cd. E già lì la musica del 5et appare di ondulata viralità ed eclissante circolarità nell’iniettarsi lo spirito di quell’antica arte nipponica ed applicarla al contemporary. Che diventa fusion in “Alamar” per rientrare, dopo la soffusa “Day a Dream”, al guscio di suggestioni dettate da Ligeti in “Gyorgy Cluster Dance”: grappoli di acciaccature a sovraintendere le iterazioni in chiave di basso e di violino verso un effetto d’insieme scioccante e talora stralunante. Ancora. “Swirl” è caratterizzata da un tempo increspato, indistinto, fuzzy, con progressioni armoniche libere un pò alla Ornette Coleman. “Upward Drop” è un brano pregno di riverberazioni e riflessi siamo cioè ancora nel grembo di una musica in qualche modo “di rappresentazione”. Carattere che il conclusivo “Blues for Larry (going ballistic)” non fa che confermare per capacità traslativa di idee in note musicali.
Francesco Maccianti – “Attese” – Abeat
 La solitudine dei numeri primi ha nell’uno, nell’unità, una dimensione tutta sua. Può essere isolamento misantropico, autoesilio individualistico, autoconfinamento ma può significare ritiro spirituale, (ri)pensamento solipsistico, monologo interiore. Che tale non è più nel momento in cui ci si esteriorizza per il tramite, ad esempio, della musica.
La solitudine dei numeri primi ha nell’uno, nell’unità, una dimensione tutta sua. Può essere isolamento misantropico, autoesilio individualistico, autoconfinamento ma può significare ritiro spirituale, (ri)pensamento solipsistico, monologo interiore. Che tale non è più nel momento in cui ci si esteriorizza per il tramite, ad esempio, della musica.
Cosa che fa il pianista-compositore Francesco Maccianti con l’album per piano solo “Attese. Live at Lyceum Club Internazionale di Firenze”, pubblicato da Abeat. Questi, dopo aver immesso una sorta di microspia che ne registra la “confessione” live, si espone al pubblico apprezzamento di una platea potenzialmente più vasta, gli ascoltatori del cd, rispetto agli spettatori della sala concerti toscana che nel disco applaude vivamente. La qual cosa, specie in un momento di fermo dei concerti, a dir poco scuote in senso positivo. Già perché cosí anche il suono “da remoto” che offre il cd, specie se ripetuto, anche se monco dell’impressione d’ambleu che è quella che in genere può folgorare, o lasciar di sasso, ma non è questo il caso, consente di capire. Carpire, captare le nicchie più riposte di una musica pianistica fatta di ridondanze (‘Cubic Dance’) ed echi (‘Falling Up’), di modi razionali (‘Attese’) e fragori improvvisi (‘Hombres’), immersioni catartiche (‘Solstizio’) e ridondanze (‘Palomar’), di profondità armoniche (‘Requiem’) e di ricami/richiami a musica altrui (‘Exactly Like You’ di Jimmy Mc Hugh) che, per fluidità di discorso melodico e improvvisativo, pare essere sua. A riprova di come, anche per i numeri primi, nella musica e nel jazz non si può in genere parlare di solitudine.
Painting Jazz Duo – “Classica” – Dodicilune
 Partiamo da Dvoràk, dalla sua Sinfonia n. 9 Dal Nuovo Mondo, dalla scoperta che il compositore boemo fece negli U.S.A. della musica popolare dei neri e dei nativi d’America.È un summit con la musica europea cosiddetta “colta” a far da epilogo all’album “Classica” del Painting Jazz Duo e cioè Emanuele Passerini ai sax e Galag Massimiliano Belloni al pianoforte, con il tema principale collocato alla fine a far da suggello simbolico. La formazione è abituata a promuovere incontri fra civiltà musicali ed a coniugare pagine autoriali classiche con altre jazzistiche e qui punta a rilevare e rivelare i legami fra musiche del nuovo mondo e del vecchio continente, quelle il cui sviluppo, secondo una miope visione storica, era sembrato potesse procedere autonomamente, a prescindere da quanto stava avvenendo di là dall’Oceano. Ecco allora spiegato l’inglobare nel cd di “Le Solitaire” di Erik Satie, in un approccio che sposa impressionismo postromantico e jazz ma vi trova spazio anche l’esuberanza realista del Mahler nel ” Titano ” (Sinfonia n. 1). C’è ancora un trittico di autori russi, Borodin, Shostakovich e Tchaikovsky, alcune pagine dei quali vengono di fatto messe a confronto con “Mareblu”, “Nordic Sun”, “Valentina”, “City Life” scritte da Passerini. Come dire la storia della musica e la sua attualità vanno a braccetto, tenute insieme da una medesima idea ispirativa legata all’istantaneità del momento vissuta dalla coppia di musicisti. Il due, non a caso, è da associarsi all’istintualità, ingrediente utile anche per rivisitare degli “standards classici”.
Partiamo da Dvoràk, dalla sua Sinfonia n. 9 Dal Nuovo Mondo, dalla scoperta che il compositore boemo fece negli U.S.A. della musica popolare dei neri e dei nativi d’America.È un summit con la musica europea cosiddetta “colta” a far da epilogo all’album “Classica” del Painting Jazz Duo e cioè Emanuele Passerini ai sax e Galag Massimiliano Belloni al pianoforte, con il tema principale collocato alla fine a far da suggello simbolico. La formazione è abituata a promuovere incontri fra civiltà musicali ed a coniugare pagine autoriali classiche con altre jazzistiche e qui punta a rilevare e rivelare i legami fra musiche del nuovo mondo e del vecchio continente, quelle il cui sviluppo, secondo una miope visione storica, era sembrato potesse procedere autonomamente, a prescindere da quanto stava avvenendo di là dall’Oceano. Ecco allora spiegato l’inglobare nel cd di “Le Solitaire” di Erik Satie, in un approccio che sposa impressionismo postromantico e jazz ma vi trova spazio anche l’esuberanza realista del Mahler nel ” Titano ” (Sinfonia n. 1). C’è ancora un trittico di autori russi, Borodin, Shostakovich e Tchaikovsky, alcune pagine dei quali vengono di fatto messe a confronto con “Mareblu”, “Nordic Sun”, “Valentina”, “City Life” scritte da Passerini. Come dire la storia della musica e la sua attualità vanno a braccetto, tenute insieme da una medesima idea ispirativa legata all’istantaneità del momento vissuta dalla coppia di musicisti. Il due, non a caso, è da associarsi all’istintualità, ingrediente utile anche per rivisitare degli “standards classici”.
Stefano Tamborrino – “Seacup” – Tūk Musik
 “Seacup” titolo dell’album di Stefano Tamborrino della Tūk, sta per “tazza di acqua marina”, una formula dell’acqua in cui le note non sono sciami “che si radunano e si disperdono a seconda dell’occasione” (Bauman). La “liquidità” della musica che vi viene raccolta è semmai parte di un mare interiore “informe e multiforme” (Jankélévitch) e nel contempo modulato e modulare, suscettibile di continue variazioni di armonie, timbri, colori, toni. E ritmi. Già perché il musicista toscano, prima di essere compositore, è anzitutto un batterista di valore aperto all’elettronica ed alla (sua) vocalità (ma in “Purple Whales” compare la voce di Naomi Berrill). Un percussionismo, il suo, che il sestetto con Ilaria Lanzoni al violino, Katia Moling alla viola, Dan Kinzelman al sax, Andrea Beninati al cello e Gabriele Evangelista al contrabbasso, sembrerebbe esser lasciato “sotto traccia”, per la presenza costante della sezione d’archi. Ma il beat c’è, più che evidente nella scansione metrica di brani jazz/minimali come “Jakarta” per diventare cadenza ondulata in “Almost Jesus”. È un moto perpetuo, mai ristagno, anche nella stasi melodica di “Coda”, nell’intimità estatica di “Noli Me Tangere”, nella spirale barocca degli archi in “Escher” … e se cresce in intensità in “Olifante” per la dialettica fra strumenti più “jazz” e altri più “classici”, in “Bird Vertigo” ė la spazialità ad estendersi come in mare aperto. Da rimarcare, in “Arcadia”, gli echi che vanno dai Kronos Quartet fino al serialismo e, in “Gamelan”, la linea melodica a dir poco struggente. Insomma una sorta di flânerie sonora fra volumi di gocce, racchiuse, metaforicamente, in questo strano contenitore di H2O, con estratti di oceano o di un gran lago salato, magari apparsi in sogno e al risveglio tradotti in musica.
“Seacup” titolo dell’album di Stefano Tamborrino della Tūk, sta per “tazza di acqua marina”, una formula dell’acqua in cui le note non sono sciami “che si radunano e si disperdono a seconda dell’occasione” (Bauman). La “liquidità” della musica che vi viene raccolta è semmai parte di un mare interiore “informe e multiforme” (Jankélévitch) e nel contempo modulato e modulare, suscettibile di continue variazioni di armonie, timbri, colori, toni. E ritmi. Già perché il musicista toscano, prima di essere compositore, è anzitutto un batterista di valore aperto all’elettronica ed alla (sua) vocalità (ma in “Purple Whales” compare la voce di Naomi Berrill). Un percussionismo, il suo, che il sestetto con Ilaria Lanzoni al violino, Katia Moling alla viola, Dan Kinzelman al sax, Andrea Beninati al cello e Gabriele Evangelista al contrabbasso, sembrerebbe esser lasciato “sotto traccia”, per la presenza costante della sezione d’archi. Ma il beat c’è, più che evidente nella scansione metrica di brani jazz/minimali come “Jakarta” per diventare cadenza ondulata in “Almost Jesus”. È un moto perpetuo, mai ristagno, anche nella stasi melodica di “Coda”, nell’intimità estatica di “Noli Me Tangere”, nella spirale barocca degli archi in “Escher” … e se cresce in intensità in “Olifante” per la dialettica fra strumenti più “jazz” e altri più “classici”, in “Bird Vertigo” ė la spazialità ad estendersi come in mare aperto. Da rimarcare, in “Arcadia”, gli echi che vanno dai Kronos Quartet fino al serialismo e, in “Gamelan”, la linea melodica a dir poco struggente. Insomma una sorta di flânerie sonora fra volumi di gocce, racchiuse, metaforicamente, in questo strano contenitore di H2O, con estratti di oceano o di un gran lago salato, magari apparsi in sogno e al risveglio tradotti in musica.
Ugoless – “ Soul Church” – Parco della Musica.
 Soul Church Music, album targato Parco della Musica, è di Ugoless, gruppo che interpreta proprie composizioni. Di base è un trio con Daniele Tittarelli al sax, Fabio Sasso alla batteria e Andrea Guastadisegni ai sintetizzatori che qui è arricchito dell’apporto del tastierista Domenico Sanna. Dunque una “band dei quattro” (che numerologicamente sta per organizzazione, stabilità) che lavora sull’intertestualità fra musica e citazioni, tant’è che lo stesso titolo riprende da Cannonball Adderley la spiegazione, ripresa da “Bach Chorale”, sulla forma di un suo brano che ricorda i gospel eseguiti in chiesa. È una fattispecie di “jazz di relazione” con modelli che possono essere in “Curvone” la struttura di “Central Park West” di Coltrane ovvero in “Bon Suarè” e “Soirèe” temi del compianto Pino Daniele. Da segnalare il tramite vocalmetallico che va ad arricchire l’apparato strumentale il quale, sarà forse superfluo precisarlo, è di prim’ordine. Così, fra un omaggio a Bud Spencer in “Bambino” e un repechage di Freud in “Nada”, l’excursus allappa e allaccia drum machine e sintetizzatori a sax e tastiere. Un modo, questo, di non lasciare il suono nudo e crudo e di ornarlo – in “Kul” sono echi da Star Wars – con l’elettronica. Quando si è campioni in campionature, se c’è gusto melodico ed inventiva e il ritmo prevale sull’ algoritmo, allora l’elemento cogitans, non l’intelligenza artificiale, dispiega appieno il proprio costrutto musicale mettendo il braccio tech al servizio della ragione creativa.
Soul Church Music, album targato Parco della Musica, è di Ugoless, gruppo che interpreta proprie composizioni. Di base è un trio con Daniele Tittarelli al sax, Fabio Sasso alla batteria e Andrea Guastadisegni ai sintetizzatori che qui è arricchito dell’apporto del tastierista Domenico Sanna. Dunque una “band dei quattro” (che numerologicamente sta per organizzazione, stabilità) che lavora sull’intertestualità fra musica e citazioni, tant’è che lo stesso titolo riprende da Cannonball Adderley la spiegazione, ripresa da “Bach Chorale”, sulla forma di un suo brano che ricorda i gospel eseguiti in chiesa. È una fattispecie di “jazz di relazione” con modelli che possono essere in “Curvone” la struttura di “Central Park West” di Coltrane ovvero in “Bon Suarè” e “Soirèe” temi del compianto Pino Daniele. Da segnalare il tramite vocalmetallico che va ad arricchire l’apparato strumentale il quale, sarà forse superfluo precisarlo, è di prim’ordine. Così, fra un omaggio a Bud Spencer in “Bambino” e un repechage di Freud in “Nada”, l’excursus allappa e allaccia drum machine e sintetizzatori a sax e tastiere. Un modo, questo, di non lasciare il suono nudo e crudo e di ornarlo – in “Kul” sono echi da Star Wars – con l’elettronica. Quando si è campioni in campionature, se c’è gusto melodico ed inventiva e il ritmo prevale sull’ algoritmo, allora l’elemento cogitans, non l’intelligenza artificiale, dispiega appieno il proprio costrutto musicale mettendo il braccio tech al servizio della ragione creativa.
da Gerlando Gatto | 28/Dic/2020 | I nostri CD, Primo piano, Recensioni
Cari Amici,
archiviato questo Natale piuttosto atipico, per usare un eufemismo, ci accingiamo ad affrontare il nuovo anno con molte speranze e pochissime certezze. Ma, dal momento che dovremo trascorrere ancora molto tempo tra le mura di casa, vi propongo una serie di album che vale la pena ascoltare.
Buona Musica e Buon Anno.

AB Quartet – “I bemolli sono blu” – TRJ records
 L’AB Quartet è un gruppo costituito da Antonio Bonazzo (pianoforte), Francesco Chiapperini (clarinetto e clarinetto basso), Cristiano Da Ros (contrabbasso), Fabrizio Carriero (batteria e percussioni). L’album prende le mosse da un obiettivo esplicitamente dichiarato da Bonazzo: elaborare, in occasione del centenario dalla morte di Claude Debussy nel 2018, un progetto basato su arrangiamenti di musica di questo compositore francese.
L’AB Quartet è un gruppo costituito da Antonio Bonazzo (pianoforte), Francesco Chiapperini (clarinetto e clarinetto basso), Cristiano Da Ros (contrabbasso), Fabrizio Carriero (batteria e percussioni). L’album prende le mosse da un obiettivo esplicitamente dichiarato da Bonazzo: elaborare, in occasione del centenario dalla morte di Claude Debussy nel 2018, un progetto basato su arrangiamenti di musica di questo compositore francese.
E il titolo viene proprio da una frase di Debussy che in una lettera parla della sua visione della musica legata principalmente ad aspetti extramusicali come il colore. Di qui un repertorio di sette brani originali. Come al solito quando un album dichiara un intento si pone la classica domanda: obiettivo raggiunto? Onestamente mi risulta difficile fornire una risposta. Comunque è innegabile che i temi scelti si facciano ascoltare con attenzione così come è innegabile che in alcuni passaggi risulti evidente l’influenza di Debussy. Pertinente è anche il linguaggio adoperato dal gruppo il che non stupisce ove si tenga conto che il gruppo affonda le proprie radici nella tradizione classica. Proprio per questo i brani sono prevalentemente scritti anche se non mancano ampi spazi per le improvvisazioni singole e collettive. Un esempio di quanto sin qui detto lo si trova già nel primo brano, “Moon”; il riferimento è al “Clair de Lune” vagamente richiamato nella linea melodica per lasciare subito il posto ad una reinterpretazione cesellata dal pianoforte di Bonazzo, mentre i clarinetti di Chiapperini creano un impasto strumentale dalle timbriche originali, con batteria e contrabbasso a intessere un impianto ritmico molto più sostenuto rispetto all’originale.
Tiziana Bacchetta – “Driving Home for Christmas” – G.T.
 Un’indispensabile premessa: io non amo particolarmente gli “album di Natale” per cui mi sono accinto ad ascoltare questo album con una buona dose di scetticismo. Ma poi, nota dopo nota, minuto dopo minuto, ho cambiato radicalmente idea tanto da poter affermare che questo è un CD di sicuro livello. E ciò per una serie di motivi che cercherò di elencare non in ordine di importanza. La scelta del repertorio: la vocalist romana, ad eccezione dei ben noti “Have Yourself a Merry Little Christmas” di Martin -Blane e “White Christmas” di Irving Berlin, ha preferito presentare brani, tutti musicalmente validi e raffinati ma assai meno battuti. Ovviamente ciò non sarebbe stato sufficiente; ecco quindi arrangiamenti sapidi, ben studiati e curati in ogni minimo aspetto con un gruppo affiatato in cui spicca l’individualità di Giacomo Tantillo, trombettista e flicornista siciliano di Palermo che passo dopo passo si avvia a diventare una certezza del panorama jazzistico nazionale. A questo punto sarebbe ingiusto non citare gli altri componenti il gruppo, vale a dire Raffaele Cervasio chitarra, Arturo Valente piano e Rhodes, Carlo Bordini batteria e Guerino Rondolone basso. Ma, com’è fin troppo ovvio, il merito principale dell’ottima riuscita dell’album è della leader, Tiziana Bacchetta. Giunta al suo terzo album, l’artista dà prova di grande maturità sfoggiando notevoli capacità interpretative supportate da un voce ben educata che riesce a transitare senza sforzo alcuno attraverso atmosfere assai differenziate. Ecco quindi il bruciante blues “Christmas Tears” portato al successo da Freddy King uno dei più talentuosi chitarristi del blues elettrico contemporaneo e interpretato dalla Bacchetta con trasporto e una voce ruvida il giusto, ecco la “Title Track” un brano bellissimo di Chris Rea, fino alla conclusione con l’evergreen “White Christmas” di Irving Berlin. Insomma una bella musica che ci accompagna verso le prossime festività, una sorta di raggio di luce in un panorama piuttosto plumbeo.
Un’indispensabile premessa: io non amo particolarmente gli “album di Natale” per cui mi sono accinto ad ascoltare questo album con una buona dose di scetticismo. Ma poi, nota dopo nota, minuto dopo minuto, ho cambiato radicalmente idea tanto da poter affermare che questo è un CD di sicuro livello. E ciò per una serie di motivi che cercherò di elencare non in ordine di importanza. La scelta del repertorio: la vocalist romana, ad eccezione dei ben noti “Have Yourself a Merry Little Christmas” di Martin -Blane e “White Christmas” di Irving Berlin, ha preferito presentare brani, tutti musicalmente validi e raffinati ma assai meno battuti. Ovviamente ciò non sarebbe stato sufficiente; ecco quindi arrangiamenti sapidi, ben studiati e curati in ogni minimo aspetto con un gruppo affiatato in cui spicca l’individualità di Giacomo Tantillo, trombettista e flicornista siciliano di Palermo che passo dopo passo si avvia a diventare una certezza del panorama jazzistico nazionale. A questo punto sarebbe ingiusto non citare gli altri componenti il gruppo, vale a dire Raffaele Cervasio chitarra, Arturo Valente piano e Rhodes, Carlo Bordini batteria e Guerino Rondolone basso. Ma, com’è fin troppo ovvio, il merito principale dell’ottima riuscita dell’album è della leader, Tiziana Bacchetta. Giunta al suo terzo album, l’artista dà prova di grande maturità sfoggiando notevoli capacità interpretative supportate da un voce ben educata che riesce a transitare senza sforzo alcuno attraverso atmosfere assai differenziate. Ecco quindi il bruciante blues “Christmas Tears” portato al successo da Freddy King uno dei più talentuosi chitarristi del blues elettrico contemporaneo e interpretato dalla Bacchetta con trasporto e una voce ruvida il giusto, ecco la “Title Track” un brano bellissimo di Chris Rea, fino alla conclusione con l’evergreen “White Christmas” di Irving Berlin. Insomma una bella musica che ci accompagna verso le prossime festività, una sorta di raggio di luce in un panorama piuttosto plumbeo.
Michel Benita – “Looking at Sounds” – ECM
 L’etichetta Ecm dedica meritoriamente due album alla scena francese, questo di Michel Benita e un altro di Matthieu Bordenave di cui ci occupiamo qui di seguito. In “Looking at Sounds” il contrabbassista franco-algerino Michel Benita si presenta in quartetto con il connazionale Philippe Garcia alla batteria, lo svizzero Matthieu Michel al flicorno e il belga Jozef Dumoulin, specialista del piano elettrico. L’album è giocato su due elementi: una raffinata ricerca timbrica e melodica, e la prevalenza del sound collettivo rispetto all’assolo. Il repertorio si compone di undici pezzi scritti in massima parte dallo stesso Benita da solo o in collaborazione con altri, cui si aggiungono due brani famosi, “Inutil Paisegem” di Antonio Carlos Jobim e Louis Olivera, e “Never Never Land” di Styne, Comden, Green. L’intro affidata al leader è una sorta di manifesto dell’intera poetica dell’album: la linea melodica, suggestiva e cantabile, disegnata dal flicorno di Matthieu Michel, viene costantemente supportata dal basso e dalla batteria di Garcia, in questo caso con mirabile gioco di spazzole, mentre Demoulin si limita a sottolineare alcuni passaggi contribuendo, però, in maniera determinante a creare quella particolare timbrica che costituisce una caratteristica dell’album. E il clima intimista, di rara suggestione si avverte per tutta la durata dell’album anche se non mancano episodi particolari come “Cloud To Cloud” declinato sul filo di una improvvisazione collettiva e il conclusivo “Never Never Land” in cui il leader, in splendida solitudine, si produce in uno dei più centrati assolo dell’album. Gustosa, infine, l’interpretazione di “Inútil Paisagem”.
L’etichetta Ecm dedica meritoriamente due album alla scena francese, questo di Michel Benita e un altro di Matthieu Bordenave di cui ci occupiamo qui di seguito. In “Looking at Sounds” il contrabbassista franco-algerino Michel Benita si presenta in quartetto con il connazionale Philippe Garcia alla batteria, lo svizzero Matthieu Michel al flicorno e il belga Jozef Dumoulin, specialista del piano elettrico. L’album è giocato su due elementi: una raffinata ricerca timbrica e melodica, e la prevalenza del sound collettivo rispetto all’assolo. Il repertorio si compone di undici pezzi scritti in massima parte dallo stesso Benita da solo o in collaborazione con altri, cui si aggiungono due brani famosi, “Inutil Paisegem” di Antonio Carlos Jobim e Louis Olivera, e “Never Never Land” di Styne, Comden, Green. L’intro affidata al leader è una sorta di manifesto dell’intera poetica dell’album: la linea melodica, suggestiva e cantabile, disegnata dal flicorno di Matthieu Michel, viene costantemente supportata dal basso e dalla batteria di Garcia, in questo caso con mirabile gioco di spazzole, mentre Demoulin si limita a sottolineare alcuni passaggi contribuendo, però, in maniera determinante a creare quella particolare timbrica che costituisce una caratteristica dell’album. E il clima intimista, di rara suggestione si avverte per tutta la durata dell’album anche se non mancano episodi particolari come “Cloud To Cloud” declinato sul filo di una improvvisazione collettiva e il conclusivo “Never Never Land” in cui il leader, in splendida solitudine, si produce in uno dei più centrati assolo dell’album. Gustosa, infine, l’interpretazione di “Inútil Paisagem”.
Roberto Bindoni Unquiet Quartet – “Mediterranean Cowboy” – Alfa Music
 E’ uscito di recente l’album d’esordio dell’Unquiet Quartet di Roberto Bindoni; il chitarrista (eccellente anche al pianoforte, strumento che però in questa occasione non usa) è accompagnato da Matteo Cuzzolin al tenore, Marco Stagni al contrabbasso e Filip Milenkovic alla batteria. Si tratta di una prova particolarmente impegnativa per Bidoni il quale si presenta anche come autore dell’intero repertorio, nove brani che riescono a ben catalizzare l’attenzione dell’ascoltatore. La linea stilistica oscilla tra il jazz modale e quelle atmosfere nordiche che abbiamo imparato ad apprezzare nel corso degli ultimi decenni grazie ad artisti quali Jan Garbarek o Jan Balke tanto per fare qualche nome. Le atmosfere sono quindi in linea di massima pacate, con una riconoscibile linea melodica e un ritmo sostanzialmente lento, ragionato, il tutto impreziosito da arrangiamenti ben scritti sia che riguardino le parti completamente scritte sia che facciano un passo indietro per lasciare spazio all’improvvisazione, terreno su cui si muove particolarmente bene il sax tenore di Cuzzolin (lo si ascolti in “Unquiet Place” e nel già citato “Kamikaze”). Particolarmente suggestivo “Encanto” con il leader in bella evidenza. Certo, come si accennava si tratta di un disco d’esordio per cui i margini di miglioramento ci sono, ma già a questo punto è un bel sentire.
E’ uscito di recente l’album d’esordio dell’Unquiet Quartet di Roberto Bindoni; il chitarrista (eccellente anche al pianoforte, strumento che però in questa occasione non usa) è accompagnato da Matteo Cuzzolin al tenore, Marco Stagni al contrabbasso e Filip Milenkovic alla batteria. Si tratta di una prova particolarmente impegnativa per Bidoni il quale si presenta anche come autore dell’intero repertorio, nove brani che riescono a ben catalizzare l’attenzione dell’ascoltatore. La linea stilistica oscilla tra il jazz modale e quelle atmosfere nordiche che abbiamo imparato ad apprezzare nel corso degli ultimi decenni grazie ad artisti quali Jan Garbarek o Jan Balke tanto per fare qualche nome. Le atmosfere sono quindi in linea di massima pacate, con una riconoscibile linea melodica e un ritmo sostanzialmente lento, ragionato, il tutto impreziosito da arrangiamenti ben scritti sia che riguardino le parti completamente scritte sia che facciano un passo indietro per lasciare spazio all’improvvisazione, terreno su cui si muove particolarmente bene il sax tenore di Cuzzolin (lo si ascolti in “Unquiet Place” e nel già citato “Kamikaze”). Particolarmente suggestivo “Encanto” con il leader in bella evidenza. Certo, come si accennava si tratta di un disco d’esordio per cui i margini di miglioramento ci sono, ma già a questo punto è un bel sentire.
Matthieu Bordenave – “La traversée” – ECM

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 80
Ecco il primo album da leader del sassofonista francese Matthieu Bordenave in trio con il tedesco Florian Weber al pianoforte e lo svizzero Patrice Moret al contrabbasso. In programma nove brani tutti composti dallo stesso sassofonista. Come espressamente dichiarato dallo stesso leader, l’idea musicale che ha ispirato l’album è quella del trio formato da Jimmy Giuffre, Paul Bley e Steve Swallow circa sessanta anni addietro ma ancora oggi attualissima. Di qui una musica allo stesso tempo moderna nel sound e nella ricerca di un linguaggio vicino alla musica contemporanea ma allo stesso tempo fortemente ancorata al passato. E la cosa si spiega assai bene ove si tenga conto che Bordenave può vantare una preparazione anche classica. L’album oscilla, quindi, tra questi due poli in una sorta di camerismo particolarmente attento allo spazio e alle sfumature che evidenzia al meglio le potenzialità dei tre artisti. Così se il sax del leader rimane costantemente in primo piano, con un sound non particolarmente robusto ma personale, pianoforte e contrabbasso non si limitano ad una funzione di supporto fornendo un contributo importante anche nella costruzione della linea portante; si ascolti al riguardo il sontuoso assolo di Patrice Moret in “Ventoux” o quello di Weber nel successivo “Incendie blanc”. Insomma nonostante la mancanza di una qualsivoglia percussione, la ‘traversata’ del trio solca mari non sempre placidi, alla costante scoperta di nuovi orizzonti.
Yilian Canizares – “Erzulie” – Planeta Y
 Questo è uno dei pochi album che vi consiglierei di ascoltare più e più volte tale e tanta è la ricchezza di contenuti in esso racchiusa. La violinista, cantante e compositrice cubana Yilian Canizares si conferma una delle artiste più originali apparsa sulla scena musicale degli ultimi anni grazie ad una concezione musicale che le consente di accorpare una formazione di base classica e i ritmi, le melodie, le danze della sua madre patria. E tutto ciò si appalesa con grande semplicità nell’album in oggetto, registrato a New Orleans ma che in realtà prende vita da un viaggio nel 2017 ad Haiti. Quì Yilian ha avuto modo di confrontarsi con i Boukman Eksperyans, band storica che prende il nome da Dutty Boukman, un sacerdote vodou che condusse una cerimonia religiosa nel 1791, considerata l’inizio della rivoluzione haitiana. Non a caso l‘album è dedicato a “Erzulie”, divinità del pantheon vudu che personifica l’essenza della femminilità e la sensualità. In effetto l’intento della Canizares è più ampio: “raccontare la storia dell’Africa attraverso i suoi figli creoli: Haiti, Cuba e New Orleans […] musica che deriva quindi da un legame che non è morto malgrado tutto ciò che è successo storicamente”. Accanto all’artista cubana troviamo un quartetto di musicisti di nazionalità e culture musicali diverse, The Maroons, altro riferimento alla storia libertaria caraibica, che allineano Paul Beaubrun (chitarrista e vocalist haitiano), Childo Tomas (basso, cori e kalimba dal Mozambico), Charlie “BKVK” Burchell (batteria e tastiere, statunitense di New Orleans) e Inor Sotolongo (percussionsta cubano). A questi si aggiungono svariati ospiti a tromba, contrabbasso, organo, tastiere, percussioni, violoncello e flauto, a costituire una formazione straordinaria. L’album si apre con la romanticamente coinvolgente “Habanera” e si chiude con “Yeyé” cantata in dialetto yoruba (o lucumi), così come “Yemayá” mentre nella title track e in “Noyé” l’artista utilizza il creolo haitiano. Un’ultima notazione tutt’altro che secondaria: nel brano “Libertad” sono inserite le voci campionate di tre donne di epoche diverse particolarmente significative in merito alle tematiche trattate: Simone de Beauvoir, Malala e Nina Simone.
Questo è uno dei pochi album che vi consiglierei di ascoltare più e più volte tale e tanta è la ricchezza di contenuti in esso racchiusa. La violinista, cantante e compositrice cubana Yilian Canizares si conferma una delle artiste più originali apparsa sulla scena musicale degli ultimi anni grazie ad una concezione musicale che le consente di accorpare una formazione di base classica e i ritmi, le melodie, le danze della sua madre patria. E tutto ciò si appalesa con grande semplicità nell’album in oggetto, registrato a New Orleans ma che in realtà prende vita da un viaggio nel 2017 ad Haiti. Quì Yilian ha avuto modo di confrontarsi con i Boukman Eksperyans, band storica che prende il nome da Dutty Boukman, un sacerdote vodou che condusse una cerimonia religiosa nel 1791, considerata l’inizio della rivoluzione haitiana. Non a caso l‘album è dedicato a “Erzulie”, divinità del pantheon vudu che personifica l’essenza della femminilità e la sensualità. In effetto l’intento della Canizares è più ampio: “raccontare la storia dell’Africa attraverso i suoi figli creoli: Haiti, Cuba e New Orleans […] musica che deriva quindi da un legame che non è morto malgrado tutto ciò che è successo storicamente”. Accanto all’artista cubana troviamo un quartetto di musicisti di nazionalità e culture musicali diverse, The Maroons, altro riferimento alla storia libertaria caraibica, che allineano Paul Beaubrun (chitarrista e vocalist haitiano), Childo Tomas (basso, cori e kalimba dal Mozambico), Charlie “BKVK” Burchell (batteria e tastiere, statunitense di New Orleans) e Inor Sotolongo (percussionsta cubano). A questi si aggiungono svariati ospiti a tromba, contrabbasso, organo, tastiere, percussioni, violoncello e flauto, a costituire una formazione straordinaria. L’album si apre con la romanticamente coinvolgente “Habanera” e si chiude con “Yeyé” cantata in dialetto yoruba (o lucumi), così come “Yemayá” mentre nella title track e in “Noyé” l’artista utilizza il creolo haitiano. Un’ultima notazione tutt’altro che secondaria: nel brano “Libertad” sono inserite le voci campionate di tre donne di epoche diverse particolarmente significative in merito alle tematiche trattate: Simone de Beauvoir, Malala e Nina Simone.
Donatello D’Attoma – “Oneness” – Dodicilune
 Donatello D’Attoma è uno dei pianisti più interessanti che si pone nella linea stilistica tracciata da alcuni grandi della tastiera, Thelonius Monk in primis e, andando più indietro nel tempo, Bill Evans. In questo album il pianista si presenta in trio con il siciliano Alberto Fidone al contrabbasso e il romano Enrico Morello alla batteria. In programma otto brani di cui ben sette dovuti alla penna del leader che quindi si dimostra anche prolifico e valente autore. La chiusura è invece affidata ad una composizione, guarda caso, di Thelonious Monk, “Coming On Thwe Hudson”. Il trio è affiatato, ben guidato e ricco di interventi solistici che impreziosiscono ogni esecuzione. Intendiamoci: nessuna dimostrazione muscolare o interventi tesi a stupire l’ascoltatore, ma grande attenzione all’espressività e quindi alla volontà di trasmettere la tensione emotiva che i tre avvertono, in un costante equilibrio tra pagina scritta e istintiva improvvisazione. In particolare D’Attoma evidenzia una solida tecnica di base cementata sia dagli studi classici sia dalla profonda conoscenza della letteratura jazzistica; di qui un rigoroso controllo di ogni elemento dell’esecuzione con un pianismo solido, raffinato, essenziale ben supportato dai compagni d’avventura che, seguendo la lezione di Evans, ricoprono un ruolo tutt’altro che marginale. E ciò appare evidente sin dal primo brano, “Fluorescent Light”, in cui i tre si muovono empaticamente, caratteristica che viene conservata per tutta la durata dell’album. I brani sono tutti godibili e ben articolati come in una sorta di percorso che mai perde d’intensità.
Donatello D’Attoma è uno dei pianisti più interessanti che si pone nella linea stilistica tracciata da alcuni grandi della tastiera, Thelonius Monk in primis e, andando più indietro nel tempo, Bill Evans. In questo album il pianista si presenta in trio con il siciliano Alberto Fidone al contrabbasso e il romano Enrico Morello alla batteria. In programma otto brani di cui ben sette dovuti alla penna del leader che quindi si dimostra anche prolifico e valente autore. La chiusura è invece affidata ad una composizione, guarda caso, di Thelonious Monk, “Coming On Thwe Hudson”. Il trio è affiatato, ben guidato e ricco di interventi solistici che impreziosiscono ogni esecuzione. Intendiamoci: nessuna dimostrazione muscolare o interventi tesi a stupire l’ascoltatore, ma grande attenzione all’espressività e quindi alla volontà di trasmettere la tensione emotiva che i tre avvertono, in un costante equilibrio tra pagina scritta e istintiva improvvisazione. In particolare D’Attoma evidenzia una solida tecnica di base cementata sia dagli studi classici sia dalla profonda conoscenza della letteratura jazzistica; di qui un rigoroso controllo di ogni elemento dell’esecuzione con un pianismo solido, raffinato, essenziale ben supportato dai compagni d’avventura che, seguendo la lezione di Evans, ricoprono un ruolo tutt’altro che marginale. E ciò appare evidente sin dal primo brano, “Fluorescent Light”, in cui i tre si muovono empaticamente, caratteristica che viene conservata per tutta la durata dell’album. I brani sono tutti godibili e ben articolati come in una sorta di percorso che mai perde d’intensità.
Elina Duni, Rob Luft – “Lost Ships” – ECM
 Registrato nello studio La Buissonne nel sud della Francia nel febbraio del 2020, questo album, in quattro lingue – albanese, francese, inglese, salentino- vede la cantante svizzero albanese Elina Duni ed il chitarrista britannico Rob Luft (la cui collaborazione risale al 2017) coadiuvati da Matthieu Michel al flugelhorn (lo si ascolti particolarmente in “Brighton”) e Fred Thomas piano e batteria. A scanso di equivoci, in questo caso il jazz appare marginale ma l’album è notevole e vale quindi la pena segnalarlo. Il programma, pur essendo assai variegato, presenta come temi centrali quelli dell’emigrazione e della difesa della natura declinati attraverso brani tradizionali, composizioni originali e due canzoni rese famose rispettivamente da Frank Sinatra e Charles Aznavour. In un cartellone siffatto appare evidente come molteplici debbano essere stati gli input ed è la stessa Duni a confermarlo: «Ci sono canzoni – afferma – che hanno influenze del passato, con il suono dell’Albania ed il folclore mediterraneo sempre presenti, ma volevamo esplorare anche altre radici musicali: ballate jazz senza tempo, canzoni francesi, canzoni popolari americane…. ». Comunque l’album, come si accennava, è di assoluto livello grazie soprattutto alla maestria di vocalist e chitarrista, l’una sempre più convincente nell’interpretazione di tematiche assai delicate, l’altro in grado di sottolineare ogni passaggio con rara discrezione e altrettanta pertinenza. Così la musica acquista attimo dopo attimo sempre più consistenza, sorretta da un’intesa non comune come evidenziato nel brano in inglese, “The Wayfaring Stranger”. Il controllo delle dinamiche è assoluto così come la capacità di ricondurre ad un unicum le quattro voci melodiche. Infine una perla di raffinatezza la chiusura con “Hier Encore” di Aznavour presentata in duo, chitarra e voce.
Registrato nello studio La Buissonne nel sud della Francia nel febbraio del 2020, questo album, in quattro lingue – albanese, francese, inglese, salentino- vede la cantante svizzero albanese Elina Duni ed il chitarrista britannico Rob Luft (la cui collaborazione risale al 2017) coadiuvati da Matthieu Michel al flugelhorn (lo si ascolti particolarmente in “Brighton”) e Fred Thomas piano e batteria. A scanso di equivoci, in questo caso il jazz appare marginale ma l’album è notevole e vale quindi la pena segnalarlo. Il programma, pur essendo assai variegato, presenta come temi centrali quelli dell’emigrazione e della difesa della natura declinati attraverso brani tradizionali, composizioni originali e due canzoni rese famose rispettivamente da Frank Sinatra e Charles Aznavour. In un cartellone siffatto appare evidente come molteplici debbano essere stati gli input ed è la stessa Duni a confermarlo: «Ci sono canzoni – afferma – che hanno influenze del passato, con il suono dell’Albania ed il folclore mediterraneo sempre presenti, ma volevamo esplorare anche altre radici musicali: ballate jazz senza tempo, canzoni francesi, canzoni popolari americane…. ». Comunque l’album, come si accennava, è di assoluto livello grazie soprattutto alla maestria di vocalist e chitarrista, l’una sempre più convincente nell’interpretazione di tematiche assai delicate, l’altro in grado di sottolineare ogni passaggio con rara discrezione e altrettanta pertinenza. Così la musica acquista attimo dopo attimo sempre più consistenza, sorretta da un’intesa non comune come evidenziato nel brano in inglese, “The Wayfaring Stranger”. Il controllo delle dinamiche è assoluto così come la capacità di ricondurre ad un unicum le quattro voci melodiche. Infine una perla di raffinatezza la chiusura con “Hier Encore” di Aznavour presentata in duo, chitarra e voce.
Erodoto Project – “Mythos Metamorphosis” – Cultural bridge
 Bob Salmieri sax tenore e soprano, ney, turkish klarinet, Alessandro de Angelis grand piano, Rhodes piano, Maurizio Perrone contrabbasso, Giampaolo Scatozza batteria e Carlo Colombo percussioni sono i responsabili dell’“Erodoto Project” giunto alla sua terza tappa attraverso i miti e le leggende del Mediterraneo. Dopo “Stories: Lands, Men And Gods” (2016) e “Molòn Labè” (2017) arriva “Mythos Metamorphosis” in cui il gruppo è affiancato dal Mirò String Trio, al secolo Fabiola Gaudio violino, Lorenzo Rundo viola e Marco Simonacci violoncello. In repertorio undici originali composti da Salmieri e De Angelis declinati attraverso l’avventura di Ulisse che affronta e resiste alle lusinghe delle sirene. Ecco quindi richiamate le leggende di Aci e Galatea, di Ifi e Iante, della Sibilla Cumana…via via fino al brano di chiusura dedicato a “Leucosya”, una delle tre sirene che, secondo la mitologia greca, viveva sugli scogli della baia di Salerno assieme a Partenope e Ligea. Essendo questo il quadro di riferimento, è chiaro che la musica prodotta dovesse in qualche modo riferirsi alle varie culture che dal Mediterraneo traggono linfa vitale. E così è stato. Ancora una volta Salmieri e compagni tengono fede alle premesse e ci regalano una musica di grande intensità caratterizzata da suadenti linee melodiche, armonizzazioni semplici ma non per questo banali e una tavolozza timbrica impreziosita, nell’occasione, dal trio d’archi i cui arrangiamenti sono stati curati da Alessandro de Angelis. Insomma un jazz senza etichette, non ascrivibile ad uno stile piuttosto che ad un altro, ma una musica libera che prende per mano l’ascoltatore e lo trasporta in un altrove impossibile da etichettare.
Bob Salmieri sax tenore e soprano, ney, turkish klarinet, Alessandro de Angelis grand piano, Rhodes piano, Maurizio Perrone contrabbasso, Giampaolo Scatozza batteria e Carlo Colombo percussioni sono i responsabili dell’“Erodoto Project” giunto alla sua terza tappa attraverso i miti e le leggende del Mediterraneo. Dopo “Stories: Lands, Men And Gods” (2016) e “Molòn Labè” (2017) arriva “Mythos Metamorphosis” in cui il gruppo è affiancato dal Mirò String Trio, al secolo Fabiola Gaudio violino, Lorenzo Rundo viola e Marco Simonacci violoncello. In repertorio undici originali composti da Salmieri e De Angelis declinati attraverso l’avventura di Ulisse che affronta e resiste alle lusinghe delle sirene. Ecco quindi richiamate le leggende di Aci e Galatea, di Ifi e Iante, della Sibilla Cumana…via via fino al brano di chiusura dedicato a “Leucosya”, una delle tre sirene che, secondo la mitologia greca, viveva sugli scogli della baia di Salerno assieme a Partenope e Ligea. Essendo questo il quadro di riferimento, è chiaro che la musica prodotta dovesse in qualche modo riferirsi alle varie culture che dal Mediterraneo traggono linfa vitale. E così è stato. Ancora una volta Salmieri e compagni tengono fede alle premesse e ci regalano una musica di grande intensità caratterizzata da suadenti linee melodiche, armonizzazioni semplici ma non per questo banali e una tavolozza timbrica impreziosita, nell’occasione, dal trio d’archi i cui arrangiamenti sono stati curati da Alessandro de Angelis. Insomma un jazz senza etichette, non ascrivibile ad uno stile piuttosto che ad un altro, ma una musica libera che prende per mano l’ascoltatore e lo trasporta in un altrove impossibile da etichettare.
Marco Fumo – “Reflections” – Odradek Records
 Merco Fumo è personaggio ben noto ed apprezzato nell’ambiente jazzistico. La sua padronanza strumentale e la sua profonda conoscenza del lessico jazzistico ne fanno personaggio di assoluto rilievo. E questo album ne è l’ennesima conferma in quanto riesce ad evidenziare, come meglio non si potrebbe, i numerosi legami – ora palesi ora più nascosti – tra l’universo euro-colto e la musica afroamericana. In un flusso rapido e spesso trascinante scorrono quindi alcuni degli autori che hanno fatto la storia della musica tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento sulle due sponde dell’Oceano Atlantico. Da Scarlatti a Joplin, da Stravinsky a Nazareth, da Debussy a Ellington tanto per fare qualche nome. Ovvero dal ragtime, dal choro, dal tango, dal blues, dallo stride piano…al jazz e alla musica classica europea in un confronto tutt’altro che banale, alla scoperta di consonanze spesso inaspettate. E’ quanto si nota, come si legge nelle note che accompagnano l’album, ascoltando il “Tango” di Stravinsky risalente al 1940 e il “Café de Barracas” di Eduardo Arolas del 1920: la concezione delle masse sonore presenta molti punti di contatto nel pensiero dei due compositori. Più evidente, è ovvio, il rapporto tra il ragtime di Scott Joplin e lo stride piano di James P. Johnson. E di questi esempi se ne possono fare molti altri costituendo per l’appunto questo il punto focale della ricerca di Marco Fumo il quale ama sottolineare come nella sua vita abbia “frequentato sempre tutta la musica, indistintamente” non facendosi mai limitare “da barriere o pregiudizi”.
Merco Fumo è personaggio ben noto ed apprezzato nell’ambiente jazzistico. La sua padronanza strumentale e la sua profonda conoscenza del lessico jazzistico ne fanno personaggio di assoluto rilievo. E questo album ne è l’ennesima conferma in quanto riesce ad evidenziare, come meglio non si potrebbe, i numerosi legami – ora palesi ora più nascosti – tra l’universo euro-colto e la musica afroamericana. In un flusso rapido e spesso trascinante scorrono quindi alcuni degli autori che hanno fatto la storia della musica tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento sulle due sponde dell’Oceano Atlantico. Da Scarlatti a Joplin, da Stravinsky a Nazareth, da Debussy a Ellington tanto per fare qualche nome. Ovvero dal ragtime, dal choro, dal tango, dal blues, dallo stride piano…al jazz e alla musica classica europea in un confronto tutt’altro che banale, alla scoperta di consonanze spesso inaspettate. E’ quanto si nota, come si legge nelle note che accompagnano l’album, ascoltando il “Tango” di Stravinsky risalente al 1940 e il “Café de Barracas” di Eduardo Arolas del 1920: la concezione delle masse sonore presenta molti punti di contatto nel pensiero dei due compositori. Più evidente, è ovvio, il rapporto tra il ragtime di Scott Joplin e lo stride piano di James P. Johnson. E di questi esempi se ne possono fare molti altri costituendo per l’appunto questo il punto focale della ricerca di Marco Fumo il quale ama sottolineare come nella sua vita abbia “frequentato sempre tutta la musica, indistintamente” non facendosi mai limitare “da barriere o pregiudizi”.
Danilo Gallo, Dark Dry Tears – “Hide, Show Yourself!” – PMR
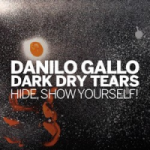 Dopo lo splendido album “Thinking Beats Where Mind Dies” del 2016, il quartetto “Dark Dry Tears” si ripresenta al pubblico del jazz con un organico leggermente diverso in quanto al posto di Francesco Bearzatti figura Massimiliano Milesi (sax tenore e soprano e clarinetto) mentre rimangono al loro posto Francesco Bigoni (sax tenore e clarinetto), Jim Black (batteria) e ovviamente Danilo Gallo al basso elettrico. In programma tredici brani tutti composti da Gallo. Ciò detto rimane sostanzialmente identica la cifra stilistica del gruppo che evidenzia ancora una volta i suoi punti di forza nell’intenso dialogo tra i due fiati, nell’incessante straordinario supporto ritmico di Jim Black (a mio avviso uno dei migliori batteristi oggi in circolazione) e nella sapiente direzione di Gallo che si fa valere non solo per l’apporto ritmico ma anche per la spinta propulsiva forniti dal suo strumento. Quanto al ruolo dei fiati, lo stesso appare evidente sin dal primo brano per proseguire, senza soluzione di continuità, fino al pezzo di chiusura. Interessante notare come l’uso del sax soprano da parte di Milesi conferisca un sapore nuovo alla tavolozza timbrica del gruppo che presenta una compattezza, una omogeneità tutt’altro cha facili da raggiungere. I quattro si muovono in perfetta simbiosi, senza un attimo di incertezza ad interpretare le sapienti composizioni di Gallo la cui raffinatezza è soprattutto evidente nelle introduzioni e nelle chiusure dei singoli brani. Si ascolti al riguardo come il basso elettrico introduca l’intero album nel brano “Demolition” caratterizzato in seguito da un trascinante crescendo.
Dopo lo splendido album “Thinking Beats Where Mind Dies” del 2016, il quartetto “Dark Dry Tears” si ripresenta al pubblico del jazz con un organico leggermente diverso in quanto al posto di Francesco Bearzatti figura Massimiliano Milesi (sax tenore e soprano e clarinetto) mentre rimangono al loro posto Francesco Bigoni (sax tenore e clarinetto), Jim Black (batteria) e ovviamente Danilo Gallo al basso elettrico. In programma tredici brani tutti composti da Gallo. Ciò detto rimane sostanzialmente identica la cifra stilistica del gruppo che evidenzia ancora una volta i suoi punti di forza nell’intenso dialogo tra i due fiati, nell’incessante straordinario supporto ritmico di Jim Black (a mio avviso uno dei migliori batteristi oggi in circolazione) e nella sapiente direzione di Gallo che si fa valere non solo per l’apporto ritmico ma anche per la spinta propulsiva forniti dal suo strumento. Quanto al ruolo dei fiati, lo stesso appare evidente sin dal primo brano per proseguire, senza soluzione di continuità, fino al pezzo di chiusura. Interessante notare come l’uso del sax soprano da parte di Milesi conferisca un sapore nuovo alla tavolozza timbrica del gruppo che presenta una compattezza, una omogeneità tutt’altro cha facili da raggiungere. I quattro si muovono in perfetta simbiosi, senza un attimo di incertezza ad interpretare le sapienti composizioni di Gallo la cui raffinatezza è soprattutto evidente nelle introduzioni e nelle chiusure dei singoli brani. Si ascolti al riguardo come il basso elettrico introduca l’intero album nel brano “Demolition” caratterizzato in seguito da un trascinante crescendo.
Keith Jarrett – “Budapest Concert” – 2 CD – ECM
 Di recente su questi stessi spazi il nostro Massimo Giuseppe Bianchi si è occupato di Keith Jarrett esaminandone due aspetti: il rapporto con il pubblico e l’approccio al repertorio classico. Venuti a conoscenza del fatto che il pianista non potrà più suonare in pubblico, ogni suo album, per quanto registrato anni addietro, assume una particolare valenza. E’ il caso di questo “Budapest Concert” inciso il 3 luglio del 2016 alla Béla Bartok Concert Hall e declinato attraverso due CD, nel primo una serie di improvvisazioni di durata medio lunga, nel secondo ancora improvvisazioni questa volta di durata inferiore e due standard “It’s A Lonesome Old Town” di Tobias e Kisco e “Answer Me, My Love” di Winkler e Rauch. Come spesso gli capitava durante le sue performances, Jarrett preferisce mettere subito in chiaro le sue intenzioni. Ecco quindi la “Part I” sicuramente la più complessa e meno melodica dell’intero programma, in cui l’artista si lancia nelle sue ardite improvvisazioni. E tutto il primo CD, corrispondente alla prima parte del concerto, ripercorre un identico canovaccio vale a dire un pianismo allo stesso tempo lucido e imperscrutabile, vorticoso e meditativo, che comunque si lascia attrarre da quell’area culturale vicina alla musica accademica in special modo del Vecchio Continente. Il discorso cambia nel secondo disco caratterizzato sin dall’inizio da una atmosfera più raccolta, intimista e da una più avvertibile cantabilità. Fino alla degna chiusura con due standard rappresentati con dolce partecipazione. E’ sicuramente questo il Jarrett che il pubblico ama di più, quell’artista che raccoglie in sé il portato di ogni stile pianistico e che, se in stato di grazia, è capace di inanellare una serie infinita di spunti melodici come nessun altro. Ed un esempio probante si ha proprio in questo secondo CD in cui ogni singola esibizione è sugellata da una caldo applauso del pubblico senza che la tensione cali per un solo attimo: lo spettatore è definitivamente conquistato così come noi che ascoltiamo l’album comodamente accovacciati in poltrona.
Di recente su questi stessi spazi il nostro Massimo Giuseppe Bianchi si è occupato di Keith Jarrett esaminandone due aspetti: il rapporto con il pubblico e l’approccio al repertorio classico. Venuti a conoscenza del fatto che il pianista non potrà più suonare in pubblico, ogni suo album, per quanto registrato anni addietro, assume una particolare valenza. E’ il caso di questo “Budapest Concert” inciso il 3 luglio del 2016 alla Béla Bartok Concert Hall e declinato attraverso due CD, nel primo una serie di improvvisazioni di durata medio lunga, nel secondo ancora improvvisazioni questa volta di durata inferiore e due standard “It’s A Lonesome Old Town” di Tobias e Kisco e “Answer Me, My Love” di Winkler e Rauch. Come spesso gli capitava durante le sue performances, Jarrett preferisce mettere subito in chiaro le sue intenzioni. Ecco quindi la “Part I” sicuramente la più complessa e meno melodica dell’intero programma, in cui l’artista si lancia nelle sue ardite improvvisazioni. E tutto il primo CD, corrispondente alla prima parte del concerto, ripercorre un identico canovaccio vale a dire un pianismo allo stesso tempo lucido e imperscrutabile, vorticoso e meditativo, che comunque si lascia attrarre da quell’area culturale vicina alla musica accademica in special modo del Vecchio Continente. Il discorso cambia nel secondo disco caratterizzato sin dall’inizio da una atmosfera più raccolta, intimista e da una più avvertibile cantabilità. Fino alla degna chiusura con due standard rappresentati con dolce partecipazione. E’ sicuramente questo il Jarrett che il pubblico ama di più, quell’artista che raccoglie in sé il portato di ogni stile pianistico e che, se in stato di grazia, è capace di inanellare una serie infinita di spunti melodici come nessun altro. Ed un esempio probante si ha proprio in questo secondo CD in cui ogni singola esibizione è sugellata da una caldo applauso del pubblico senza che la tensione cali per un solo attimo: lo spettatore è definitivamente conquistato così come noi che ascoltiamo l’album comodamente accovacciati in poltrona.
Anja Lechner, François Couturier – “Lontano” – ECM
 Dopo il felice debutto nel 2014 con “Moderato cantabile” sempre firmato ECM, la violoncellista tedesca e il pianista francese tornano in sala di incisione per dar vita a questo “Lontano” articolato su sedici brani sia originali sia dovuti ad autori di aree ed epoche diverse, da Ariel Ramirez a Giya Kancheli, da Anouar Brahem a Henri Dutilleux. Come si può facilmente desumere dall’organico, si tratta di una musica dall’impianto cameristico. Quel che fa la differenza rispetto ad altre registrazioni del genere è da un canto la statura artistica dei due artisti, dall’altro la scelta del repertorio. Ascoltando l’album sin dalle primissime note si ha netta la sensazione di ascoltare musicisti in grado di coniugare una preparazione classica con il linguaggio improvvisativo proprio del jazz. Di qui un suono, una timbrica, un gioco di colori molto vicini alla tradizione cameristica europea. D’altro canto non mancano pagine in cui la capacità di improvvisare prende il sopravvento sulla pagina scritta. Funzionale a tutto ciò la scelta di un repertorio che tende quasi ad annullare qualsiasi distanza temporale tra i vari brani nell’intento – del tutto riuscito – di evidenziare come la buona musica non conosca limiti di tempo. Così, dopo i primi tre brani di impronta “colta”, il ben noto e struggente “Alfonsina y el mar” di Ariel Ramirez. E questa particolare capacità di attualizzare alcune partiture appare altresì evidente, come chiarito nel libretto che accompagna l’album, in almeno altri quattro brani: in “Memory of a Melody” ci si richiama all’aria dalla Cantata BWV 105 di Bach, in “Hymne” si avverte l’influenza di Gurdjieff, in “Postludium” fa capolino l’arte del pianista e compositore ucrainoValentin Silvestrov mentre nella title track si omaggia Federico Mompou esplicitamente ricordato nel già citato “Moderato cantabile”.
Dopo il felice debutto nel 2014 con “Moderato cantabile” sempre firmato ECM, la violoncellista tedesca e il pianista francese tornano in sala di incisione per dar vita a questo “Lontano” articolato su sedici brani sia originali sia dovuti ad autori di aree ed epoche diverse, da Ariel Ramirez a Giya Kancheli, da Anouar Brahem a Henri Dutilleux. Come si può facilmente desumere dall’organico, si tratta di una musica dall’impianto cameristico. Quel che fa la differenza rispetto ad altre registrazioni del genere è da un canto la statura artistica dei due artisti, dall’altro la scelta del repertorio. Ascoltando l’album sin dalle primissime note si ha netta la sensazione di ascoltare musicisti in grado di coniugare una preparazione classica con il linguaggio improvvisativo proprio del jazz. Di qui un suono, una timbrica, un gioco di colori molto vicini alla tradizione cameristica europea. D’altro canto non mancano pagine in cui la capacità di improvvisare prende il sopravvento sulla pagina scritta. Funzionale a tutto ciò la scelta di un repertorio che tende quasi ad annullare qualsiasi distanza temporale tra i vari brani nell’intento – del tutto riuscito – di evidenziare come la buona musica non conosca limiti di tempo. Così, dopo i primi tre brani di impronta “colta”, il ben noto e struggente “Alfonsina y el mar” di Ariel Ramirez. E questa particolare capacità di attualizzare alcune partiture appare altresì evidente, come chiarito nel libretto che accompagna l’album, in almeno altri quattro brani: in “Memory of a Melody” ci si richiama all’aria dalla Cantata BWV 105 di Bach, in “Hymne” si avverte l’influenza di Gurdjieff, in “Postludium” fa capolino l’arte del pianista e compositore ucrainoValentin Silvestrov mentre nella title track si omaggia Federico Mompou esplicitamente ricordato nel già citato “Moderato cantabile”.
Gianni Lenoci – “Wild Geese” – Dodicilune
 Quando Gianni Lenoci ci lasciò improvvisamente, su questi stessi spazi ebbi modo di sottolineare come la sua dipartita lasciasse un vuoto difficilmente colmabile. E questo album, postumo, registrato nel 2017, ne è l’ennesima conferma. Lenoci era artista di indubbio talento che trovava i suoi punti di forza da un canto in una grande capacità improvvisativa declinata attraverso composizioni originali sempre indirizzate verso una sperimentazione mai fine a sé stessa, dall’altro nell’estremo rispetto degli altri, dei suoi colleghi che lo portava ad eseguire le composizioni altrui senza alcunché perdere dell’originario fascino. In questa sua ultima fatica discografica, Lenoci è in trio con Pasquale Gadaleta al basso e Ra-Kalam Bob Moses alla batteria. In repertorio nove composizioni scritte da alcuni grandi del jazz: quattro a testa da Carla Bley e Ornette Coleman, una da Gary Peacock. L’album produce una duplice sensazione: il piacere di ascoltare alcuni standard che restano nella storia della musica e allo stesso tempo l’ammirazione per come Lenoci e compagni siano capaci di riavvolgere il nastro, scomporre i nove brani e ripresentarli secondo una logica nuova, personale, che lascia intravedere, quasi in filigrana, la profonda conoscenza della musica interpretata. E a mio avviso due sono i brani che meglio illustrano quanto sin qui detto, “Latin Genetics” e il conclusivo “Ida Lupino”, senza alcunché togliere alla maestria con cui il trio affronta tutti i brani in programma, a partire dal sontuoso “And now the queen” cui fa seguito “Job Mob“ impreziosito da un Gadaleta in grande spolvero e con un Lenoci quasi a richiamare atmosfere proprie del free. Pezzi che ci introducono alla parte centrale dell’album costituita da tre brani tutti di lunghezza superiore ai dieci minuti. Insomma un album straordinario che merita di essere ascoltato anche da chi non si professa particolarmente amante del jazz: sono sicuro che piacerà anche a costoro.
Quando Gianni Lenoci ci lasciò improvvisamente, su questi stessi spazi ebbi modo di sottolineare come la sua dipartita lasciasse un vuoto difficilmente colmabile. E questo album, postumo, registrato nel 2017, ne è l’ennesima conferma. Lenoci era artista di indubbio talento che trovava i suoi punti di forza da un canto in una grande capacità improvvisativa declinata attraverso composizioni originali sempre indirizzate verso una sperimentazione mai fine a sé stessa, dall’altro nell’estremo rispetto degli altri, dei suoi colleghi che lo portava ad eseguire le composizioni altrui senza alcunché perdere dell’originario fascino. In questa sua ultima fatica discografica, Lenoci è in trio con Pasquale Gadaleta al basso e Ra-Kalam Bob Moses alla batteria. In repertorio nove composizioni scritte da alcuni grandi del jazz: quattro a testa da Carla Bley e Ornette Coleman, una da Gary Peacock. L’album produce una duplice sensazione: il piacere di ascoltare alcuni standard che restano nella storia della musica e allo stesso tempo l’ammirazione per come Lenoci e compagni siano capaci di riavvolgere il nastro, scomporre i nove brani e ripresentarli secondo una logica nuova, personale, che lascia intravedere, quasi in filigrana, la profonda conoscenza della musica interpretata. E a mio avviso due sono i brani che meglio illustrano quanto sin qui detto, “Latin Genetics” e il conclusivo “Ida Lupino”, senza alcunché togliere alla maestria con cui il trio affronta tutti i brani in programma, a partire dal sontuoso “And now the queen” cui fa seguito “Job Mob“ impreziosito da un Gadaleta in grande spolvero e con un Lenoci quasi a richiamare atmosfere proprie del free. Pezzi che ci introducono alla parte centrale dell’album costituita da tre brani tutti di lunghezza superiore ai dieci minuti. Insomma un album straordinario che merita di essere ascoltato anche da chi non si professa particolarmente amante del jazz: sono sicuro che piacerà anche a costoro.
Ivano Nardi – “Homage to Kandinsky” –
 Il batterista Ivano Nardi può a ben ragione essere considerato personaggio storico del jazz italiano e romano in particolare. Sulla scena oramai da parecchi anni, ha collaborato con alcuni bei nomi del panorama internazionale (Massimo Urbani fra tutti e poi Mario Schiano, Marco Colonna, Steve Lacy, Evan Parker, Don Cherry e Lester Bowie) sviluppando uno stile percussivo affatto personale che oscilla tra free jazz e improvvisazione totale. In questa ultima fatica discografica si presenta in quartetto con Eugenio Colombo (sax e flauti), Roberto Bellatalla (contrabbasso) e Giancarlo Schiaffini (trombone). L’Album, come evidenziato dallo stesso titolo, trae ispirazione dai quadri del pittore russo nell’intento di rievocare, attraverso le note, i tratti caratteristici di Kandinsky, dalle armonie dei colori alla vividezza del tocco; di qui le improvvisazioni che assumono titoli quali Giallo indiano, Rosso, Giallo 1, Giallo 2, Grigio scuro, Blu ecc. In buona sostanza la materia indagata a fondo dall’artista russo viene trasformata in materia sonora ora attraverso i solo del leader ora con le improvvisazioni collettive del gruppo che ci riportano ad atmosfere proprie degli anni ’70. Il tutto viene esplicitato ulteriormente da una frase dello stesso Nardi laddove afferma, cito testualmente, che “continuo a leggere e ad approfondire cose che riguardano l’arte tutta: so che non basta una vita a raccogliere tutti questi stimoli!”.
Il batterista Ivano Nardi può a ben ragione essere considerato personaggio storico del jazz italiano e romano in particolare. Sulla scena oramai da parecchi anni, ha collaborato con alcuni bei nomi del panorama internazionale (Massimo Urbani fra tutti e poi Mario Schiano, Marco Colonna, Steve Lacy, Evan Parker, Don Cherry e Lester Bowie) sviluppando uno stile percussivo affatto personale che oscilla tra free jazz e improvvisazione totale. In questa ultima fatica discografica si presenta in quartetto con Eugenio Colombo (sax e flauti), Roberto Bellatalla (contrabbasso) e Giancarlo Schiaffini (trombone). L’Album, come evidenziato dallo stesso titolo, trae ispirazione dai quadri del pittore russo nell’intento di rievocare, attraverso le note, i tratti caratteristici di Kandinsky, dalle armonie dei colori alla vividezza del tocco; di qui le improvvisazioni che assumono titoli quali Giallo indiano, Rosso, Giallo 1, Giallo 2, Grigio scuro, Blu ecc. In buona sostanza la materia indagata a fondo dall’artista russo viene trasformata in materia sonora ora attraverso i solo del leader ora con le improvvisazioni collettive del gruppo che ci riportano ad atmosfere proprie degli anni ’70. Il tutto viene esplicitato ulteriormente da una frase dello stesso Nardi laddove afferma, cito testualmente, che “continuo a leggere e ad approfondire cose che riguardano l’arte tutta: so che non basta una vita a raccogliere tutti questi stimoli!”.
Novotono – “Wood (Wind) at Work” – Autrecords
 Sotto l’insegna dei “Novotono” incontriamo il progetto dei fratelli Adalberto ed Andrea Ferrari con il nuovo album uscito qualche mese fa. Per chi non conosca ancora questi due artisti sottolineiamo che si tratta di improvvisatori di alto livello specialisti di tutta una serie di strumenti a fiato: clarinetto basso, alto sax e baritone sax Andrea, Eb tubax, clarinetto basso, clarinetto, alto sax, soprano sax, contrabbasso clarinetto Adalberto. Già la struttura stessa dell’organico fa capire come ci si trovi dinnanzi ad una musica particolare, spesso giocata sull’aspetto timbrico ma che non trascura il lato melodico né quello ritmico. I due musicisti, fidando su capacità improvvisative non comuni, affrontano terreni spesso disagevoli inerpicandosi su chine pericolose da cui comunque escono sempre bene. Così ad esempio è davvero esemplare il modo in cui i due riescono a rendere vivo il dialogo tra gli strumenti in “Melodie Per Un Burattino Di Legno”, dialogo che sembra non risentire della mancanza di parole per rendersi esplicito nella sua natura più profonda, mentre in “Gegheghè” si abbandona questa atmosfera intima per tuffarsi in un clima rockeggiante. Ma, come si accennava, non si trascura gli spetti ritmici e melodici: ecco, quindi, “Old Durmast” caratterizzato da un andamento ritmico inusuale, a tratti sghembo ma affascinante e “Contratuba Seguoia” con una bella linea melodica ben individuabile, interrotta quasi a metà del brano da un lacerto sonoro assolutamente straniante, dopo di che il pezzo si avvia a conclusione riprendendo l’originario schema. Bella la chiusura con “Wooden Toys” scritto con piacevole ironia. Insomma un album di non facile ascolto ma di sicuro interesse da cui si ricava una importante lezione: l’improvvisazione è stato, è e sarà un elemento imprescindibile della musica jazz.
Sotto l’insegna dei “Novotono” incontriamo il progetto dei fratelli Adalberto ed Andrea Ferrari con il nuovo album uscito qualche mese fa. Per chi non conosca ancora questi due artisti sottolineiamo che si tratta di improvvisatori di alto livello specialisti di tutta una serie di strumenti a fiato: clarinetto basso, alto sax e baritone sax Andrea, Eb tubax, clarinetto basso, clarinetto, alto sax, soprano sax, contrabbasso clarinetto Adalberto. Già la struttura stessa dell’organico fa capire come ci si trovi dinnanzi ad una musica particolare, spesso giocata sull’aspetto timbrico ma che non trascura il lato melodico né quello ritmico. I due musicisti, fidando su capacità improvvisative non comuni, affrontano terreni spesso disagevoli inerpicandosi su chine pericolose da cui comunque escono sempre bene. Così ad esempio è davvero esemplare il modo in cui i due riescono a rendere vivo il dialogo tra gli strumenti in “Melodie Per Un Burattino Di Legno”, dialogo che sembra non risentire della mancanza di parole per rendersi esplicito nella sua natura più profonda, mentre in “Gegheghè” si abbandona questa atmosfera intima per tuffarsi in un clima rockeggiante. Ma, come si accennava, non si trascura gli spetti ritmici e melodici: ecco, quindi, “Old Durmast” caratterizzato da un andamento ritmico inusuale, a tratti sghembo ma affascinante e “Contratuba Seguoia” con una bella linea melodica ben individuabile, interrotta quasi a metà del brano da un lacerto sonoro assolutamente straniante, dopo di che il pezzo si avvia a conclusione riprendendo l’originario schema. Bella la chiusura con “Wooden Toys” scritto con piacevole ironia. Insomma un album di non facile ascolto ma di sicuro interesse da cui si ricava una importante lezione: l’improvvisazione è stato, è e sarà un elemento imprescindibile della musica jazz.
Enrico Pieranunzi – “Time’s Passage” – abeat
 Enrico Pieranunzi è uno di quei non molti musicisti che mai sbaglia un colpo. Ogni qualvolta decide di entrare in sala di incisione è perché ha qualcosa da dire e solitamente si tratta di qualcosa di interessante. Anche questo album registrato nel maggio del 2019, non sfugge alla regola. Il pianista-compositore romano si presenta, questa volta, alla testa di un quintetto con il grande batterista francese Dedè Ceccarelli, il compagno di tante avventure Luca Bulgarelli al contrabbasso e basso elettrico, e due ospiti di lusso quali Andrea Dulbecco al vibrafono e Simona Severini alla voce; in programma nove brani di cui sei scritti dallo stesso leader, in epoche assai diverse e due standard dovuti alle penne di David Mann e Bob Hillard l’uno, e di Arthur Hamilton e Johnny Mandel l’altro. Già dalle prime note della title track si intuisce quale sarà l’andamento dell’album: una musica oscillante tra il jazz da camera e lo swing canonico. Ecco così la delicata “Time’s Passage” impreziosita dai delicati volteggi di un Dulbecco particolarmente brillante cui fa seguito il “Valzer” espressamente dedicato ad Apollinaire con testo in francese. Con “Biff” le atmosfere virano decisamente verso uno swing più accentuato impreziosito dalle improvvisazioni dei quattro musicisti (esclusa la Severini che non figura in questo brano). E così fino all’ultimo brano, “Vacation from The Blues”. Una curiosità: nel disco c’è una doppia versione del brano “In the wee small hours of the morning” portata al successo da Frank Sinatra, una con l’ensemble e una piano e voce. Questa scelta piuttosto anomala, come spiega lo stesso Pieranunzi, è dovuta al fatto che la Severini “ha cantato così bene in entrambe le versioni di questo delicato standard americano, ha espresso il mood della canzone con tanto feeling e fascino narrativo che non me la sono sentita di togliere una delle due versioni. Meritano assolutamente di essere ascoltate entrambe”. E come dargli torto?
Enrico Pieranunzi è uno di quei non molti musicisti che mai sbaglia un colpo. Ogni qualvolta decide di entrare in sala di incisione è perché ha qualcosa da dire e solitamente si tratta di qualcosa di interessante. Anche questo album registrato nel maggio del 2019, non sfugge alla regola. Il pianista-compositore romano si presenta, questa volta, alla testa di un quintetto con il grande batterista francese Dedè Ceccarelli, il compagno di tante avventure Luca Bulgarelli al contrabbasso e basso elettrico, e due ospiti di lusso quali Andrea Dulbecco al vibrafono e Simona Severini alla voce; in programma nove brani di cui sei scritti dallo stesso leader, in epoche assai diverse e due standard dovuti alle penne di David Mann e Bob Hillard l’uno, e di Arthur Hamilton e Johnny Mandel l’altro. Già dalle prime note della title track si intuisce quale sarà l’andamento dell’album: una musica oscillante tra il jazz da camera e lo swing canonico. Ecco così la delicata “Time’s Passage” impreziosita dai delicati volteggi di un Dulbecco particolarmente brillante cui fa seguito il “Valzer” espressamente dedicato ad Apollinaire con testo in francese. Con “Biff” le atmosfere virano decisamente verso uno swing più accentuato impreziosito dalle improvvisazioni dei quattro musicisti (esclusa la Severini che non figura in questo brano). E così fino all’ultimo brano, “Vacation from The Blues”. Una curiosità: nel disco c’è una doppia versione del brano “In the wee small hours of the morning” portata al successo da Frank Sinatra, una con l’ensemble e una piano e voce. Questa scelta piuttosto anomala, come spiega lo stesso Pieranunzi, è dovuta al fatto che la Severini “ha cantato così bene in entrambe le versioni di questo delicato standard americano, ha espresso il mood della canzone con tanto feeling e fascino narrativo che non me la sono sentita di togliere una delle due versioni. Meritano assolutamente di essere ascoltate entrambe”. E come dargli torto?
Dino Rubino – “Time of Silence” – Tuk Music
 Dino Rubino è senza dubbio alcuno uno dei più fulgidi talenti emersi negli ultimi due decenni. Il trombettista, flicornista, pianista, compositore siciliano si è costruito una solida reputazione passo dopo passo, mai bruciando i tempi e mai accontentandosi dei traguardi raggiunti. Da un po’ di tempo incide per la Tuk Music e con l’etichetta di Paolo Fresu sta sfornando degli album davvero eccellenti. Quest’ultimo lo vede alla testa di un quartetto con Emanuele Cisi al sassofono tenore, Paolino Dalla Porta al contrabbasso e Enzo Zirilli alla batteria. In programma dieci brani tutti originali di Rubino che si esprime al pianoforte imbracciando il flicorno solo in un brano, “Settembre”, a chiusura del programma. Spesso ci si interroga circa la pertinenza del titolo dell’album con la musica proposta. Ebbene, in questo caso, il nesso c’è ed è evidente. In un momento in cui chi strepita più forte sembra avere la meglio (e non solo in musica) Rubino sceglie una strada diversa, una strada che privilegia la melodia che non deve essere gridata, basta sussurrarla. E’ una sorta di afflato poetico quello che scaturisce dalle note del siciliano, una musica raffinata, elegante ma tutt’altro che leziosa o banale. Prendendo spunto proprio dal silenzio quale dimensione non secondaria, Rubino guida il gruppo con un pianismo che si fonde senza alcuna forzatura con il resto del gruppo a conferma di una intesa completa. Si ascolti, ad esempio, in “Claire” il modo in cui, dopo un bell’assolo del leader, Cisi raccoglie il testimone per dialogare con il pianoforte in una sorta di botta e risposta affascinante. Così come in “Karol”, i due trovano modo di integrarsi alla perfezione evidenziando le rispettive potenzialità. Potenzialità che nel caso di Rubino sono particolarmente evidenziate in “Owl in the Moon” impreziosito da un assolo pianistico coinvolgente nella sua semplicità. Infine come non segnalare l’ultimo brano, il malinconico “Settembre”, in cui Rubino si esprime magnificamente al flicorno. Al di là della musica, bella la cover dovuta all’artista svizzero Stephan Schmitz.
Dino Rubino è senza dubbio alcuno uno dei più fulgidi talenti emersi negli ultimi due decenni. Il trombettista, flicornista, pianista, compositore siciliano si è costruito una solida reputazione passo dopo passo, mai bruciando i tempi e mai accontentandosi dei traguardi raggiunti. Da un po’ di tempo incide per la Tuk Music e con l’etichetta di Paolo Fresu sta sfornando degli album davvero eccellenti. Quest’ultimo lo vede alla testa di un quartetto con Emanuele Cisi al sassofono tenore, Paolino Dalla Porta al contrabbasso e Enzo Zirilli alla batteria. In programma dieci brani tutti originali di Rubino che si esprime al pianoforte imbracciando il flicorno solo in un brano, “Settembre”, a chiusura del programma. Spesso ci si interroga circa la pertinenza del titolo dell’album con la musica proposta. Ebbene, in questo caso, il nesso c’è ed è evidente. In un momento in cui chi strepita più forte sembra avere la meglio (e non solo in musica) Rubino sceglie una strada diversa, una strada che privilegia la melodia che non deve essere gridata, basta sussurrarla. E’ una sorta di afflato poetico quello che scaturisce dalle note del siciliano, una musica raffinata, elegante ma tutt’altro che leziosa o banale. Prendendo spunto proprio dal silenzio quale dimensione non secondaria, Rubino guida il gruppo con un pianismo che si fonde senza alcuna forzatura con il resto del gruppo a conferma di una intesa completa. Si ascolti, ad esempio, in “Claire” il modo in cui, dopo un bell’assolo del leader, Cisi raccoglie il testimone per dialogare con il pianoforte in una sorta di botta e risposta affascinante. Così come in “Karol”, i due trovano modo di integrarsi alla perfezione evidenziando le rispettive potenzialità. Potenzialità che nel caso di Rubino sono particolarmente evidenziate in “Owl in the Moon” impreziosito da un assolo pianistico coinvolgente nella sua semplicità. Infine come non segnalare l’ultimo brano, il malinconico “Settembre”, in cui Rubino si esprime magnificamente al flicorno. Al di là della musica, bella la cover dovuta all’artista svizzero Stephan Schmitz.
Terje Rypdal – “Conspiracy” – ECM
 Conosco personalmente Rypdal da più di 40 anni e fin dall’inizio l’ho considerato uno dei veri, pochi in novatori che hanno illuminato la scena jazzistica internazionale negli ultimi decenni. A mio avviso una delle caratteristiche che fanno davvero grande un musicista è la riconoscibilità: tu ascolti poche note di sassofono e riconosci Charlie Parker così come ti basta qualche accenno pianistico per individuare Keith Jarrett; egualmente sono sufficienti poche note di chitarra amplificate in un certo modo per individuare tutto un mondo: quello per l’appunto di Terje Rypdal. Registrato a Oslo nel febbraio dello scorso anno in quartetto con Ståle Storløkken keyboards, Endre Hareide Hallre basso elettrico e Pål Thowsen batteria, l’album si articola in sei composizioni del leader che attraversano un po’ tutto il suo spettro compositivo. L’aggancio a quel jazz-rock degli anni ‘70 e ’80 appare evidente ma il tutto viene reinterpretato alla luce di una modernità che si respira evidente mai dando l’impressione del deja-vu. Così se il brano d’apertura “As if the Ghost… was Me?” (“Come se fossi io, il fantasma?”) velato da sottile ironia ripercorre situazioni care al Rypdal che tutti conosciamo, ecco che già in “What was I thinking” ascoltiamo un chitarrista più pensoso, più intimista a dialogare con il basso. Più legata a stilemi rockeggianti la title-track (con evidente richiamo alla Mahavishnu Orchestra) mentre tutta la seconda parte del breve album (appena una trentina di minuti) presenta una musica più evocativa, descrittiva, melodica, oserei dire malinconica a dimostrazione di come, contrariamente a quanto asserito da qualche pur illustre collega, non si tratti di un album quasi routinario ma di una realizzazione fortemente pensata e voluta da una artista che non ha perso un’oncia della sua creatività. Per concludere si ascolti con attenzione la splendida ballad “By His Lonesome”.
Conosco personalmente Rypdal da più di 40 anni e fin dall’inizio l’ho considerato uno dei veri, pochi in novatori che hanno illuminato la scena jazzistica internazionale negli ultimi decenni. A mio avviso una delle caratteristiche che fanno davvero grande un musicista è la riconoscibilità: tu ascolti poche note di sassofono e riconosci Charlie Parker così come ti basta qualche accenno pianistico per individuare Keith Jarrett; egualmente sono sufficienti poche note di chitarra amplificate in un certo modo per individuare tutto un mondo: quello per l’appunto di Terje Rypdal. Registrato a Oslo nel febbraio dello scorso anno in quartetto con Ståle Storløkken keyboards, Endre Hareide Hallre basso elettrico e Pål Thowsen batteria, l’album si articola in sei composizioni del leader che attraversano un po’ tutto il suo spettro compositivo. L’aggancio a quel jazz-rock degli anni ‘70 e ’80 appare evidente ma il tutto viene reinterpretato alla luce di una modernità che si respira evidente mai dando l’impressione del deja-vu. Così se il brano d’apertura “As if the Ghost… was Me?” (“Come se fossi io, il fantasma?”) velato da sottile ironia ripercorre situazioni care al Rypdal che tutti conosciamo, ecco che già in “What was I thinking” ascoltiamo un chitarrista più pensoso, più intimista a dialogare con il basso. Più legata a stilemi rockeggianti la title-track (con evidente richiamo alla Mahavishnu Orchestra) mentre tutta la seconda parte del breve album (appena una trentina di minuti) presenta una musica più evocativa, descrittiva, melodica, oserei dire malinconica a dimostrazione di come, contrariamente a quanto asserito da qualche pur illustre collega, non si tratti di un album quasi routinario ma di una realizzazione fortemente pensata e voluta da una artista che non ha perso un’oncia della sua creatività. Per concludere si ascolti con attenzione la splendida ballad “By His Lonesome”.
Dino Saluzzi – “Albores” – ECM
 Tutte le volte che ho ascoltato Dino Saluzzi dal vivo ne ho sempre ricavato una forte iniezione di energia, una carica di vitalità che non sembra risentire del trascorrere del tempo. Ad onta dei suoi ottantacinque anni Saluzzi è sempre in piena attività, tanto che da poco è uscito questo suo nuovo disco. Album tra l’altro assai particolare in quanto dopo più di trent’anni il maestro argentino torna ad incidere in totale solitudine, con nove sue composizioni. Ed è ancora una volta un piccolo capolavoro. Saluzzi prosegue lungo il suo cammino, con la sua musica che è allo stesso tempo astrazione allo stato puro e narrazione di una memoria che si perde nel tempo. Di qui i riferimenti a persone a lui care e a paesaggi e scorci di natura che fanno parte del suo essere. Il tutto eseguito con uno strumento, il bandoneon, che egli ha portato a livelli di espressività mai raggiunti fino ad oggi. Certo c’è sempre Astor Piazzolla ma il linguaggio adoperato dai due è completamente diverso sì da renderne impossibile un qualsivoglia raffronto. Ma torniamo ad “Albores” che si apre con un omaggio al compositore georgiano Giya Kancheli (“Adios Maestro Kancheli”) la cui musica ha già inciso insieme al celebre violinista lettone Gidon Kremer. Immancabili i riferimenti alla musica andina che viene trasposta in un universo sonoro senza tempo (“La cruz del Sur”) così come inevitabile, lo struggente ricordo del padre (“Don Caye – Variaciones sobre obra de Cayetano Saluzzi”). Senza trascurare i rimandi ad una Buenos Aires d’altri tempi: si ascolti “Segun me cuenta la vida” una milonga ma nello stile di Saluzzi e il successivo “Intimo”. L’album si conclude con “Ofrenda – Toccata”, un brano di rara suggestione in cui misticismo e devozione coesistono a conclusione di un viaggio intriso di nostalgia, bellezza, corporeità e spiritualità a cui tutti noi siamo invitati.
Tutte le volte che ho ascoltato Dino Saluzzi dal vivo ne ho sempre ricavato una forte iniezione di energia, una carica di vitalità che non sembra risentire del trascorrere del tempo. Ad onta dei suoi ottantacinque anni Saluzzi è sempre in piena attività, tanto che da poco è uscito questo suo nuovo disco. Album tra l’altro assai particolare in quanto dopo più di trent’anni il maestro argentino torna ad incidere in totale solitudine, con nove sue composizioni. Ed è ancora una volta un piccolo capolavoro. Saluzzi prosegue lungo il suo cammino, con la sua musica che è allo stesso tempo astrazione allo stato puro e narrazione di una memoria che si perde nel tempo. Di qui i riferimenti a persone a lui care e a paesaggi e scorci di natura che fanno parte del suo essere. Il tutto eseguito con uno strumento, il bandoneon, che egli ha portato a livelli di espressività mai raggiunti fino ad oggi. Certo c’è sempre Astor Piazzolla ma il linguaggio adoperato dai due è completamente diverso sì da renderne impossibile un qualsivoglia raffronto. Ma torniamo ad “Albores” che si apre con un omaggio al compositore georgiano Giya Kancheli (“Adios Maestro Kancheli”) la cui musica ha già inciso insieme al celebre violinista lettone Gidon Kremer. Immancabili i riferimenti alla musica andina che viene trasposta in un universo sonoro senza tempo (“La cruz del Sur”) così come inevitabile, lo struggente ricordo del padre (“Don Caye – Variaciones sobre obra de Cayetano Saluzzi”). Senza trascurare i rimandi ad una Buenos Aires d’altri tempi: si ascolti “Segun me cuenta la vida” una milonga ma nello stile di Saluzzi e il successivo “Intimo”. L’album si conclude con “Ofrenda – Toccata”, un brano di rara suggestione in cui misticismo e devozione coesistono a conclusione di un viaggio intriso di nostalgia, bellezza, corporeità e spiritualità a cui tutti noi siamo invitati.
The Auanders – “Text (us)” – Auand
 Era il 2011 quando su un palco a New York, per festeggiare i dieci anni della Auand, prese forma l’idea di formare una sorta di all-star costituita da artisti dell’etichetta pugliese. Nel corso degli anni il progetto è stato presentato in molte città con organici differenti mentre dal punto di vista discografico siamo adesso al secondo capitolo. Questa volta il lavoro è frutto di una residenza di una settimana ad Arezzo presso il Cicaleto, con un programma di 8 brani originali commissionati ad hoc ad alcuni dei musicisti più attivi che collaborano con la Auand. Ecco quindi un tentetto base – Mirko Cisilino tromba e corno francese), Michele Tino (sax alto e flauto), Francesco Panconesi (sax tenore), Beppe Scardino (sax baritono e clarinetto basso), Filippo Vignato (trombone), Glauco Benedetti (tuba), Francesco Diodati (chitarra), Enrico Zanisi (pianoforte, rhodes, synth e glockenspiel), Francesco Ponticelli (basso e basso elettrico) e Stefano Tamborrino (batteria, percussioni e voce) cui si affiancano in veste di ospiti Sara Battaglini (voce), Francesco Bearzatti (clarinetto), Stefano Calderano (chitarra), Simone Graziano (rhodes) ed Evita Polidoro (voce). Il titolo – Text(Us)(“Scrivici un messaggio”) – contiene di per sé una della carte vincenti dell’etichetta di Bisceglie, vale a dire la voglia di entrare in contatto e in empatia con l’ascoltatore . Dal punto di vista prettamente musicale l’album risulta interessante soprattutto per le modalità di esecuzione: il gruppo, pur essendo numeroso, si muove con grande scioltezza evidenziando una notevole intesa sia nelle parti d’assieme sia nei momenti in cui vengono lasciati spazi ai molti solisti. Il tutto reso possibile da centrati arrangiamenti attraverso cui gli artisti trovano, per l’appunto, modo di esprimere le proprie potenzialità. Notevoli, da questo punto di vista, le sortite, tanto per citare qualche nome, di Francesco Bearzatti in “Song to the Unborn”, Filippo Vignato in “One Week”, oltre alle splendide voci di Sara Battaglini e Evita Polidoro.
Era il 2011 quando su un palco a New York, per festeggiare i dieci anni della Auand, prese forma l’idea di formare una sorta di all-star costituita da artisti dell’etichetta pugliese. Nel corso degli anni il progetto è stato presentato in molte città con organici differenti mentre dal punto di vista discografico siamo adesso al secondo capitolo. Questa volta il lavoro è frutto di una residenza di una settimana ad Arezzo presso il Cicaleto, con un programma di 8 brani originali commissionati ad hoc ad alcuni dei musicisti più attivi che collaborano con la Auand. Ecco quindi un tentetto base – Mirko Cisilino tromba e corno francese), Michele Tino (sax alto e flauto), Francesco Panconesi (sax tenore), Beppe Scardino (sax baritono e clarinetto basso), Filippo Vignato (trombone), Glauco Benedetti (tuba), Francesco Diodati (chitarra), Enrico Zanisi (pianoforte, rhodes, synth e glockenspiel), Francesco Ponticelli (basso e basso elettrico) e Stefano Tamborrino (batteria, percussioni e voce) cui si affiancano in veste di ospiti Sara Battaglini (voce), Francesco Bearzatti (clarinetto), Stefano Calderano (chitarra), Simone Graziano (rhodes) ed Evita Polidoro (voce). Il titolo – Text(Us)(“Scrivici un messaggio”) – contiene di per sé una della carte vincenti dell’etichetta di Bisceglie, vale a dire la voglia di entrare in contatto e in empatia con l’ascoltatore . Dal punto di vista prettamente musicale l’album risulta interessante soprattutto per le modalità di esecuzione: il gruppo, pur essendo numeroso, si muove con grande scioltezza evidenziando una notevole intesa sia nelle parti d’assieme sia nei momenti in cui vengono lasciati spazi ai molti solisti. Il tutto reso possibile da centrati arrangiamenti attraverso cui gli artisti trovano, per l’appunto, modo di esprimere le proprie potenzialità. Notevoli, da questo punto di vista, le sortite, tanto per citare qualche nome, di Francesco Bearzatti in “Song to the Unborn”, Filippo Vignato in “One Week”, oltre alle splendide voci di Sara Battaglini e Evita Polidoro.
Tingvall Trio – “Dance” – Skip Records
 Martin Tingvall (pianoforte), Omar Rodriguez Calvo (basso) e Jürgen Spiegel (batteria) sono i protagonisti di questo convincente album registrato per la “Skip Records”. La formazione ha oramai acquisito una solida reputazione confermata da quest’ultima fatica discografica. Tingvall e compagni prendono per mano l’ascoltatore e lo conducono in un immaginario viaggio attorno al mondo a ritmo dei vari stili di danza. Il tutto interpretato sempre con pertinenza e alla luce di un’empatia che il trio ha evidenziato in tutti gli album fin qui incisi. Quest’ultimo “Dance” è declinato attraverso tredici brani tutti scritti dal leader e arrangiati collegialmente dal trio in modo davvero assai curato come si evidenzia sia dalle intro sia dalle chiusure dei vari brani. Si parte con un esplicito richiamo al Giappone cui fa seguito la title track caratterizzata da una suadente linea melodica ben disegnata dal leader con i tamburi a sottolineare un clima arcaico, senza tempo. In “Spanish Swing”, “Cuban SMS” e “Bolero” è l’anima latina a prevalere grazie ad una caratterizzazione ritmica particolarmente centrata in “Bolero” mentre in “Arabic Slow Dance” si avvertono i profumi dell’Oriente con una significativa introduzione di Calvo impegnato poi in un fitto dialogo con il leader per tutta la durata del brano. “Ya Man” tratteggia un’atmosfera diversa dal resto dell’album in quanto siamo in pieno clima reggae con una forte tappeto ritmico intessuto da Calvo e Spiegel nel cui ambito si inserisce il pianismo di Tingvall. Se questi sono i brani in cui maggiormente si avverte il sapore della “danza” non mancano mezzi più meditativi e introspettivi come il conclusivo “In memory…”.
Martin Tingvall (pianoforte), Omar Rodriguez Calvo (basso) e Jürgen Spiegel (batteria) sono i protagonisti di questo convincente album registrato per la “Skip Records”. La formazione ha oramai acquisito una solida reputazione confermata da quest’ultima fatica discografica. Tingvall e compagni prendono per mano l’ascoltatore e lo conducono in un immaginario viaggio attorno al mondo a ritmo dei vari stili di danza. Il tutto interpretato sempre con pertinenza e alla luce di un’empatia che il trio ha evidenziato in tutti gli album fin qui incisi. Quest’ultimo “Dance” è declinato attraverso tredici brani tutti scritti dal leader e arrangiati collegialmente dal trio in modo davvero assai curato come si evidenzia sia dalle intro sia dalle chiusure dei vari brani. Si parte con un esplicito richiamo al Giappone cui fa seguito la title track caratterizzata da una suadente linea melodica ben disegnata dal leader con i tamburi a sottolineare un clima arcaico, senza tempo. In “Spanish Swing”, “Cuban SMS” e “Bolero” è l’anima latina a prevalere grazie ad una caratterizzazione ritmica particolarmente centrata in “Bolero” mentre in “Arabic Slow Dance” si avvertono i profumi dell’Oriente con una significativa introduzione di Calvo impegnato poi in un fitto dialogo con il leader per tutta la durata del brano. “Ya Man” tratteggia un’atmosfera diversa dal resto dell’album in quanto siamo in pieno clima reggae con una forte tappeto ritmico intessuto da Calvo e Spiegel nel cui ambito si inserisce il pianismo di Tingvall. Se questi sono i brani in cui maggiormente si avverte il sapore della “danza” non mancano mezzi più meditativi e introspettivi come il conclusivo “In memory…”.
Oltre al CD e all’uscita digitale, sarà presto disponibile anche una stampa vinile da 180 gr.
Dominik Wania – “Lonely Shadows” – ECM
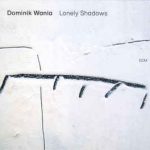 Dopo i successi ottenuti con il Maciej Obara Quartet (“Unloved”, “Three crowns”, ambedue targati ECM)), il pianista polacco Dominik Wania si misura con un ‘piano solo’ registrato nel novembre del 2019 a Lugano, ma che comincia a prendere forma già alcuni anni addietro dopo le registrazioni del citato “Unloved”. Per quanti seguono il jazz con buona attenzione non sarà sfuggito il valore di questo pianista che coniuga un background di tipo classico con capacità improvvisative proprie del jazz-man. Forte di queste caratteristiche Wania affronta la prova più difficile e importante della sua carriera e ne esce a fronte alta. In undici brani tutti di sua composizione e tutti affidati all’improvvisazione del momento, il pianista ci offre una sorta di summa delle sue capacità compositive e interpretative. La sua musica, tutt’altro che di facile ascolto, presenta evidenti richiami a Satie, Ravel e Messiaen; il tocco è leggero, fluido; grande l’attenzione per il dettaglio acustico; solida la concezione architettonica delle composizioni nonostante sia praticamente impossibile individuare chiare linee melodiche o qualsivoglia pattern ritmico. Insomma, come già accennato, siamo nel campo dell’improvvisazione totale che l’artista maneggia con disinvoltura e con originalità mai proponendo qualcosa di banale. Tra i vari brani da segnalare “AG76” un omaggio all’artista polacco Zdzisław Beksiński (1929-2005) le cui distopiche e surreali immagini hanno fortemente influenzato Wania il quale per eseguire il brano ha ricercato una timbrica delicata e nebbiosa, mentre “Indifferent Attitude” si differenzia dagli altri pezzi per essere molto vicino ad atmsfere tipiche del free jazz storico.
Dopo i successi ottenuti con il Maciej Obara Quartet (“Unloved”, “Three crowns”, ambedue targati ECM)), il pianista polacco Dominik Wania si misura con un ‘piano solo’ registrato nel novembre del 2019 a Lugano, ma che comincia a prendere forma già alcuni anni addietro dopo le registrazioni del citato “Unloved”. Per quanti seguono il jazz con buona attenzione non sarà sfuggito il valore di questo pianista che coniuga un background di tipo classico con capacità improvvisative proprie del jazz-man. Forte di queste caratteristiche Wania affronta la prova più difficile e importante della sua carriera e ne esce a fronte alta. In undici brani tutti di sua composizione e tutti affidati all’improvvisazione del momento, il pianista ci offre una sorta di summa delle sue capacità compositive e interpretative. La sua musica, tutt’altro che di facile ascolto, presenta evidenti richiami a Satie, Ravel e Messiaen; il tocco è leggero, fluido; grande l’attenzione per il dettaglio acustico; solida la concezione architettonica delle composizioni nonostante sia praticamente impossibile individuare chiare linee melodiche o qualsivoglia pattern ritmico. Insomma, come già accennato, siamo nel campo dell’improvvisazione totale che l’artista maneggia con disinvoltura e con originalità mai proponendo qualcosa di banale. Tra i vari brani da segnalare “AG76” un omaggio all’artista polacco Zdzisław Beksiński (1929-2005) le cui distopiche e surreali immagini hanno fortemente influenzato Wania il quale per eseguire il brano ha ricercato una timbrica delicata e nebbiosa, mentre “Indifferent Attitude” si differenzia dagli altri pezzi per essere molto vicino ad atmsfere tipiche del free jazz storico.
Marcin Wasilewski Trio, Joe Lovano – “Arctic Riff” – ECM
 Incontro al vertice tra uno dei più grandi sassofonisti degli ultimi decenni e un trio polacco di tutto rispetto guidato dal pianista Marcin Wasilewski e completato da Slawomir Kurkiewicz al contrabbasso e Michail Miskiewicz alla batteria. Quasi inutile sottolineare la grande versatilità di Lovano che riesce a mantenere intatta la propria individualità indipendentemente dal contesto in cui si trova ad operare. Dal canto suo il trio polacco conferma quanto di buono aveva già evidenziato anche nelle collaborazioni con il trombettista anch’egli polacco Tomasz Stanko. In repertorio composizioni dei due leader, un brano di Carla Bley e uno di Joe Lovano cui si aggiungono alcune improvvisazioni collettive. Il quartetto si muove, quindi, su coordinate piuttosto differenziate. Così, ad esempio, nella doppia versione di “Vashkar” di Carla Bley mentre nella prima dopo una breve introduzione di Lovano, Wasilewski si impossessa del tema per svilupparlo alla sua maniera dopo di che interviene ancora Lovano il tutto mantenendosi nei limiti di una visitazione piuttosto letterale, nella seconda prevale un maggior spirito improvvisativo. Ben strutturate le melodie del pianista che si avvalgono di un Lovano in gran spolvero specie in “Fading Sorrow” mentre in “L’Amour Fou” è il batterista a mettersi in particolare luce; splendido il brano finale, “Old Hat”, una suggestiva ballad impreziosita dagli assolo dei due leader che si iscrive di diritto nelle grandi tradizioni del jazz. Nelle improvvisazioni collettive è tutto il quartetto a marciare all’unisono grazie soprattutto al sassofonista che, come si accennava, è riuscito ad inserirsi perfettamente nel già rodato meccanismo del trio polacco.
Incontro al vertice tra uno dei più grandi sassofonisti degli ultimi decenni e un trio polacco di tutto rispetto guidato dal pianista Marcin Wasilewski e completato da Slawomir Kurkiewicz al contrabbasso e Michail Miskiewicz alla batteria. Quasi inutile sottolineare la grande versatilità di Lovano che riesce a mantenere intatta la propria individualità indipendentemente dal contesto in cui si trova ad operare. Dal canto suo il trio polacco conferma quanto di buono aveva già evidenziato anche nelle collaborazioni con il trombettista anch’egli polacco Tomasz Stanko. In repertorio composizioni dei due leader, un brano di Carla Bley e uno di Joe Lovano cui si aggiungono alcune improvvisazioni collettive. Il quartetto si muove, quindi, su coordinate piuttosto differenziate. Così, ad esempio, nella doppia versione di “Vashkar” di Carla Bley mentre nella prima dopo una breve introduzione di Lovano, Wasilewski si impossessa del tema per svilupparlo alla sua maniera dopo di che interviene ancora Lovano il tutto mantenendosi nei limiti di una visitazione piuttosto letterale, nella seconda prevale un maggior spirito improvvisativo. Ben strutturate le melodie del pianista che si avvalgono di un Lovano in gran spolvero specie in “Fading Sorrow” mentre in “L’Amour Fou” è il batterista a mettersi in particolare luce; splendido il brano finale, “Old Hat”, una suggestiva ballad impreziosita dagli assolo dei due leader che si iscrive di diritto nelle grandi tradizioni del jazz. Nelle improvvisazioni collettive è tutto il quartetto a marciare all’unisono grazie soprattutto al sassofonista che, come si accennava, è riuscito ad inserirsi perfettamente nel già rodato meccanismo del trio polacco.
da Redazione | 08/Set/2020 | News, Primo piano
di Alessandro Fadalti –
Un contrabbassista divenuto tale per il fato. Nato nel 1935, la sua educazione musicale passa per vari strumenti. Ha espresso la sua arte sul pianoforte, sulla tromba e sulla batteria, per poi ritrovarsi tra le mani quel grande armadio di pregiata liuteria durante la sua permanenza in Germania poco prima di cominciare a suonare con Bud Shank a Francoforte. Il destino volle che il bassista del gruppo in cui suonava in quegli anni si sposasse e mettesse su famiglia, abbandonando la musica. Gary Peacock dovette passare dalle corde del piano a quelle del contrabbasso in uno schiocco di dita. Studiava e migliorava giorno dopo giorno a una rapidità tale che pareva nato per quello strumento. Tornato negli Stati Uniti, iniziò a farsi un nome suonando in alcune Session con Art Pepper. Successivamente si trasferì con la sposa novizia, Annette, a New York e da lì in poi la sua carriera si compone di numerose collaborazioni con grandissimi nomi del Jazz.

Gary Peacock
Quello che molti sottolineano di Gary Peacock è l’estrema connessione che riesce a stabilire con i musicisti. Nelle interviste è difficile che il contrabbassista parli di artisti o gruppi in cui non si sia trovato a proprio agio. La sua figura è indissolubilmente legata al concetto di Interplay nel senso più puro, forse anche grazie alle esperienze da polistrumentista. Questi caratteri trovano forte spazio nella sua più memorabile e proficua collaborazione con il Keith Jarret Trio, a cui si aggiungono la più datata e duratura fratellanza con il pianista Paul Bley e i primi passi all’interno del mondo del Free con il sassofonista Albert Ayler.

Keith Jarrett Trio
Con lui giunge anche il suo periodo di vita più buio. Gli anni ‘60 stavano tramontando, l’abuso di acidi e i problemi di salute lo portano a mettere in discussione se stesso fino alla radice. Si analizza come essere umano, realizzando che tolto il basso dalle sue mani vivrebbe lo stesso, ma lui è soltanto un musicista e nient’altro. Questa crisi interiore lo porterà ad abbandonare la scena musicale e trasferirsi per qualche anno in Giappone a studiare medicina orientale. Una scelta convergente al suo interesse per il buddismo zen. Ritrova un equilibrio nella sua esistenza attraverso la filosofia orientale e la meditazione Zazen, ma soprattutto riscopre l’entusiasmo di suonare grazie ad alcuni musicisti locali. Produce due album “Eastward”(1970) e “Voices” (1971) con il pianista Masabumi Kikuchi, il batterista Hiroshi Murakami, e il percussionista Masahiko Togashi. I due dischi sono la messa su nastro del risveglio e cambiamento del suo io più profondo. Possiamo udire un netto cambio di stile, il suo approccio mantiene la caratteristica timbrica possente che sa dare al contrabbasso, a cui va ad amplificarsi quella che è la sensibilità armonico-melodica. Nella sua estetica si aggiunge il carattere dello spazio che il suono occupa, includendo molti più silenzi e note sospese. In ultimo, si libera del tempo stabile, carattere quest’ultimo che entra in risonanza con l’amore per Ornette Coleman, che scoprì grazie al suo collega e amico Scott LaFaro. “Ishi” è il brano d’apertura dell’album “Voices”: basterà ascoltare i quattro minuti iniziali del solo di contrabbasso per percepire quanto la spiritualità zen abbia influenzato il suo modo di suonare.

Quanto detto ci permette di capire l’intensità sensibile che, chi lo ama, ritrova nella sua musica con Keith Jarrett e Jack DeJohnette: un trio in cui, a sue parole, si percepiva una magica intesa che portava tutti a essere così dentro le composizioni da riuscire a esprimersi oltre i propri limiti. In esso possiamo sentire la massima maturazione della sua musica, che affonda radici in quella collaborazione nipponica meno discussa tra gli ascoltatori di Jazz. Proprio in Jarrett ritrova quel senso Zen che stava cercando; infatti, in un’intervista per All About Jazz, Peacock riporta la risposta del suo maestro zen John Daido Lori, alla domanda cosa sia lo zen: «Just do what you’re doing while you’re doing it. – e continua commentando – It’s so simple, but it’s so hard! That’s something about Keith. Whatever he’s doing, he’s doing it. In some ways he’s more Zen than anybody I’ve ever met». («Fai semplicemente quello che stai facendo mentre lo stai facendo – e continua commentando – È così semplice, ma è così difficile! È qualcosa su Keith. Qualunque cosa stia facendo, la sta facendo. In un certo senso è più zen di chiunque io abbia mai incontrato».)
Dell’ultima decade, va menzionato con particolare attenzione l’album come bandleader “Tangents” (2016) con il suo trio assieme al pianista Marc Copland, amico di lunga data, e il batterista Joey Baron in cui il brano “Empty Forest” è forse il miglior lascito di questo modo profondamente spirituale di vivere da musicista. Non far diventare il proprio strumento un’estensione di sé, ma connettersi con esso come fosse una persona a parte, così come si fa con gli artisti con cui si suona.
Di lui ricorderemo il suo esser ben più che un musicista nella vita: la filosofia zen che si fonde con le corde del suo basso.
Alessandro Fadalti
 “Jazz Area – seipersei – Pgg.160 ” trae origine dalla mostra “Jazz Area la mia storia con il jazz in 25 quadri” commissionata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pavia nel 1999, e poi esposta una decina di volte. Come sottolinea lo stesso Masotti, l’opera andrebbe considerata come “la mia storia attraverso il jazz più che con il jazz”. Insomma una sorta di viaggio autobiografico il cui tragitto viene ripercorso attraverso una serie di immagini mai banali. Il libro si apre con la formazione “Detroit Free Jazz”, con Art Fletcher, Don Moye e Ron Miller al Conservatorio di Bologna nel 1968, e si chiude con un fotomontaggio relativo a Sun Ra.
“Jazz Area – seipersei – Pgg.160 ” trae origine dalla mostra “Jazz Area la mia storia con il jazz in 25 quadri” commissionata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pavia nel 1999, e poi esposta una decina di volte. Come sottolinea lo stesso Masotti, l’opera andrebbe considerata come “la mia storia attraverso il jazz più che con il jazz”. Insomma una sorta di viaggio autobiografico il cui tragitto viene ripercorso attraverso una serie di immagini mai banali. Il libro si apre con la formazione “Detroit Free Jazz”, con Art Fletcher, Don Moye e Ron Miller al Conservatorio di Bologna nel 1968, e si chiude con un fotomontaggio relativo a Sun Ra. Le foto sono impaginate in modo assai particolare: una stampa a colore argento su una carta spessa e nera, associate a titoli, didascalie, brevi testi, per cui, evidenzia ancora Masotti, è “più un progetto di mostra che un risultato fissato per sempre, più una riflessione sul jazz filtrata dalla mia personale esperienza che una storia del jazz per immagini per forza di cose limitata e parziale”. Così si susseguono una serie di istantanee accomunate da un filo rosso: l’intenzione di Masotti di non presentare una galleria di ritratti ma, in qualche modo, di interpretare il soggetto che viene ripreso in un momento di verità. Quindi nessuna posa ma scatti che colgono i musicisti o sul palco o in un momento di pausa. Le foto sono organizzate per aree tematiche tra cui: blues; blowers sassofoni; canto; Miles Davis; Sam Rivers – Archie Shepp, Jazz & Polities; Steve Lacy; Drums – drummers; Gruppi; Dave Holland big-band; Brotherhood of Breath; Jazz italiano; Jazz Rock; Chitarristi; ECM, Keith Jarrett… I protagonisti di questa galleria sono quindi tantissimi e sarebbe inutile citarli tutti; valga comunque qualche nome: Miles Davis, Gato Barbieri, Steve Lacy, Max Roach, Ornette Coleman, Sonny Rollins, Archie Shepp, Carla Bley, Sam Rivers, Cecil Taylor, Charles Mingus, e, tra gli italiani, Stefano Bollani, Antonello Salis, Roberto Ottaviano, Gianluca Petrella.
Le foto sono impaginate in modo assai particolare: una stampa a colore argento su una carta spessa e nera, associate a titoli, didascalie, brevi testi, per cui, evidenzia ancora Masotti, è “più un progetto di mostra che un risultato fissato per sempre, più una riflessione sul jazz filtrata dalla mia personale esperienza che una storia del jazz per immagini per forza di cose limitata e parziale”. Così si susseguono una serie di istantanee accomunate da un filo rosso: l’intenzione di Masotti di non presentare una galleria di ritratti ma, in qualche modo, di interpretare il soggetto che viene ripreso in un momento di verità. Quindi nessuna posa ma scatti che colgono i musicisti o sul palco o in un momento di pausa. Le foto sono organizzate per aree tematiche tra cui: blues; blowers sassofoni; canto; Miles Davis; Sam Rivers – Archie Shepp, Jazz & Polities; Steve Lacy; Drums – drummers; Gruppi; Dave Holland big-band; Brotherhood of Breath; Jazz italiano; Jazz Rock; Chitarristi; ECM, Keith Jarrett… I protagonisti di questa galleria sono quindi tantissimi e sarebbe inutile citarli tutti; valga comunque qualche nome: Miles Davis, Gato Barbieri, Steve Lacy, Max Roach, Ornette Coleman, Sonny Rollins, Archie Shepp, Carla Bley, Sam Rivers, Cecil Taylor, Charles Mingus, e, tra gli italiani, Stefano Bollani, Antonello Salis, Roberto Ottaviano, Gianluca Petrella. “Keith Jarrett a portrait – seipersei – Pgg. 112” è invece di impostazione completamente diversa. Si tratta di un vero e proprio omaggio, o se volete un atto d’amore, che il fotografo dedica ad uno dei più grandi pianisti del jazz. Le foto sono accompagnate da testi di Geoff Dyer, Franco Fabbri e dello stesso Masotti il quale afferma esplicitamente che “In questa lunga serie di fotografie che osservo retrospettivamente, si gioca decisamente sulla presenza, quella del corpo e dello strumento, che compaiono nell’immagine. Le foto sono il risultato di una intima e oggettiva attenzione nei confronti di un artista a lungo seguito e ammirato, ma anche di una sua risposta che è consapevole accettazione, e soprattutto, partecipazione. Suo, solo suo, è il suono di una musica inconfondibile che la serie di fotografie ambisce di evocare e far risuonare.” In effetti Masotti ha assistito ad un centinaio di suoi concerti avendo così moltissime occasioni per estrinsecare la sua arte. Il libro si apre con una foto molti importante nella vita di Roberto: siamo nel 1969 e Keith Jarrett si esibisce al Teatro Comunale di Bologna nell’ambito del locale jazz Festival. Masotti non è ancora un professionista; fotografa con la Rolleiflex del padre, ma il risultato è talmente soddisfacente da indurlo a proseguire lungo la via delle foto. Dopo questa prima foto, gli scatti, esclusivamente in bianco e nero, sono organizzati in ordine cronologico fino al 2009… ed è davvero straniante constatare come l’aspetto del pianista sia cambiato con lo scorrere del tempo e come Masotti sia riuscito a cogliere gli aspetti più intimi della personalità dell’artista…anche perché è stato per lungo tempo l’unico fotografo ammesso alle prove di Jarrett. Ecco quindi il pianista impegnato durante un concerto… o in un momento di riposo accomodato in poltrona… o ancora seduto dietro una batteria o intento a suonare il sax soprano. E ammirando queste foto si ha quasi l’impressione di sentire le dita di Jarrett scorrere sulla tastiera per quelle straordinarie improvvisazioni che ci hanno deliziato fino al 2018 anno che ha segnato il definitivo abbandono delle scene da parte del pianista colpito da due ictus.
“Keith Jarrett a portrait – seipersei – Pgg. 112” è invece di impostazione completamente diversa. Si tratta di un vero e proprio omaggio, o se volete un atto d’amore, che il fotografo dedica ad uno dei più grandi pianisti del jazz. Le foto sono accompagnate da testi di Geoff Dyer, Franco Fabbri e dello stesso Masotti il quale afferma esplicitamente che “In questa lunga serie di fotografie che osservo retrospettivamente, si gioca decisamente sulla presenza, quella del corpo e dello strumento, che compaiono nell’immagine. Le foto sono il risultato di una intima e oggettiva attenzione nei confronti di un artista a lungo seguito e ammirato, ma anche di una sua risposta che è consapevole accettazione, e soprattutto, partecipazione. Suo, solo suo, è il suono di una musica inconfondibile che la serie di fotografie ambisce di evocare e far risuonare.” In effetti Masotti ha assistito ad un centinaio di suoi concerti avendo così moltissime occasioni per estrinsecare la sua arte. Il libro si apre con una foto molti importante nella vita di Roberto: siamo nel 1969 e Keith Jarrett si esibisce al Teatro Comunale di Bologna nell’ambito del locale jazz Festival. Masotti non è ancora un professionista; fotografa con la Rolleiflex del padre, ma il risultato è talmente soddisfacente da indurlo a proseguire lungo la via delle foto. Dopo questa prima foto, gli scatti, esclusivamente in bianco e nero, sono organizzati in ordine cronologico fino al 2009… ed è davvero straniante constatare come l’aspetto del pianista sia cambiato con lo scorrere del tempo e come Masotti sia riuscito a cogliere gli aspetti più intimi della personalità dell’artista…anche perché è stato per lungo tempo l’unico fotografo ammesso alle prove di Jarrett. Ecco quindi il pianista impegnato durante un concerto… o in un momento di riposo accomodato in poltrona… o ancora seduto dietro una batteria o intento a suonare il sax soprano. E ammirando queste foto si ha quasi l’impressione di sentire le dita di Jarrett scorrere sulla tastiera per quelle straordinarie improvvisazioni che ci hanno deliziato fino al 2018 anno che ha segnato il definitivo abbandono delle scene da parte del pianista colpito da due ictus.
































 Questo del sassofonista Stefano Di Battista è il primo dei tre album dedicati al cinema che viene ospitato nella nostra abituale rassegna discografica. L’album è particolare in quanto Di Battista, ben coadiuvato da Fred Nardin al pianoforte, Daniele Sorrentino al contrabbasso e il fantastico André Ceccarelli alla batteria, dedica questa sua ultima impresa discografica a Ennio Morricone, uno dei più grandi musicisti italiani degli ultimi tempi, al quale era legato da profonda e sincera amicizia. E lo fa nel modo migliore, vale a dire tralasciando i brani più noti, quelli che tutti conosciamo, per far ricorso ad alcune vere e proprie perle del Maestro che purtroppo non sempre godono di grande popolarità. Così l’unico brano universalmente conosciuto è “Metti una sera a cena” dall’omonimo film del 1969 diretto da Giuseppe Patroni Griffi, con Lino Capolicchio e Florinda Bolkan magnifici interpreti. Di Battista ce lo ripropone in una versione swingante in cui il sassofonista si produce in uno degli assolo più riusciti dell’intero album, che nulla toglie all’originaria bellezza del pezzo. Toccante, così come l’originale, “Tema di Deborah” da “C’era una volta in America” mentre in “Gabriel’s Oboe” da “Mission” Di Battista sostituisce il suo sax soprano all’originario oboe, con risultati straordinari nel mantenere sempre e comunque l’originaria bellezza della scrittura ‘morriconiana’. E questa sorta di devozione si avverte anche nel modo in cui la musica viene eseguita: niente muscolose esibizioni di bravura, niente arrangiamenti particolarmente sofisticati, insomma nessun escamotage per stupire l’ascoltatore, ma solo il piacere di suonare una musica evidentemente amata e profondamente vissuta. Splendida, e come poteva essere diversamente, anche l’interpretazione di “Flora” un pezzo che Morricone scrisse appositamente per Di Battista. Il disco è stato preceduto dai tre singoli “Peur sur la ville” (uscito il 29 gennaio), “Cosa avete fatto a Solange?” (uscito il 26 febbraio) e “Gabriel’s Oboe” (uscito il 19 marzo).
Questo del sassofonista Stefano Di Battista è il primo dei tre album dedicati al cinema che viene ospitato nella nostra abituale rassegna discografica. L’album è particolare in quanto Di Battista, ben coadiuvato da Fred Nardin al pianoforte, Daniele Sorrentino al contrabbasso e il fantastico André Ceccarelli alla batteria, dedica questa sua ultima impresa discografica a Ennio Morricone, uno dei più grandi musicisti italiani degli ultimi tempi, al quale era legato da profonda e sincera amicizia. E lo fa nel modo migliore, vale a dire tralasciando i brani più noti, quelli che tutti conosciamo, per far ricorso ad alcune vere e proprie perle del Maestro che purtroppo non sempre godono di grande popolarità. Così l’unico brano universalmente conosciuto è “Metti una sera a cena” dall’omonimo film del 1969 diretto da Giuseppe Patroni Griffi, con Lino Capolicchio e Florinda Bolkan magnifici interpreti. Di Battista ce lo ripropone in una versione swingante in cui il sassofonista si produce in uno degli assolo più riusciti dell’intero album, che nulla toglie all’originaria bellezza del pezzo. Toccante, così come l’originale, “Tema di Deborah” da “C’era una volta in America” mentre in “Gabriel’s Oboe” da “Mission” Di Battista sostituisce il suo sax soprano all’originario oboe, con risultati straordinari nel mantenere sempre e comunque l’originaria bellezza della scrittura ‘morriconiana’. E questa sorta di devozione si avverte anche nel modo in cui la musica viene eseguita: niente muscolose esibizioni di bravura, niente arrangiamenti particolarmente sofisticati, insomma nessun escamotage per stupire l’ascoltatore, ma solo il piacere di suonare una musica evidentemente amata e profondamente vissuta. Splendida, e come poteva essere diversamente, anche l’interpretazione di “Flora” un pezzo che Morricone scrisse appositamente per Di Battista. Il disco è stato preceduto dai tre singoli “Peur sur la ville” (uscito il 29 gennaio), “Cosa avete fatto a Solange?” (uscito il 26 febbraio) e “Gabriel’s Oboe” (uscito il 19 marzo). Il terzo album in qualche modo dedicato al cinema è questo “Ciak” che vede impegnati Renzo Ruggieri alla fisarmonica e Marino De Federicis alla chitarra. Si tratta di un duo ampiamente collaudato che ha già inciso un album, “Terre” (2008), e che si è esibito con successo in Finlandia e Austria, oltre che in diversi festival italiani. Adesso tornano a presentarsi al pubblico del jazz con questo nuovo album composto da cinque brani per un totale di circa ventisette minuti di musica comunque di eccellente qualità. Il fatto è che Renzo Ruggieri si è oramai imposto all’attenzione del pubblico internazionale come uno dei migliori fisarmonicisti non solo italiani e può vantare una certa parsimonia nell’entrare in sala di registrazione: tutti i suoi album conservano uno standard qualitativo molto elevato grazie al fatto che Renzo decide di incidere un disco solo se ha qualcosa da dire. Dal canto suo Mauro De Federicis può esibire una preparazione di base di assoluto rispetto e una continua frequentazione con l’olimpo del jazz testimoniato dalle collaborazioni con nomi prestigiosi quali Dee Dee Bridgewater, Paolo Fresu, Bob Mintzer, tanto per fare qualche esempio. In questo album, dedicato al cinema, i due hanno scelto di eseguire due composizioni originali e tre brani di assoluto spessore come “Il postino” di Luis Bacalov, Riccardo Del Turco e Paolo Margheri, “La gita in barca” di Piero Piccioni e “Speak Softly Love” di Rota tratto da “Il Padrino”. Una scelta coraggiosa non fosse altro che per aver tralasciato quel Morricone cui viceversa sono dedicati i due precedenti album. Particolarmente interessante il modo in cui i due attualizzano le atmosfere proprie di giganti del cinema dedicando loro due brani, “De Niro” (Marino De Federicis) e “Fellini” (Ruggieri). Comunque il pezzo che più mi ha toccato è stato “Il Postino” il cui originario pathos è stato perfettamente riproposto. E devo dire che in questo tipo di riletture Ruggieri è davvero un maestro: basti dire che ogni qualvolta lo ascolto eseguire “Caruso” mi è difficile contenere la commozione.
Il terzo album in qualche modo dedicato al cinema è questo “Ciak” che vede impegnati Renzo Ruggieri alla fisarmonica e Marino De Federicis alla chitarra. Si tratta di un duo ampiamente collaudato che ha già inciso un album, “Terre” (2008), e che si è esibito con successo in Finlandia e Austria, oltre che in diversi festival italiani. Adesso tornano a presentarsi al pubblico del jazz con questo nuovo album composto da cinque brani per un totale di circa ventisette minuti di musica comunque di eccellente qualità. Il fatto è che Renzo Ruggieri si è oramai imposto all’attenzione del pubblico internazionale come uno dei migliori fisarmonicisti non solo italiani e può vantare una certa parsimonia nell’entrare in sala di registrazione: tutti i suoi album conservano uno standard qualitativo molto elevato grazie al fatto che Renzo decide di incidere un disco solo se ha qualcosa da dire. Dal canto suo Mauro De Federicis può esibire una preparazione di base di assoluto rispetto e una continua frequentazione con l’olimpo del jazz testimoniato dalle collaborazioni con nomi prestigiosi quali Dee Dee Bridgewater, Paolo Fresu, Bob Mintzer, tanto per fare qualche esempio. In questo album, dedicato al cinema, i due hanno scelto di eseguire due composizioni originali e tre brani di assoluto spessore come “Il postino” di Luis Bacalov, Riccardo Del Turco e Paolo Margheri, “La gita in barca” di Piero Piccioni e “Speak Softly Love” di Rota tratto da “Il Padrino”. Una scelta coraggiosa non fosse altro che per aver tralasciato quel Morricone cui viceversa sono dedicati i due precedenti album. Particolarmente interessante il modo in cui i due attualizzano le atmosfere proprie di giganti del cinema dedicando loro due brani, “De Niro” (Marino De Federicis) e “Fellini” (Ruggieri). Comunque il pezzo che più mi ha toccato è stato “Il Postino” il cui originario pathos è stato perfettamente riproposto. E devo dire che in questo tipo di riletture Ruggieri è davvero un maestro: basti dire che ogni qualvolta lo ascolto eseguire “Caruso” mi è difficile contenere la commozione. Conosco e apprezzo oramai da molti anni Claudio Angeleri e non credo di sbagliare di molto se affermo che questo album è uno dei migliori che il pianista bergamasco abbia prodotto nel corso della sua oramai lunga carriera. A coadiuvarlo in questa ennesima fatica un gruppo di eccellenti musicisti: Giulio Visibelli (sax soprano, flauto), Paola Milzani (voce), Virginia Sutera (violino), Michele Gentilini (chitarra elettrica), Marco Esposito (basso elettrico), Luca Bongiovanni (batteria, percussioni) e, nel brano “Two or three stories”, Gabriele Comeglio (sax alto). Oltre al celebrato “Round about Midnight” di Monk, l’album consta di otto composizioni dello stesso Angeleri liberamente tratti dal breve romanzo fantastico “Il castello dei destini incrociati” di Italo Calvino. “L’idea di realizzare un nuovo progetto intorno alla letteratura di Italo Calvino – afferma lo stesso Angeleri – scaturisce da un invito del MIT Jazz Festival di Musica Oggi al Piccolo Teatro di Milano nello scorso novembre 2019. Lo spettacolo è stato poi replicato a gennaio al Blue Note, per essere messo in scena a luglio alla rassegna che ha significato la ripresa dal vivo dopo il lockdown a Bergamo”. E di certo bisogna avere una fervida immaginazione e soprattutto molto coraggio per trasporre in musica la scrittura non facile e mai banale di Italo Calvino. Di qui una musica ricca di colori in cui non sempre è facile distinguere le parti improvvisate da quelle scritte. Una musica in cui i vari strumenti diventano essi stessi voci narranti sì da rappresentare, – spiega ancora Angeleri – “per il loro carattere sonoro specifici personaggi”. Come si evince da queste poche note un compito davvero difficile che solo un musicista maturo, perfettamente consapevole dei propri mezzi espressivi, in possesso di una solida preparazione non solo come strumentista, poteva pensare di intraprendere e di traghettare alla meta con successo.
Conosco e apprezzo oramai da molti anni Claudio Angeleri e non credo di sbagliare di molto se affermo che questo album è uno dei migliori che il pianista bergamasco abbia prodotto nel corso della sua oramai lunga carriera. A coadiuvarlo in questa ennesima fatica un gruppo di eccellenti musicisti: Giulio Visibelli (sax soprano, flauto), Paola Milzani (voce), Virginia Sutera (violino), Michele Gentilini (chitarra elettrica), Marco Esposito (basso elettrico), Luca Bongiovanni (batteria, percussioni) e, nel brano “Two or three stories”, Gabriele Comeglio (sax alto). Oltre al celebrato “Round about Midnight” di Monk, l’album consta di otto composizioni dello stesso Angeleri liberamente tratti dal breve romanzo fantastico “Il castello dei destini incrociati” di Italo Calvino. “L’idea di realizzare un nuovo progetto intorno alla letteratura di Italo Calvino – afferma lo stesso Angeleri – scaturisce da un invito del MIT Jazz Festival di Musica Oggi al Piccolo Teatro di Milano nello scorso novembre 2019. Lo spettacolo è stato poi replicato a gennaio al Blue Note, per essere messo in scena a luglio alla rassegna che ha significato la ripresa dal vivo dopo il lockdown a Bergamo”. E di certo bisogna avere una fervida immaginazione e soprattutto molto coraggio per trasporre in musica la scrittura non facile e mai banale di Italo Calvino. Di qui una musica ricca di colori in cui non sempre è facile distinguere le parti improvvisate da quelle scritte. Una musica in cui i vari strumenti diventano essi stessi voci narranti sì da rappresentare, – spiega ancora Angeleri – “per il loro carattere sonoro specifici personaggi”. Come si evince da queste poche note un compito davvero difficile che solo un musicista maturo, perfettamente consapevole dei propri mezzi espressivi, in possesso di una solida preparazione non solo come strumentista, poteva pensare di intraprendere e di traghettare alla meta con successo. Per chi ancora non conoscesse questo straordinario pianista e compositore svizzero, ecco un’ottima occasione per colmare questa lacuna. Nel panorama jazzistico internazionale oggi Bärtsch è personaggio imprescindibile tale e tanta è l’importanza che man mano va assumendo grazie anche ad alcune produzioni discografiche di eccellente livello. E’ questo il caso di “Entendre” declinato attraverso sei originali tutti composti da Nik e tutti eseguiti al piano solo. Lo stile dell’artista è assolutamente personale in quanto risultato da molti anni di continue sperimentazioni in cui Bärtsch ha cercato – e trovato – una soddisfacente sintesi tra jazz, minimalismo, poliritmie. Molti dei brani (quasi tutti intitolati Modul + numero, secondo consuetudine di Bärtsch) sono già stati presentati in altri album ma il pianista li rivisita apportando modifiche non di poco conto. Così ora tralascia precedenti climi jazz-rock per affidarsi unicamente alle sonorità dello strumento, ora si affida al giuoco minimalista alla ricerca con grande personalità di sottili variazioni timbriche. Il tutto completato da straordinarie capacità interpretative che portano l’artista a misurarsi anche sul piano dell’espressività. Si ascolti con attenzione l’apertura di “Modul 5” già proposto in “Llyrìa” (2010): la ricerca spazio-temporale in cui Bärtsch inserisce il suo pianismo è assolutamente straordinaria e mai conosce un attimo di stanca pur articolandosi su poche note che comunque delineano un quadro ben preciso. L’album si chiude con lo splendido “Déjà-vu, Vienna”, il pezzo più breve di “Entendre” (5:15), dal vago sapore impressionistico e dalla riconoscibile linea melodica elemento non certo usuale nelle concezioni di Bärtsch.
Per chi ancora non conoscesse questo straordinario pianista e compositore svizzero, ecco un’ottima occasione per colmare questa lacuna. Nel panorama jazzistico internazionale oggi Bärtsch è personaggio imprescindibile tale e tanta è l’importanza che man mano va assumendo grazie anche ad alcune produzioni discografiche di eccellente livello. E’ questo il caso di “Entendre” declinato attraverso sei originali tutti composti da Nik e tutti eseguiti al piano solo. Lo stile dell’artista è assolutamente personale in quanto risultato da molti anni di continue sperimentazioni in cui Bärtsch ha cercato – e trovato – una soddisfacente sintesi tra jazz, minimalismo, poliritmie. Molti dei brani (quasi tutti intitolati Modul + numero, secondo consuetudine di Bärtsch) sono già stati presentati in altri album ma il pianista li rivisita apportando modifiche non di poco conto. Così ora tralascia precedenti climi jazz-rock per affidarsi unicamente alle sonorità dello strumento, ora si affida al giuoco minimalista alla ricerca con grande personalità di sottili variazioni timbriche. Il tutto completato da straordinarie capacità interpretative che portano l’artista a misurarsi anche sul piano dell’espressività. Si ascolti con attenzione l’apertura di “Modul 5” già proposto in “Llyrìa” (2010): la ricerca spazio-temporale in cui Bärtsch inserisce il suo pianismo è assolutamente straordinaria e mai conosce un attimo di stanca pur articolandosi su poche note che comunque delineano un quadro ben preciso. L’album si chiude con lo splendido “Déjà-vu, Vienna”, il pezzo più breve di “Entendre” (5:15), dal vago sapore impressionistico e dalla riconoscibile linea melodica elemento non certo usuale nelle concezioni di Bärtsch. E’ davvero un piacere presentare questi due giovani straordinari musicisti che ancora non sono molto conosciuti dal pubblico italiano, ma la cui collaborazione era forse scritta negli astri dal momento che ambedue sono nati nel 1987. Enzo Carniel è un pianista francese dedito allo studio dello strumento sin da giovanissimo; sale agli onori della cronaca nel 2019 quando incide, con il gruppo House Of Echo, l’album ‘Wallsdown’. Filippo Vignato è a ben ragione considerato l‘astro nascente del trombonismo jazz italiano; anch’egli ha cominciato a studiare musica sin da bambino (a dieci anni) e oggi può vantare uno stile e una tecnica assolutamente personali. Ad onta delle difficoltà notoriamente insite in un duo, soprattutto se due artisti si cimentano per la prima volta in un organico del genere, questo “Aria” evidenzia una profonda empatia, un’intesa che trova la sua ragion d’essere nell’idem sentire dei due musicisti. Così il dialogo si svolge su binari sicuri anche se non banali, mai dando così all’ascoltatore l’impressione del ‘già sentito’ o peggio ancora di moduli predefiniti. Il risultato è un sound del tutto particolare determinato anche dall’uso del Fender Rhodes e dei sintetizzatori, la visione di un universo musicale multicolore, in cui i due artisti improvvisano continuamente essendo perfettamente in grado l’uno di capire le intenzioni dell’altro, in un susseguirsi si input, di stimoli, di processi creativi che si susseguono senza soluzione di continuità. Il tutto impreziosito da una riuscita ricerca sulle linee melodiche che costituiscono l’ossatura stessa dell’intero repertorio, otto brani tra cui spicca per intensità emotiva “Aria” la composizione che apre l’album in acustica per chiuderlo in versione elettronica. L’album, uscito il 16 aprile scorso per l’etichetta franco-giapponese Menace è stato anticipato da due singoli: la title-track Aria uscito il 5 febbraio e Babele uscito il 10 marzo.
E’ davvero un piacere presentare questi due giovani straordinari musicisti che ancora non sono molto conosciuti dal pubblico italiano, ma la cui collaborazione era forse scritta negli astri dal momento che ambedue sono nati nel 1987. Enzo Carniel è un pianista francese dedito allo studio dello strumento sin da giovanissimo; sale agli onori della cronaca nel 2019 quando incide, con il gruppo House Of Echo, l’album ‘Wallsdown’. Filippo Vignato è a ben ragione considerato l‘astro nascente del trombonismo jazz italiano; anch’egli ha cominciato a studiare musica sin da bambino (a dieci anni) e oggi può vantare uno stile e una tecnica assolutamente personali. Ad onta delle difficoltà notoriamente insite in un duo, soprattutto se due artisti si cimentano per la prima volta in un organico del genere, questo “Aria” evidenzia una profonda empatia, un’intesa che trova la sua ragion d’essere nell’idem sentire dei due musicisti. Così il dialogo si svolge su binari sicuri anche se non banali, mai dando così all’ascoltatore l’impressione del ‘già sentito’ o peggio ancora di moduli predefiniti. Il risultato è un sound del tutto particolare determinato anche dall’uso del Fender Rhodes e dei sintetizzatori, la visione di un universo musicale multicolore, in cui i due artisti improvvisano continuamente essendo perfettamente in grado l’uno di capire le intenzioni dell’altro, in un susseguirsi si input, di stimoli, di processi creativi che si susseguono senza soluzione di continuità. Il tutto impreziosito da una riuscita ricerca sulle linee melodiche che costituiscono l’ossatura stessa dell’intero repertorio, otto brani tra cui spicca per intensità emotiva “Aria” la composizione che apre l’album in acustica per chiuderlo in versione elettronica. L’album, uscito il 16 aprile scorso per l’etichetta franco-giapponese Menace è stato anticipato da due singoli: la title-track Aria uscito il 5 febbraio e Babele uscito il 10 marzo. Lo stato di maturità del jazz italiano è dimostrato, seppur ce ne fosse ancora bisogno, dal proliferare di nuovi talenti. Tra questi c’è senza dubbio alcuno il ventisettenne sassofonista romano (alto e soprano) Vittorio Cuculo al suo secondo album. Il titolo è determinato dal fatto che il quartetto capitanato da Cuculo incontra i sassofoni della Filarmonica Sabina “Foronovana” con risultati eccellenti ma di cui parleremo tra poco. Il quartetto comprende, altre al leader, Danilo Blaiotta al pianoforte, Enrico Mianulli al contrabbasso, Gegè Munari alla batteria e in veste di special guest Lucia Filaci che interpreta con coraggio e bravura la cover di “Brava”, il pezzo di Bruno Canfora portato al successo da Mina. Il resto del repertorio è costituito da sei brani standard appartenenti alla tradizione jazz frutto della verve compositiva di alcuni grandi quali Charlie Parker, Errol Garner, Juan Tizol, Thelonius Monk, Rogers & Hart e due composizioni originali di Roberto Spadoni. Ciò detto vediamo più da vicino la musica proposta. Si tratta di un jazz mainstream che si rifà chiaramente agli stilemi del bop e dell’hard-bop interpretato con efficacia dal gruppo nel suo complesso che ben si amalgama con i fiati della Filarmonica, dando vita ad un sound particolare. Ovviamente sempre in primo piano il leader che data la scelta del repertorio comunica apertamente l’intento di volersi confrontare con un certo tipo di jazz sebbene avvalendosi di nuovi arrangiamenti, firmati da Riccardo Nebbiosi, Mario Corvini, Roberto Spadoni e Massimo Valentini. Ora che un giovane musicista scelga di suonare bop, ci sta tutto…ci mancherebbe altro. Solo che ci piacerebbe ascoltare Cuculo anche in contesti diversi in cui magari le eccelse capacità tecniche non sono poi così fondamentali.
Lo stato di maturità del jazz italiano è dimostrato, seppur ce ne fosse ancora bisogno, dal proliferare di nuovi talenti. Tra questi c’è senza dubbio alcuno il ventisettenne sassofonista romano (alto e soprano) Vittorio Cuculo al suo secondo album. Il titolo è determinato dal fatto che il quartetto capitanato da Cuculo incontra i sassofoni della Filarmonica Sabina “Foronovana” con risultati eccellenti ma di cui parleremo tra poco. Il quartetto comprende, altre al leader, Danilo Blaiotta al pianoforte, Enrico Mianulli al contrabbasso, Gegè Munari alla batteria e in veste di special guest Lucia Filaci che interpreta con coraggio e bravura la cover di “Brava”, il pezzo di Bruno Canfora portato al successo da Mina. Il resto del repertorio è costituito da sei brani standard appartenenti alla tradizione jazz frutto della verve compositiva di alcuni grandi quali Charlie Parker, Errol Garner, Juan Tizol, Thelonius Monk, Rogers & Hart e due composizioni originali di Roberto Spadoni. Ciò detto vediamo più da vicino la musica proposta. Si tratta di un jazz mainstream che si rifà chiaramente agli stilemi del bop e dell’hard-bop interpretato con efficacia dal gruppo nel suo complesso che ben si amalgama con i fiati della Filarmonica, dando vita ad un sound particolare. Ovviamente sempre in primo piano il leader che data la scelta del repertorio comunica apertamente l’intento di volersi confrontare con un certo tipo di jazz sebbene avvalendosi di nuovi arrangiamenti, firmati da Riccardo Nebbiosi, Mario Corvini, Roberto Spadoni e Massimo Valentini. Ora che un giovane musicista scelga di suonare bop, ci sta tutto…ci mancherebbe altro. Solo che ci piacerebbe ascoltare Cuculo anche in contesti diversi in cui magari le eccelse capacità tecniche non sono poi così fondamentali. Dino Rubino alla tromba e al flicorno, Rino Cirinnà al sax tenore, Joe Debono al pianoforte, Nello Toscano al contrabbasso e Paolo Vicari alla batteria sono i componenti del Joe Debono Quintet. Prodotto dall’etichetta discografica Anaglyphos Records e supportato da Malta Arts Fund – Arts Council Malta, la tracklist del CD è formata da otto composizioni originali del pianista, e da “Innu Lil San Guzepp”, un inno di San Giuseppe composto dal compositore maltese Carlo Diacono all’inizio del ventesimo secolo. In un momento come l’attuale, in cui il jazz si sta praticamente frammentando in moltissimi rivoli, in cui non sempre è facile trovare tracce di un passato anche se non remoto, questo album ci riporta in piena atmosfera jazz, senza equivoci di sorta. Il linguaggio di tutti è perfettamente in linea con le migliori tradizioni della musica afro-americana senza per ciò peccare di pedissequa imitazione. Ottima la ricerca sul sound come dimostra l’impasto sonoro determinato dalle parti suonate all’unisono da sassofono e tromba, sempre ben sostenute da una eccellente sezione ritmica. E al riguardo non si può non sottolineare da un canto la conferma a livelli straordinari di un musicista come Dino Rubino (che forse molti non lo sanno ma suona benissimo anche il pianoforte) e la rapida ascesa di Paolo Vicari batterista giovane ma già in possesso di una buona tecnica. Ovviamente più che positivo l’apporto di Rino Cirinnà sassofonista di vaglia e di Nello Toscano contrabbassista siciliano tra i più validi a livello nazionale. Bisogna comunque dare atto a Joe Debono, pianista e compositore maltese, di aver saputo costituire un quintetto capace di produrre un jazz elegante, raffinato, con un repertorio assolutamente confacente alle caratteristiche dei singoli musicisti. Si ascolti al riguardo “Gigi”, brano dolcissimo introdotto dallo stesso Debono e ben sviluppato dai fiati.
Dino Rubino alla tromba e al flicorno, Rino Cirinnà al sax tenore, Joe Debono al pianoforte, Nello Toscano al contrabbasso e Paolo Vicari alla batteria sono i componenti del Joe Debono Quintet. Prodotto dall’etichetta discografica Anaglyphos Records e supportato da Malta Arts Fund – Arts Council Malta, la tracklist del CD è formata da otto composizioni originali del pianista, e da “Innu Lil San Guzepp”, un inno di San Giuseppe composto dal compositore maltese Carlo Diacono all’inizio del ventesimo secolo. In un momento come l’attuale, in cui il jazz si sta praticamente frammentando in moltissimi rivoli, in cui non sempre è facile trovare tracce di un passato anche se non remoto, questo album ci riporta in piena atmosfera jazz, senza equivoci di sorta. Il linguaggio di tutti è perfettamente in linea con le migliori tradizioni della musica afro-americana senza per ciò peccare di pedissequa imitazione. Ottima la ricerca sul sound come dimostra l’impasto sonoro determinato dalle parti suonate all’unisono da sassofono e tromba, sempre ben sostenute da una eccellente sezione ritmica. E al riguardo non si può non sottolineare da un canto la conferma a livelli straordinari di un musicista come Dino Rubino (che forse molti non lo sanno ma suona benissimo anche il pianoforte) e la rapida ascesa di Paolo Vicari batterista giovane ma già in possesso di una buona tecnica. Ovviamente più che positivo l’apporto di Rino Cirinnà sassofonista di vaglia e di Nello Toscano contrabbassista siciliano tra i più validi a livello nazionale. Bisogna comunque dare atto a Joe Debono, pianista e compositore maltese, di aver saputo costituire un quintetto capace di produrre un jazz elegante, raffinato, con un repertorio assolutamente confacente alle caratteristiche dei singoli musicisti. Si ascolti al riguardo “Gigi”, brano dolcissimo introdotto dallo stesso Debono e ben sviluppato dai fiati. Undici brani originali declinati attraverso una interpretazione per piano solo. Con questo album Alessandro Deledda, jazzista sardo che abita a Perugia, abbandona la strada tracciata in precedenza sia con l’elettro-jazz di “Conception & Contamination” del 2011 assieme a Simone Alessandrini, sax e Mirko Ferrantini, dj, ritmiche, sia con il CD del 2014, “Morbid Dialogues” in cui era alla guida di un quartetto di chiara impronta jazzistica con Francesco Bearzatti al sassofono, Silvia Bolognesi al contrabbasso e Ferdinando Faraò alla batteria. Infatti questa volta si presenta al pubblico nella duplice veste di compositore (il repertorio è tutto da lui scritto) ed esecutore. Il risultato è apprezzabile: le composizioni sono ben strutturate, con una bella linea melodica, e inserite in un ambito in cui le sensazioni più intimiste sembrano prevalere sul resto. Non a caso alcuni titoli – “Ginevra”, “Sulla strada di casa tua”, “L’Aquilone”, “Gino e l’ulivo” – sembrano riferirsi ad esperienze direttamente vissute dal musicista. Così ad esempio “Madreterra” è un esplicito omaggio alla terra natia mentre “Ginevra”, afferma Deledda, “è la storia di una cagnolina, chiamata Ginevra che ritrova nella sua nuova famiglia il suo sorriso, abbandonato nel bosco con le sue fragilità, per andare a vivere fedele una nuova melodia”. Dal punto di vista esecutivo lo stile pianistico di Deledda rifugge sia da qualsivoglia sperimentazione sia da passaggi particolarmente complessi e arditi per frequentare terreni più aperti alla comprensione, in cui i riferimenti al jazz si mescolano con quelli alla popular music.
Undici brani originali declinati attraverso una interpretazione per piano solo. Con questo album Alessandro Deledda, jazzista sardo che abita a Perugia, abbandona la strada tracciata in precedenza sia con l’elettro-jazz di “Conception & Contamination” del 2011 assieme a Simone Alessandrini, sax e Mirko Ferrantini, dj, ritmiche, sia con il CD del 2014, “Morbid Dialogues” in cui era alla guida di un quartetto di chiara impronta jazzistica con Francesco Bearzatti al sassofono, Silvia Bolognesi al contrabbasso e Ferdinando Faraò alla batteria. Infatti questa volta si presenta al pubblico nella duplice veste di compositore (il repertorio è tutto da lui scritto) ed esecutore. Il risultato è apprezzabile: le composizioni sono ben strutturate, con una bella linea melodica, e inserite in un ambito in cui le sensazioni più intimiste sembrano prevalere sul resto. Non a caso alcuni titoli – “Ginevra”, “Sulla strada di casa tua”, “L’Aquilone”, “Gino e l’ulivo” – sembrano riferirsi ad esperienze direttamente vissute dal musicista. Così ad esempio “Madreterra” è un esplicito omaggio alla terra natia mentre “Ginevra”, afferma Deledda, “è la storia di una cagnolina, chiamata Ginevra che ritrova nella sua nuova famiglia il suo sorriso, abbandonato nel bosco con le sue fragilità, per andare a vivere fedele una nuova melodia”. Dal punto di vista esecutivo lo stile pianistico di Deledda rifugge sia da qualsivoglia sperimentazione sia da passaggi particolarmente complessi e arditi per frequentare terreni più aperti alla comprensione, in cui i riferimenti al jazz si mescolano con quelli alla popular music. A solo un anno da “Iperboliche distanze”, ecco tornare sulle scene discografiche il filosofo–trombettista Massimo Donà (nell’occasione anche chitarrista e rapper), alla testa di un ampio organico in cui spiccano i nomi del sassofonista Michele Polga e del batterista Davide Ragazzoni, quest’ultimo unico musicista presente, insieme al leader, in ogni traccia del Cd; in un solo brano (“E chi no”) è possibile ascoltare anche Francesco Bearzatti. Questo nuovo album, “Magister Puck”, si sostanzia, quindi, di colori, atmosfere assai diversificate pur mantenendo una sua coerenza di fondo. Ecco, quindi, in apertura “Topi in terrazza” di chiara impronta funky così come “Tagology” che non a caso presenta quasi lo stesso organico del pezzo di apertura con, oltre al leader, Michele Polga al sax tenore, Maurizio Trionfo alla chitarra, Stefano Olivato basso e clavinet, Davide Ragazzoni batteria, assente, quindi, Bebo Baldan al sintetizzatore. Più influenzato dal pop, seppure di classe, “I’m in Love” impreziosito dalla voce di Paola Donà e con un bell’assolo, vagamente davisiano, del leader. Anche “Magister Puck’s Theory” sembra seguire le orme del precedente “I’m in Love” prima di trasformarsi in un incalzante rap dal testo significativamente ironico. Nel brano decisamente più lungo dell’intero album, “E chi no”, si rinnova la collaborazione tra Massimo Donà e David Riondino che frutti succosi aveva già dato nel precedente album dello stesso trombettista, “Iperboliche distanze”, dedicato alla figura del grande filosofo veneto Andrea Emo. Il disco si chiude con una registrazione del 1989, “Irrisoluzione cromatica”, ad opera di un sestetto di chiara derivazione davisiana post ’69.
A solo un anno da “Iperboliche distanze”, ecco tornare sulle scene discografiche il filosofo–trombettista Massimo Donà (nell’occasione anche chitarrista e rapper), alla testa di un ampio organico in cui spiccano i nomi del sassofonista Michele Polga e del batterista Davide Ragazzoni, quest’ultimo unico musicista presente, insieme al leader, in ogni traccia del Cd; in un solo brano (“E chi no”) è possibile ascoltare anche Francesco Bearzatti. Questo nuovo album, “Magister Puck”, si sostanzia, quindi, di colori, atmosfere assai diversificate pur mantenendo una sua coerenza di fondo. Ecco, quindi, in apertura “Topi in terrazza” di chiara impronta funky così come “Tagology” che non a caso presenta quasi lo stesso organico del pezzo di apertura con, oltre al leader, Michele Polga al sax tenore, Maurizio Trionfo alla chitarra, Stefano Olivato basso e clavinet, Davide Ragazzoni batteria, assente, quindi, Bebo Baldan al sintetizzatore. Più influenzato dal pop, seppure di classe, “I’m in Love” impreziosito dalla voce di Paola Donà e con un bell’assolo, vagamente davisiano, del leader. Anche “Magister Puck’s Theory” sembra seguire le orme del precedente “I’m in Love” prima di trasformarsi in un incalzante rap dal testo significativamente ironico. Nel brano decisamente più lungo dell’intero album, “E chi no”, si rinnova la collaborazione tra Massimo Donà e David Riondino che frutti succosi aveva già dato nel precedente album dello stesso trombettista, “Iperboliche distanze”, dedicato alla figura del grande filosofo veneto Andrea Emo. Il disco si chiude con una registrazione del 1989, “Irrisoluzione cromatica”, ad opera di un sestetto di chiara derivazione davisiana post ’69. Pochi anni fa ero stato fin troppo facile profeta nel prevedere che Cettina Donato sarebbe divenuta una delle punte di diamante del jazz mady in Italy. Ciò perché sin dall’inizio l’artista messinese mostrava una completezza straordinaria essendo allo stesso tempo, pianista preparata, compositrice assai feconda, capace direttrice anche di grosse formazioni. Il tutto è ben compendiato in questo ultimo album in cui si fortifica quella stretta collaborazione che oramai va avanti da qualche tempo tra Cettina e l’attore, regista anch’egli siciliano, Ninni Bruschetta. I due sono reduci dai successi teatrali de “Il mio nome è Caino” di Claudio Fava, i quali, dopo aver interpretato un testo di impegno civile servendosi solo di voce e pianoforte presentano adesso il volto poetico e letterario dell’isola. Di qui l’album “I siciliani”: otto pezzi originali scritti dalla Donato con testi dello scrittore siciliano Antonio Caldarella scomparso nel 2008, interpretati da un gruppo con Dario Cecchini (clarinetto basso, sax soprano e baritono), Dario Rosciglione (contrabbasso e basso elettrico), Mimmo Campanale (batteria e percussioni) con l’aggiunta degli archi della B.I.M. Orchestra e dell’attrice e cantante Celeste Gugliandolo (che interpreta “Le siciliane”). Tutti gli altri brani sono affidati alla voce spesso roca e graffiante di Bruschetta che si amalgama in maniera straordinaria con il pianismo della Donato e più in generale con il sound dell’ensemble. Come sottolineato in apertura, la Donato trova quindi terreno fertile per evidenziare tutte le sue capacità, di strumentista, di compositrice, di arrangiatrice e di direttrice d’orchestra, in un alternarsi di atmosfere che forse solo un siciliano doc può capire sino in fondo. Una musica che sottolinea alcune peculiarità di una terra tanto straordinaria quanto ancora oggi ben difficile da vivere.
Pochi anni fa ero stato fin troppo facile profeta nel prevedere che Cettina Donato sarebbe divenuta una delle punte di diamante del jazz mady in Italy. Ciò perché sin dall’inizio l’artista messinese mostrava una completezza straordinaria essendo allo stesso tempo, pianista preparata, compositrice assai feconda, capace direttrice anche di grosse formazioni. Il tutto è ben compendiato in questo ultimo album in cui si fortifica quella stretta collaborazione che oramai va avanti da qualche tempo tra Cettina e l’attore, regista anch’egli siciliano, Ninni Bruschetta. I due sono reduci dai successi teatrali de “Il mio nome è Caino” di Claudio Fava, i quali, dopo aver interpretato un testo di impegno civile servendosi solo di voce e pianoforte presentano adesso il volto poetico e letterario dell’isola. Di qui l’album “I siciliani”: otto pezzi originali scritti dalla Donato con testi dello scrittore siciliano Antonio Caldarella scomparso nel 2008, interpretati da un gruppo con Dario Cecchini (clarinetto basso, sax soprano e baritono), Dario Rosciglione (contrabbasso e basso elettrico), Mimmo Campanale (batteria e percussioni) con l’aggiunta degli archi della B.I.M. Orchestra e dell’attrice e cantante Celeste Gugliandolo (che interpreta “Le siciliane”). Tutti gli altri brani sono affidati alla voce spesso roca e graffiante di Bruschetta che si amalgama in maniera straordinaria con il pianismo della Donato e più in generale con il sound dell’ensemble. Come sottolineato in apertura, la Donato trova quindi terreno fertile per evidenziare tutte le sue capacità, di strumentista, di compositrice, di arrangiatrice e di direttrice d’orchestra, in un alternarsi di atmosfere che forse solo un siciliano doc può capire sino in fondo. Una musica che sottolinea alcune peculiarità di una terra tanto straordinaria quanto ancora oggi ben difficile da vivere. Ecco un trio di assoluto livello internazionale composto da Slava Ganelin al pianoforte, tastiere, live electronics e percussioni, Alexey Kruglov sax alto e soprano, Oleg Yudanov batteria e percussioni, vale a dire tre dei migliori esponenti del free jazz russo. Quindi un organico non usuale caratterizzato dalla mancanza del contrabbasso, impegnato in un repertorio di sei brani interamente scritto dai tre. Registrato il 13 novembre del 2017, l’album rappresenta uno dei migliori esempi di free jazz realizzato in Europa in quest’ultimo decennio. La cosa non stupisce più di tanto ove si consideri la statura artistica del russo Ganelin già noto al pubblico del jazz per il suo fantastico trio con Tarasov e Chekasin. Questa volta a completare il trio sono due altri jazzisti ma il risultato finale non cambia granché. Nato nel 2012 il trio frequenta il terreno della libera improvvisazione in cui non esistono strutture predefinite che viceversa si creano nel momento stesso in cui si suona, quindi in quello strettissimo lasso di tempo che passa dall’idea musicale all’esecuzione. Quasi inutile sottolineare come la musica sia caratterizzata da una forte energia creativa che trova in Ornette Coleman il suo nume tutelare e che mai conosce un attimo di stanca con i tre musicisti che riescono a ritagliarsi spazi appropriati alle loro grandi possibilità. Il clima generale dell’album è perfettamente disegnato sin dal primo brano, quando dopo una sorta di introduzione a tempo lento il sassofonista prende in mano le redini del gruppo e si lancia in una trascinante improvvisazione, seguito a ruota da Ganelin mentre Yudanov sorregge il tutto con precisione; a circa 2:40 Ganelin si sostituisce a Kruglov mantenendo un clima incandescente che non muta quando a circa tre quarti dell’esecuzione Kruglov passa al sax soprano. E sarà poi questa l’atmosfera che si respirerà durante tutto l’arco dell’album.
Ecco un trio di assoluto livello internazionale composto da Slava Ganelin al pianoforte, tastiere, live electronics e percussioni, Alexey Kruglov sax alto e soprano, Oleg Yudanov batteria e percussioni, vale a dire tre dei migliori esponenti del free jazz russo. Quindi un organico non usuale caratterizzato dalla mancanza del contrabbasso, impegnato in un repertorio di sei brani interamente scritto dai tre. Registrato il 13 novembre del 2017, l’album rappresenta uno dei migliori esempi di free jazz realizzato in Europa in quest’ultimo decennio. La cosa non stupisce più di tanto ove si consideri la statura artistica del russo Ganelin già noto al pubblico del jazz per il suo fantastico trio con Tarasov e Chekasin. Questa volta a completare il trio sono due altri jazzisti ma il risultato finale non cambia granché. Nato nel 2012 il trio frequenta il terreno della libera improvvisazione in cui non esistono strutture predefinite che viceversa si creano nel momento stesso in cui si suona, quindi in quello strettissimo lasso di tempo che passa dall’idea musicale all’esecuzione. Quasi inutile sottolineare come la musica sia caratterizzata da una forte energia creativa che trova in Ornette Coleman il suo nume tutelare e che mai conosce un attimo di stanca con i tre musicisti che riescono a ritagliarsi spazi appropriati alle loro grandi possibilità. Il clima generale dell’album è perfettamente disegnato sin dal primo brano, quando dopo una sorta di introduzione a tempo lento il sassofonista prende in mano le redini del gruppo e si lancia in una trascinante improvvisazione, seguito a ruota da Ganelin mentre Yudanov sorregge il tutto con precisione; a circa 2:40 Ganelin si sostituisce a Kruglov mantenendo un clima incandescente che non muta quando a circa tre quarti dell’esecuzione Kruglov passa al sax soprano. E sarà poi questa l’atmosfera che si respirerà durante tutto l’arco dell’album. Nato ad Albany da genitori indiani di etnia dravidica Tamil, Vijay a cinquant’anni viene giustamente considerato uno dei migliori pianisti jazz oggi in esercizio. Considerazione conquistata grazie ad un talento cristallino e ad una personalità molto forte che è riuscita a coniugare un profondo sapere extra-musicale (è laureato in matematica e fisica alla Yale, insegnante ad Harvard, esperto in psicologia cognitiva con specifico riferimento alla capacità psico-fisica di relazionarsi ai vari linguaggi musicali) con una straordinaria dedizione alla musica essendo giunto al ventiquattresimo disco da leader, senza considerare le moltissime composizioni eseguite anche da formazioni non jazzistiche. In questo “Uneasy” Vijay suona in trio con Linda May Han Oh, contrabbassista di origine malese ma cresciuta in Australia e poi negli States e Tyshawn Sorey alla batteria, personaggio ben apprezzato sia nella musica classica sia nel jazz. In repertorio dieci composizioni tutte scritte dal pianista eccezion fatta per “Night and Day” di Cole Porter e “Drummer’s Song” di Gery Allen. Il clima nel cui ambito si muove Iyer è quello bop e post-bop, quindi un jazz sanguigno che si rifà alle radici più autentiche della musica afro-americana e che proprio per questo necessita di una profonda conoscenza della materia. Conoscenza che sicuramente non manca nel bagaglio dell’artista, il cui pianismo si svolge solido per tutta la durata dell’album validamente supportato da batteria e contrabbasso precisi e propositivi nella loro costante azione. Non si esagera affermando che tutti i brani meritano un attento ascolto anche se lo standard “Night and Day” si fa particolarmente apprezzare per come l’artista riesce a personalizzare il brano senza alcunché perdere né dell’originaria riconoscibilità né tanto meno della sua splendida linea melodica. Particolarmente interessante anche “Entrustment, brano di profonda suggestione, intimista, a chiudere nel modo migliore un album assolutamente consigliato.
Nato ad Albany da genitori indiani di etnia dravidica Tamil, Vijay a cinquant’anni viene giustamente considerato uno dei migliori pianisti jazz oggi in esercizio. Considerazione conquistata grazie ad un talento cristallino e ad una personalità molto forte che è riuscita a coniugare un profondo sapere extra-musicale (è laureato in matematica e fisica alla Yale, insegnante ad Harvard, esperto in psicologia cognitiva con specifico riferimento alla capacità psico-fisica di relazionarsi ai vari linguaggi musicali) con una straordinaria dedizione alla musica essendo giunto al ventiquattresimo disco da leader, senza considerare le moltissime composizioni eseguite anche da formazioni non jazzistiche. In questo “Uneasy” Vijay suona in trio con Linda May Han Oh, contrabbassista di origine malese ma cresciuta in Australia e poi negli States e Tyshawn Sorey alla batteria, personaggio ben apprezzato sia nella musica classica sia nel jazz. In repertorio dieci composizioni tutte scritte dal pianista eccezion fatta per “Night and Day” di Cole Porter e “Drummer’s Song” di Gery Allen. Il clima nel cui ambito si muove Iyer è quello bop e post-bop, quindi un jazz sanguigno che si rifà alle radici più autentiche della musica afro-americana e che proprio per questo necessita di una profonda conoscenza della materia. Conoscenza che sicuramente non manca nel bagaglio dell’artista, il cui pianismo si svolge solido per tutta la durata dell’album validamente supportato da batteria e contrabbasso precisi e propositivi nella loro costante azione. Non si esagera affermando che tutti i brani meritano un attento ascolto anche se lo standard “Night and Day” si fa particolarmente apprezzare per come l’artista riesce a personalizzare il brano senza alcunché perdere né dell’originaria riconoscibilità né tanto meno della sua splendida linea melodica. Particolarmente interessante anche “Entrustment, brano di profonda suggestione, intimista, a chiudere nel modo migliore un album assolutamente consigliato. Il Kantele è lo strumento tipico della musica folkloristica finlandese e Sinikka Langeland è specialista di questo strumento nonché cantante folk di Finnskogen, la « foresta finlandese » norvegese. In questo sesto album targato ECM, Sinikka, diversamente da altri album, si appalesa in splendida solitudine utilizzando ben tre tipi di kantele, a cinque, a quindici e a trentanove corde, facendoci così apprezzare le innumerevoli sfaccettature dello strumento. Nella maggior parte dei brani Sinikka si esprime anche vocalmente, il tutto ad elaborare un’espressività che questa volta nulla ha da spartire con il linguaggio jazzistico, restando, comunque, sulla scorta di un’estetica che nella ECM ha trovato la sua più completa estrinsecazione. Insomma una musica tutta giocata su melodie ampie, ariose, spesso evocative, alle volte venate da quella sorta di dolce malinconia che attraversa le atmosfere nordiche. Una profondità d’ispirazione che caratterizza oramai le realizzazioni della Langeland, ispirazione che specie se, come chi scrive, conosci quei luoghi, non può non toccarti nel profondo. Dal punto di vista testuale, Sinikka ha tratto ispirazione da molte fonti: ecco quindi il drammaturgo Jon Fosse accanto al filosofo e mistico del tredicesimo secolo Meister Eckhart… e ancora il poeta norvegese Olav H. Hauge. In tale contesto suggerire un brano in particolare è impresa quanto mai ardua anche se la title track appare degna di particolare attenzione: brano molto delicato ed intimista racconta l’inverno, ovvero quello stato della natura in cui tutto pare fermarsi prima del risveglio primaverile. Per raccontarci tutto ciò l’artista alterna l’archetto al pizzichio delle dita sullo strumento e chiude il brano con la sua voce che si alza stentorea sull’accompagnamento strumentale.
Il Kantele è lo strumento tipico della musica folkloristica finlandese e Sinikka Langeland è specialista di questo strumento nonché cantante folk di Finnskogen, la « foresta finlandese » norvegese. In questo sesto album targato ECM, Sinikka, diversamente da altri album, si appalesa in splendida solitudine utilizzando ben tre tipi di kantele, a cinque, a quindici e a trentanove corde, facendoci così apprezzare le innumerevoli sfaccettature dello strumento. Nella maggior parte dei brani Sinikka si esprime anche vocalmente, il tutto ad elaborare un’espressività che questa volta nulla ha da spartire con il linguaggio jazzistico, restando, comunque, sulla scorta di un’estetica che nella ECM ha trovato la sua più completa estrinsecazione. Insomma una musica tutta giocata su melodie ampie, ariose, spesso evocative, alle volte venate da quella sorta di dolce malinconia che attraversa le atmosfere nordiche. Una profondità d’ispirazione che caratterizza oramai le realizzazioni della Langeland, ispirazione che specie se, come chi scrive, conosci quei luoghi, non può non toccarti nel profondo. Dal punto di vista testuale, Sinikka ha tratto ispirazione da molte fonti: ecco quindi il drammaturgo Jon Fosse accanto al filosofo e mistico del tredicesimo secolo Meister Eckhart… e ancora il poeta norvegese Olav H. Hauge. In tale contesto suggerire un brano in particolare è impresa quanto mai ardua anche se la title track appare degna di particolare attenzione: brano molto delicato ed intimista racconta l’inverno, ovvero quello stato della natura in cui tutto pare fermarsi prima del risveglio primaverile. Per raccontarci tutto ciò l’artista alterna l’archetto al pizzichio delle dita sullo strumento e chiude il brano con la sua voce che si alza stentorea sull’accompagnamento strumentale. Ecco una preziosa realizzazione della Artesuono concepita per festeggiare la sua duecentesima produzione discografica: un cofanetto in edizione limitata di 300 copie, numerate a mano, contenente un CD audio, le tavole con le partiture pittoriche realizzate da Giovanni Maier, e le foto delle registrazioni scattate da Luca D’Agostino.
Ecco una preziosa realizzazione della Artesuono concepita per festeggiare la sua duecentesima produzione discografica: un cofanetto in edizione limitata di 300 copie, numerate a mano, contenente un CD audio, le tavole con le partiture pittoriche realizzate da Giovanni Maier, e le foto delle registrazioni scattate da Luca D’Agostino. Album davvero particolare questo di Michael Mantler, che si inserisce nel solco tracciato dal precedente album “Jazz Composer’s Orchestra Update” osannato dalla critica internazionale. Questa volta Mantler compie un’operazione ancora più audace; sceglie, nell’ambito della sua larga produzione, alcuni brani che considera particolarmente significativi e li riarrangia in forma di suite per farli eseguire da un’orchestra comprendente musicisti jazz e classici. Così i brani che ascoltiamo provengono dai seguenti album: “13 and ¾”, “Cerco un paese innocente”, “Alien”, “Folly Seeing All This”, “For Two” e “Hide And Seek”. Il risultato è semplicemente spettacolare grazie anche ai solisti di vaglia presenti in orchestra: Maximilian Kanzler acclamato come uno dei migliori giovani percussionisti e vibrafonisti del momento; il chitarrista Bjarne Roupé, membro fondamentale della Mantler’s Chamber Music and Songs Ensemble; il pianista austriaco David Helbock che a soli 37 anni è già un’icona della scena jazz europea… per non parlare dello stesso leader che si fa apprezzare, more solito, come eccellente trombettista. A tutto ciò si aggiunga la preziosa opera dell’Orchestra nel suo insieme (ben 26 elementi) e si avrà un quadro più preciso del perché si è definito spettacolare l’esecuzione di questa compagine. Tra i membri dell’orchestra da segnalare la presenza della croata violoncellista Asja Valcic che aveva già collaborato con Mantler nell’incisione dell’album “Jazz Composer’s Orchestra Update”. Coda è stato registrato al “Vienna’s Porgy & Bess Studio” nel settembre del 2019, e missato presso gli studi La Buissonne in Francia.
Album davvero particolare questo di Michael Mantler, che si inserisce nel solco tracciato dal precedente album “Jazz Composer’s Orchestra Update” osannato dalla critica internazionale. Questa volta Mantler compie un’operazione ancora più audace; sceglie, nell’ambito della sua larga produzione, alcuni brani che considera particolarmente significativi e li riarrangia in forma di suite per farli eseguire da un’orchestra comprendente musicisti jazz e classici. Così i brani che ascoltiamo provengono dai seguenti album: “13 and ¾”, “Cerco un paese innocente”, “Alien”, “Folly Seeing All This”, “For Two” e “Hide And Seek”. Il risultato è semplicemente spettacolare grazie anche ai solisti di vaglia presenti in orchestra: Maximilian Kanzler acclamato come uno dei migliori giovani percussionisti e vibrafonisti del momento; il chitarrista Bjarne Roupé, membro fondamentale della Mantler’s Chamber Music and Songs Ensemble; il pianista austriaco David Helbock che a soli 37 anni è già un’icona della scena jazz europea… per non parlare dello stesso leader che si fa apprezzare, more solito, come eccellente trombettista. A tutto ciò si aggiunga la preziosa opera dell’Orchestra nel suo insieme (ben 26 elementi) e si avrà un quadro più preciso del perché si è definito spettacolare l’esecuzione di questa compagine. Tra i membri dell’orchestra da segnalare la presenza della croata violoncellista Asja Valcic che aveva già collaborato con Mantler nell’incisione dell’album “Jazz Composer’s Orchestra Update”. Coda è stato registrato al “Vienna’s Porgy & Bess Studio” nel settembre del 2019, e missato presso gli studi La Buissonne in Francia. Il pianista americano Mike Melillo pubblica il suo nuovo album “In Free Association”, tratto da un radio-concerto effettuato nella primavera del 1974 in quartetto con Roy Cumming (contrabbasso), Glenn Davis (batteria) e Harry Leahey (chitarra). Essendo oggi impossibile ammirare ancora questo gruppo data la dipartita di Harry Leahey, l’ascolto di queste registrazioni, finora inedite, risulta ancora più interessante. La genesi del combo viene riassunta brevemente dallo stesso Melillo nelle note che accompagnano l’album. Apprendiamo, così, che inizialmente si trattava di un trio (senza Leahey) per cui Melillo componeva pezzi orchestrali e da camera sperimentali, Nel ’71, con l’arrivo di Leahey, il trio è diventato un quartetto che ha avuto un buon successo grazie alla qualità della musica proposta e che ritroviamo in questo album. In repertorio sei brani di cui tre scritti dal leader e gli altri tre vere e proprie perle del jazz come “Criss Cross” di Thelonious Monk, “Mimi” di Rodgers e Hart e “What’ll I Do” di Irving Berlin. Il tutto a costituire un insieme omogeneo e di grande livello. In effetti quello proposto dal gruppo è un Jazz senza se e senza ma, un jazz che si rifà agli stilemi del bop e dell’hard-bop con un Melillo che mette in evidenza le sue doti migliori. Un pianismo sorretto da una formidabile tecnica di base, che affronta con eguale bravura sia temi particolarmente complessi e sorretti da un ritmo veloce come “Criss Cross” e “See Hunt and Liddy” in cui si fa apprezzare anche la chitarra di Harry Leahey, sia brani più melodici come “A Little Piece” dello stesso Melillo e “What’ll I Do”. Impeccabile la sezione ritmica. Infine una notazione di carattere tecnico: nonostante si tratti di una ripresa da trasmissione radiofonica, la resa complessiva è più che accettabile.
Il pianista americano Mike Melillo pubblica il suo nuovo album “In Free Association”, tratto da un radio-concerto effettuato nella primavera del 1974 in quartetto con Roy Cumming (contrabbasso), Glenn Davis (batteria) e Harry Leahey (chitarra). Essendo oggi impossibile ammirare ancora questo gruppo data la dipartita di Harry Leahey, l’ascolto di queste registrazioni, finora inedite, risulta ancora più interessante. La genesi del combo viene riassunta brevemente dallo stesso Melillo nelle note che accompagnano l’album. Apprendiamo, così, che inizialmente si trattava di un trio (senza Leahey) per cui Melillo componeva pezzi orchestrali e da camera sperimentali, Nel ’71, con l’arrivo di Leahey, il trio è diventato un quartetto che ha avuto un buon successo grazie alla qualità della musica proposta e che ritroviamo in questo album. In repertorio sei brani di cui tre scritti dal leader e gli altri tre vere e proprie perle del jazz come “Criss Cross” di Thelonious Monk, “Mimi” di Rodgers e Hart e “What’ll I Do” di Irving Berlin. Il tutto a costituire un insieme omogeneo e di grande livello. In effetti quello proposto dal gruppo è un Jazz senza se e senza ma, un jazz che si rifà agli stilemi del bop e dell’hard-bop con un Melillo che mette in evidenza le sue doti migliori. Un pianismo sorretto da una formidabile tecnica di base, che affronta con eguale bravura sia temi particolarmente complessi e sorretti da un ritmo veloce come “Criss Cross” e “See Hunt and Liddy” in cui si fa apprezzare anche la chitarra di Harry Leahey, sia brani più melodici come “A Little Piece” dello stesso Melillo e “What’ll I Do”. Impeccabile la sezione ritmica. Infine una notazione di carattere tecnico: nonostante si tratti di una ripresa da trasmissione radiofonica, la resa complessiva è più che accettabile. Ascoltare la musica del tedesco Stephan Micus (classe 1953) è come addentrarsi in una foresta incantata, impreziosita da episodi di rara bellezza. Episodi determinati dalle sorprese che in ogni sua avventura questo personaggio ci propone. In qualunque contesto si abbia la fortuna di incontrare l’arte di Micus, la mente vaga ben al di là del contingente, alla ricerca di un approdo che mai risulta facile trovare, e ciò indipendentemente dalla preparazione musicale di ciascuno. Siamo trasportati in un mondo “altro” in cui le certezze vacillano alla ricerca di un qualche appiglio sonoro che ci restituisca punti fermi, conoscenze a cui rifarsi. In effetti la musica di Micus non ammette di essere incasellata in un genere ben preciso per cui si mantiene ben lontana da qualsivoglia proposta commercialmente allettante. Più sopra si accennava alle sorprese che ogni volta il musicista ci riserva: questa volta la novità consiste nell’utilizzo di due strumenti presentati da Micus per la prima volta: il chikulo e il tongue drum. Il primo, come spiega lo stesso Micus nelle note di copertina, è uno xilofono basso del Mozambico utilizzato in gruppi che solitamente comprendono una dozzina di xilofoni, mentre il tongue drum è una scatola di legno originaria dell’Africa che può essere suonata con le mani o con le bacchette. Ora detta così non ci sarebbe alcunché di strano … salvo il fatto che Micus non è solo un compositore e un sorprendente polistrumentista ma un etnomusicologo costantemente in evoluzione e in viaggio, soprattutto in Asia e in Africa, con l’intento di scovare e studiare strumenti desueti, talvolta addirittura dimenticati. Una volta trovati, li modifica con nuove accordature prima di adoperarli, con risultati strabilianti. È impressionante il numero di strumenti che padroneggia, strumenti che si ascoltano nelle musiche originali di tutti i continenti. Ciò detto risulta facile immaginare la musica di quest’ultimo album in cui Micus, come al solito in assoluta solitudine, ci racconta a modo suo il fluire della vita attraverso il succedersi delle stagioni. Un album sicuramente impegnativo ma altrettanto certamente di sicuro interesse.
Ascoltare la musica del tedesco Stephan Micus (classe 1953) è come addentrarsi in una foresta incantata, impreziosita da episodi di rara bellezza. Episodi determinati dalle sorprese che in ogni sua avventura questo personaggio ci propone. In qualunque contesto si abbia la fortuna di incontrare l’arte di Micus, la mente vaga ben al di là del contingente, alla ricerca di un approdo che mai risulta facile trovare, e ciò indipendentemente dalla preparazione musicale di ciascuno. Siamo trasportati in un mondo “altro” in cui le certezze vacillano alla ricerca di un qualche appiglio sonoro che ci restituisca punti fermi, conoscenze a cui rifarsi. In effetti la musica di Micus non ammette di essere incasellata in un genere ben preciso per cui si mantiene ben lontana da qualsivoglia proposta commercialmente allettante. Più sopra si accennava alle sorprese che ogni volta il musicista ci riserva: questa volta la novità consiste nell’utilizzo di due strumenti presentati da Micus per la prima volta: il chikulo e il tongue drum. Il primo, come spiega lo stesso Micus nelle note di copertina, è uno xilofono basso del Mozambico utilizzato in gruppi che solitamente comprendono una dozzina di xilofoni, mentre il tongue drum è una scatola di legno originaria dell’Africa che può essere suonata con le mani o con le bacchette. Ora detta così non ci sarebbe alcunché di strano … salvo il fatto che Micus non è solo un compositore e un sorprendente polistrumentista ma un etnomusicologo costantemente in evoluzione e in viaggio, soprattutto in Asia e in Africa, con l’intento di scovare e studiare strumenti desueti, talvolta addirittura dimenticati. Una volta trovati, li modifica con nuove accordature prima di adoperarli, con risultati strabilianti. È impressionante il numero di strumenti che padroneggia, strumenti che si ascoltano nelle musiche originali di tutti i continenti. Ciò detto risulta facile immaginare la musica di quest’ultimo album in cui Micus, come al solito in assoluta solitudine, ci racconta a modo suo il fluire della vita attraverso il succedersi delle stagioni. Un album sicuramente impegnativo ma altrettanto certamente di sicuro interesse. Così come nello sport non basta assemblare ottimi giocatori per fare una buona squadra, così nella musica non è detto che tre pur bravi musicisti riescano a produrre qualcosa di buono. Certo che se poi i tre musicisti rispondono ai nomi di Gabriele Mirabassi al clarinetto, Nando Di Modugno alla chitarra e Pierluigi Balducci alla chitarra basso le probabilità di ascoltare dell’ottima musica aumentano… e di tanto. Ed in effetti ottima musica è quella che si ascolta in questo “Tabacco e caffè” registrato sei anni dopo “Amori sospesi” che vedeva impegnato lo stesso trio. La linea ispirativa rimane sostanzialmente la stessa: una sorta di viaggio sulla rotta Mediterraneo, America del Sud attraverso un linguaggio originale in cui coesistono jazz, folk, tradizione classica. E non è certo un caso che in repertorio figurino nove brani di cui quattro composizioni originali rispettivamente di Mirabassi (“Espinha de truta”), Di Modugno (“Salgado”) e Balducci (“Tobaco y cafè” e “La ballata dei giorni piovosi”) e cinque riletture di brani più o meno celebri di Toninho Horta (“Party in Olinda”), Henry Mancini (“Two for the road”), Egberto Gismonti (“Frevo”), Guinga (“Ellingtoniana”) e della conclusiva “Choro bandido” firmata da Edu Lobo e Chico Buarque. Indipendentemente dal pezzo affrontato, l’interpretazione rimane calda, oseremmo dire intimista, con i tre che dialogano piacevolmente, in piena rilassatezza senza un solo momento in cui il trio sembra spinto verso lidi che non siano comuni ai tre. Interessanti le note di copertina di Gabriele Mirabassi in cui il clarinettista illustra l’importanza del tabacco e del caffè considerati vizi ma che in realtà “più di tutto sono modi di stare insieme. In Italia poi, veri fondamenti della cultura nazionale”.
Così come nello sport non basta assemblare ottimi giocatori per fare una buona squadra, così nella musica non è detto che tre pur bravi musicisti riescano a produrre qualcosa di buono. Certo che se poi i tre musicisti rispondono ai nomi di Gabriele Mirabassi al clarinetto, Nando Di Modugno alla chitarra e Pierluigi Balducci alla chitarra basso le probabilità di ascoltare dell’ottima musica aumentano… e di tanto. Ed in effetti ottima musica è quella che si ascolta in questo “Tabacco e caffè” registrato sei anni dopo “Amori sospesi” che vedeva impegnato lo stesso trio. La linea ispirativa rimane sostanzialmente la stessa: una sorta di viaggio sulla rotta Mediterraneo, America del Sud attraverso un linguaggio originale in cui coesistono jazz, folk, tradizione classica. E non è certo un caso che in repertorio figurino nove brani di cui quattro composizioni originali rispettivamente di Mirabassi (“Espinha de truta”), Di Modugno (“Salgado”) e Balducci (“Tobaco y cafè” e “La ballata dei giorni piovosi”) e cinque riletture di brani più o meno celebri di Toninho Horta (“Party in Olinda”), Henry Mancini (“Two for the road”), Egberto Gismonti (“Frevo”), Guinga (“Ellingtoniana”) e della conclusiva “Choro bandido” firmata da Edu Lobo e Chico Buarque. Indipendentemente dal pezzo affrontato, l’interpretazione rimane calda, oseremmo dire intimista, con i tre che dialogano piacevolmente, in piena rilassatezza senza un solo momento in cui il trio sembra spinto verso lidi che non siano comuni ai tre. Interessanti le note di copertina di Gabriele Mirabassi in cui il clarinettista illustra l’importanza del tabacco e del caffè considerati vizi ma che in realtà “più di tutto sono modi di stare insieme. In Italia poi, veri fondamenti della cultura nazionale”. Dino Plasmati chitarra, Antonio Tosques chitarra, Bruno Montrone organo e Marcello Nisi batteria sono i protagonisti di questa nuova produzione firmata Caligola. Particolarmente impegnativo il programma dal momento che comprende una serie di brani ‘storici’ con un solo pezzo originale scritto da Plasmati, “Boundless Energy”. Come recita il nome del gruppo, a indirizzare il tutto sono le due chitarre di Plasmati e Tosques suonate con tecnica tradizionale, senza cioè l’ausilio dell’elettronica, e questa “guida” si avverte ben certa per tutta la durata dell’album anche se non mancano, ovviamente, momenti in cui in primo piano sale l’Organo Hammond nelle sapienti mani di Bruno Montone; è il caso dell’original cui si faceva riferimento. Per il resto i due leader guidano il gruppo con mano sicura per nell’affrontare temi che sulla carta mal si prestano ad interpretazioni chitarristiche: è il caso ad esempio del brano d’apertura, “Airegin”, scritto da Sonny Rollins. Ma da questo punto di vista le sorprese non mancano: ecco quindi la convincente disinvoltura con cui eseguono “Your own Sweet Way” di Dave Brubeck o la delicatezza con cui cesellano “I’ve Accustomed to Her Face” di Loewe Lerner complice anche il bel lavoro di Montrone all’Hammond. O ancora la pertinenza di linguaggio con i ritmi sudamericani di “When Sunny Gets Blue” di Fisher-Segal, in cui si apprezza anche l’eccellente supporto di Nisi alla batteria. A chiudere una convincente interpretazione del colemaniano “Turnaround” eseguito dai due chitarristi senza sezione ritmica.
Dino Plasmati chitarra, Antonio Tosques chitarra, Bruno Montrone organo e Marcello Nisi batteria sono i protagonisti di questa nuova produzione firmata Caligola. Particolarmente impegnativo il programma dal momento che comprende una serie di brani ‘storici’ con un solo pezzo originale scritto da Plasmati, “Boundless Energy”. Come recita il nome del gruppo, a indirizzare il tutto sono le due chitarre di Plasmati e Tosques suonate con tecnica tradizionale, senza cioè l’ausilio dell’elettronica, e questa “guida” si avverte ben certa per tutta la durata dell’album anche se non mancano, ovviamente, momenti in cui in primo piano sale l’Organo Hammond nelle sapienti mani di Bruno Montone; è il caso dell’original cui si faceva riferimento. Per il resto i due leader guidano il gruppo con mano sicura per nell’affrontare temi che sulla carta mal si prestano ad interpretazioni chitarristiche: è il caso ad esempio del brano d’apertura, “Airegin”, scritto da Sonny Rollins. Ma da questo punto di vista le sorprese non mancano: ecco quindi la convincente disinvoltura con cui eseguono “Your own Sweet Way” di Dave Brubeck o la delicatezza con cui cesellano “I’ve Accustomed to Her Face” di Loewe Lerner complice anche il bel lavoro di Montrone all’Hammond. O ancora la pertinenza di linguaggio con i ritmi sudamericani di “When Sunny Gets Blue” di Fisher-Segal, in cui si apprezza anche l’eccellente supporto di Nisi alla batteria. A chiudere una convincente interpretazione del colemaniano “Turnaround” eseguito dai due chitarristi senza sezione ritmica. Ancora un duo e ancora bella musica. Protagonisti Emanuele Sartoris al pianoforte e Daniele Di Bonaventura al bandoneon. Vista la struttura dell’organico, si poteva temere una certa staticità dell’album a discapito del possibile interesse dell’ascoltatore. Pericolo assolutamente evitato dai due artisti che invece sfoggiano una verve fantastica dando vita a otto composizioni originali scritte dai due singolarmente o in cooperazione, che tengono desta l’attenzione dalla prima all’ultima nota. Merito da un canto della bellezza dei temi tutti caratterizzati da un’accurata ricerca melodica, dall’altro dalla perizia strumentale dei due che pur non sfoggiando alcuna particolare ricercatezza tecnica, suonano comunque con grande partecipazione e intensità. Doti che non si affievoliscono – anzi – quando decidono di reinterpretare due notturni di Chopin vale a dire il Notturno op.9 n.1 e il Notturno op.9 n.2, che non a caso aprono e chiudono l’album. Insomma un disco più che interessante scaturito dall’incontro tra il pianoforte di Emanuele Sartoris, musicista che ben conosce anche la musica classica, e il bandoneon di Daniele di Bonaventura, uno dei maggiori interpreti internazionali dello strumento. Un disco che sembra quasi invitarci ad una sorta di viaggio interiore alla scoperta di ciò che è veramente importante. E ci piace chiudere questa breve presentazione citando le parole con cui il violoncellista di fama internazionale Mario Brunello conclude le sue preziose note di copertina: “Un viaggio slow, un cammino nel vissuto della musica, a cui si aggiungono le improvvisazioni e l’ispirazione di due formidabili e coraggiosi musicisti che hanno il talento sincero per avvicinarsi ed addentrarsi nella magica atmosfera dei Notturni”.
Ancora un duo e ancora bella musica. Protagonisti Emanuele Sartoris al pianoforte e Daniele Di Bonaventura al bandoneon. Vista la struttura dell’organico, si poteva temere una certa staticità dell’album a discapito del possibile interesse dell’ascoltatore. Pericolo assolutamente evitato dai due artisti che invece sfoggiano una verve fantastica dando vita a otto composizioni originali scritte dai due singolarmente o in cooperazione, che tengono desta l’attenzione dalla prima all’ultima nota. Merito da un canto della bellezza dei temi tutti caratterizzati da un’accurata ricerca melodica, dall’altro dalla perizia strumentale dei due che pur non sfoggiando alcuna particolare ricercatezza tecnica, suonano comunque con grande partecipazione e intensità. Doti che non si affievoliscono – anzi – quando decidono di reinterpretare due notturni di Chopin vale a dire il Notturno op.9 n.1 e il Notturno op.9 n.2, che non a caso aprono e chiudono l’album. Insomma un disco più che interessante scaturito dall’incontro tra il pianoforte di Emanuele Sartoris, musicista che ben conosce anche la musica classica, e il bandoneon di Daniele di Bonaventura, uno dei maggiori interpreti internazionali dello strumento. Un disco che sembra quasi invitarci ad una sorta di viaggio interiore alla scoperta di ciò che è veramente importante. E ci piace chiudere questa breve presentazione citando le parole con cui il violoncellista di fama internazionale Mario Brunello conclude le sue preziose note di copertina: “Un viaggio slow, un cammino nel vissuto della musica, a cui si aggiungono le improvvisazioni e l’ispirazione di due formidabili e coraggiosi musicisti che hanno il talento sincero per avvicinarsi ed addentrarsi nella magica atmosfera dei Notturni”. Album d’esordio per questo trio composto dal batterista Thomas Strønen, dalla pianista Ayumi Tanaka e dalla clarinettista, vocalist, percussionista Marthe Lea. L’album si inserisce in quella corrente che a partire dagli anni ’70 ha portato il jazz norvegese ai massimi livelli delle scene jazzistiche internazionali. Vale a dire una musica che si rifà al patrimonio folkloristico delle popolazioni nordiche (in particolare norvegesi) declinata attraverso un linguaggio che incorpora elementi tratti dal jazz, dalla musica classica e ovviamente dal folk. Non a caso in programma ci sono dieci brani tutti scritti dai tre musicisti ma tutti basati sul folk norvegese. Quindi una musica delicata, intimista, che affronta spazi aperti quali sono quelli che si aprono alla nostra mente quando pensiamo ai paesaggi nordici. Ascoltare l’intero album è un’esperienza singolare tanto che ad un certo punto è come se il concetto spazio-temporale si perda per assorbici totalmente nell’atmosfera creata dai tre musicisti che denotano, improvvisando costantemente, un affiatamento non comune. D’altro canto la genesi del gruppo spiega la ragione di tale empatia: dapprima si trattava di un duo composto da pianista e batterista cui in un secondo tempo si è aggiunta Marthe Lea. I tre si sono, quindi, trovati assieme alla “Oslo’s Royal Academy of Music” dove per ben due anni hanno provato assieme ogni settimana alla ricerca di un quid che permettesse loro di suonare musica improvvisata. Evidentemente questo quid l’hanno trovato e così è nato questo “Bayou” frutto come afferma lo stesso Strønen di quelle esperienze: “Noi suonavamo sempre liberamente – afferma – mescolando elementi di musica classica contemporanea, folk, jazz, a seconda di come ciascuno di noi era ispirato al momento. Alle volte la musica era molto calma, delicata e minimalista: suonando assieme si sono generate alcune speciali esperienze”: Quelle stesse esperienze che si avvertono ascoltando l’album.
Album d’esordio per questo trio composto dal batterista Thomas Strønen, dalla pianista Ayumi Tanaka e dalla clarinettista, vocalist, percussionista Marthe Lea. L’album si inserisce in quella corrente che a partire dagli anni ’70 ha portato il jazz norvegese ai massimi livelli delle scene jazzistiche internazionali. Vale a dire una musica che si rifà al patrimonio folkloristico delle popolazioni nordiche (in particolare norvegesi) declinata attraverso un linguaggio che incorpora elementi tratti dal jazz, dalla musica classica e ovviamente dal folk. Non a caso in programma ci sono dieci brani tutti scritti dai tre musicisti ma tutti basati sul folk norvegese. Quindi una musica delicata, intimista, che affronta spazi aperti quali sono quelli che si aprono alla nostra mente quando pensiamo ai paesaggi nordici. Ascoltare l’intero album è un’esperienza singolare tanto che ad un certo punto è come se il concetto spazio-temporale si perda per assorbici totalmente nell’atmosfera creata dai tre musicisti che denotano, improvvisando costantemente, un affiatamento non comune. D’altro canto la genesi del gruppo spiega la ragione di tale empatia: dapprima si trattava di un duo composto da pianista e batterista cui in un secondo tempo si è aggiunta Marthe Lea. I tre si sono, quindi, trovati assieme alla “Oslo’s Royal Academy of Music” dove per ben due anni hanno provato assieme ogni settimana alla ricerca di un quid che permettesse loro di suonare musica improvvisata. Evidentemente questo quid l’hanno trovato e così è nato questo “Bayou” frutto come afferma lo stesso Strønen di quelle esperienze: “Noi suonavamo sempre liberamente – afferma – mescolando elementi di musica classica contemporanea, folk, jazz, a seconda di come ciascuno di noi era ispirato al momento. Alle volte la musica era molto calma, delicata e minimalista: suonando assieme si sono generate alcune speciali esperienze”: Quelle stesse esperienze che si avvertono ascoltando l’album. La sassofonista norvegese Elisabeth Lid Trøen (eccellente anche al flauto) si presenta alla testa di un quartetto con Dag Arnesen al piano, Ole Marius Sandberg al basso e Sigurd Steinkopf alla batteria. Il repertorio è costituito da dieci brani di cui otto scritti dalla leader e due dal pianista. Due le linee direttrici dell’album: da un canto la ricerca della linea melodica, dall’altro la capacità di improvvisare sulla stessa. Per rendersi conto, ad esempio, della capacità dei quattro di tener fede a quanto sopra detto basta ascoltare “Just Thinking”: il brano si apre su tempo lento con una linea perfettamente riconoscibile ma dopo l’esposizione del tema con la Trøen al flauto ecco un assolo di pianoforte che si avventura nelle pieghe del brano per scoprirne e lumeggiarne ogni più nascosto anfratto mentre sul finale si riascolta il flauto della leader. “Sarah’s Bounce” si apre a tempo di marcia sospinta dalla batteria di Steinkopf il quale, nello scorrere del brano, dimostra di poter avere anche un approccio melodico allo strumento. In ogni caso il pallino resta nelle mani di sassofonista e pianista che dimostrano di essere complementari nel loro linguaggio dato che le sortite solistiche dell’una vengono riprese ed rilanciate a tutto tondo dall’altro. Altro brano particolarmente interessante “Partysvensken” che si distacca piuttosto nettamente dalle atmosfere degli altri brani data la sua vicinanza, in alcuni momenti, agli stilemi del free jazz. L’album si chiude con “Denne” il pezzo che maggiormente richiama le atmosfere nordiche grazie soprattutto ad un meditativo assolo del pianista; di rilievo anche l’assolo del bassista Ole Marius Sandberg. Ma a proposito di atmosfere nordiche, l’ascoltatore più attento non potrà non rilevare qua e là, spiccate influenze della musica popolare norvegese che tanta importanza ha avuto sulla musica di quel Paese grazie ad artisti quali Jan Garbarek e Terje Rypdal.
La sassofonista norvegese Elisabeth Lid Trøen (eccellente anche al flauto) si presenta alla testa di un quartetto con Dag Arnesen al piano, Ole Marius Sandberg al basso e Sigurd Steinkopf alla batteria. Il repertorio è costituito da dieci brani di cui otto scritti dalla leader e due dal pianista. Due le linee direttrici dell’album: da un canto la ricerca della linea melodica, dall’altro la capacità di improvvisare sulla stessa. Per rendersi conto, ad esempio, della capacità dei quattro di tener fede a quanto sopra detto basta ascoltare “Just Thinking”: il brano si apre su tempo lento con una linea perfettamente riconoscibile ma dopo l’esposizione del tema con la Trøen al flauto ecco un assolo di pianoforte che si avventura nelle pieghe del brano per scoprirne e lumeggiarne ogni più nascosto anfratto mentre sul finale si riascolta il flauto della leader. “Sarah’s Bounce” si apre a tempo di marcia sospinta dalla batteria di Steinkopf il quale, nello scorrere del brano, dimostra di poter avere anche un approccio melodico allo strumento. In ogni caso il pallino resta nelle mani di sassofonista e pianista che dimostrano di essere complementari nel loro linguaggio dato che le sortite solistiche dell’una vengono riprese ed rilanciate a tutto tondo dall’altro. Altro brano particolarmente interessante “Partysvensken” che si distacca piuttosto nettamente dalle atmosfere degli altri brani data la sua vicinanza, in alcuni momenti, agli stilemi del free jazz. L’album si chiude con “Denne” il pezzo che maggiormente richiama le atmosfere nordiche grazie soprattutto ad un meditativo assolo del pianista; di rilievo anche l’assolo del bassista Ole Marius Sandberg. Ma a proposito di atmosfere nordiche, l’ascoltatore più attento non potrà non rilevare qua e là, spiccate influenze della musica popolare norvegese che tanta importanza ha avuto sulla musica di quel Paese grazie ad artisti quali Jan Garbarek e Terje Rypdal. E’ con vero piacere che vi segnalo questo “Italian Way to Feel Blues” non solo per la validità del progetto ma anche perché è presente un musicista a cui sono legato da particolari legami affettivi, un organista che ho conosciuto quando ancora abitavo in Sicilia (quindi primissimi anni ’70) e che ancora a mio avviso non ha ottenuto i riconoscimenti che merita. Sto parlando di Pippo Guarnera nell’occasione non solo all’organo Hammond ma anche al pianoforte. Oltre a lui e ovviamente al leader Vince Vallicelli alle percussioni, troviamo Nahuel Schiumarini alla chitarra elettrica, Andrea Valeri alla chitarra acustica, Roberto Luti al dobro e Felice Del Gaudio al basso. Come si può facilmente intuire da quanto sin qui detto, la musica è trascinante con tutti gli artisti in grado di ritagliarsi importanti spazi di improvvisazione. Ecco quindi Pippo Guarnera primeggiare all’organo in “Art” di Vallicelli, per lasciare successivamente spazio alle chitarre di Schiumarini e Valeri nonché al dobro di Roberto Luti, il tutto sorretto da una metronomica sezione ritmica con batteria e basso che non sbagliano un colpo. Insomma musica che fa battere il classico piedino sia che si affrontino temi originali (ben sette sui nove proposti dall’album) sia che si rileggano pagine importanti come “After Hours” di Avery Parrish standard jazz tra i più eseguiti che venne registrato per la prima volta dal suo stesso autore con la Erskine Hawkins Orchestra, il 10 giugno 1940 o “Windy e Warm” di John D. Loudermilk considerato a ben ragione un classico del fingerstyle, ripreso da artisti di assoluto livello quali Chet Atkins, Doc Watson e Tommy Emmanuel.
E’ con vero piacere che vi segnalo questo “Italian Way to Feel Blues” non solo per la validità del progetto ma anche perché è presente un musicista a cui sono legato da particolari legami affettivi, un organista che ho conosciuto quando ancora abitavo in Sicilia (quindi primissimi anni ’70) e che ancora a mio avviso non ha ottenuto i riconoscimenti che merita. Sto parlando di Pippo Guarnera nell’occasione non solo all’organo Hammond ma anche al pianoforte. Oltre a lui e ovviamente al leader Vince Vallicelli alle percussioni, troviamo Nahuel Schiumarini alla chitarra elettrica, Andrea Valeri alla chitarra acustica, Roberto Luti al dobro e Felice Del Gaudio al basso. Come si può facilmente intuire da quanto sin qui detto, la musica è trascinante con tutti gli artisti in grado di ritagliarsi importanti spazi di improvvisazione. Ecco quindi Pippo Guarnera primeggiare all’organo in “Art” di Vallicelli, per lasciare successivamente spazio alle chitarre di Schiumarini e Valeri nonché al dobro di Roberto Luti, il tutto sorretto da una metronomica sezione ritmica con batteria e basso che non sbagliano un colpo. Insomma musica che fa battere il classico piedino sia che si affrontino temi originali (ben sette sui nove proposti dall’album) sia che si rileggano pagine importanti come “After Hours” di Avery Parrish standard jazz tra i più eseguiti che venne registrato per la prima volta dal suo stesso autore con la Erskine Hawkins Orchestra, il 10 giugno 1940 o “Windy e Warm” di John D. Loudermilk considerato a ben ragione un classico del fingerstyle, ripreso da artisti di assoluto livello quali Chet Atkins, Doc Watson e Tommy Emmanuel. Se allo Steinway e Sons siede Stefano Bollani ed al suo cospetto sta un’orchestra “tipica” come la Sin Fin diretta da Exequeil Mantega, non si sa se aspettarsi un’atmosfera più jazz o più classica avendo ben nota la versatilità del musicista a destreggiarsi in più ambiti e “ambienti”. Se si guarda al “Concerto Azzurro” che impegna e impregna una buona mezzora dell’album Alobar “El Chakracanta, Live in Buenos Aires”, commissionatogli da Kristjan Järvi e dalla MDR – Leipzig Radio Symphony di Lipsia, se ne constata la struttura classica di base in tempi allegro, adagio ed allegro molto. Una suddivisione che peraltro lascia ampio spazio alla libertà ed all’improvvisazione dell’interprete-compositore Bollani nello schema orchestrale disegnato da Paolo Silvestri. La risposta data dall’ascolto ha due facce che diventano una poiché sin dalle prime note se ne evidenzia l’impasto ibrido che coniuga latin tinge e mood nordamericano, emisferi coesi da una tastiera cosparsa di riflessi timbrici di quel nuovo mondo che incuriosí Debussy, Poulenc, Ravel…misti a spirito contemporaneo. L’azzurro è il colore del quinto chakra, della gola, ed è quello, come osserva lo stesso pianista in un web/video del Centro Culturale Kirchner di Baires “che sovraintende alla espressione”. Per farlo “star bene” è utile che si dica quello che si ha da dire e si esprima ciò che si vuole esprimere in un dato momento della vita. Ed il jazzista, in questa particolare fase della propria carriera artistica, sta denudando sempre più un’anima spanish che va ad infonderne sia la vis compositiva che la pratica esecutiva. Lavoro di ampio respiro melodico è quindi “Concerto Verde” dove il pigmento bollaniano, intinto nel quarto Chakra del Cuore e dell’Amore, si cimenta in un saliscendi di sincopi e contrattempi di tanghi e milonghe collocate in quel suolo in cui il pianista ha esportato, oltre ad un certo estro mozartiano, una valigia zeppa di suoni ed armonie. Il disco è completato da due brani arrangiati ed orchestrati da Diego Schissi, il piazzolliano “Libertango”, doveroso omaggio all’ideatore del Nuevo Tango e “Don Agustín Bardi”, di Horacio Salgán, che la performance con l’orchestra trasforma in rito collettivo di tributo ad un altro grande musicista argentino.
Se allo Steinway e Sons siede Stefano Bollani ed al suo cospetto sta un’orchestra “tipica” come la Sin Fin diretta da Exequeil Mantega, non si sa se aspettarsi un’atmosfera più jazz o più classica avendo ben nota la versatilità del musicista a destreggiarsi in più ambiti e “ambienti”. Se si guarda al “Concerto Azzurro” che impegna e impregna una buona mezzora dell’album Alobar “El Chakracanta, Live in Buenos Aires”, commissionatogli da Kristjan Järvi e dalla MDR – Leipzig Radio Symphony di Lipsia, se ne constata la struttura classica di base in tempi allegro, adagio ed allegro molto. Una suddivisione che peraltro lascia ampio spazio alla libertà ed all’improvvisazione dell’interprete-compositore Bollani nello schema orchestrale disegnato da Paolo Silvestri. La risposta data dall’ascolto ha due facce che diventano una poiché sin dalle prime note se ne evidenzia l’impasto ibrido che coniuga latin tinge e mood nordamericano, emisferi coesi da una tastiera cosparsa di riflessi timbrici di quel nuovo mondo che incuriosí Debussy, Poulenc, Ravel…misti a spirito contemporaneo. L’azzurro è il colore del quinto chakra, della gola, ed è quello, come osserva lo stesso pianista in un web/video del Centro Culturale Kirchner di Baires “che sovraintende alla espressione”. Per farlo “star bene” è utile che si dica quello che si ha da dire e si esprima ciò che si vuole esprimere in un dato momento della vita. Ed il jazzista, in questa particolare fase della propria carriera artistica, sta denudando sempre più un’anima spanish che va ad infonderne sia la vis compositiva che la pratica esecutiva. Lavoro di ampio respiro melodico è quindi “Concerto Verde” dove il pigmento bollaniano, intinto nel quarto Chakra del Cuore e dell’Amore, si cimenta in un saliscendi di sincopi e contrattempi di tanghi e milonghe collocate in quel suolo in cui il pianista ha esportato, oltre ad un certo estro mozartiano, una valigia zeppa di suoni ed armonie. Il disco è completato da due brani arrangiati ed orchestrati da Diego Schissi, il piazzolliano “Libertango”, doveroso omaggio all’ideatore del Nuevo Tango e “Don Agustín Bardi”, di Horacio Salgán, che la performance con l’orchestra trasforma in rito collettivo di tributo ad un altro grande musicista argentino. Ogni montagna è, a modo suo, incantata. Sarà la maestosità, sarà il senso di infinito che ispira il contemplarla, sarà la magia che la ricopre… la montagna ha dei suoni; ed ha degli echi, oltre quelli naturali, che le provengono dal passato, dalla storia che ne ha attraversato rocce, valichi, passi, sentieri, versanti, ghiacciai… Il clarinettista Francesco Chiapperini ha inteso dedicare l’album “On The Bare Rocks and Glaciers” (Caligola Records) al mondo alpino riprendendo il titolo del lavoro dalla “Preghiera degli Alpini” di Giovanni Veneri recitata in chiusura dall’ospite Maurizio Arena. Con un sestetto di taglio cameristico, formato da un “coro” di fiati (Vito Emanuele Galante, tromba; Mario Mariotti, cornet; Roger Roota, bassoon, Andrea Ferrari, sax baritono) e un violino (Virginia Sutera) ha inteso ricreare una particolare coralità che consentisse la rappresentazione musicale di un ambiente che è stato testimone di vicende umane, anche quelle più tragiche come la guerra. La sensazione che si avverte nelle diciotto tracce, tutte in tema, alcune tradizionali altre di autori come Steve Swallow (“The Green Mountains”), Pergolesi (“Stabat Mater”), Grieg (“I Dovregubbens Hall”) oltre che di Chiapperini, Bregani, Malatesta, De Marzi, è di una pervadente wilderness tutta spirituale. L’ incontaminata “altezza” è “scalata” da note musicali che quasi paiono arrampicarsi in cordata per trasmetterci l’ebbrezza dell’altitudine. Un’impressione che viene interrotta a volte da valanghe di suoni per poi rientrare nell’atmosfera composta di un sempre millenario, fra i deserti d’alta quota di una montagna bella impossibile.
Ogni montagna è, a modo suo, incantata. Sarà la maestosità, sarà il senso di infinito che ispira il contemplarla, sarà la magia che la ricopre… la montagna ha dei suoni; ed ha degli echi, oltre quelli naturali, che le provengono dal passato, dalla storia che ne ha attraversato rocce, valichi, passi, sentieri, versanti, ghiacciai… Il clarinettista Francesco Chiapperini ha inteso dedicare l’album “On The Bare Rocks and Glaciers” (Caligola Records) al mondo alpino riprendendo il titolo del lavoro dalla “Preghiera degli Alpini” di Giovanni Veneri recitata in chiusura dall’ospite Maurizio Arena. Con un sestetto di taglio cameristico, formato da un “coro” di fiati (Vito Emanuele Galante, tromba; Mario Mariotti, cornet; Roger Roota, bassoon, Andrea Ferrari, sax baritono) e un violino (Virginia Sutera) ha inteso ricreare una particolare coralità che consentisse la rappresentazione musicale di un ambiente che è stato testimone di vicende umane, anche quelle più tragiche come la guerra. La sensazione che si avverte nelle diciotto tracce, tutte in tema, alcune tradizionali altre di autori come Steve Swallow (“The Green Mountains”), Pergolesi (“Stabat Mater”), Grieg (“I Dovregubbens Hall”) oltre che di Chiapperini, Bregani, Malatesta, De Marzi, è di una pervadente wilderness tutta spirituale. L’ incontaminata “altezza” è “scalata” da note musicali che quasi paiono arrampicarsi in cordata per trasmetterci l’ebbrezza dell’altitudine. Un’impressione che viene interrotta a volte da valanghe di suoni per poi rientrare nell’atmosfera composta di un sempre millenario, fra i deserti d’alta quota di una montagna bella impossibile. Luca DalPozzo, contrabbassista leader del 5et che annovera Frank Martino alla chitarra, Manuel Caliumi all’alto sax, Giulio Stermieri al piano e Marco Frattini alla batteria, ha concepito l’album “Rust” dopo essere rimasto folgorato, durante una visita in una mostra bolognese nel 2018, dalle opere di Hiroshige e di Hokusai. La pittura di quest’ultimo, in particolare, ispirata a “immagini del mondo fluttuante” nel Giappone di inizio ottocento, consta di vedute dall’alto, contorni dettagliati, ed è antesignana di prospettiva. Dal canto suo, l’incisore Hiroshige, suo contemporaneo, fu un grande “paesaggista” il cui tratto figurativo venne apprezzato dagli stessi impressionisti in Europa. Si intende allora l’input di questo disco il cui titolo lo si può riferire al noto videogioco od all’omologo linguaggio di programmazione, certamente Rust non starà per ruggine a volerne seguire la traduzione letterale. All’origine vi sono due figure simbolo del movimento “Ukiyo-E” a cui è dedicato l’incipit fra le sette tracce del cd. E già lì la musica del 5et appare di ondulata viralità ed eclissante circolarità nell’iniettarsi lo spirito di quell’antica arte nipponica ed applicarla al contemporary. Che diventa fusion in “Alamar” per rientrare, dopo la soffusa “Day a Dream”, al guscio di suggestioni dettate da Ligeti in “Gyorgy Cluster Dance”: grappoli di acciaccature a sovraintendere le iterazioni in chiave di basso e di violino verso un effetto d’insieme scioccante e talora stralunante. Ancora. “Swirl” è caratterizzata da un tempo increspato, indistinto, fuzzy, con progressioni armoniche libere un pò alla Ornette Coleman. “Upward Drop” è un brano pregno di riverberazioni e riflessi siamo cioè ancora nel grembo di una musica in qualche modo “di rappresentazione”. Carattere che il conclusivo “Blues for Larry (going ballistic)” non fa che confermare per capacità traslativa di idee in note musicali.
Luca DalPozzo, contrabbassista leader del 5et che annovera Frank Martino alla chitarra, Manuel Caliumi all’alto sax, Giulio Stermieri al piano e Marco Frattini alla batteria, ha concepito l’album “Rust” dopo essere rimasto folgorato, durante una visita in una mostra bolognese nel 2018, dalle opere di Hiroshige e di Hokusai. La pittura di quest’ultimo, in particolare, ispirata a “immagini del mondo fluttuante” nel Giappone di inizio ottocento, consta di vedute dall’alto, contorni dettagliati, ed è antesignana di prospettiva. Dal canto suo, l’incisore Hiroshige, suo contemporaneo, fu un grande “paesaggista” il cui tratto figurativo venne apprezzato dagli stessi impressionisti in Europa. Si intende allora l’input di questo disco il cui titolo lo si può riferire al noto videogioco od all’omologo linguaggio di programmazione, certamente Rust non starà per ruggine a volerne seguire la traduzione letterale. All’origine vi sono due figure simbolo del movimento “Ukiyo-E” a cui è dedicato l’incipit fra le sette tracce del cd. E già lì la musica del 5et appare di ondulata viralità ed eclissante circolarità nell’iniettarsi lo spirito di quell’antica arte nipponica ed applicarla al contemporary. Che diventa fusion in “Alamar” per rientrare, dopo la soffusa “Day a Dream”, al guscio di suggestioni dettate da Ligeti in “Gyorgy Cluster Dance”: grappoli di acciaccature a sovraintendere le iterazioni in chiave di basso e di violino verso un effetto d’insieme scioccante e talora stralunante. Ancora. “Swirl” è caratterizzata da un tempo increspato, indistinto, fuzzy, con progressioni armoniche libere un pò alla Ornette Coleman. “Upward Drop” è un brano pregno di riverberazioni e riflessi siamo cioè ancora nel grembo di una musica in qualche modo “di rappresentazione”. Carattere che il conclusivo “Blues for Larry (going ballistic)” non fa che confermare per capacità traslativa di idee in note musicali. La solitudine dei numeri primi ha nell’uno, nell’unità, una dimensione tutta sua. Può essere isolamento misantropico, autoesilio individualistico, autoconfinamento ma può significare ritiro spirituale, (ri)pensamento solipsistico, monologo interiore. Che tale non è più nel momento in cui ci si esteriorizza per il tramite, ad esempio, della musica.
La solitudine dei numeri primi ha nell’uno, nell’unità, una dimensione tutta sua. Può essere isolamento misantropico, autoesilio individualistico, autoconfinamento ma può significare ritiro spirituale, (ri)pensamento solipsistico, monologo interiore. Che tale non è più nel momento in cui ci si esteriorizza per il tramite, ad esempio, della musica. Partiamo da Dvoràk, dalla sua Sinfonia n. 9 Dal Nuovo Mondo, dalla scoperta che il compositore boemo fece negli U.S.A. della musica popolare dei neri e dei nativi d’America.È un summit con la musica europea cosiddetta “colta” a far da epilogo all’album “Classica” del Painting Jazz Duo e cioè Emanuele Passerini ai sax e Galag Massimiliano Belloni al pianoforte, con il tema principale collocato alla fine a far da suggello simbolico. La formazione è abituata a promuovere incontri fra civiltà musicali ed a coniugare pagine autoriali classiche con altre jazzistiche e qui punta a rilevare e rivelare i legami fra musiche del nuovo mondo e del vecchio continente, quelle il cui sviluppo, secondo una miope visione storica, era sembrato potesse procedere autonomamente, a prescindere da quanto stava avvenendo di là dall’Oceano. Ecco allora spiegato l’inglobare nel cd di “Le Solitaire” di Erik Satie, in un approccio che sposa impressionismo postromantico e jazz ma vi trova spazio anche l’esuberanza realista del Mahler nel ” Titano ” (Sinfonia n. 1). C’è ancora un trittico di autori russi, Borodin, Shostakovich e Tchaikovsky, alcune pagine dei quali vengono di fatto messe a confronto con “Mareblu”, “Nordic Sun”, “Valentina”, “City Life” scritte da Passerini. Come dire la storia della musica e la sua attualità vanno a braccetto, tenute insieme da una medesima idea ispirativa legata all’istantaneità del momento vissuta dalla coppia di musicisti. Il due, non a caso, è da associarsi all’istintualità, ingrediente utile anche per rivisitare degli “standards classici”.
Partiamo da Dvoràk, dalla sua Sinfonia n. 9 Dal Nuovo Mondo, dalla scoperta che il compositore boemo fece negli U.S.A. della musica popolare dei neri e dei nativi d’America.È un summit con la musica europea cosiddetta “colta” a far da epilogo all’album “Classica” del Painting Jazz Duo e cioè Emanuele Passerini ai sax e Galag Massimiliano Belloni al pianoforte, con il tema principale collocato alla fine a far da suggello simbolico. La formazione è abituata a promuovere incontri fra civiltà musicali ed a coniugare pagine autoriali classiche con altre jazzistiche e qui punta a rilevare e rivelare i legami fra musiche del nuovo mondo e del vecchio continente, quelle il cui sviluppo, secondo una miope visione storica, era sembrato potesse procedere autonomamente, a prescindere da quanto stava avvenendo di là dall’Oceano. Ecco allora spiegato l’inglobare nel cd di “Le Solitaire” di Erik Satie, in un approccio che sposa impressionismo postromantico e jazz ma vi trova spazio anche l’esuberanza realista del Mahler nel ” Titano ” (Sinfonia n. 1). C’è ancora un trittico di autori russi, Borodin, Shostakovich e Tchaikovsky, alcune pagine dei quali vengono di fatto messe a confronto con “Mareblu”, “Nordic Sun”, “Valentina”, “City Life” scritte da Passerini. Come dire la storia della musica e la sua attualità vanno a braccetto, tenute insieme da una medesima idea ispirativa legata all’istantaneità del momento vissuta dalla coppia di musicisti. Il due, non a caso, è da associarsi all’istintualità, ingrediente utile anche per rivisitare degli “standards classici”. “Seacup” titolo dell’album di Stefano Tamborrino della Tūk, sta per “tazza di acqua marina”, una formula dell’acqua in cui le note non sono sciami “che si radunano e si disperdono a seconda dell’occasione” (Bauman). La “liquidità” della musica che vi viene raccolta è semmai parte di un mare interiore “informe e multiforme” (Jankélévitch) e nel contempo modulato e modulare, suscettibile di continue variazioni di armonie, timbri, colori, toni. E ritmi. Già perché il musicista toscano, prima di essere compositore, è anzitutto un batterista di valore aperto all’elettronica ed alla (sua) vocalità (ma in “Purple Whales” compare la voce di Naomi Berrill). Un percussionismo, il suo, che il sestetto con Ilaria Lanzoni al violino, Katia Moling alla viola, Dan Kinzelman al sax, Andrea Beninati al cello e Gabriele Evangelista al contrabbasso, sembrerebbe esser lasciato “sotto traccia”, per la presenza costante della sezione d’archi. Ma il beat c’è, più che evidente nella scansione metrica di brani jazz/minimali come “Jakarta” per diventare cadenza ondulata in “Almost Jesus”. È un moto perpetuo, mai ristagno, anche nella stasi melodica di “Coda”, nell’intimità estatica di “Noli Me Tangere”, nella spirale barocca degli archi in “Escher” … e se cresce in intensità in “Olifante” per la dialettica fra strumenti più “jazz” e altri più “classici”, in “Bird Vertigo” ė la spazialità ad estendersi come in mare aperto. Da rimarcare, in “Arcadia”, gli echi che vanno dai Kronos Quartet fino al serialismo e, in “Gamelan”, la linea melodica a dir poco struggente. Insomma una sorta di flânerie sonora fra volumi di gocce, racchiuse, metaforicamente, in questo strano contenitore di H2O, con estratti di oceano o di un gran lago salato, magari apparsi in sogno e al risveglio tradotti in musica.
“Seacup” titolo dell’album di Stefano Tamborrino della Tūk, sta per “tazza di acqua marina”, una formula dell’acqua in cui le note non sono sciami “che si radunano e si disperdono a seconda dell’occasione” (Bauman). La “liquidità” della musica che vi viene raccolta è semmai parte di un mare interiore “informe e multiforme” (Jankélévitch) e nel contempo modulato e modulare, suscettibile di continue variazioni di armonie, timbri, colori, toni. E ritmi. Già perché il musicista toscano, prima di essere compositore, è anzitutto un batterista di valore aperto all’elettronica ed alla (sua) vocalità (ma in “Purple Whales” compare la voce di Naomi Berrill). Un percussionismo, il suo, che il sestetto con Ilaria Lanzoni al violino, Katia Moling alla viola, Dan Kinzelman al sax, Andrea Beninati al cello e Gabriele Evangelista al contrabbasso, sembrerebbe esser lasciato “sotto traccia”, per la presenza costante della sezione d’archi. Ma il beat c’è, più che evidente nella scansione metrica di brani jazz/minimali come “Jakarta” per diventare cadenza ondulata in “Almost Jesus”. È un moto perpetuo, mai ristagno, anche nella stasi melodica di “Coda”, nell’intimità estatica di “Noli Me Tangere”, nella spirale barocca degli archi in “Escher” … e se cresce in intensità in “Olifante” per la dialettica fra strumenti più “jazz” e altri più “classici”, in “Bird Vertigo” ė la spazialità ad estendersi come in mare aperto. Da rimarcare, in “Arcadia”, gli echi che vanno dai Kronos Quartet fino al serialismo e, in “Gamelan”, la linea melodica a dir poco struggente. Insomma una sorta di flânerie sonora fra volumi di gocce, racchiuse, metaforicamente, in questo strano contenitore di H2O, con estratti di oceano o di un gran lago salato, magari apparsi in sogno e al risveglio tradotti in musica. Soul Church Music, album targato Parco della Musica, è di Ugoless, gruppo che interpreta proprie composizioni. Di base è un trio con Daniele Tittarelli al sax, Fabio Sasso alla batteria e Andrea Guastadisegni ai sintetizzatori che qui è arricchito dell’apporto del tastierista Domenico Sanna. Dunque una “band dei quattro” (che numerologicamente sta per organizzazione, stabilità) che lavora sull’intertestualità fra musica e citazioni, tant’è che lo stesso titolo riprende da Cannonball Adderley la spiegazione, ripresa da “Bach Chorale”, sulla forma di un suo brano che ricorda i gospel eseguiti in chiesa. È una fattispecie di “jazz di relazione” con modelli che possono essere in “Curvone” la struttura di “Central Park West” di Coltrane ovvero in “Bon Suarè” e “Soirèe” temi del compianto Pino Daniele. Da segnalare il tramite vocalmetallico che va ad arricchire l’apparato strumentale il quale, sarà forse superfluo precisarlo, è di prim’ordine. Così, fra un omaggio a Bud Spencer in “Bambino” e un repechage di Freud in “Nada”, l’excursus allappa e allaccia drum machine e sintetizzatori a sax e tastiere. Un modo, questo, di non lasciare il suono nudo e crudo e di ornarlo – in “Kul” sono echi da Star Wars – con l’elettronica. Quando si è campioni in campionature, se c’è gusto melodico ed inventiva e il ritmo prevale sull’ algoritmo, allora l’elemento cogitans, non l’intelligenza artificiale, dispiega appieno il proprio costrutto musicale mettendo il braccio tech al servizio della ragione creativa.
Soul Church Music, album targato Parco della Musica, è di Ugoless, gruppo che interpreta proprie composizioni. Di base è un trio con Daniele Tittarelli al sax, Fabio Sasso alla batteria e Andrea Guastadisegni ai sintetizzatori che qui è arricchito dell’apporto del tastierista Domenico Sanna. Dunque una “band dei quattro” (che numerologicamente sta per organizzazione, stabilità) che lavora sull’intertestualità fra musica e citazioni, tant’è che lo stesso titolo riprende da Cannonball Adderley la spiegazione, ripresa da “Bach Chorale”, sulla forma di un suo brano che ricorda i gospel eseguiti in chiesa. È una fattispecie di “jazz di relazione” con modelli che possono essere in “Curvone” la struttura di “Central Park West” di Coltrane ovvero in “Bon Suarè” e “Soirèe” temi del compianto Pino Daniele. Da segnalare il tramite vocalmetallico che va ad arricchire l’apparato strumentale il quale, sarà forse superfluo precisarlo, è di prim’ordine. Così, fra un omaggio a Bud Spencer in “Bambino” e un repechage di Freud in “Nada”, l’excursus allappa e allaccia drum machine e sintetizzatori a sax e tastiere. Un modo, questo, di non lasciare il suono nudo e crudo e di ornarlo – in “Kul” sono echi da Star Wars – con l’elettronica. Quando si è campioni in campionature, se c’è gusto melodico ed inventiva e il ritmo prevale sull’ algoritmo, allora l’elemento cogitans, non l’intelligenza artificiale, dispiega appieno il proprio costrutto musicale mettendo il braccio tech al servizio della ragione creativa.