da Redazione | 20/Mag/2021 | News, Primo piano
di Alessandro Fadalti-
 Franco Battiato, purtroppo scomparso l’altro ieri a 76 anni nella sua casa di Milo, in Sicilia, è uno di quegli artisti che è riuscito a legarsi a noi in maniera indissolubile attraverso il ricordo. La sua musica è in qualche modo associata alla memoria di ognuno di noi, basta scorrere gli articoli, le interviste e la sezione commenti YouTube sotto le sue canzoni per poter leggere milioni di storie di persone e del primo momento in cui hanno incontrato la sua musica. Si legge di chi lo ha scoperto in spiaggia con gli amici, chi ascoltandolo nella macchina del padre, chi sentendolo suonato alla chitarra da qualche ragazzo tra le gradinate degli atenei universitari. Nel mio caso era una lezione di Filosofia, al terzo anno di Liceo, il professore per concludere un argomento su un autore ci fece ascoltare “Centro di gravità permanente”. Non ricordo attualmente quale fosse il collegamento, ma il dubbio che mi sorse immediatamente fu più o meno: “Qual è il nesso con la filosofia?”. Ottima domanda. Il punto è che la storia di Battiato è come una cassetta a nastro, esiste un lato B che si ascolta sempre successivamente al lato A. Per alcuni questo è avvenuto frugando in scatoloni pieni di polvere che appartenevano a un parente, dai quali sbucano dei dischi abbandonati da chissà quando ma che colpiscono la nostra attenzione. Io stesso ho provato questa sensazione, ma in formato digitale. Stavo ascoltando il “Canto Sospeso” di Luigi Nono, dovevo studiarlo per un esame, quando l’algoritmo di YouTube decide di consigliarmi “L’Egitto Prima delle Sabbie” del 1978.
Franco Battiato, purtroppo scomparso l’altro ieri a 76 anni nella sua casa di Milo, in Sicilia, è uno di quegli artisti che è riuscito a legarsi a noi in maniera indissolubile attraverso il ricordo. La sua musica è in qualche modo associata alla memoria di ognuno di noi, basta scorrere gli articoli, le interviste e la sezione commenti YouTube sotto le sue canzoni per poter leggere milioni di storie di persone e del primo momento in cui hanno incontrato la sua musica. Si legge di chi lo ha scoperto in spiaggia con gli amici, chi ascoltandolo nella macchina del padre, chi sentendolo suonato alla chitarra da qualche ragazzo tra le gradinate degli atenei universitari. Nel mio caso era una lezione di Filosofia, al terzo anno di Liceo, il professore per concludere un argomento su un autore ci fece ascoltare “Centro di gravità permanente”. Non ricordo attualmente quale fosse il collegamento, ma il dubbio che mi sorse immediatamente fu più o meno: “Qual è il nesso con la filosofia?”. Ottima domanda. Il punto è che la storia di Battiato è come una cassetta a nastro, esiste un lato B che si ascolta sempre successivamente al lato A. Per alcuni questo è avvenuto frugando in scatoloni pieni di polvere che appartenevano a un parente, dai quali sbucano dei dischi abbandonati da chissà quando ma che colpiscono la nostra attenzione. Io stesso ho provato questa sensazione, ma in formato digitale. Stavo ascoltando il “Canto Sospeso” di Luigi Nono, dovevo studiarlo per un esame, quando l’algoritmo di YouTube decide di consigliarmi “L’Egitto Prima delle Sabbie” del 1978.
 La prima reazione, dopo aver visto, titolo, copertina e autore fu di curiosità. Mi aspettavo qualche brano pop-synth con dei testi evocativi ma nonsense, nella mia ignoranza. Quello del cantautore siciliano è infatti una storia dove questo Lato B, spesso è tralasciato o non conosciuto da molti, tra cui io! Cliccai Play sullo schermo e… non potevo credere alle mie orecchie! Arpeggi di una scala su un pianoforte a cui seguivano le risonanze con il pedale e si chiudevano fino a sparire nel silenzio. Ad ogni ciclo, questo gesto si faceva sempre più lontano dalla sua ripetizione. Il secondo brano segue una logica simile ma con una sequenza di accordi e un ritmo variato. Era qualcosa che assomigliava più a un’opera minimalista di Philip Glass; cosa c’entra Battiato con questo? Questa storia, apparentemente nascosta, prosegue incessantemente e si finisce per scoprire album come “Clic” del 1974, “Sulle Corde di Aries” del 1973 e, seguendo questo Filo d’Arianna, si arriva al suo primo album in studio, “Fetus”.
La prima reazione, dopo aver visto, titolo, copertina e autore fu di curiosità. Mi aspettavo qualche brano pop-synth con dei testi evocativi ma nonsense, nella mia ignoranza. Quello del cantautore siciliano è infatti una storia dove questo Lato B, spesso è tralasciato o non conosciuto da molti, tra cui io! Cliccai Play sullo schermo e… non potevo credere alle mie orecchie! Arpeggi di una scala su un pianoforte a cui seguivano le risonanze con il pedale e si chiudevano fino a sparire nel silenzio. Ad ogni ciclo, questo gesto si faceva sempre più lontano dalla sua ripetizione. Il secondo brano segue una logica simile ma con una sequenza di accordi e un ritmo variato. Era qualcosa che assomigliava più a un’opera minimalista di Philip Glass; cosa c’entra Battiato con questo? Questa storia, apparentemente nascosta, prosegue incessantemente e si finisce per scoprire album come “Clic” del 1974, “Sulle Corde di Aries” del 1973 e, seguendo questo Filo d’Arianna, si arriva al suo primo album in studio, “Fetus”.
 Nel 1971 alcuni pensieri sbocciano in Battiato, perché, da come viene raccontato, in quel suo periodo di attività sembra che si sia trasformato improvvisamente in un compositore contemporaneo sperimentale. “Fetus” è un complesso e articolato concept album che racconta di una società distopica, il tutto attraverso sonorità elettroniche di sintetizzatori e drum machine che si mescolano con echi di musica classica e passaggi in stile progressive rock. Soltanto due anni dopo uscirà “Sulle Corde di Aries”, dove l’organico standard del rock viene abbandonato in favore di quello orchestrale; infine, l’anno successivo, arriva “Clic”, che sembra un lavoro misto tra Tape Music, Classica e Jazz, per alcuni passaggi.
Nel 1971 alcuni pensieri sbocciano in Battiato, perché, da come viene raccontato, in quel suo periodo di attività sembra che si sia trasformato improvvisamente in un compositore contemporaneo sperimentale. “Fetus” è un complesso e articolato concept album che racconta di una società distopica, il tutto attraverso sonorità elettroniche di sintetizzatori e drum machine che si mescolano con echi di musica classica e passaggi in stile progressive rock. Soltanto due anni dopo uscirà “Sulle Corde di Aries”, dove l’organico standard del rock viene abbandonato in favore di quello orchestrale; infine, l’anno successivo, arriva “Clic”, che sembra un lavoro misto tra Tape Music, Classica e Jazz, per alcuni passaggi.
Nel primo pezzo, “I cancelli della memoria”, questo si percepisce nella citazione al pianoforte di “Danze Rumene n. 3” di Bartòk, prima dell’ingresso di un basso ostinato e di un solo di chitarra. Tuttavia, in quest’album quello che più sconvolge e lascia aperti molti quesiti è il penultimo pezzo: “Nel Cantiere di un’Infanzia”, che unisce l’estetica cageiana e sembra citare il “Gesang der Jünglinge” (1955) di Karlheinz Stockhausen, aspetto che si può associare anche all’ultimo brano: “Ethika fon Ethica”, con la differenza che in questo caso è molto più in stile Tape Music che Musica Concreta, come era l’opera elettroacustica di Stockhausen. Quello tra il compositore tedesco e il cantautore siciliano non è un sodalizio nato dal caso – entrambi sono fortemente accomunati da un interesse per la filosofia, la spiritualità e l’esoterismo – ma un’amicizia che Battiato ricorda in questo modo in un’intervista:
«Stockhausen, mi ha spinto, e gli sarò grato tutta la vita, a studiare la notazione. Quando ho incontrato Stockhausen la prima volta, avevo già realizzato tre/quattro dischi, ma non conoscevo la notazione tradizionale. Mi sono messo a studiare grazie a lui, che ha insistito, dicendomi: “vedrai che quando avrai sessanta anni non potrai più fare musica pop”. Oggi, continuo a far musica pop, ma fortunatamente ho imparato un mestiere, che non avevo nelle mani.»
Di quel periodo, Battiato inoltre ricorda l’incontro con Cage a Milano, negli anni ‘70, il che fa pensare come di fondo, nonostante sia nato come cantautore, abbia sempre avuto un certo interesse nelle forme cosiddette colte di espressione musicale. Ciò che diventa interessante, e mi spinge a parlare di memoria in musica attraverso l’esempio di Battiato, è un fatto singolare: nel giro di un anno tutto questo motore sperimentale sembra fermarsi di colpo.
Il 1979 è l’anno in cui vinse il Premio Stockhausen di Musica Contemporanea per il brano “L’Egitto Prima delle Sabbie”. Al contempo, esce l’album che è da molti considerato l’inizio del Battiato che tutti conoscono: “L’Era del Cinghiale”, frutto del sodalizio con l’amico e violinista Giusto Pio. Il salto non è netto, ma fluido, infatti, seppure venga considerato un album pop, i riferimenti esoterici, al sufismo tanto amato da lui e alla figura del filosofo e intellettuale convertito all’Islam René-Jean-Marie-Joseph Guénon, sono onnipresenti.
Questo ritorno alla musica popular, dopo anni di sperimentazione, prende un significato ancora più apparentemente bizzarro quando si legge una sua dichiarazione del 2014 alla conferenza stampa nel Cilento per la rassegna di concerti e spettacoli Meeting del Mare:
«Per musica contemporanea si intende quello spicchio di musica che ha completamente svilito la grandiosità del sentimento. Sono cose che può fare anche un gatto. Se tu lo metti su un pianoforte, non dici che è un gatto e lo registri, quelli a cui piace questa musica dicono pure che è bella!»
La persona che pose la domanda a Battiato, riguardo alla musica contemporanea, avrebbe potuto aggiungere provocatoriamente: “ma non è letteralmente quello che lei faceva negli anni ’70?”. Questa frase di Battiato sembra quella di un ripensamento nei confronti della propria carriera di musicista, fattore che ci viene suggerito anche dal suo commento al rapporto con Stockhausen. La risposta, invece, va cercata in uno dei concetti su cui Battiato si è espresso più volte nelle interviste. Il cantautore vuole parlare dell’umano e all’umano, volendo raggiungere più persone possibili. Il problema è che il linguaggio contemporaneo di quegli anni era fatto di correnti ostiche a un largo pubblico, il Serialismo, il Minimalismo, le sperimentazioni in ambito elettronico, ed emergeva sempre di più la giovane generazione di spettralisti francesi. Il panorama è quello di una musica che spesso viene accusata di autoreferenzialità, di essere priva di un’estetica in favore di intellettualismi scevri, come dice lui, di sentimento ed in questo Battiato non si riconosce più e probabilmente non vuole essere associato a essa.
A fronte di questo discorso ripensiamo alla chiave della memoria in musica. La memoria, in effetti, si lega spesso a un gesto musicale e l’assenza di estetica della musica contemporanea diventa il motivo della critica, ed è forse per questo che è così difficile comunicare e creare un legame tra anima e ricordi con l’umanità attraverso essa. Quelle frasi estremamente melodiche ed evocative dei suoi brani negli anni ‘80 sono il mezzo più diretto per arrivare alla memoria e al cuore delle persone, ma questo il cantautore non l’ha fatto attraverso una musica commerciale e superficiale, ha sempre avuto l’animo dello sperimentatore anche dopo, era semplicemente subentrata la sua voglia di comunicare direttamente al mondo, in un perenne dialogo con esso.
 Tutta questa spinta sperimentale si è sopita del tutto oggi? Battiato davvero non si è mai stancato di fare pop? In effetti, qualche parentesi c’è stata. Nel 2000, ad esempio, con “Campi Magnetici” e nel 2004 in “Dieci Stratagemmi”; ma c’è un esempio anche in tempi più recenti. Nello stesso anno della conferenza stampa di Meeting al Mare esce “Joe Patti’s Experimental Group” (2014) con Franco Battiato alla voce e sintetizzatore, Pino Pischetola, live electronics e Carlo Guaitoli al pianoforte. Diventa interessante pensare come quella critica alla musica contemporanea si sovrapponga al ritorno per il suo grande amore per l’elettronica sperimentale, dimostrando quanto, alla fine, l’anima del catanese sia quanto mai un trittico di fiori dai petali multicolore.
Tutta questa spinta sperimentale si è sopita del tutto oggi? Battiato davvero non si è mai stancato di fare pop? In effetti, qualche parentesi c’è stata. Nel 2000, ad esempio, con “Campi Magnetici” e nel 2004 in “Dieci Stratagemmi”; ma c’è un esempio anche in tempi più recenti. Nello stesso anno della conferenza stampa di Meeting al Mare esce “Joe Patti’s Experimental Group” (2014) con Franco Battiato alla voce e sintetizzatore, Pino Pischetola, live electronics e Carlo Guaitoli al pianoforte. Diventa interessante pensare come quella critica alla musica contemporanea si sovrapponga al ritorno per il suo grande amore per l’elettronica sperimentale, dimostrando quanto, alla fine, l’anima del catanese sia quanto mai un trittico di fiori dai petali multicolore.
Battiato nei suoi testi si insinua in un mondo profondo, che riguarda l’animo umano attraverso concetti di intellettuali e filosofi da cui attinge l’ispirazione e rimanda al suo pubblico in chiavi di letture ricche di atmosfere musicali oltre ogni genere prestabilito, ma pur sempre in fin dei conti pop. Se parliamo strettamente a livello musicale la produzione di Battiato, dall’inizio alla fine, ci fa domandare quale sia il vero confine tra una melodia che chiunque può canticchiare e un gesto musicalmente concettuale. Personalmente rimango sempre affascinato quando una persona ricerca e trova in musica la sintesi tra due linguaggi che accademicamente – e a parer mio aggiungo in maniera passatista – si tende a separare nettamente: popular e colta hanno sempre respirato in osmosi, solo che purtroppo questo sodalizio non avviene mai alla luce del sole. In effetti, si nasconde in quei maledetti scatoloni impolverati in cui qualcuno avrà trovato proprio un vinile come “L’Egitto Prima delle Sabbie”. Personalmente in questo mi sono trovato molto vicino a Battiato, e nonostante non sia un suo ascoltatore frequente, è riuscito a entrare nella mia vita e a legarsi qualche modo alla mia memoria, tra cene con amici, lezioni di filosofia in classe e qualche strimpellata sotto i portici nelle afose giornate estive.
Questo è forse il lascito più forte che nella sua vita ci ha donato Franco Battiato.
p.s. per favore, non chiamatelo Maestro, non sopportava quell’appellativo.
Alessandro Fadalti
da Gerlando Gatto | 28/Dic/2020 | I nostri CD, Primo piano, Recensioni
Cari Amici,
archiviato questo Natale piuttosto atipico, per usare un eufemismo, ci accingiamo ad affrontare il nuovo anno con molte speranze e pochissime certezze. Ma, dal momento che dovremo trascorrere ancora molto tempo tra le mura di casa, vi propongo una serie di album che vale la pena ascoltare.
Buona Musica e Buon Anno.

AB Quartet – “I bemolli sono blu” – TRJ records
 L’AB Quartet è un gruppo costituito da Antonio Bonazzo (pianoforte), Francesco Chiapperini (clarinetto e clarinetto basso), Cristiano Da Ros (contrabbasso), Fabrizio Carriero (batteria e percussioni). L’album prende le mosse da un obiettivo esplicitamente dichiarato da Bonazzo: elaborare, in occasione del centenario dalla morte di Claude Debussy nel 2018, un progetto basato su arrangiamenti di musica di questo compositore francese.
L’AB Quartet è un gruppo costituito da Antonio Bonazzo (pianoforte), Francesco Chiapperini (clarinetto e clarinetto basso), Cristiano Da Ros (contrabbasso), Fabrizio Carriero (batteria e percussioni). L’album prende le mosse da un obiettivo esplicitamente dichiarato da Bonazzo: elaborare, in occasione del centenario dalla morte di Claude Debussy nel 2018, un progetto basato su arrangiamenti di musica di questo compositore francese.
E il titolo viene proprio da una frase di Debussy che in una lettera parla della sua visione della musica legata principalmente ad aspetti extramusicali come il colore. Di qui un repertorio di sette brani originali. Come al solito quando un album dichiara un intento si pone la classica domanda: obiettivo raggiunto? Onestamente mi risulta difficile fornire una risposta. Comunque è innegabile che i temi scelti si facciano ascoltare con attenzione così come è innegabile che in alcuni passaggi risulti evidente l’influenza di Debussy. Pertinente è anche il linguaggio adoperato dal gruppo il che non stupisce ove si tenga conto che il gruppo affonda le proprie radici nella tradizione classica. Proprio per questo i brani sono prevalentemente scritti anche se non mancano ampi spazi per le improvvisazioni singole e collettive. Un esempio di quanto sin qui detto lo si trova già nel primo brano, “Moon”; il riferimento è al “Clair de Lune” vagamente richiamato nella linea melodica per lasciare subito il posto ad una reinterpretazione cesellata dal pianoforte di Bonazzo, mentre i clarinetti di Chiapperini creano un impasto strumentale dalle timbriche originali, con batteria e contrabbasso a intessere un impianto ritmico molto più sostenuto rispetto all’originale.
Tiziana Bacchetta – “Driving Home for Christmas” – G.T.
 Un’indispensabile premessa: io non amo particolarmente gli “album di Natale” per cui mi sono accinto ad ascoltare questo album con una buona dose di scetticismo. Ma poi, nota dopo nota, minuto dopo minuto, ho cambiato radicalmente idea tanto da poter affermare che questo è un CD di sicuro livello. E ciò per una serie di motivi che cercherò di elencare non in ordine di importanza. La scelta del repertorio: la vocalist romana, ad eccezione dei ben noti “Have Yourself a Merry Little Christmas” di Martin -Blane e “White Christmas” di Irving Berlin, ha preferito presentare brani, tutti musicalmente validi e raffinati ma assai meno battuti. Ovviamente ciò non sarebbe stato sufficiente; ecco quindi arrangiamenti sapidi, ben studiati e curati in ogni minimo aspetto con un gruppo affiatato in cui spicca l’individualità di Giacomo Tantillo, trombettista e flicornista siciliano di Palermo che passo dopo passo si avvia a diventare una certezza del panorama jazzistico nazionale. A questo punto sarebbe ingiusto non citare gli altri componenti il gruppo, vale a dire Raffaele Cervasio chitarra, Arturo Valente piano e Rhodes, Carlo Bordini batteria e Guerino Rondolone basso. Ma, com’è fin troppo ovvio, il merito principale dell’ottima riuscita dell’album è della leader, Tiziana Bacchetta. Giunta al suo terzo album, l’artista dà prova di grande maturità sfoggiando notevoli capacità interpretative supportate da un voce ben educata che riesce a transitare senza sforzo alcuno attraverso atmosfere assai differenziate. Ecco quindi il bruciante blues “Christmas Tears” portato al successo da Freddy King uno dei più talentuosi chitarristi del blues elettrico contemporaneo e interpretato dalla Bacchetta con trasporto e una voce ruvida il giusto, ecco la “Title Track” un brano bellissimo di Chris Rea, fino alla conclusione con l’evergreen “White Christmas” di Irving Berlin. Insomma una bella musica che ci accompagna verso le prossime festività, una sorta di raggio di luce in un panorama piuttosto plumbeo.
Un’indispensabile premessa: io non amo particolarmente gli “album di Natale” per cui mi sono accinto ad ascoltare questo album con una buona dose di scetticismo. Ma poi, nota dopo nota, minuto dopo minuto, ho cambiato radicalmente idea tanto da poter affermare che questo è un CD di sicuro livello. E ciò per una serie di motivi che cercherò di elencare non in ordine di importanza. La scelta del repertorio: la vocalist romana, ad eccezione dei ben noti “Have Yourself a Merry Little Christmas” di Martin -Blane e “White Christmas” di Irving Berlin, ha preferito presentare brani, tutti musicalmente validi e raffinati ma assai meno battuti. Ovviamente ciò non sarebbe stato sufficiente; ecco quindi arrangiamenti sapidi, ben studiati e curati in ogni minimo aspetto con un gruppo affiatato in cui spicca l’individualità di Giacomo Tantillo, trombettista e flicornista siciliano di Palermo che passo dopo passo si avvia a diventare una certezza del panorama jazzistico nazionale. A questo punto sarebbe ingiusto non citare gli altri componenti il gruppo, vale a dire Raffaele Cervasio chitarra, Arturo Valente piano e Rhodes, Carlo Bordini batteria e Guerino Rondolone basso. Ma, com’è fin troppo ovvio, il merito principale dell’ottima riuscita dell’album è della leader, Tiziana Bacchetta. Giunta al suo terzo album, l’artista dà prova di grande maturità sfoggiando notevoli capacità interpretative supportate da un voce ben educata che riesce a transitare senza sforzo alcuno attraverso atmosfere assai differenziate. Ecco quindi il bruciante blues “Christmas Tears” portato al successo da Freddy King uno dei più talentuosi chitarristi del blues elettrico contemporaneo e interpretato dalla Bacchetta con trasporto e una voce ruvida il giusto, ecco la “Title Track” un brano bellissimo di Chris Rea, fino alla conclusione con l’evergreen “White Christmas” di Irving Berlin. Insomma una bella musica che ci accompagna verso le prossime festività, una sorta di raggio di luce in un panorama piuttosto plumbeo.
Michel Benita – “Looking at Sounds” – ECM
 L’etichetta Ecm dedica meritoriamente due album alla scena francese, questo di Michel Benita e un altro di Matthieu Bordenave di cui ci occupiamo qui di seguito. In “Looking at Sounds” il contrabbassista franco-algerino Michel Benita si presenta in quartetto con il connazionale Philippe Garcia alla batteria, lo svizzero Matthieu Michel al flicorno e il belga Jozef Dumoulin, specialista del piano elettrico. L’album è giocato su due elementi: una raffinata ricerca timbrica e melodica, e la prevalenza del sound collettivo rispetto all’assolo. Il repertorio si compone di undici pezzi scritti in massima parte dallo stesso Benita da solo o in collaborazione con altri, cui si aggiungono due brani famosi, “Inutil Paisegem” di Antonio Carlos Jobim e Louis Olivera, e “Never Never Land” di Styne, Comden, Green. L’intro affidata al leader è una sorta di manifesto dell’intera poetica dell’album: la linea melodica, suggestiva e cantabile, disegnata dal flicorno di Matthieu Michel, viene costantemente supportata dal basso e dalla batteria di Garcia, in questo caso con mirabile gioco di spazzole, mentre Demoulin si limita a sottolineare alcuni passaggi contribuendo, però, in maniera determinante a creare quella particolare timbrica che costituisce una caratteristica dell’album. E il clima intimista, di rara suggestione si avverte per tutta la durata dell’album anche se non mancano episodi particolari come “Cloud To Cloud” declinato sul filo di una improvvisazione collettiva e il conclusivo “Never Never Land” in cui il leader, in splendida solitudine, si produce in uno dei più centrati assolo dell’album. Gustosa, infine, l’interpretazione di “Inútil Paisagem”.
L’etichetta Ecm dedica meritoriamente due album alla scena francese, questo di Michel Benita e un altro di Matthieu Bordenave di cui ci occupiamo qui di seguito. In “Looking at Sounds” il contrabbassista franco-algerino Michel Benita si presenta in quartetto con il connazionale Philippe Garcia alla batteria, lo svizzero Matthieu Michel al flicorno e il belga Jozef Dumoulin, specialista del piano elettrico. L’album è giocato su due elementi: una raffinata ricerca timbrica e melodica, e la prevalenza del sound collettivo rispetto all’assolo. Il repertorio si compone di undici pezzi scritti in massima parte dallo stesso Benita da solo o in collaborazione con altri, cui si aggiungono due brani famosi, “Inutil Paisegem” di Antonio Carlos Jobim e Louis Olivera, e “Never Never Land” di Styne, Comden, Green. L’intro affidata al leader è una sorta di manifesto dell’intera poetica dell’album: la linea melodica, suggestiva e cantabile, disegnata dal flicorno di Matthieu Michel, viene costantemente supportata dal basso e dalla batteria di Garcia, in questo caso con mirabile gioco di spazzole, mentre Demoulin si limita a sottolineare alcuni passaggi contribuendo, però, in maniera determinante a creare quella particolare timbrica che costituisce una caratteristica dell’album. E il clima intimista, di rara suggestione si avverte per tutta la durata dell’album anche se non mancano episodi particolari come “Cloud To Cloud” declinato sul filo di una improvvisazione collettiva e il conclusivo “Never Never Land” in cui il leader, in splendida solitudine, si produce in uno dei più centrati assolo dell’album. Gustosa, infine, l’interpretazione di “Inútil Paisagem”.
Roberto Bindoni Unquiet Quartet – “Mediterranean Cowboy” – Alfa Music
 E’ uscito di recente l’album d’esordio dell’Unquiet Quartet di Roberto Bindoni; il chitarrista (eccellente anche al pianoforte, strumento che però in questa occasione non usa) è accompagnato da Matteo Cuzzolin al tenore, Marco Stagni al contrabbasso e Filip Milenkovic alla batteria. Si tratta di una prova particolarmente impegnativa per Bidoni il quale si presenta anche come autore dell’intero repertorio, nove brani che riescono a ben catalizzare l’attenzione dell’ascoltatore. La linea stilistica oscilla tra il jazz modale e quelle atmosfere nordiche che abbiamo imparato ad apprezzare nel corso degli ultimi decenni grazie ad artisti quali Jan Garbarek o Jan Balke tanto per fare qualche nome. Le atmosfere sono quindi in linea di massima pacate, con una riconoscibile linea melodica e un ritmo sostanzialmente lento, ragionato, il tutto impreziosito da arrangiamenti ben scritti sia che riguardino le parti completamente scritte sia che facciano un passo indietro per lasciare spazio all’improvvisazione, terreno su cui si muove particolarmente bene il sax tenore di Cuzzolin (lo si ascolti in “Unquiet Place” e nel già citato “Kamikaze”). Particolarmente suggestivo “Encanto” con il leader in bella evidenza. Certo, come si accennava si tratta di un disco d’esordio per cui i margini di miglioramento ci sono, ma già a questo punto è un bel sentire.
E’ uscito di recente l’album d’esordio dell’Unquiet Quartet di Roberto Bindoni; il chitarrista (eccellente anche al pianoforte, strumento che però in questa occasione non usa) è accompagnato da Matteo Cuzzolin al tenore, Marco Stagni al contrabbasso e Filip Milenkovic alla batteria. Si tratta di una prova particolarmente impegnativa per Bidoni il quale si presenta anche come autore dell’intero repertorio, nove brani che riescono a ben catalizzare l’attenzione dell’ascoltatore. La linea stilistica oscilla tra il jazz modale e quelle atmosfere nordiche che abbiamo imparato ad apprezzare nel corso degli ultimi decenni grazie ad artisti quali Jan Garbarek o Jan Balke tanto per fare qualche nome. Le atmosfere sono quindi in linea di massima pacate, con una riconoscibile linea melodica e un ritmo sostanzialmente lento, ragionato, il tutto impreziosito da arrangiamenti ben scritti sia che riguardino le parti completamente scritte sia che facciano un passo indietro per lasciare spazio all’improvvisazione, terreno su cui si muove particolarmente bene il sax tenore di Cuzzolin (lo si ascolti in “Unquiet Place” e nel già citato “Kamikaze”). Particolarmente suggestivo “Encanto” con il leader in bella evidenza. Certo, come si accennava si tratta di un disco d’esordio per cui i margini di miglioramento ci sono, ma già a questo punto è un bel sentire.
Matthieu Bordenave – “La traversée” – ECM

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 80
Ecco il primo album da leader del sassofonista francese Matthieu Bordenave in trio con il tedesco Florian Weber al pianoforte e lo svizzero Patrice Moret al contrabbasso. In programma nove brani tutti composti dallo stesso sassofonista. Come espressamente dichiarato dallo stesso leader, l’idea musicale che ha ispirato l’album è quella del trio formato da Jimmy Giuffre, Paul Bley e Steve Swallow circa sessanta anni addietro ma ancora oggi attualissima. Di qui una musica allo stesso tempo moderna nel sound e nella ricerca di un linguaggio vicino alla musica contemporanea ma allo stesso tempo fortemente ancorata al passato. E la cosa si spiega assai bene ove si tenga conto che Bordenave può vantare una preparazione anche classica. L’album oscilla, quindi, tra questi due poli in una sorta di camerismo particolarmente attento allo spazio e alle sfumature che evidenzia al meglio le potenzialità dei tre artisti. Così se il sax del leader rimane costantemente in primo piano, con un sound non particolarmente robusto ma personale, pianoforte e contrabbasso non si limitano ad una funzione di supporto fornendo un contributo importante anche nella costruzione della linea portante; si ascolti al riguardo il sontuoso assolo di Patrice Moret in “Ventoux” o quello di Weber nel successivo “Incendie blanc”. Insomma nonostante la mancanza di una qualsivoglia percussione, la ‘traversata’ del trio solca mari non sempre placidi, alla costante scoperta di nuovi orizzonti.
Yilian Canizares – “Erzulie” – Planeta Y
 Questo è uno dei pochi album che vi consiglierei di ascoltare più e più volte tale e tanta è la ricchezza di contenuti in esso racchiusa. La violinista, cantante e compositrice cubana Yilian Canizares si conferma una delle artiste più originali apparsa sulla scena musicale degli ultimi anni grazie ad una concezione musicale che le consente di accorpare una formazione di base classica e i ritmi, le melodie, le danze della sua madre patria. E tutto ciò si appalesa con grande semplicità nell’album in oggetto, registrato a New Orleans ma che in realtà prende vita da un viaggio nel 2017 ad Haiti. Quì Yilian ha avuto modo di confrontarsi con i Boukman Eksperyans, band storica che prende il nome da Dutty Boukman, un sacerdote vodou che condusse una cerimonia religiosa nel 1791, considerata l’inizio della rivoluzione haitiana. Non a caso l‘album è dedicato a “Erzulie”, divinità del pantheon vudu che personifica l’essenza della femminilità e la sensualità. In effetto l’intento della Canizares è più ampio: “raccontare la storia dell’Africa attraverso i suoi figli creoli: Haiti, Cuba e New Orleans […] musica che deriva quindi da un legame che non è morto malgrado tutto ciò che è successo storicamente”. Accanto all’artista cubana troviamo un quartetto di musicisti di nazionalità e culture musicali diverse, The Maroons, altro riferimento alla storia libertaria caraibica, che allineano Paul Beaubrun (chitarrista e vocalist haitiano), Childo Tomas (basso, cori e kalimba dal Mozambico), Charlie “BKVK” Burchell (batteria e tastiere, statunitense di New Orleans) e Inor Sotolongo (percussionsta cubano). A questi si aggiungono svariati ospiti a tromba, contrabbasso, organo, tastiere, percussioni, violoncello e flauto, a costituire una formazione straordinaria. L’album si apre con la romanticamente coinvolgente “Habanera” e si chiude con “Yeyé” cantata in dialetto yoruba (o lucumi), così come “Yemayá” mentre nella title track e in “Noyé” l’artista utilizza il creolo haitiano. Un’ultima notazione tutt’altro che secondaria: nel brano “Libertad” sono inserite le voci campionate di tre donne di epoche diverse particolarmente significative in merito alle tematiche trattate: Simone de Beauvoir, Malala e Nina Simone.
Questo è uno dei pochi album che vi consiglierei di ascoltare più e più volte tale e tanta è la ricchezza di contenuti in esso racchiusa. La violinista, cantante e compositrice cubana Yilian Canizares si conferma una delle artiste più originali apparsa sulla scena musicale degli ultimi anni grazie ad una concezione musicale che le consente di accorpare una formazione di base classica e i ritmi, le melodie, le danze della sua madre patria. E tutto ciò si appalesa con grande semplicità nell’album in oggetto, registrato a New Orleans ma che in realtà prende vita da un viaggio nel 2017 ad Haiti. Quì Yilian ha avuto modo di confrontarsi con i Boukman Eksperyans, band storica che prende il nome da Dutty Boukman, un sacerdote vodou che condusse una cerimonia religiosa nel 1791, considerata l’inizio della rivoluzione haitiana. Non a caso l‘album è dedicato a “Erzulie”, divinità del pantheon vudu che personifica l’essenza della femminilità e la sensualità. In effetto l’intento della Canizares è più ampio: “raccontare la storia dell’Africa attraverso i suoi figli creoli: Haiti, Cuba e New Orleans […] musica che deriva quindi da un legame che non è morto malgrado tutto ciò che è successo storicamente”. Accanto all’artista cubana troviamo un quartetto di musicisti di nazionalità e culture musicali diverse, The Maroons, altro riferimento alla storia libertaria caraibica, che allineano Paul Beaubrun (chitarrista e vocalist haitiano), Childo Tomas (basso, cori e kalimba dal Mozambico), Charlie “BKVK” Burchell (batteria e tastiere, statunitense di New Orleans) e Inor Sotolongo (percussionsta cubano). A questi si aggiungono svariati ospiti a tromba, contrabbasso, organo, tastiere, percussioni, violoncello e flauto, a costituire una formazione straordinaria. L’album si apre con la romanticamente coinvolgente “Habanera” e si chiude con “Yeyé” cantata in dialetto yoruba (o lucumi), così come “Yemayá” mentre nella title track e in “Noyé” l’artista utilizza il creolo haitiano. Un’ultima notazione tutt’altro che secondaria: nel brano “Libertad” sono inserite le voci campionate di tre donne di epoche diverse particolarmente significative in merito alle tematiche trattate: Simone de Beauvoir, Malala e Nina Simone.
Donatello D’Attoma – “Oneness” – Dodicilune
 Donatello D’Attoma è uno dei pianisti più interessanti che si pone nella linea stilistica tracciata da alcuni grandi della tastiera, Thelonius Monk in primis e, andando più indietro nel tempo, Bill Evans. In questo album il pianista si presenta in trio con il siciliano Alberto Fidone al contrabbasso e il romano Enrico Morello alla batteria. In programma otto brani di cui ben sette dovuti alla penna del leader che quindi si dimostra anche prolifico e valente autore. La chiusura è invece affidata ad una composizione, guarda caso, di Thelonious Monk, “Coming On Thwe Hudson”. Il trio è affiatato, ben guidato e ricco di interventi solistici che impreziosiscono ogni esecuzione. Intendiamoci: nessuna dimostrazione muscolare o interventi tesi a stupire l’ascoltatore, ma grande attenzione all’espressività e quindi alla volontà di trasmettere la tensione emotiva che i tre avvertono, in un costante equilibrio tra pagina scritta e istintiva improvvisazione. In particolare D’Attoma evidenzia una solida tecnica di base cementata sia dagli studi classici sia dalla profonda conoscenza della letteratura jazzistica; di qui un rigoroso controllo di ogni elemento dell’esecuzione con un pianismo solido, raffinato, essenziale ben supportato dai compagni d’avventura che, seguendo la lezione di Evans, ricoprono un ruolo tutt’altro che marginale. E ciò appare evidente sin dal primo brano, “Fluorescent Light”, in cui i tre si muovono empaticamente, caratteristica che viene conservata per tutta la durata dell’album. I brani sono tutti godibili e ben articolati come in una sorta di percorso che mai perde d’intensità.
Donatello D’Attoma è uno dei pianisti più interessanti che si pone nella linea stilistica tracciata da alcuni grandi della tastiera, Thelonius Monk in primis e, andando più indietro nel tempo, Bill Evans. In questo album il pianista si presenta in trio con il siciliano Alberto Fidone al contrabbasso e il romano Enrico Morello alla batteria. In programma otto brani di cui ben sette dovuti alla penna del leader che quindi si dimostra anche prolifico e valente autore. La chiusura è invece affidata ad una composizione, guarda caso, di Thelonious Monk, “Coming On Thwe Hudson”. Il trio è affiatato, ben guidato e ricco di interventi solistici che impreziosiscono ogni esecuzione. Intendiamoci: nessuna dimostrazione muscolare o interventi tesi a stupire l’ascoltatore, ma grande attenzione all’espressività e quindi alla volontà di trasmettere la tensione emotiva che i tre avvertono, in un costante equilibrio tra pagina scritta e istintiva improvvisazione. In particolare D’Attoma evidenzia una solida tecnica di base cementata sia dagli studi classici sia dalla profonda conoscenza della letteratura jazzistica; di qui un rigoroso controllo di ogni elemento dell’esecuzione con un pianismo solido, raffinato, essenziale ben supportato dai compagni d’avventura che, seguendo la lezione di Evans, ricoprono un ruolo tutt’altro che marginale. E ciò appare evidente sin dal primo brano, “Fluorescent Light”, in cui i tre si muovono empaticamente, caratteristica che viene conservata per tutta la durata dell’album. I brani sono tutti godibili e ben articolati come in una sorta di percorso che mai perde d’intensità.
Elina Duni, Rob Luft – “Lost Ships” – ECM
 Registrato nello studio La Buissonne nel sud della Francia nel febbraio del 2020, questo album, in quattro lingue – albanese, francese, inglese, salentino- vede la cantante svizzero albanese Elina Duni ed il chitarrista britannico Rob Luft (la cui collaborazione risale al 2017) coadiuvati da Matthieu Michel al flugelhorn (lo si ascolti particolarmente in “Brighton”) e Fred Thomas piano e batteria. A scanso di equivoci, in questo caso il jazz appare marginale ma l’album è notevole e vale quindi la pena segnalarlo. Il programma, pur essendo assai variegato, presenta come temi centrali quelli dell’emigrazione e della difesa della natura declinati attraverso brani tradizionali, composizioni originali e due canzoni rese famose rispettivamente da Frank Sinatra e Charles Aznavour. In un cartellone siffatto appare evidente come molteplici debbano essere stati gli input ed è la stessa Duni a confermarlo: «Ci sono canzoni – afferma – che hanno influenze del passato, con il suono dell’Albania ed il folclore mediterraneo sempre presenti, ma volevamo esplorare anche altre radici musicali: ballate jazz senza tempo, canzoni francesi, canzoni popolari americane…. ». Comunque l’album, come si accennava, è di assoluto livello grazie soprattutto alla maestria di vocalist e chitarrista, l’una sempre più convincente nell’interpretazione di tematiche assai delicate, l’altro in grado di sottolineare ogni passaggio con rara discrezione e altrettanta pertinenza. Così la musica acquista attimo dopo attimo sempre più consistenza, sorretta da un’intesa non comune come evidenziato nel brano in inglese, “The Wayfaring Stranger”. Il controllo delle dinamiche è assoluto così come la capacità di ricondurre ad un unicum le quattro voci melodiche. Infine una perla di raffinatezza la chiusura con “Hier Encore” di Aznavour presentata in duo, chitarra e voce.
Registrato nello studio La Buissonne nel sud della Francia nel febbraio del 2020, questo album, in quattro lingue – albanese, francese, inglese, salentino- vede la cantante svizzero albanese Elina Duni ed il chitarrista britannico Rob Luft (la cui collaborazione risale al 2017) coadiuvati da Matthieu Michel al flugelhorn (lo si ascolti particolarmente in “Brighton”) e Fred Thomas piano e batteria. A scanso di equivoci, in questo caso il jazz appare marginale ma l’album è notevole e vale quindi la pena segnalarlo. Il programma, pur essendo assai variegato, presenta come temi centrali quelli dell’emigrazione e della difesa della natura declinati attraverso brani tradizionali, composizioni originali e due canzoni rese famose rispettivamente da Frank Sinatra e Charles Aznavour. In un cartellone siffatto appare evidente come molteplici debbano essere stati gli input ed è la stessa Duni a confermarlo: «Ci sono canzoni – afferma – che hanno influenze del passato, con il suono dell’Albania ed il folclore mediterraneo sempre presenti, ma volevamo esplorare anche altre radici musicali: ballate jazz senza tempo, canzoni francesi, canzoni popolari americane…. ». Comunque l’album, come si accennava, è di assoluto livello grazie soprattutto alla maestria di vocalist e chitarrista, l’una sempre più convincente nell’interpretazione di tematiche assai delicate, l’altro in grado di sottolineare ogni passaggio con rara discrezione e altrettanta pertinenza. Così la musica acquista attimo dopo attimo sempre più consistenza, sorretta da un’intesa non comune come evidenziato nel brano in inglese, “The Wayfaring Stranger”. Il controllo delle dinamiche è assoluto così come la capacità di ricondurre ad un unicum le quattro voci melodiche. Infine una perla di raffinatezza la chiusura con “Hier Encore” di Aznavour presentata in duo, chitarra e voce.
Erodoto Project – “Mythos Metamorphosis” – Cultural bridge
 Bob Salmieri sax tenore e soprano, ney, turkish klarinet, Alessandro de Angelis grand piano, Rhodes piano, Maurizio Perrone contrabbasso, Giampaolo Scatozza batteria e Carlo Colombo percussioni sono i responsabili dell’“Erodoto Project” giunto alla sua terza tappa attraverso i miti e le leggende del Mediterraneo. Dopo “Stories: Lands, Men And Gods” (2016) e “Molòn Labè” (2017) arriva “Mythos Metamorphosis” in cui il gruppo è affiancato dal Mirò String Trio, al secolo Fabiola Gaudio violino, Lorenzo Rundo viola e Marco Simonacci violoncello. In repertorio undici originali composti da Salmieri e De Angelis declinati attraverso l’avventura di Ulisse che affronta e resiste alle lusinghe delle sirene. Ecco quindi richiamate le leggende di Aci e Galatea, di Ifi e Iante, della Sibilla Cumana…via via fino al brano di chiusura dedicato a “Leucosya”, una delle tre sirene che, secondo la mitologia greca, viveva sugli scogli della baia di Salerno assieme a Partenope e Ligea. Essendo questo il quadro di riferimento, è chiaro che la musica prodotta dovesse in qualche modo riferirsi alle varie culture che dal Mediterraneo traggono linfa vitale. E così è stato. Ancora una volta Salmieri e compagni tengono fede alle premesse e ci regalano una musica di grande intensità caratterizzata da suadenti linee melodiche, armonizzazioni semplici ma non per questo banali e una tavolozza timbrica impreziosita, nell’occasione, dal trio d’archi i cui arrangiamenti sono stati curati da Alessandro de Angelis. Insomma un jazz senza etichette, non ascrivibile ad uno stile piuttosto che ad un altro, ma una musica libera che prende per mano l’ascoltatore e lo trasporta in un altrove impossibile da etichettare.
Bob Salmieri sax tenore e soprano, ney, turkish klarinet, Alessandro de Angelis grand piano, Rhodes piano, Maurizio Perrone contrabbasso, Giampaolo Scatozza batteria e Carlo Colombo percussioni sono i responsabili dell’“Erodoto Project” giunto alla sua terza tappa attraverso i miti e le leggende del Mediterraneo. Dopo “Stories: Lands, Men And Gods” (2016) e “Molòn Labè” (2017) arriva “Mythos Metamorphosis” in cui il gruppo è affiancato dal Mirò String Trio, al secolo Fabiola Gaudio violino, Lorenzo Rundo viola e Marco Simonacci violoncello. In repertorio undici originali composti da Salmieri e De Angelis declinati attraverso l’avventura di Ulisse che affronta e resiste alle lusinghe delle sirene. Ecco quindi richiamate le leggende di Aci e Galatea, di Ifi e Iante, della Sibilla Cumana…via via fino al brano di chiusura dedicato a “Leucosya”, una delle tre sirene che, secondo la mitologia greca, viveva sugli scogli della baia di Salerno assieme a Partenope e Ligea. Essendo questo il quadro di riferimento, è chiaro che la musica prodotta dovesse in qualche modo riferirsi alle varie culture che dal Mediterraneo traggono linfa vitale. E così è stato. Ancora una volta Salmieri e compagni tengono fede alle premesse e ci regalano una musica di grande intensità caratterizzata da suadenti linee melodiche, armonizzazioni semplici ma non per questo banali e una tavolozza timbrica impreziosita, nell’occasione, dal trio d’archi i cui arrangiamenti sono stati curati da Alessandro de Angelis. Insomma un jazz senza etichette, non ascrivibile ad uno stile piuttosto che ad un altro, ma una musica libera che prende per mano l’ascoltatore e lo trasporta in un altrove impossibile da etichettare.
Marco Fumo – “Reflections” – Odradek Records
 Merco Fumo è personaggio ben noto ed apprezzato nell’ambiente jazzistico. La sua padronanza strumentale e la sua profonda conoscenza del lessico jazzistico ne fanno personaggio di assoluto rilievo. E questo album ne è l’ennesima conferma in quanto riesce ad evidenziare, come meglio non si potrebbe, i numerosi legami – ora palesi ora più nascosti – tra l’universo euro-colto e la musica afroamericana. In un flusso rapido e spesso trascinante scorrono quindi alcuni degli autori che hanno fatto la storia della musica tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento sulle due sponde dell’Oceano Atlantico. Da Scarlatti a Joplin, da Stravinsky a Nazareth, da Debussy a Ellington tanto per fare qualche nome. Ovvero dal ragtime, dal choro, dal tango, dal blues, dallo stride piano…al jazz e alla musica classica europea in un confronto tutt’altro che banale, alla scoperta di consonanze spesso inaspettate. E’ quanto si nota, come si legge nelle note che accompagnano l’album, ascoltando il “Tango” di Stravinsky risalente al 1940 e il “Café de Barracas” di Eduardo Arolas del 1920: la concezione delle masse sonore presenta molti punti di contatto nel pensiero dei due compositori. Più evidente, è ovvio, il rapporto tra il ragtime di Scott Joplin e lo stride piano di James P. Johnson. E di questi esempi se ne possono fare molti altri costituendo per l’appunto questo il punto focale della ricerca di Marco Fumo il quale ama sottolineare come nella sua vita abbia “frequentato sempre tutta la musica, indistintamente” non facendosi mai limitare “da barriere o pregiudizi”.
Merco Fumo è personaggio ben noto ed apprezzato nell’ambiente jazzistico. La sua padronanza strumentale e la sua profonda conoscenza del lessico jazzistico ne fanno personaggio di assoluto rilievo. E questo album ne è l’ennesima conferma in quanto riesce ad evidenziare, come meglio non si potrebbe, i numerosi legami – ora palesi ora più nascosti – tra l’universo euro-colto e la musica afroamericana. In un flusso rapido e spesso trascinante scorrono quindi alcuni degli autori che hanno fatto la storia della musica tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento sulle due sponde dell’Oceano Atlantico. Da Scarlatti a Joplin, da Stravinsky a Nazareth, da Debussy a Ellington tanto per fare qualche nome. Ovvero dal ragtime, dal choro, dal tango, dal blues, dallo stride piano…al jazz e alla musica classica europea in un confronto tutt’altro che banale, alla scoperta di consonanze spesso inaspettate. E’ quanto si nota, come si legge nelle note che accompagnano l’album, ascoltando il “Tango” di Stravinsky risalente al 1940 e il “Café de Barracas” di Eduardo Arolas del 1920: la concezione delle masse sonore presenta molti punti di contatto nel pensiero dei due compositori. Più evidente, è ovvio, il rapporto tra il ragtime di Scott Joplin e lo stride piano di James P. Johnson. E di questi esempi se ne possono fare molti altri costituendo per l’appunto questo il punto focale della ricerca di Marco Fumo il quale ama sottolineare come nella sua vita abbia “frequentato sempre tutta la musica, indistintamente” non facendosi mai limitare “da barriere o pregiudizi”.
Danilo Gallo, Dark Dry Tears – “Hide, Show Yourself!” – PMR
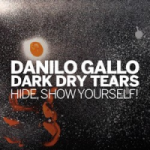 Dopo lo splendido album “Thinking Beats Where Mind Dies” del 2016, il quartetto “Dark Dry Tears” si ripresenta al pubblico del jazz con un organico leggermente diverso in quanto al posto di Francesco Bearzatti figura Massimiliano Milesi (sax tenore e soprano e clarinetto) mentre rimangono al loro posto Francesco Bigoni (sax tenore e clarinetto), Jim Black (batteria) e ovviamente Danilo Gallo al basso elettrico. In programma tredici brani tutti composti da Gallo. Ciò detto rimane sostanzialmente identica la cifra stilistica del gruppo che evidenzia ancora una volta i suoi punti di forza nell’intenso dialogo tra i due fiati, nell’incessante straordinario supporto ritmico di Jim Black (a mio avviso uno dei migliori batteristi oggi in circolazione) e nella sapiente direzione di Gallo che si fa valere non solo per l’apporto ritmico ma anche per la spinta propulsiva forniti dal suo strumento. Quanto al ruolo dei fiati, lo stesso appare evidente sin dal primo brano per proseguire, senza soluzione di continuità, fino al pezzo di chiusura. Interessante notare come l’uso del sax soprano da parte di Milesi conferisca un sapore nuovo alla tavolozza timbrica del gruppo che presenta una compattezza, una omogeneità tutt’altro cha facili da raggiungere. I quattro si muovono in perfetta simbiosi, senza un attimo di incertezza ad interpretare le sapienti composizioni di Gallo la cui raffinatezza è soprattutto evidente nelle introduzioni e nelle chiusure dei singoli brani. Si ascolti al riguardo come il basso elettrico introduca l’intero album nel brano “Demolition” caratterizzato in seguito da un trascinante crescendo.
Dopo lo splendido album “Thinking Beats Where Mind Dies” del 2016, il quartetto “Dark Dry Tears” si ripresenta al pubblico del jazz con un organico leggermente diverso in quanto al posto di Francesco Bearzatti figura Massimiliano Milesi (sax tenore e soprano e clarinetto) mentre rimangono al loro posto Francesco Bigoni (sax tenore e clarinetto), Jim Black (batteria) e ovviamente Danilo Gallo al basso elettrico. In programma tredici brani tutti composti da Gallo. Ciò detto rimane sostanzialmente identica la cifra stilistica del gruppo che evidenzia ancora una volta i suoi punti di forza nell’intenso dialogo tra i due fiati, nell’incessante straordinario supporto ritmico di Jim Black (a mio avviso uno dei migliori batteristi oggi in circolazione) e nella sapiente direzione di Gallo che si fa valere non solo per l’apporto ritmico ma anche per la spinta propulsiva forniti dal suo strumento. Quanto al ruolo dei fiati, lo stesso appare evidente sin dal primo brano per proseguire, senza soluzione di continuità, fino al pezzo di chiusura. Interessante notare come l’uso del sax soprano da parte di Milesi conferisca un sapore nuovo alla tavolozza timbrica del gruppo che presenta una compattezza, una omogeneità tutt’altro cha facili da raggiungere. I quattro si muovono in perfetta simbiosi, senza un attimo di incertezza ad interpretare le sapienti composizioni di Gallo la cui raffinatezza è soprattutto evidente nelle introduzioni e nelle chiusure dei singoli brani. Si ascolti al riguardo come il basso elettrico introduca l’intero album nel brano “Demolition” caratterizzato in seguito da un trascinante crescendo.
Keith Jarrett – “Budapest Concert” – 2 CD – ECM
 Di recente su questi stessi spazi il nostro Massimo Giuseppe Bianchi si è occupato di Keith Jarrett esaminandone due aspetti: il rapporto con il pubblico e l’approccio al repertorio classico. Venuti a conoscenza del fatto che il pianista non potrà più suonare in pubblico, ogni suo album, per quanto registrato anni addietro, assume una particolare valenza. E’ il caso di questo “Budapest Concert” inciso il 3 luglio del 2016 alla Béla Bartok Concert Hall e declinato attraverso due CD, nel primo una serie di improvvisazioni di durata medio lunga, nel secondo ancora improvvisazioni questa volta di durata inferiore e due standard “It’s A Lonesome Old Town” di Tobias e Kisco e “Answer Me, My Love” di Winkler e Rauch. Come spesso gli capitava durante le sue performances, Jarrett preferisce mettere subito in chiaro le sue intenzioni. Ecco quindi la “Part I” sicuramente la più complessa e meno melodica dell’intero programma, in cui l’artista si lancia nelle sue ardite improvvisazioni. E tutto il primo CD, corrispondente alla prima parte del concerto, ripercorre un identico canovaccio vale a dire un pianismo allo stesso tempo lucido e imperscrutabile, vorticoso e meditativo, che comunque si lascia attrarre da quell’area culturale vicina alla musica accademica in special modo del Vecchio Continente. Il discorso cambia nel secondo disco caratterizzato sin dall’inizio da una atmosfera più raccolta, intimista e da una più avvertibile cantabilità. Fino alla degna chiusura con due standard rappresentati con dolce partecipazione. E’ sicuramente questo il Jarrett che il pubblico ama di più, quell’artista che raccoglie in sé il portato di ogni stile pianistico e che, se in stato di grazia, è capace di inanellare una serie infinita di spunti melodici come nessun altro. Ed un esempio probante si ha proprio in questo secondo CD in cui ogni singola esibizione è sugellata da una caldo applauso del pubblico senza che la tensione cali per un solo attimo: lo spettatore è definitivamente conquistato così come noi che ascoltiamo l’album comodamente accovacciati in poltrona.
Di recente su questi stessi spazi il nostro Massimo Giuseppe Bianchi si è occupato di Keith Jarrett esaminandone due aspetti: il rapporto con il pubblico e l’approccio al repertorio classico. Venuti a conoscenza del fatto che il pianista non potrà più suonare in pubblico, ogni suo album, per quanto registrato anni addietro, assume una particolare valenza. E’ il caso di questo “Budapest Concert” inciso il 3 luglio del 2016 alla Béla Bartok Concert Hall e declinato attraverso due CD, nel primo una serie di improvvisazioni di durata medio lunga, nel secondo ancora improvvisazioni questa volta di durata inferiore e due standard “It’s A Lonesome Old Town” di Tobias e Kisco e “Answer Me, My Love” di Winkler e Rauch. Come spesso gli capitava durante le sue performances, Jarrett preferisce mettere subito in chiaro le sue intenzioni. Ecco quindi la “Part I” sicuramente la più complessa e meno melodica dell’intero programma, in cui l’artista si lancia nelle sue ardite improvvisazioni. E tutto il primo CD, corrispondente alla prima parte del concerto, ripercorre un identico canovaccio vale a dire un pianismo allo stesso tempo lucido e imperscrutabile, vorticoso e meditativo, che comunque si lascia attrarre da quell’area culturale vicina alla musica accademica in special modo del Vecchio Continente. Il discorso cambia nel secondo disco caratterizzato sin dall’inizio da una atmosfera più raccolta, intimista e da una più avvertibile cantabilità. Fino alla degna chiusura con due standard rappresentati con dolce partecipazione. E’ sicuramente questo il Jarrett che il pubblico ama di più, quell’artista che raccoglie in sé il portato di ogni stile pianistico e che, se in stato di grazia, è capace di inanellare una serie infinita di spunti melodici come nessun altro. Ed un esempio probante si ha proprio in questo secondo CD in cui ogni singola esibizione è sugellata da una caldo applauso del pubblico senza che la tensione cali per un solo attimo: lo spettatore è definitivamente conquistato così come noi che ascoltiamo l’album comodamente accovacciati in poltrona.
Anja Lechner, François Couturier – “Lontano” – ECM
 Dopo il felice debutto nel 2014 con “Moderato cantabile” sempre firmato ECM, la violoncellista tedesca e il pianista francese tornano in sala di incisione per dar vita a questo “Lontano” articolato su sedici brani sia originali sia dovuti ad autori di aree ed epoche diverse, da Ariel Ramirez a Giya Kancheli, da Anouar Brahem a Henri Dutilleux. Come si può facilmente desumere dall’organico, si tratta di una musica dall’impianto cameristico. Quel che fa la differenza rispetto ad altre registrazioni del genere è da un canto la statura artistica dei due artisti, dall’altro la scelta del repertorio. Ascoltando l’album sin dalle primissime note si ha netta la sensazione di ascoltare musicisti in grado di coniugare una preparazione classica con il linguaggio improvvisativo proprio del jazz. Di qui un suono, una timbrica, un gioco di colori molto vicini alla tradizione cameristica europea. D’altro canto non mancano pagine in cui la capacità di improvvisare prende il sopravvento sulla pagina scritta. Funzionale a tutto ciò la scelta di un repertorio che tende quasi ad annullare qualsiasi distanza temporale tra i vari brani nell’intento – del tutto riuscito – di evidenziare come la buona musica non conosca limiti di tempo. Così, dopo i primi tre brani di impronta “colta”, il ben noto e struggente “Alfonsina y el mar” di Ariel Ramirez. E questa particolare capacità di attualizzare alcune partiture appare altresì evidente, come chiarito nel libretto che accompagna l’album, in almeno altri quattro brani: in “Memory of a Melody” ci si richiama all’aria dalla Cantata BWV 105 di Bach, in “Hymne” si avverte l’influenza di Gurdjieff, in “Postludium” fa capolino l’arte del pianista e compositore ucrainoValentin Silvestrov mentre nella title track si omaggia Federico Mompou esplicitamente ricordato nel già citato “Moderato cantabile”.
Dopo il felice debutto nel 2014 con “Moderato cantabile” sempre firmato ECM, la violoncellista tedesca e il pianista francese tornano in sala di incisione per dar vita a questo “Lontano” articolato su sedici brani sia originali sia dovuti ad autori di aree ed epoche diverse, da Ariel Ramirez a Giya Kancheli, da Anouar Brahem a Henri Dutilleux. Come si può facilmente desumere dall’organico, si tratta di una musica dall’impianto cameristico. Quel che fa la differenza rispetto ad altre registrazioni del genere è da un canto la statura artistica dei due artisti, dall’altro la scelta del repertorio. Ascoltando l’album sin dalle primissime note si ha netta la sensazione di ascoltare musicisti in grado di coniugare una preparazione classica con il linguaggio improvvisativo proprio del jazz. Di qui un suono, una timbrica, un gioco di colori molto vicini alla tradizione cameristica europea. D’altro canto non mancano pagine in cui la capacità di improvvisare prende il sopravvento sulla pagina scritta. Funzionale a tutto ciò la scelta di un repertorio che tende quasi ad annullare qualsiasi distanza temporale tra i vari brani nell’intento – del tutto riuscito – di evidenziare come la buona musica non conosca limiti di tempo. Così, dopo i primi tre brani di impronta “colta”, il ben noto e struggente “Alfonsina y el mar” di Ariel Ramirez. E questa particolare capacità di attualizzare alcune partiture appare altresì evidente, come chiarito nel libretto che accompagna l’album, in almeno altri quattro brani: in “Memory of a Melody” ci si richiama all’aria dalla Cantata BWV 105 di Bach, in “Hymne” si avverte l’influenza di Gurdjieff, in “Postludium” fa capolino l’arte del pianista e compositore ucrainoValentin Silvestrov mentre nella title track si omaggia Federico Mompou esplicitamente ricordato nel già citato “Moderato cantabile”.
Gianni Lenoci – “Wild Geese” – Dodicilune
 Quando Gianni Lenoci ci lasciò improvvisamente, su questi stessi spazi ebbi modo di sottolineare come la sua dipartita lasciasse un vuoto difficilmente colmabile. E questo album, postumo, registrato nel 2017, ne è l’ennesima conferma. Lenoci era artista di indubbio talento che trovava i suoi punti di forza da un canto in una grande capacità improvvisativa declinata attraverso composizioni originali sempre indirizzate verso una sperimentazione mai fine a sé stessa, dall’altro nell’estremo rispetto degli altri, dei suoi colleghi che lo portava ad eseguire le composizioni altrui senza alcunché perdere dell’originario fascino. In questa sua ultima fatica discografica, Lenoci è in trio con Pasquale Gadaleta al basso e Ra-Kalam Bob Moses alla batteria. In repertorio nove composizioni scritte da alcuni grandi del jazz: quattro a testa da Carla Bley e Ornette Coleman, una da Gary Peacock. L’album produce una duplice sensazione: il piacere di ascoltare alcuni standard che restano nella storia della musica e allo stesso tempo l’ammirazione per come Lenoci e compagni siano capaci di riavvolgere il nastro, scomporre i nove brani e ripresentarli secondo una logica nuova, personale, che lascia intravedere, quasi in filigrana, la profonda conoscenza della musica interpretata. E a mio avviso due sono i brani che meglio illustrano quanto sin qui detto, “Latin Genetics” e il conclusivo “Ida Lupino”, senza alcunché togliere alla maestria con cui il trio affronta tutti i brani in programma, a partire dal sontuoso “And now the queen” cui fa seguito “Job Mob“ impreziosito da un Gadaleta in grande spolvero e con un Lenoci quasi a richiamare atmosfere proprie del free. Pezzi che ci introducono alla parte centrale dell’album costituita da tre brani tutti di lunghezza superiore ai dieci minuti. Insomma un album straordinario che merita di essere ascoltato anche da chi non si professa particolarmente amante del jazz: sono sicuro che piacerà anche a costoro.
Quando Gianni Lenoci ci lasciò improvvisamente, su questi stessi spazi ebbi modo di sottolineare come la sua dipartita lasciasse un vuoto difficilmente colmabile. E questo album, postumo, registrato nel 2017, ne è l’ennesima conferma. Lenoci era artista di indubbio talento che trovava i suoi punti di forza da un canto in una grande capacità improvvisativa declinata attraverso composizioni originali sempre indirizzate verso una sperimentazione mai fine a sé stessa, dall’altro nell’estremo rispetto degli altri, dei suoi colleghi che lo portava ad eseguire le composizioni altrui senza alcunché perdere dell’originario fascino. In questa sua ultima fatica discografica, Lenoci è in trio con Pasquale Gadaleta al basso e Ra-Kalam Bob Moses alla batteria. In repertorio nove composizioni scritte da alcuni grandi del jazz: quattro a testa da Carla Bley e Ornette Coleman, una da Gary Peacock. L’album produce una duplice sensazione: il piacere di ascoltare alcuni standard che restano nella storia della musica e allo stesso tempo l’ammirazione per come Lenoci e compagni siano capaci di riavvolgere il nastro, scomporre i nove brani e ripresentarli secondo una logica nuova, personale, che lascia intravedere, quasi in filigrana, la profonda conoscenza della musica interpretata. E a mio avviso due sono i brani che meglio illustrano quanto sin qui detto, “Latin Genetics” e il conclusivo “Ida Lupino”, senza alcunché togliere alla maestria con cui il trio affronta tutti i brani in programma, a partire dal sontuoso “And now the queen” cui fa seguito “Job Mob“ impreziosito da un Gadaleta in grande spolvero e con un Lenoci quasi a richiamare atmosfere proprie del free. Pezzi che ci introducono alla parte centrale dell’album costituita da tre brani tutti di lunghezza superiore ai dieci minuti. Insomma un album straordinario che merita di essere ascoltato anche da chi non si professa particolarmente amante del jazz: sono sicuro che piacerà anche a costoro.
Ivano Nardi – “Homage to Kandinsky” –
 Il batterista Ivano Nardi può a ben ragione essere considerato personaggio storico del jazz italiano e romano in particolare. Sulla scena oramai da parecchi anni, ha collaborato con alcuni bei nomi del panorama internazionale (Massimo Urbani fra tutti e poi Mario Schiano, Marco Colonna, Steve Lacy, Evan Parker, Don Cherry e Lester Bowie) sviluppando uno stile percussivo affatto personale che oscilla tra free jazz e improvvisazione totale. In questa ultima fatica discografica si presenta in quartetto con Eugenio Colombo (sax e flauti), Roberto Bellatalla (contrabbasso) e Giancarlo Schiaffini (trombone). L’Album, come evidenziato dallo stesso titolo, trae ispirazione dai quadri del pittore russo nell’intento di rievocare, attraverso le note, i tratti caratteristici di Kandinsky, dalle armonie dei colori alla vividezza del tocco; di qui le improvvisazioni che assumono titoli quali Giallo indiano, Rosso, Giallo 1, Giallo 2, Grigio scuro, Blu ecc. In buona sostanza la materia indagata a fondo dall’artista russo viene trasformata in materia sonora ora attraverso i solo del leader ora con le improvvisazioni collettive del gruppo che ci riportano ad atmosfere proprie degli anni ’70. Il tutto viene esplicitato ulteriormente da una frase dello stesso Nardi laddove afferma, cito testualmente, che “continuo a leggere e ad approfondire cose che riguardano l’arte tutta: so che non basta una vita a raccogliere tutti questi stimoli!”.
Il batterista Ivano Nardi può a ben ragione essere considerato personaggio storico del jazz italiano e romano in particolare. Sulla scena oramai da parecchi anni, ha collaborato con alcuni bei nomi del panorama internazionale (Massimo Urbani fra tutti e poi Mario Schiano, Marco Colonna, Steve Lacy, Evan Parker, Don Cherry e Lester Bowie) sviluppando uno stile percussivo affatto personale che oscilla tra free jazz e improvvisazione totale. In questa ultima fatica discografica si presenta in quartetto con Eugenio Colombo (sax e flauti), Roberto Bellatalla (contrabbasso) e Giancarlo Schiaffini (trombone). L’Album, come evidenziato dallo stesso titolo, trae ispirazione dai quadri del pittore russo nell’intento di rievocare, attraverso le note, i tratti caratteristici di Kandinsky, dalle armonie dei colori alla vividezza del tocco; di qui le improvvisazioni che assumono titoli quali Giallo indiano, Rosso, Giallo 1, Giallo 2, Grigio scuro, Blu ecc. In buona sostanza la materia indagata a fondo dall’artista russo viene trasformata in materia sonora ora attraverso i solo del leader ora con le improvvisazioni collettive del gruppo che ci riportano ad atmosfere proprie degli anni ’70. Il tutto viene esplicitato ulteriormente da una frase dello stesso Nardi laddove afferma, cito testualmente, che “continuo a leggere e ad approfondire cose che riguardano l’arte tutta: so che non basta una vita a raccogliere tutti questi stimoli!”.
Novotono – “Wood (Wind) at Work” – Autrecords
 Sotto l’insegna dei “Novotono” incontriamo il progetto dei fratelli Adalberto ed Andrea Ferrari con il nuovo album uscito qualche mese fa. Per chi non conosca ancora questi due artisti sottolineiamo che si tratta di improvvisatori di alto livello specialisti di tutta una serie di strumenti a fiato: clarinetto basso, alto sax e baritone sax Andrea, Eb tubax, clarinetto basso, clarinetto, alto sax, soprano sax, contrabbasso clarinetto Adalberto. Già la struttura stessa dell’organico fa capire come ci si trovi dinnanzi ad una musica particolare, spesso giocata sull’aspetto timbrico ma che non trascura il lato melodico né quello ritmico. I due musicisti, fidando su capacità improvvisative non comuni, affrontano terreni spesso disagevoli inerpicandosi su chine pericolose da cui comunque escono sempre bene. Così ad esempio è davvero esemplare il modo in cui i due riescono a rendere vivo il dialogo tra gli strumenti in “Melodie Per Un Burattino Di Legno”, dialogo che sembra non risentire della mancanza di parole per rendersi esplicito nella sua natura più profonda, mentre in “Gegheghè” si abbandona questa atmosfera intima per tuffarsi in un clima rockeggiante. Ma, come si accennava, non si trascura gli spetti ritmici e melodici: ecco, quindi, “Old Durmast” caratterizzato da un andamento ritmico inusuale, a tratti sghembo ma affascinante e “Contratuba Seguoia” con una bella linea melodica ben individuabile, interrotta quasi a metà del brano da un lacerto sonoro assolutamente straniante, dopo di che il pezzo si avvia a conclusione riprendendo l’originario schema. Bella la chiusura con “Wooden Toys” scritto con piacevole ironia. Insomma un album di non facile ascolto ma di sicuro interesse da cui si ricava una importante lezione: l’improvvisazione è stato, è e sarà un elemento imprescindibile della musica jazz.
Sotto l’insegna dei “Novotono” incontriamo il progetto dei fratelli Adalberto ed Andrea Ferrari con il nuovo album uscito qualche mese fa. Per chi non conosca ancora questi due artisti sottolineiamo che si tratta di improvvisatori di alto livello specialisti di tutta una serie di strumenti a fiato: clarinetto basso, alto sax e baritone sax Andrea, Eb tubax, clarinetto basso, clarinetto, alto sax, soprano sax, contrabbasso clarinetto Adalberto. Già la struttura stessa dell’organico fa capire come ci si trovi dinnanzi ad una musica particolare, spesso giocata sull’aspetto timbrico ma che non trascura il lato melodico né quello ritmico. I due musicisti, fidando su capacità improvvisative non comuni, affrontano terreni spesso disagevoli inerpicandosi su chine pericolose da cui comunque escono sempre bene. Così ad esempio è davvero esemplare il modo in cui i due riescono a rendere vivo il dialogo tra gli strumenti in “Melodie Per Un Burattino Di Legno”, dialogo che sembra non risentire della mancanza di parole per rendersi esplicito nella sua natura più profonda, mentre in “Gegheghè” si abbandona questa atmosfera intima per tuffarsi in un clima rockeggiante. Ma, come si accennava, non si trascura gli spetti ritmici e melodici: ecco, quindi, “Old Durmast” caratterizzato da un andamento ritmico inusuale, a tratti sghembo ma affascinante e “Contratuba Seguoia” con una bella linea melodica ben individuabile, interrotta quasi a metà del brano da un lacerto sonoro assolutamente straniante, dopo di che il pezzo si avvia a conclusione riprendendo l’originario schema. Bella la chiusura con “Wooden Toys” scritto con piacevole ironia. Insomma un album di non facile ascolto ma di sicuro interesse da cui si ricava una importante lezione: l’improvvisazione è stato, è e sarà un elemento imprescindibile della musica jazz.
Enrico Pieranunzi – “Time’s Passage” – abeat
 Enrico Pieranunzi è uno di quei non molti musicisti che mai sbaglia un colpo. Ogni qualvolta decide di entrare in sala di incisione è perché ha qualcosa da dire e solitamente si tratta di qualcosa di interessante. Anche questo album registrato nel maggio del 2019, non sfugge alla regola. Il pianista-compositore romano si presenta, questa volta, alla testa di un quintetto con il grande batterista francese Dedè Ceccarelli, il compagno di tante avventure Luca Bulgarelli al contrabbasso e basso elettrico, e due ospiti di lusso quali Andrea Dulbecco al vibrafono e Simona Severini alla voce; in programma nove brani di cui sei scritti dallo stesso leader, in epoche assai diverse e due standard dovuti alle penne di David Mann e Bob Hillard l’uno, e di Arthur Hamilton e Johnny Mandel l’altro. Già dalle prime note della title track si intuisce quale sarà l’andamento dell’album: una musica oscillante tra il jazz da camera e lo swing canonico. Ecco così la delicata “Time’s Passage” impreziosita dai delicati volteggi di un Dulbecco particolarmente brillante cui fa seguito il “Valzer” espressamente dedicato ad Apollinaire con testo in francese. Con “Biff” le atmosfere virano decisamente verso uno swing più accentuato impreziosito dalle improvvisazioni dei quattro musicisti (esclusa la Severini che non figura in questo brano). E così fino all’ultimo brano, “Vacation from The Blues”. Una curiosità: nel disco c’è una doppia versione del brano “In the wee small hours of the morning” portata al successo da Frank Sinatra, una con l’ensemble e una piano e voce. Questa scelta piuttosto anomala, come spiega lo stesso Pieranunzi, è dovuta al fatto che la Severini “ha cantato così bene in entrambe le versioni di questo delicato standard americano, ha espresso il mood della canzone con tanto feeling e fascino narrativo che non me la sono sentita di togliere una delle due versioni. Meritano assolutamente di essere ascoltate entrambe”. E come dargli torto?
Enrico Pieranunzi è uno di quei non molti musicisti che mai sbaglia un colpo. Ogni qualvolta decide di entrare in sala di incisione è perché ha qualcosa da dire e solitamente si tratta di qualcosa di interessante. Anche questo album registrato nel maggio del 2019, non sfugge alla regola. Il pianista-compositore romano si presenta, questa volta, alla testa di un quintetto con il grande batterista francese Dedè Ceccarelli, il compagno di tante avventure Luca Bulgarelli al contrabbasso e basso elettrico, e due ospiti di lusso quali Andrea Dulbecco al vibrafono e Simona Severini alla voce; in programma nove brani di cui sei scritti dallo stesso leader, in epoche assai diverse e due standard dovuti alle penne di David Mann e Bob Hillard l’uno, e di Arthur Hamilton e Johnny Mandel l’altro. Già dalle prime note della title track si intuisce quale sarà l’andamento dell’album: una musica oscillante tra il jazz da camera e lo swing canonico. Ecco così la delicata “Time’s Passage” impreziosita dai delicati volteggi di un Dulbecco particolarmente brillante cui fa seguito il “Valzer” espressamente dedicato ad Apollinaire con testo in francese. Con “Biff” le atmosfere virano decisamente verso uno swing più accentuato impreziosito dalle improvvisazioni dei quattro musicisti (esclusa la Severini che non figura in questo brano). E così fino all’ultimo brano, “Vacation from The Blues”. Una curiosità: nel disco c’è una doppia versione del brano “In the wee small hours of the morning” portata al successo da Frank Sinatra, una con l’ensemble e una piano e voce. Questa scelta piuttosto anomala, come spiega lo stesso Pieranunzi, è dovuta al fatto che la Severini “ha cantato così bene in entrambe le versioni di questo delicato standard americano, ha espresso il mood della canzone con tanto feeling e fascino narrativo che non me la sono sentita di togliere una delle due versioni. Meritano assolutamente di essere ascoltate entrambe”. E come dargli torto?
Dino Rubino – “Time of Silence” – Tuk Music
 Dino Rubino è senza dubbio alcuno uno dei più fulgidi talenti emersi negli ultimi due decenni. Il trombettista, flicornista, pianista, compositore siciliano si è costruito una solida reputazione passo dopo passo, mai bruciando i tempi e mai accontentandosi dei traguardi raggiunti. Da un po’ di tempo incide per la Tuk Music e con l’etichetta di Paolo Fresu sta sfornando degli album davvero eccellenti. Quest’ultimo lo vede alla testa di un quartetto con Emanuele Cisi al sassofono tenore, Paolino Dalla Porta al contrabbasso e Enzo Zirilli alla batteria. In programma dieci brani tutti originali di Rubino che si esprime al pianoforte imbracciando il flicorno solo in un brano, “Settembre”, a chiusura del programma. Spesso ci si interroga circa la pertinenza del titolo dell’album con la musica proposta. Ebbene, in questo caso, il nesso c’è ed è evidente. In un momento in cui chi strepita più forte sembra avere la meglio (e non solo in musica) Rubino sceglie una strada diversa, una strada che privilegia la melodia che non deve essere gridata, basta sussurrarla. E’ una sorta di afflato poetico quello che scaturisce dalle note del siciliano, una musica raffinata, elegante ma tutt’altro che leziosa o banale. Prendendo spunto proprio dal silenzio quale dimensione non secondaria, Rubino guida il gruppo con un pianismo che si fonde senza alcuna forzatura con il resto del gruppo a conferma di una intesa completa. Si ascolti, ad esempio, in “Claire” il modo in cui, dopo un bell’assolo del leader, Cisi raccoglie il testimone per dialogare con il pianoforte in una sorta di botta e risposta affascinante. Così come in “Karol”, i due trovano modo di integrarsi alla perfezione evidenziando le rispettive potenzialità. Potenzialità che nel caso di Rubino sono particolarmente evidenziate in “Owl in the Moon” impreziosito da un assolo pianistico coinvolgente nella sua semplicità. Infine come non segnalare l’ultimo brano, il malinconico “Settembre”, in cui Rubino si esprime magnificamente al flicorno. Al di là della musica, bella la cover dovuta all’artista svizzero Stephan Schmitz.
Dino Rubino è senza dubbio alcuno uno dei più fulgidi talenti emersi negli ultimi due decenni. Il trombettista, flicornista, pianista, compositore siciliano si è costruito una solida reputazione passo dopo passo, mai bruciando i tempi e mai accontentandosi dei traguardi raggiunti. Da un po’ di tempo incide per la Tuk Music e con l’etichetta di Paolo Fresu sta sfornando degli album davvero eccellenti. Quest’ultimo lo vede alla testa di un quartetto con Emanuele Cisi al sassofono tenore, Paolino Dalla Porta al contrabbasso e Enzo Zirilli alla batteria. In programma dieci brani tutti originali di Rubino che si esprime al pianoforte imbracciando il flicorno solo in un brano, “Settembre”, a chiusura del programma. Spesso ci si interroga circa la pertinenza del titolo dell’album con la musica proposta. Ebbene, in questo caso, il nesso c’è ed è evidente. In un momento in cui chi strepita più forte sembra avere la meglio (e non solo in musica) Rubino sceglie una strada diversa, una strada che privilegia la melodia che non deve essere gridata, basta sussurrarla. E’ una sorta di afflato poetico quello che scaturisce dalle note del siciliano, una musica raffinata, elegante ma tutt’altro che leziosa o banale. Prendendo spunto proprio dal silenzio quale dimensione non secondaria, Rubino guida il gruppo con un pianismo che si fonde senza alcuna forzatura con il resto del gruppo a conferma di una intesa completa. Si ascolti, ad esempio, in “Claire” il modo in cui, dopo un bell’assolo del leader, Cisi raccoglie il testimone per dialogare con il pianoforte in una sorta di botta e risposta affascinante. Così come in “Karol”, i due trovano modo di integrarsi alla perfezione evidenziando le rispettive potenzialità. Potenzialità che nel caso di Rubino sono particolarmente evidenziate in “Owl in the Moon” impreziosito da un assolo pianistico coinvolgente nella sua semplicità. Infine come non segnalare l’ultimo brano, il malinconico “Settembre”, in cui Rubino si esprime magnificamente al flicorno. Al di là della musica, bella la cover dovuta all’artista svizzero Stephan Schmitz.
Terje Rypdal – “Conspiracy” – ECM
 Conosco personalmente Rypdal da più di 40 anni e fin dall’inizio l’ho considerato uno dei veri, pochi in novatori che hanno illuminato la scena jazzistica internazionale negli ultimi decenni. A mio avviso una delle caratteristiche che fanno davvero grande un musicista è la riconoscibilità: tu ascolti poche note di sassofono e riconosci Charlie Parker così come ti basta qualche accenno pianistico per individuare Keith Jarrett; egualmente sono sufficienti poche note di chitarra amplificate in un certo modo per individuare tutto un mondo: quello per l’appunto di Terje Rypdal. Registrato a Oslo nel febbraio dello scorso anno in quartetto con Ståle Storløkken keyboards, Endre Hareide Hallre basso elettrico e Pål Thowsen batteria, l’album si articola in sei composizioni del leader che attraversano un po’ tutto il suo spettro compositivo. L’aggancio a quel jazz-rock degli anni ‘70 e ’80 appare evidente ma il tutto viene reinterpretato alla luce di una modernità che si respira evidente mai dando l’impressione del deja-vu. Così se il brano d’apertura “As if the Ghost… was Me?” (“Come se fossi io, il fantasma?”) velato da sottile ironia ripercorre situazioni care al Rypdal che tutti conosciamo, ecco che già in “What was I thinking” ascoltiamo un chitarrista più pensoso, più intimista a dialogare con il basso. Più legata a stilemi rockeggianti la title-track (con evidente richiamo alla Mahavishnu Orchestra) mentre tutta la seconda parte del breve album (appena una trentina di minuti) presenta una musica più evocativa, descrittiva, melodica, oserei dire malinconica a dimostrazione di come, contrariamente a quanto asserito da qualche pur illustre collega, non si tratti di un album quasi routinario ma di una realizzazione fortemente pensata e voluta da una artista che non ha perso un’oncia della sua creatività. Per concludere si ascolti con attenzione la splendida ballad “By His Lonesome”.
Conosco personalmente Rypdal da più di 40 anni e fin dall’inizio l’ho considerato uno dei veri, pochi in novatori che hanno illuminato la scena jazzistica internazionale negli ultimi decenni. A mio avviso una delle caratteristiche che fanno davvero grande un musicista è la riconoscibilità: tu ascolti poche note di sassofono e riconosci Charlie Parker così come ti basta qualche accenno pianistico per individuare Keith Jarrett; egualmente sono sufficienti poche note di chitarra amplificate in un certo modo per individuare tutto un mondo: quello per l’appunto di Terje Rypdal. Registrato a Oslo nel febbraio dello scorso anno in quartetto con Ståle Storløkken keyboards, Endre Hareide Hallre basso elettrico e Pål Thowsen batteria, l’album si articola in sei composizioni del leader che attraversano un po’ tutto il suo spettro compositivo. L’aggancio a quel jazz-rock degli anni ‘70 e ’80 appare evidente ma il tutto viene reinterpretato alla luce di una modernità che si respira evidente mai dando l’impressione del deja-vu. Così se il brano d’apertura “As if the Ghost… was Me?” (“Come se fossi io, il fantasma?”) velato da sottile ironia ripercorre situazioni care al Rypdal che tutti conosciamo, ecco che già in “What was I thinking” ascoltiamo un chitarrista più pensoso, più intimista a dialogare con il basso. Più legata a stilemi rockeggianti la title-track (con evidente richiamo alla Mahavishnu Orchestra) mentre tutta la seconda parte del breve album (appena una trentina di minuti) presenta una musica più evocativa, descrittiva, melodica, oserei dire malinconica a dimostrazione di come, contrariamente a quanto asserito da qualche pur illustre collega, non si tratti di un album quasi routinario ma di una realizzazione fortemente pensata e voluta da una artista che non ha perso un’oncia della sua creatività. Per concludere si ascolti con attenzione la splendida ballad “By His Lonesome”.
Dino Saluzzi – “Albores” – ECM
 Tutte le volte che ho ascoltato Dino Saluzzi dal vivo ne ho sempre ricavato una forte iniezione di energia, una carica di vitalità che non sembra risentire del trascorrere del tempo. Ad onta dei suoi ottantacinque anni Saluzzi è sempre in piena attività, tanto che da poco è uscito questo suo nuovo disco. Album tra l’altro assai particolare in quanto dopo più di trent’anni il maestro argentino torna ad incidere in totale solitudine, con nove sue composizioni. Ed è ancora una volta un piccolo capolavoro. Saluzzi prosegue lungo il suo cammino, con la sua musica che è allo stesso tempo astrazione allo stato puro e narrazione di una memoria che si perde nel tempo. Di qui i riferimenti a persone a lui care e a paesaggi e scorci di natura che fanno parte del suo essere. Il tutto eseguito con uno strumento, il bandoneon, che egli ha portato a livelli di espressività mai raggiunti fino ad oggi. Certo c’è sempre Astor Piazzolla ma il linguaggio adoperato dai due è completamente diverso sì da renderne impossibile un qualsivoglia raffronto. Ma torniamo ad “Albores” che si apre con un omaggio al compositore georgiano Giya Kancheli (“Adios Maestro Kancheli”) la cui musica ha già inciso insieme al celebre violinista lettone Gidon Kremer. Immancabili i riferimenti alla musica andina che viene trasposta in un universo sonoro senza tempo (“La cruz del Sur”) così come inevitabile, lo struggente ricordo del padre (“Don Caye – Variaciones sobre obra de Cayetano Saluzzi”). Senza trascurare i rimandi ad una Buenos Aires d’altri tempi: si ascolti “Segun me cuenta la vida” una milonga ma nello stile di Saluzzi e il successivo “Intimo”. L’album si conclude con “Ofrenda – Toccata”, un brano di rara suggestione in cui misticismo e devozione coesistono a conclusione di un viaggio intriso di nostalgia, bellezza, corporeità e spiritualità a cui tutti noi siamo invitati.
Tutte le volte che ho ascoltato Dino Saluzzi dal vivo ne ho sempre ricavato una forte iniezione di energia, una carica di vitalità che non sembra risentire del trascorrere del tempo. Ad onta dei suoi ottantacinque anni Saluzzi è sempre in piena attività, tanto che da poco è uscito questo suo nuovo disco. Album tra l’altro assai particolare in quanto dopo più di trent’anni il maestro argentino torna ad incidere in totale solitudine, con nove sue composizioni. Ed è ancora una volta un piccolo capolavoro. Saluzzi prosegue lungo il suo cammino, con la sua musica che è allo stesso tempo astrazione allo stato puro e narrazione di una memoria che si perde nel tempo. Di qui i riferimenti a persone a lui care e a paesaggi e scorci di natura che fanno parte del suo essere. Il tutto eseguito con uno strumento, il bandoneon, che egli ha portato a livelli di espressività mai raggiunti fino ad oggi. Certo c’è sempre Astor Piazzolla ma il linguaggio adoperato dai due è completamente diverso sì da renderne impossibile un qualsivoglia raffronto. Ma torniamo ad “Albores” che si apre con un omaggio al compositore georgiano Giya Kancheli (“Adios Maestro Kancheli”) la cui musica ha già inciso insieme al celebre violinista lettone Gidon Kremer. Immancabili i riferimenti alla musica andina che viene trasposta in un universo sonoro senza tempo (“La cruz del Sur”) così come inevitabile, lo struggente ricordo del padre (“Don Caye – Variaciones sobre obra de Cayetano Saluzzi”). Senza trascurare i rimandi ad una Buenos Aires d’altri tempi: si ascolti “Segun me cuenta la vida” una milonga ma nello stile di Saluzzi e il successivo “Intimo”. L’album si conclude con “Ofrenda – Toccata”, un brano di rara suggestione in cui misticismo e devozione coesistono a conclusione di un viaggio intriso di nostalgia, bellezza, corporeità e spiritualità a cui tutti noi siamo invitati.
The Auanders – “Text (us)” – Auand
 Era il 2011 quando su un palco a New York, per festeggiare i dieci anni della Auand, prese forma l’idea di formare una sorta di all-star costituita da artisti dell’etichetta pugliese. Nel corso degli anni il progetto è stato presentato in molte città con organici differenti mentre dal punto di vista discografico siamo adesso al secondo capitolo. Questa volta il lavoro è frutto di una residenza di una settimana ad Arezzo presso il Cicaleto, con un programma di 8 brani originali commissionati ad hoc ad alcuni dei musicisti più attivi che collaborano con la Auand. Ecco quindi un tentetto base – Mirko Cisilino tromba e corno francese), Michele Tino (sax alto e flauto), Francesco Panconesi (sax tenore), Beppe Scardino (sax baritono e clarinetto basso), Filippo Vignato (trombone), Glauco Benedetti (tuba), Francesco Diodati (chitarra), Enrico Zanisi (pianoforte, rhodes, synth e glockenspiel), Francesco Ponticelli (basso e basso elettrico) e Stefano Tamborrino (batteria, percussioni e voce) cui si affiancano in veste di ospiti Sara Battaglini (voce), Francesco Bearzatti (clarinetto), Stefano Calderano (chitarra), Simone Graziano (rhodes) ed Evita Polidoro (voce). Il titolo – Text(Us)(“Scrivici un messaggio”) – contiene di per sé una della carte vincenti dell’etichetta di Bisceglie, vale a dire la voglia di entrare in contatto e in empatia con l’ascoltatore . Dal punto di vista prettamente musicale l’album risulta interessante soprattutto per le modalità di esecuzione: il gruppo, pur essendo numeroso, si muove con grande scioltezza evidenziando una notevole intesa sia nelle parti d’assieme sia nei momenti in cui vengono lasciati spazi ai molti solisti. Il tutto reso possibile da centrati arrangiamenti attraverso cui gli artisti trovano, per l’appunto, modo di esprimere le proprie potenzialità. Notevoli, da questo punto di vista, le sortite, tanto per citare qualche nome, di Francesco Bearzatti in “Song to the Unborn”, Filippo Vignato in “One Week”, oltre alle splendide voci di Sara Battaglini e Evita Polidoro.
Era il 2011 quando su un palco a New York, per festeggiare i dieci anni della Auand, prese forma l’idea di formare una sorta di all-star costituita da artisti dell’etichetta pugliese. Nel corso degli anni il progetto è stato presentato in molte città con organici differenti mentre dal punto di vista discografico siamo adesso al secondo capitolo. Questa volta il lavoro è frutto di una residenza di una settimana ad Arezzo presso il Cicaleto, con un programma di 8 brani originali commissionati ad hoc ad alcuni dei musicisti più attivi che collaborano con la Auand. Ecco quindi un tentetto base – Mirko Cisilino tromba e corno francese), Michele Tino (sax alto e flauto), Francesco Panconesi (sax tenore), Beppe Scardino (sax baritono e clarinetto basso), Filippo Vignato (trombone), Glauco Benedetti (tuba), Francesco Diodati (chitarra), Enrico Zanisi (pianoforte, rhodes, synth e glockenspiel), Francesco Ponticelli (basso e basso elettrico) e Stefano Tamborrino (batteria, percussioni e voce) cui si affiancano in veste di ospiti Sara Battaglini (voce), Francesco Bearzatti (clarinetto), Stefano Calderano (chitarra), Simone Graziano (rhodes) ed Evita Polidoro (voce). Il titolo – Text(Us)(“Scrivici un messaggio”) – contiene di per sé una della carte vincenti dell’etichetta di Bisceglie, vale a dire la voglia di entrare in contatto e in empatia con l’ascoltatore . Dal punto di vista prettamente musicale l’album risulta interessante soprattutto per le modalità di esecuzione: il gruppo, pur essendo numeroso, si muove con grande scioltezza evidenziando una notevole intesa sia nelle parti d’assieme sia nei momenti in cui vengono lasciati spazi ai molti solisti. Il tutto reso possibile da centrati arrangiamenti attraverso cui gli artisti trovano, per l’appunto, modo di esprimere le proprie potenzialità. Notevoli, da questo punto di vista, le sortite, tanto per citare qualche nome, di Francesco Bearzatti in “Song to the Unborn”, Filippo Vignato in “One Week”, oltre alle splendide voci di Sara Battaglini e Evita Polidoro.
Tingvall Trio – “Dance” – Skip Records
 Martin Tingvall (pianoforte), Omar Rodriguez Calvo (basso) e Jürgen Spiegel (batteria) sono i protagonisti di questo convincente album registrato per la “Skip Records”. La formazione ha oramai acquisito una solida reputazione confermata da quest’ultima fatica discografica. Tingvall e compagni prendono per mano l’ascoltatore e lo conducono in un immaginario viaggio attorno al mondo a ritmo dei vari stili di danza. Il tutto interpretato sempre con pertinenza e alla luce di un’empatia che il trio ha evidenziato in tutti gli album fin qui incisi. Quest’ultimo “Dance” è declinato attraverso tredici brani tutti scritti dal leader e arrangiati collegialmente dal trio in modo davvero assai curato come si evidenzia sia dalle intro sia dalle chiusure dei vari brani. Si parte con un esplicito richiamo al Giappone cui fa seguito la title track caratterizzata da una suadente linea melodica ben disegnata dal leader con i tamburi a sottolineare un clima arcaico, senza tempo. In “Spanish Swing”, “Cuban SMS” e “Bolero” è l’anima latina a prevalere grazie ad una caratterizzazione ritmica particolarmente centrata in “Bolero” mentre in “Arabic Slow Dance” si avvertono i profumi dell’Oriente con una significativa introduzione di Calvo impegnato poi in un fitto dialogo con il leader per tutta la durata del brano. “Ya Man” tratteggia un’atmosfera diversa dal resto dell’album in quanto siamo in pieno clima reggae con una forte tappeto ritmico intessuto da Calvo e Spiegel nel cui ambito si inserisce il pianismo di Tingvall. Se questi sono i brani in cui maggiormente si avverte il sapore della “danza” non mancano mezzi più meditativi e introspettivi come il conclusivo “In memory…”.
Martin Tingvall (pianoforte), Omar Rodriguez Calvo (basso) e Jürgen Spiegel (batteria) sono i protagonisti di questo convincente album registrato per la “Skip Records”. La formazione ha oramai acquisito una solida reputazione confermata da quest’ultima fatica discografica. Tingvall e compagni prendono per mano l’ascoltatore e lo conducono in un immaginario viaggio attorno al mondo a ritmo dei vari stili di danza. Il tutto interpretato sempre con pertinenza e alla luce di un’empatia che il trio ha evidenziato in tutti gli album fin qui incisi. Quest’ultimo “Dance” è declinato attraverso tredici brani tutti scritti dal leader e arrangiati collegialmente dal trio in modo davvero assai curato come si evidenzia sia dalle intro sia dalle chiusure dei vari brani. Si parte con un esplicito richiamo al Giappone cui fa seguito la title track caratterizzata da una suadente linea melodica ben disegnata dal leader con i tamburi a sottolineare un clima arcaico, senza tempo. In “Spanish Swing”, “Cuban SMS” e “Bolero” è l’anima latina a prevalere grazie ad una caratterizzazione ritmica particolarmente centrata in “Bolero” mentre in “Arabic Slow Dance” si avvertono i profumi dell’Oriente con una significativa introduzione di Calvo impegnato poi in un fitto dialogo con il leader per tutta la durata del brano. “Ya Man” tratteggia un’atmosfera diversa dal resto dell’album in quanto siamo in pieno clima reggae con una forte tappeto ritmico intessuto da Calvo e Spiegel nel cui ambito si inserisce il pianismo di Tingvall. Se questi sono i brani in cui maggiormente si avverte il sapore della “danza” non mancano mezzi più meditativi e introspettivi come il conclusivo “In memory…”.
Oltre al CD e all’uscita digitale, sarà presto disponibile anche una stampa vinile da 180 gr.
Dominik Wania – “Lonely Shadows” – ECM
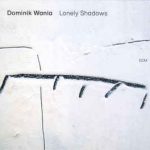 Dopo i successi ottenuti con il Maciej Obara Quartet (“Unloved”, “Three crowns”, ambedue targati ECM)), il pianista polacco Dominik Wania si misura con un ‘piano solo’ registrato nel novembre del 2019 a Lugano, ma che comincia a prendere forma già alcuni anni addietro dopo le registrazioni del citato “Unloved”. Per quanti seguono il jazz con buona attenzione non sarà sfuggito il valore di questo pianista che coniuga un background di tipo classico con capacità improvvisative proprie del jazz-man. Forte di queste caratteristiche Wania affronta la prova più difficile e importante della sua carriera e ne esce a fronte alta. In undici brani tutti di sua composizione e tutti affidati all’improvvisazione del momento, il pianista ci offre una sorta di summa delle sue capacità compositive e interpretative. La sua musica, tutt’altro che di facile ascolto, presenta evidenti richiami a Satie, Ravel e Messiaen; il tocco è leggero, fluido; grande l’attenzione per il dettaglio acustico; solida la concezione architettonica delle composizioni nonostante sia praticamente impossibile individuare chiare linee melodiche o qualsivoglia pattern ritmico. Insomma, come già accennato, siamo nel campo dell’improvvisazione totale che l’artista maneggia con disinvoltura e con originalità mai proponendo qualcosa di banale. Tra i vari brani da segnalare “AG76” un omaggio all’artista polacco Zdzisław Beksiński (1929-2005) le cui distopiche e surreali immagini hanno fortemente influenzato Wania il quale per eseguire il brano ha ricercato una timbrica delicata e nebbiosa, mentre “Indifferent Attitude” si differenzia dagli altri pezzi per essere molto vicino ad atmsfere tipiche del free jazz storico.
Dopo i successi ottenuti con il Maciej Obara Quartet (“Unloved”, “Three crowns”, ambedue targati ECM)), il pianista polacco Dominik Wania si misura con un ‘piano solo’ registrato nel novembre del 2019 a Lugano, ma che comincia a prendere forma già alcuni anni addietro dopo le registrazioni del citato “Unloved”. Per quanti seguono il jazz con buona attenzione non sarà sfuggito il valore di questo pianista che coniuga un background di tipo classico con capacità improvvisative proprie del jazz-man. Forte di queste caratteristiche Wania affronta la prova più difficile e importante della sua carriera e ne esce a fronte alta. In undici brani tutti di sua composizione e tutti affidati all’improvvisazione del momento, il pianista ci offre una sorta di summa delle sue capacità compositive e interpretative. La sua musica, tutt’altro che di facile ascolto, presenta evidenti richiami a Satie, Ravel e Messiaen; il tocco è leggero, fluido; grande l’attenzione per il dettaglio acustico; solida la concezione architettonica delle composizioni nonostante sia praticamente impossibile individuare chiare linee melodiche o qualsivoglia pattern ritmico. Insomma, come già accennato, siamo nel campo dell’improvvisazione totale che l’artista maneggia con disinvoltura e con originalità mai proponendo qualcosa di banale. Tra i vari brani da segnalare “AG76” un omaggio all’artista polacco Zdzisław Beksiński (1929-2005) le cui distopiche e surreali immagini hanno fortemente influenzato Wania il quale per eseguire il brano ha ricercato una timbrica delicata e nebbiosa, mentre “Indifferent Attitude” si differenzia dagli altri pezzi per essere molto vicino ad atmsfere tipiche del free jazz storico.
Marcin Wasilewski Trio, Joe Lovano – “Arctic Riff” – ECM
 Incontro al vertice tra uno dei più grandi sassofonisti degli ultimi decenni e un trio polacco di tutto rispetto guidato dal pianista Marcin Wasilewski e completato da Slawomir Kurkiewicz al contrabbasso e Michail Miskiewicz alla batteria. Quasi inutile sottolineare la grande versatilità di Lovano che riesce a mantenere intatta la propria individualità indipendentemente dal contesto in cui si trova ad operare. Dal canto suo il trio polacco conferma quanto di buono aveva già evidenziato anche nelle collaborazioni con il trombettista anch’egli polacco Tomasz Stanko. In repertorio composizioni dei due leader, un brano di Carla Bley e uno di Joe Lovano cui si aggiungono alcune improvvisazioni collettive. Il quartetto si muove, quindi, su coordinate piuttosto differenziate. Così, ad esempio, nella doppia versione di “Vashkar” di Carla Bley mentre nella prima dopo una breve introduzione di Lovano, Wasilewski si impossessa del tema per svilupparlo alla sua maniera dopo di che interviene ancora Lovano il tutto mantenendosi nei limiti di una visitazione piuttosto letterale, nella seconda prevale un maggior spirito improvvisativo. Ben strutturate le melodie del pianista che si avvalgono di un Lovano in gran spolvero specie in “Fading Sorrow” mentre in “L’Amour Fou” è il batterista a mettersi in particolare luce; splendido il brano finale, “Old Hat”, una suggestiva ballad impreziosita dagli assolo dei due leader che si iscrive di diritto nelle grandi tradizioni del jazz. Nelle improvvisazioni collettive è tutto il quartetto a marciare all’unisono grazie soprattutto al sassofonista che, come si accennava, è riuscito ad inserirsi perfettamente nel già rodato meccanismo del trio polacco.
Incontro al vertice tra uno dei più grandi sassofonisti degli ultimi decenni e un trio polacco di tutto rispetto guidato dal pianista Marcin Wasilewski e completato da Slawomir Kurkiewicz al contrabbasso e Michail Miskiewicz alla batteria. Quasi inutile sottolineare la grande versatilità di Lovano che riesce a mantenere intatta la propria individualità indipendentemente dal contesto in cui si trova ad operare. Dal canto suo il trio polacco conferma quanto di buono aveva già evidenziato anche nelle collaborazioni con il trombettista anch’egli polacco Tomasz Stanko. In repertorio composizioni dei due leader, un brano di Carla Bley e uno di Joe Lovano cui si aggiungono alcune improvvisazioni collettive. Il quartetto si muove, quindi, su coordinate piuttosto differenziate. Così, ad esempio, nella doppia versione di “Vashkar” di Carla Bley mentre nella prima dopo una breve introduzione di Lovano, Wasilewski si impossessa del tema per svilupparlo alla sua maniera dopo di che interviene ancora Lovano il tutto mantenendosi nei limiti di una visitazione piuttosto letterale, nella seconda prevale un maggior spirito improvvisativo. Ben strutturate le melodie del pianista che si avvalgono di un Lovano in gran spolvero specie in “Fading Sorrow” mentre in “L’Amour Fou” è il batterista a mettersi in particolare luce; splendido il brano finale, “Old Hat”, una suggestiva ballad impreziosita dagli assolo dei due leader che si iscrive di diritto nelle grandi tradizioni del jazz. Nelle improvvisazioni collettive è tutto il quartetto a marciare all’unisono grazie soprattutto al sassofonista che, come si accennava, è riuscito ad inserirsi perfettamente nel già rodato meccanismo del trio polacco.
da Marina Tuni | 23/Nov/2020 | News, Primo piano, Recensioni
Quando in redazione abbiamo ricevuto il comunicato stampa del RomaJazz Festival, 44a edizione, con l’annuncio che i concerti, per ovvi motivi, si sarebbero tenuti live ma in streaming… beh, devo confessare di aver arricciato il naso!
#jazzforchange è il claim scelto per questa edizione. E il cambiamento è epocale, nel senso che se l’adattamento è la chiave di ogni trasformazione, ecco che il direttore artistico Mario Ciampà deve aver fatto suo il concetto di “ottimismo della volontà” per allestire un intero festival in “virtual mood”, in questi difficili tempi di pandemia.
Devo dire che per una giornalista del mio stampo, un’Artemide sempre a caccia di emozioni vive e costantemente alla ricerca di percorsi sinestetici e di suggestioni, un concerto non in presenza rappresentava una bella incognita… quale sarebbe stato il mio approccio a questa modalità? Forse, l’unico modo sarebbe stato quello di considerare la realtà virtuale come mezzo di comunicazione, un ponte attraverso il quale vivere l’esperienza, focalizzando la mia attenzione sugli stimoli provenienti da questo scenario, semplicemente lasciandomi andare… senza pregiudizio alcuno.
Scorrendo il programma, il concerto che più ha solleticato la mia curiosità è senza dubbio quello del trombettista beneventano Luca Aquino, che il 17 novembre presentava in live streaming HD, in anteprima mondiale, il suo progetto “Gong. Il Suono dell’ultimo Round”, dedicato ai grandi personaggi della boxe mondiale, con il suo trio formato da Antonio Jasevoli alla chitarra elettrica, Pierpaolo Ranieri al basso e un ospite specialissimo: il franco-ivoriano Manu Katchè alla batteria, un’autentica leggenda che annovera tra le sue collaborazioni Jan Garbarek, Joe Satriani, Peter Gabriel, Joni Mitchell, i Pink Floyd, i Dire Straits, Sting, Pino Daniele, Stefano Bollani… e l’elenco potrebbe continuare.
A completare la rosa dei protagonisti di questo spettacolo multimediale, le opere visive inedite di Mimmo Paladino, tra i principali esponenti della Transavanguardia italiana, e i testi di Giorgio Terruzzi, valente giornalista sportivo e scrittore.
Le storie dei boxeur raccontate sono quelle di Primo Carnera, Muhammad Ali, Sugar Ray Robinson, Nicolino Locche, Carlos Monzon e Mike Tyson.
Il canovaccio dello spettacolo è molto semplice ma di grande impatto e si snoda attorno alle storie, anche personali, di questi miti dello sport. Le musiche originali accompagnano immagini d’epoca dei match più significativi affrontati dai protagonisti, le loro vittorie e le loro pesanti sconfitte, dai primi anni del ‘900 con il gigante di Sequals, Primo Carnera, per arrivare fino ai nostri tempi con il racconto dell’epopea di “Iron” Mike Tyson.
Sul ring virtuale dell’Auditorium Parco della Musica scorrono sul grande schermo le forme stilizzate ed evocative di Paladino, potenti nella loro essenzialità: sfondo blu notte e tratto bianco. È evidente, da parte del Maestro, la ricerca del segno, in un perfetto equilibrio tra significato e significante inserito in un processo digitale di smaterializzazione del ritratto in megapixel… Il Maestro non è nuovo a queste contaminazioni, mi riferisco all’imponente installazione “I Dormienti” composta da cinquanta sculture in terracotta – venti coccodrilli e trenta uomini – collocati nel 1999 nella undercroft della Roundhouse di Londra, con gli interventi musicali (sebbene sia parecchio riduttivo classificarli come “interventi musicali”) di Brian Eno.
Il talento nella scrittura di Giorgio Terruzzi traspare anche in questi racconti di vite da film quasi sempre senza happy ending… La struttura delle storie è reticolare e consequenziale ed ogni parola confluisce verso un apogeo che spesso, per contro, corrisponde alla fase discendente della carriera e della vita di questi grandi uomini.

Primo Carnera
La prima narrazione è dedicata ad uno dei miei conterranei più famosi: Primo Carnera, il colosso dai piedi d’argilla (due metri per 120 kg!) un guerriero leale, un’anima gentile e un uomo di carne e di valori profondamente radicati, che Aquino ha saputo rappresentare in musica attraverso una ballata dall’andamento solenne, che quasi pareva di udire sul palco il passo cadenzato e greve del gigante… La tromba di Luca ha un impatto timbrico onirico, evocativo e lui ha un’abilità pazzesca nel saper “ascoltare” l’ambiente in cui suona, addomesticando riverberi al servizio del suo strumento.
Le tessiture ritmiche di Manu Katchè sono, ad ogni esibizione, una lezione di sagacia tattile mista ad un’incredibile scioltezza nei movimenti e ad un timbro delicato ma incisivo. Il batterista franco-ivoriano accarezza le pelli, sfiora i piatti, il suo drumming è un dono prezioso che lui elargisce sempre in punta di sorriso. Seducente!
Il secondo round dispiega una delle figure più iconiche del ‘900: Muhammad Ali, nato Cassius Clay nel 1942. “I campioni non si costruiscono in palestra. Si costruiscono dall’interno, partendo da qualcosa che hanno nel profondo: un desiderio, un sogno, una visione”; invero, queste celebri parole del boxeur sono applicabili non solo ai campioni dello sport…

Muhammad Ali
Ali era leggenda, un’icona per i diritti degli afro-americani, un esempio di coraggio contro ogni convenzione, “The Greatest” ricevette persino la medaglia presidenziale della libertà, tra le massime onorificenze negli Stati Uniti. Sul ring sembrava un danzatore, era aggraziato, come il brano che accompagna le immagini d’antan: un pezzo lento con la chitarra di Jasevoli dai toni vagamente arabeggianti e il basso di Ranieri protagonista con una linea originalissima, che riunisce armoniosamente aspetti ritmici e melodici; bello lo slide. Il finale molto free è assolutamente in linea con il personaggio a cui il brano è dedicato!
L’estrosa Cadillac rosa del 5 volte campione del mondo dei pesi piuma Sugar Ray Robinson irrompe idealmente sulla scena. Sugar, quello delle epiche sfide con Jake La Motta (il Toro Scatenato di De Niro nell’omonimo film!) era nato nel 1921, ballava il tip tap nei Teatri di Broadway, suonava la batteria e la tromba nei locali jazz… e tirava in palestra: un tipo decisamente eclettico! La musica che lo descrive è dolce come lui, un dio della grazia, e inizia con bel giro di chitarra Fender intorno alla quale s’inseriscono man mano gli altri strumenti. Katchè fa sentire la sua presenza ma con un’inarrivabile leggiadria, un motore ritmico che gira in perfetta simbiosi con i compagni di palco. I cambi inaspettati di tempo, le sfumature jazz-fusion, un bel solo di basso e un volo di trilli della tromba di Aquino, che nel finale passa al flicorno, rendono l’ascolto di questo brano particolarmente avvincente.
 “El intocable” Nicolino Locche, mostro sacro, assieme a Monzon, della noble art in Argentina (ma la famiglia era di origini sarde), era un vero e proprio grillo, maestro della schivata e molto incline alla trasgressione (fumava continuamente, anche un minuto prima di salire sul ring!) Morì a 66 anni – i polmoni… ça va sans dire – con un palmares di 136 incontri, di cui 117 vinti, 5 persi e 14 pareggi. Aquino, in scena da solo, ci mette momentaneamente in knock-down con la sua tromba midi e una loop machine con cui crea un tappeto di suoni sui quali ricama con flicorno, djembè, egg shaker… un’azione sonora totale e un’interazione molto ben calibrata tra acustico ed elettronico.
“El intocable” Nicolino Locche, mostro sacro, assieme a Monzon, della noble art in Argentina (ma la famiglia era di origini sarde), era un vero e proprio grillo, maestro della schivata e molto incline alla trasgressione (fumava continuamente, anche un minuto prima di salire sul ring!) Morì a 66 anni – i polmoni… ça va sans dire – con un palmares di 136 incontri, di cui 117 vinti, 5 persi e 14 pareggi. Aquino, in scena da solo, ci mette momentaneamente in knock-down con la sua tromba midi e una loop machine con cui crea un tappeto di suoni sui quali ricama con flicorno, djembè, egg shaker… un’azione sonora totale e un’interazione molto ben calibrata tra acustico ed elettronico.
È di questi giorni la notizia che Mike Tyson torna sul ring il 28 Novembre, a 54 anni e dopo ben 15 anni di inattività; combatterà contro Roy Jones.
 Iron Mike si porta dietro la nomea di essere il più pericoloso e violento pugile della storia: un cattivo soggetto, per nascita, ceto, destinazione… tante le sue vittorie ma anche squalifiche, accuse di stupro, carcere, botte, morsi (ricordate l’orecchio di Evander Holyfield che Tyson quasi mozzò, sputandone un pezzo sul tappeto e che gli costò la sospensione della licenza da pugile?), una vera e propria Gigantomachia la sua, un gigante solo contro tutti. L’opinione pubblica contro, pronta a giudicare, ad etichettarlo come un animale, senza chiedersi mai quali demoni interiori abbiano albergato in lui che, al contrario del dàimon socratico, lo hanno fatto sprofondare in una spirale distruttiva. E dopo tre mogli e otto figli (una di essi, Exodus, morta a 4 anni) Mike si rialza un’altra volta, forse dopo aver finalmente imparato il valore di una carezza.
Iron Mike si porta dietro la nomea di essere il più pericoloso e violento pugile della storia: un cattivo soggetto, per nascita, ceto, destinazione… tante le sue vittorie ma anche squalifiche, accuse di stupro, carcere, botte, morsi (ricordate l’orecchio di Evander Holyfield che Tyson quasi mozzò, sputandone un pezzo sul tappeto e che gli costò la sospensione della licenza da pugile?), una vera e propria Gigantomachia la sua, un gigante solo contro tutti. L’opinione pubblica contro, pronta a giudicare, ad etichettarlo come un animale, senza chiedersi mai quali demoni interiori abbiano albergato in lui che, al contrario del dàimon socratico, lo hanno fatto sprofondare in una spirale distruttiva. E dopo tre mogli e otto figli (una di essi, Exodus, morta a 4 anni) Mike si rialza un’altra volta, forse dopo aver finalmente imparato il valore di una carezza.
Musicisti ora tutti sul palco per un insieme musicale molto mobile, con cambi di tempo, passaggi di tonalità e stacchi, connotato da una linea di basso molto efficace, dove il chitarrista – davvero bravo – esprime una marcata vena fusion e Katchè ci ricorda ancora una volta quanto sia un fuoriclasse, eseguendo in scioltezza le più articolate figure ritmiche, come nel suo solo dove il piede sulla cassa percuote a una velocità tale da trasformarsi nel becco di un picchio rosso su un tronco d’albero!
Il crescendo finale è corale, sulla scia della chitarra entra il flicorno minimalista di Luca Aquino, totalmente disinteressato ai fraseggi virtuosi ma cercando piuttosto l’essenza del suono. È un jazz palpitante, che scalcia e ripudia stilemi banali e dove un ballabile valzer vira improvvisamente in un incalzante ritmo latineggiante.
A questo punto, un applauso agli ingegneri del suono non è solo doveroso ma ampiamente meritato. Bravi! Ho trovato invece meno azzeccate le scelte della regia video: per l’amor del cielo, si vedeva benissimo, fin nei minimi particolari… ma forse, quello che non ha funzionato, a mio avviso, è proprio questo, i continui cambi di campo delle telecamere, i numerosi primi piani, non mi hanno fatto vivere il live come avrei sperato, ovvero facendomi dimenticare di non essere nella platea del teatro…
 Nel corso dei saluti finali, Luca ammette quanto non sia facile suonare senza lasciarsi condizionare da file e file di poltrone vuote, in una dimensione quasi irreale.
Nel corso dei saluti finali, Luca ammette quanto non sia facile suonare senza lasciarsi condizionare da file e file di poltrone vuote, in una dimensione quasi irreale.
Chissà se ciò gli avrà ricordato le atmosfere dello splendido concerto tenuto con il suo trio italiano e la Jordanian National Orchestra a Petra, l’antica città Rosa della Giordania, patrimonio dell’umanità UNESCO e considerata una delle sette meraviglie del mondo moderno; ovviamente quella romana non sarà stata un’esperienza così mistica ma ugualmente surreale ed intensa.
Chiudo citando quelle che mi sembrano le parole più adatte alle sensazioni provate dopo aver sperimentato anche questa nuova pratica di ascolto, imposta dalla pandemia.
Sono del trombettista statunitense Jon Hassel: “gran parte del mondo percepisce la musica nei termini di un flusso che avanza, basandosi su dove la musica va e cosa viene dopo. C’è però un’altra angolatura: l’ascolto verticale, che consiste nel sentire quel che accade al momento”.
ps: il Digiuno Imposto che ho citato nel titolo di questo articolo è anche quello di un libro di poesie uscito nel 2000 in Germania, per i tipi di Matthes&Seitz Verlag di Monaco di Baviera, illustrato da Mimmo Paladino.
Marina Tuni
La redazione di A Proposito di Jazz ringrazia Giorgio Enea Sironi (ufficio stampa dell’Auditorium Parco della Musica di Roma) per la collaborazione e Riccardo Musacchio, Flavio Ianniello e Chiara Pasqualini per le immagini presenti nell’articolo.
da Redazione | 06/Mag/2020 | Interviste, News, Primo piano
Intervista raccolta da Gerlando Gatto

Giovanni Palombo, chitarrista – ph Roberto Moretti
-Come sta vivendo queste giornate?
“Il periodo di “clausura” ci ha preso tutti in contropiede, io sono dovuto tornare un po’ affannosamente da alcuni concerti in Germania, e dunque son dovuto passare improvvisamente da giornate di continui spostamenti alla immobilità di questi giorni. All’inizio la sensazione era di un fermo circoscritto nel tempo, e una sorta di allarme interiore risuonava solo saltuariamente. Nei momenti meno coscienti sembrava di essere in una bolla, al limite di una situazione sognata, nonostante la dura realtà appresa dai media e dalle poche uscite permesse. La reazione è stata di organizzarmi in pochi giorni con una specie di tabella di marcia, flessibile e non rigida ma costante delle attività che voglio e posso fare, con la musica ovviamente al centro di questo programma”.
– Come ha influito tutto ciò sul suo lavoro? Pensa che in futuro sarà lo stesso?
“La situazione sul lavoro ha influito enormemente, azzerando concerti (per me 12 date in tre mesi!), lezioni, ipotesi di progetti con altri musicisti. Di fondo sono un ottimista per cui penso che le cose troveranno una soluzione, ma come tutti nel nostro settore temo che ci vorrà veramente molto tempo, soprattutto per i concerti live, che comportano comunque gruppi di persone riunite. Soprattutto i club ne soffriranno a lungo. Forse ci sarà una ripresa graduale, con situazioni iniziali possibili dove ci sono spazi più ampi. Sembra veramente irreale, i luoghi dei concerti sono posti di condivisione, vicinanza, emozione condivisa, saluti, abbracci, incontri di persone…”.
– Come riesce a sbarcare il lunario?
“La precarietà economica dell’essere musicista è proverbiale, con continui ondeggiamenti nei vari periodi, tra lezioni e periodi di stasi, concerti pagati poco e qualche data remunerata più dignitosamente (soprattutto all’estero devo dire). Adesso siamo nella incertezza più completa, è vero che non siamo i soli in questa situazione, ma spesso la musica e l’arte in genere sono considerate purtroppo una delle attività secondarie, di contorno. Sono riuscito a organizzare delle lezioni on line, quindi l’insegnamento in questa forma va avanti. Certo in modo più limitato, e comunque la lezione senza contatto umano sa sempre di ripiego”.
– Vive da solo o con qualcuno? E quanto ciò risulta importante?
“Vivo con la mia famiglia, quasi al completo perché mia figlia è all’estero. In questa situazione trovo che la famiglia abbia un ruolo molto importante. Ti dà forza, voglia di uscirne, condivisione di emozioni, dai momenti “down” agli slanci nel pensare a cosa si farà in futuro. Non invidio chi in questi giorni è costretto a vivere in solitudine, penso che tranne rari casi sia una ulteriore sofferenza. Questo stare così vicini tutti i momenti ha ovviamente anche dei limiti ed evidenzia momenti di crisi, ma soprattutto esprime con forza le sfaccettature dei sentimenti e della personalità di noi tutti, una cosa che spesso viene trascurata o percepita solo occasionalmente nella quotidianità usuale”.
– Pensa che questo momento di forzato isolamento ci indurrà a considerare i rapporti umani e professionali sotto una luce diversa?
“Il timore di “risvegliarsi” diversi, e che la situazione possa obbligare a mantenere distanza e diffidenza purtroppo c’è. Tutto un contorno di misure di prevenzione e controllo evocano sempre di più una società che tende al “grande fratello”, che penso sia uno dei grandi timori per tanti, e soprattutto per quelli della mia generazione. Non posso neanche negare il timore di dover vivere una professionalità diversa, più artificiosa e difficile da realizzare. D’altra parte ho anche fiducia nelle risorse umane, nei sentimenti di solidarietà che nonostante tutto si intravedono un po’ ovunque. Ripeto che sono un ottimista, e vedo anche delle lezioni utili in questa crisi, che spero siano capitalizzate da noi tutti, dalla società e dai politici, per impostare un modo più equo ed ecologico di vivere”.
-Crede che la musica possa dare la forza per superare questo terribile momento?
“La musica può avere un ruolo formidabile in questi momenti. Forse dobbiamo dimenticare il ruolo performativo e assumere una funzione di esaltazione dei sentimenti e delle passioni, della essenza interiore nostra e degli altri. Per arrivare a una sorta di verità condivisa che guarda al meglio, e che spesso è difficile vedere”.
-Se non la musica a cosa ci si può affidare?
“Ci si deve affidare a una razionalità che viva di buon senso, senza dimenticare i buoni sentimenti, non dimenticare di sforzarsi di tendere sempre al meglio. Questo ciascuno nel proprio settore, e direi anche nel proprio piccolo”.
– Quanto c’è di retorica in questi continui richiami all’unità?
“La retorica è un elemento costante degli italiani, ereditata dalla civiltà greca e romana, ci accompagnerà sempre. In giorni come questi può assumere aspetti patetici, soprattutto quando è manipolata dai politici o dai media. E se sfiora il nazionalismo diventa anche pericolosa. A volte accompagna la portentosa vena polemica che è un’altra costante del carattere nostrano. Forse a volte la smussa un po’, non saprei, ma mi sembra inevitabile viste le nostre caratteristiche”.
– È soddisfatto di come si stanno muovendo i Vostri organismi di rappresentanza?
“È una domanda difficile. La sensazione che i nostri rappresentanti mostrino un livello di confusione e contraddittorietà è spesso presente, ma anche questo è un elemento storicamente presente. D’altra parte è anche evidente che in questa situazione è difficile orientarsi, e che le certezze siano poche. Lo dimostrano le posizioni di altri paesi europei, sbandierate inizialmente con forza e poi cambiate. Quello che vedo è che le misure prese alla fine sono condivise a livello mondiale direi, quindi pur nella precarietà e confusione si è andati nella direzione giusta”.
– Se avesse la possibilità di essere ricevuto dal Governo, cosa chiederebbe?
“Capisco che è una affermazione generica ma chiederei che gli interventi di sostegno non si dimentichino di nessuno. D’altra parte è una posizione dichiarata, e speriamo mantenuta”.
– Ha qualche particolare suggerimento di ascolto per chi ci legge in questo momento?
“Posso consigliare questi ascolti: 1) Renaud Garcia Fons, in particolare il CD “La linea del sur”, e i concerti live reperibili su YouTube. 2) Ralph Towner, “My Foolish Heart” e molto altro, anche con gli Oregon. 3) Tigran Hamasyan, su YouTube un mucchio di cose, ad es. Fides Tua. 4) Egbert Gismonti, quasi tutto. 5) Questo è diverso, non è jazz ma mi ha preso molto lo stesso: David Crosby, “Croz”, cantautorato californiano di qualità. 7) De Andrè, “Creuza de Ma” e “Anime Salve”. L’ordine non è di preferenza, e ci sarebbe molto altro…”.
da Daniela Floris | 28/Lug/2019 | Eventi, News, Primo piano, Recensioni

Le foto sono di LAURA GIROLAMI
CIVITAFESTIVAL
Forte Sangallo, Cortile Maggiore
Venerdì 12 luglio 2019
Ore 21:30
Adam Pieronczyk Quintet
Adam Pieronczyk, sax tenore e soprano
Ramberto Ciammarughi, pianoforte
Jacopo Ferrazza, contrabbasso
John B. Arnold, batteria
guest Fabio Zeppetella, chitarra elettrica
Trentunesima edizione del Civita Festival: una volta di più il direttore artistico Fabio Galadini riesce a portare a casa un Festival denso di eventi di ogni genere, quest’ anno senza alcun contributo pubblico, ma solo con sponsor e incassi di biglietti di ingresso a prezzi popolarissimi, che si svolgono per la maggior parte nello stupendo Cortile Maggiore del Forte Sangallo. Teatro, Danza, Musica, Reading, una varietà di spettacoli davvero notevole, un successo di pubblico altrettanto notevole: un pubblico variegato di esperti, appassionati, ma anche di curiosi, a riprova che se si investe nella cultura in maniera intelligente la gente risponde eccome. Anche quest’anno, come ogni anno.
Tra gli eventi il concerto del quintetto di Adam Pieronczyk. Un gruppo inedito, formatosi per l’occasione, con la regia del batterista John B.Arnold. Una regia attenta che ha messo insieme cinque musicisti portatori di personalità musicale alquanto spiccata. Questo è ciò che è accaduto al Forte Sangallo, o meglio, ciò che io ho visto e ascoltato accadere dal mio punto di vista (e di osservazione)

Adam Pieronxczyk apre il concerto con un assolo di sax: una intro libera che dopo qualche minuto svela il tema portante del brano, che viene doppiato dalla mano sinistra di Ramberto Ciammarughi al pianoforte, e dal contrabbasso di Jacopo Ferrazza. John B. Arnold entra con la batteria, senza toccare il rullante, insistendo sui tom e sui ride. La chitarra di Fabio Zeppetella comincia ad incalzare ed elegge ad alter ego, in un dialogo serrato, il pianoforte. Il suono potente del contrabbasso tira le fila della tessitura complessiva, fino all’ assolo di Ciammarughi.

Un assolo in cui idee estemporanee si intrecciano con frammenti del tema principale, mai buttati via. La mano destra e la mano sinistra sono totalmente indipendenti tra loro, è come ascoltare l’esecuzione di due strumenti, due linee complementari, non linea principale e accompagnamento.
Segue l’improvvisazione di Pieronxczyk: un fraseggiare legato, melodico, denso di idee ma aperto alle sollecitazioni degli accordi pieni del pianoforte e del procedere instancabile del contrabbasso.

Al rientro in scena della chitarra elettrica, con una nota ribattuta ostinata, il volume si intensifica fino ad un massimo che poi gradualmente si assottiglia: si torna al sax che rimane solo, come all’inizio, e che sussurra, fino all’ultimo armonico.


Il secondo brano comincia con sax e contrabbasso all’unisono: la batteria colora con suoni sospesi. Il pianoforte interviene con tocchi sporadici. Si unisce all’unisono anche la chitarra, unico suono non acustico. A un breve silenzio, suggestivo, segue il tintinnare del ride e una sezione in quartetto. Il (doppio) pianoforte di Ciammarughi, la batteria di Arnold, il contrabbasso di Ferrazza e la chitarra di Zeppetella procedono insieme in un dialogo serrato, fino a quando non entra Pieronxczyk. Tacciono chitarra e piano, e un nuovo trio entra in scena: contrabbasso, batteria e sax.
Su giri armonici semplici si imperniano idee suggestive. La composizione dei musicisti sul palco cambia continuamente dando adito a una ricerca sonora e timbrica costante.

Quando il dialogo è tra Pieronxczyk e Ciammarughi, in alcuni brani che prevedono questo inizio, il sax accenna il tema e il pianoforte prende corpo lentamente, passando da una leggera scansione armonico – ritmica ad una interazione paritaria. Niente è mai ripetuto, ma, allo stesso tempo, nessun “mattoncino sonoro” viene prematuramente abbandonato. Una cellula melodica, o ritmica, può nascere dal sax, passa alla chitarra elettrica, rimbalza sul pianoforte, viene ripresa dal contrabbasso, mentre anche la batteria riesce a cantarla. Il tutto veleggiando tra momenti adrenalinici ed episodi intimisti, passando per molte sfumature possibili.
Dimenticavo di scrivere che tutta la musica suonata, bis compreso, è stata musica originale.

L’IMPATTO SU CHI VI SCRIVE
Un quintetto, come accennavo, che – poste precedenti collaborazioni tra alcuni di loro, come quella lunghissima tra Ramberto Ciammarughi e Fabio Zeppetella, o quella tra John B. Arnold e Adam Pieronxczyk, si è costituito per la prima volta proprio in occasione del Civitafestival.
I musicisti, come spesso accade in questi casi, hanno provato poco prima di suonare: le possibilità di solito sono due. Si può assistere a una Jam Session, magari anche di altro livello, o si assiste a un concerto in cui non si improvvisa su schemi prevedibili, ma si compone estemporaneamente qualcosa di nuovo e, chissà, anche irripetibile.
Ho assistito alla performance di un quintetto affiatato, composto da cinque musicisti capaci di dare forma comune e suggestiva alla spiccata personalità di ognuno, estemporaneamente.
Ho notato i dialoghi serrati tra Fabio Zeppetella e Jacopo Ferrazza: chitarra elettrica e contrabbasso intrecciati in una trama base fondante della pienezza, della compiutezza del sound complessivo. E protagonisti di assoli interessanti e intensi.
Ritengo una fortuna quella di aver avuto la possibilità di ascoltare Ramberto Ciammarughi, artista tanto defilato quanto originale, capace di essere delicato e vulcanico, ovvero dall’espressività sanguigna, torrenziale, ma anche improvvisamente intimista. Consiglio a tutti di non perdere i pochi concerti cui cede: è un pianista originale, dallo stile del tutto particolare.
Non conoscevo Adam Pieronxczyk: è stato una bella scoperta, ho trovato il suo modo di suonare singolarmente in equilibrio tra una spiccata vena melodica e una istintiva propensione alla sperimentazione, con fraseggi inusuali che spiccano durante le parti in solo o l’esposizione dei temi ma anche la capacità di intrecciarsi con il resto del gruppo diventando parte di un voicing interessante anche quando le sequenze armoniche sono costruite su schemi semplici.
John B. Arnold fa parte di quel voicing: con la sua batteria spesso va oltre l’accompagnamento ritmico e si inserisce armonicamente nel tessuto complessivo. Davvero un bellissimo suono.
da Daniela Floris | 19/Giu/2019 | Fotoreportage, News, Primo piano, Recensioni

Tutte le foto sono di ADRIANO BELLUCCI
GIANICOLO IN JAZZ
Terrazza del Gianicolo, 11 giugno 2019, ore 21:30
LORENZO TUCCI TRIO
Lorenzo Tucci, batteria
Luca Mannutza, pianoforte
Jacopo Ferrazza, contrabbasso
Gianicolo in Jazz è una location suggestiva, con concerti ad ingresso libero, un panorama notturno mozzafiato, un po’ di quel vento che a Roma viene chiamato ponentino e che dona refrigerio, la sera, dopo giornate cittadine ormai torride: il cielo, stasera, è limpido. Comincia la musica.


Il primo brano si intitola Afrodolce, ed è una nuova composizione di Lorenzo Tucci, che evidenzia ancora una volta la propensione di un batterista dalle lampanti, inconfutabili doti ritmiche, per melodie cantabili, dolci, ma persistenti, anche quando inserite in schemi armonici per nulla scontati, e che mantengono la loro forza melodica anche durante l’intensificarsi dei volumi e della polifonia del suo strumento.
L’andamento è cullante e terzinato, le bacchette percuotono soprattutto i ride e il rullante (sui bordi). I tamburi appaiono meno, inizialmente, ma poi i colori aumentano, complice anche il pianoforte di Luca Mannutza, che interviene con accordi sempre più pieni.

L’intenzione dolce, poetica, però rimane intatta, e l’assolo di Jacopo Ferrazza è la pausa sospesa che prelude al finale, in cui il tema ritorna.

Si prosegue con brano imperniato su un martellante riff di pianoforte fatto di note ribattute, discendenti nell’ambito di un intervallo di terza minore, in progressione cromatica, che contrasta con la leggerezza della batteria. Il tutto avviene su un ostinato di contrabbasso. Il loop iniziale di pianoforte e contrabbasso è sottolineato dai contrasti timbrici e dinamici creati da questo schema fisso, in cui paradossalmente la parte più “melodica” è quella attribuita alla batteria: a lungo il clima rimane quello, tanto da diventare quasi ipnotico.

Improvvisamente però tutto muta: è proprio Lorenzo Tucci a cambiare le carte in tavola con la sua batteria, prende ad improvvisare, intensificando battiti, schemi ritmici, introducendo variazioni continue, seguito da Luca Mannutza, che a quel punto alla batteria si intreccia, percussivamente, con accordi pieni e percorrendo tutta la tastiera: Ferrazza invece strenuamente mantiene il punto con il suo ostinato, fino ad un istante in cui la batteria tace. Il cerchio si chiude su quel riff potente iniziale di note ribattute discendenti.

Si prosegue con Hope, una delle composizioni più note di Tucci, un brano intenso, placido, il cui tema classicamente è affidato al contrabbasso: Ferrazza lo espone accendendolo con accenti e dinamiche poetici.
Tucci suona inizialmente con i mallets, toccando soprattutto i ride.

All’assolo di pianoforte, in cui Mannutza improvvisa intensificando il volume, allargando lo spessore sonoro con accordi complessi, le bacchette sostituiscono i mallets. Eppure non viene smentita l’atmosfera iniziale, sognante, placida: come? il Trio è sempre, costantemente bilanciato. Non vi sono strappi improvvisi. I volumi si alzano in maniera costante, le note aumentano mentre i battiti aumentano, l’insieme rimane “armonico”.


Il concerto prosegue con i brani presenti nel cd Sparkle, tra assoli sinceramente stupefacenti della batteria ed improvvisazioni intense del pianoforte e del contrabbasso. Fino ad un Bis richiestissimo , e applauditissimo.
L’IMPATTO SU CHI VI SCRIVE
Un concerto divertente, travolgente, a tratti delicato e suggestivo. Tutta musica originale: originale anche perché Tucci compone con una sua cifra precisa, presentando melodie e arrangiamenti che hanno il pregio di rimanere impressi anche molto dopo che la musica è terminata. Sono efficaci, mai banali. E soprattutto vengono continuamente sottolineati, coccolati, incorniciati da continue varianti che sgorgano da un drumming veramente inarrestabile, in cui le capacità tecniche sono asservite ad una incessante fantasia creativa. La batteria canta, insieme al pianoforte di Mannutza (che raccoglie e offre continui spunti), i ruoli si scambiano, il contrabbasso di Ferrazza è presente sia nelle situazioni dai volumi sommessi che nei momenti più vigorosi, risultando persino, appropriatamente, sgargiante.
L’intesa tra Tucci, Mannutza e Ferrazza è totale, e questo si traduce in un bilanciamento continuo, qualsiasi sia l’atmosfera, dalla più lieve a quella più adrenalinica: la musica, quando è così, semplicemente, è bella.
 Franco Battiato, purtroppo scomparso l’altro ieri a 76 anni nella sua casa di Milo, in Sicilia, è uno di quegli artisti che è riuscito a legarsi a noi in maniera indissolubile attraverso il ricordo. La sua musica è in qualche modo associata alla memoria di ognuno di noi, basta scorrere gli articoli, le interviste e la sezione commenti YouTube sotto le sue canzoni per poter leggere milioni di storie di persone e del primo momento in cui hanno incontrato la sua musica. Si legge di chi lo ha scoperto in spiaggia con gli amici, chi ascoltandolo nella macchina del padre, chi sentendolo suonato alla chitarra da qualche ragazzo tra le gradinate degli atenei universitari. Nel mio caso era una lezione di Filosofia, al terzo anno di Liceo, il professore per concludere un argomento su un autore ci fece ascoltare “Centro di gravità permanente”. Non ricordo attualmente quale fosse il collegamento, ma il dubbio che mi sorse immediatamente fu più o meno: “Qual è il nesso con la filosofia?”. Ottima domanda. Il punto è che la storia di Battiato è come una cassetta a nastro, esiste un lato B che si ascolta sempre successivamente al lato A. Per alcuni questo è avvenuto frugando in scatoloni pieni di polvere che appartenevano a un parente, dai quali sbucano dei dischi abbandonati da chissà quando ma che colpiscono la nostra attenzione. Io stesso ho provato questa sensazione, ma in formato digitale. Stavo ascoltando il “Canto Sospeso” di Luigi Nono, dovevo studiarlo per un esame, quando l’algoritmo di YouTube decide di consigliarmi “L’Egitto Prima delle Sabbie” del 1978.
Franco Battiato, purtroppo scomparso l’altro ieri a 76 anni nella sua casa di Milo, in Sicilia, è uno di quegli artisti che è riuscito a legarsi a noi in maniera indissolubile attraverso il ricordo. La sua musica è in qualche modo associata alla memoria di ognuno di noi, basta scorrere gli articoli, le interviste e la sezione commenti YouTube sotto le sue canzoni per poter leggere milioni di storie di persone e del primo momento in cui hanno incontrato la sua musica. Si legge di chi lo ha scoperto in spiaggia con gli amici, chi ascoltandolo nella macchina del padre, chi sentendolo suonato alla chitarra da qualche ragazzo tra le gradinate degli atenei universitari. Nel mio caso era una lezione di Filosofia, al terzo anno di Liceo, il professore per concludere un argomento su un autore ci fece ascoltare “Centro di gravità permanente”. Non ricordo attualmente quale fosse il collegamento, ma il dubbio che mi sorse immediatamente fu più o meno: “Qual è il nesso con la filosofia?”. Ottima domanda. Il punto è che la storia di Battiato è come una cassetta a nastro, esiste un lato B che si ascolta sempre successivamente al lato A. Per alcuni questo è avvenuto frugando in scatoloni pieni di polvere che appartenevano a un parente, dai quali sbucano dei dischi abbandonati da chissà quando ma che colpiscono la nostra attenzione. Io stesso ho provato questa sensazione, ma in formato digitale. Stavo ascoltando il “Canto Sospeso” di Luigi Nono, dovevo studiarlo per un esame, quando l’algoritmo di YouTube decide di consigliarmi “L’Egitto Prima delle Sabbie” del 1978. La prima reazione, dopo aver visto, titolo, copertina e autore fu di curiosità. Mi aspettavo qualche brano pop-synth con dei testi evocativi ma nonsense, nella mia ignoranza. Quello del cantautore siciliano è infatti una storia dove questo Lato B, spesso è tralasciato o non conosciuto da molti, tra cui io! Cliccai Play sullo schermo e… non potevo credere alle mie orecchie! Arpeggi di una scala su un pianoforte a cui seguivano le risonanze con il pedale e si chiudevano fino a sparire nel silenzio. Ad ogni ciclo, questo gesto si faceva sempre più lontano dalla sua ripetizione. Il secondo brano segue una logica simile ma con una sequenza di accordi e un ritmo variato. Era qualcosa che assomigliava più a un’opera minimalista di Philip Glass; cosa c’entra Battiato con questo? Questa storia, apparentemente nascosta, prosegue incessantemente e si finisce per scoprire album come “Clic” del 1974, “Sulle Corde di Aries” del 1973 e, seguendo questo Filo d’Arianna, si arriva al suo primo album in studio, “Fetus”.
La prima reazione, dopo aver visto, titolo, copertina e autore fu di curiosità. Mi aspettavo qualche brano pop-synth con dei testi evocativi ma nonsense, nella mia ignoranza. Quello del cantautore siciliano è infatti una storia dove questo Lato B, spesso è tralasciato o non conosciuto da molti, tra cui io! Cliccai Play sullo schermo e… non potevo credere alle mie orecchie! Arpeggi di una scala su un pianoforte a cui seguivano le risonanze con il pedale e si chiudevano fino a sparire nel silenzio. Ad ogni ciclo, questo gesto si faceva sempre più lontano dalla sua ripetizione. Il secondo brano segue una logica simile ma con una sequenza di accordi e un ritmo variato. Era qualcosa che assomigliava più a un’opera minimalista di Philip Glass; cosa c’entra Battiato con questo? Questa storia, apparentemente nascosta, prosegue incessantemente e si finisce per scoprire album come “Clic” del 1974, “Sulle Corde di Aries” del 1973 e, seguendo questo Filo d’Arianna, si arriva al suo primo album in studio, “Fetus”.
 Nel 1971 alcuni pensieri sbocciano in Battiato, perché, da come viene raccontato, in quel suo periodo di attività sembra che si sia trasformato improvvisamente in un compositore contemporaneo sperimentale. “Fetus” è un complesso e articolato concept album che racconta di una società distopica, il tutto attraverso sonorità elettroniche di sintetizzatori e drum machine che si mescolano con echi di musica classica e passaggi in stile progressive rock. Soltanto due anni dopo uscirà “Sulle Corde di Aries”, dove l’organico standard del rock viene abbandonato in favore di quello orchestrale; infine, l’anno successivo, arriva “Clic”, che sembra un lavoro misto tra Tape Music, Classica e Jazz, per alcuni passaggi.
Nel 1971 alcuni pensieri sbocciano in Battiato, perché, da come viene raccontato, in quel suo periodo di attività sembra che si sia trasformato improvvisamente in un compositore contemporaneo sperimentale. “Fetus” è un complesso e articolato concept album che racconta di una società distopica, il tutto attraverso sonorità elettroniche di sintetizzatori e drum machine che si mescolano con echi di musica classica e passaggi in stile progressive rock. Soltanto due anni dopo uscirà “Sulle Corde di Aries”, dove l’organico standard del rock viene abbandonato in favore di quello orchestrale; infine, l’anno successivo, arriva “Clic”, che sembra un lavoro misto tra Tape Music, Classica e Jazz, per alcuni passaggi. Tutta questa spinta sperimentale si è sopita del tutto oggi? Battiato davvero non si è mai stancato di fare pop? In effetti, qualche parentesi c’è stata. Nel 2000, ad esempio, con “Campi Magnetici” e nel 2004 in “Dieci Stratagemmi”; ma c’è un esempio anche in tempi più recenti. Nello stesso anno della conferenza stampa di Meeting al Mare esce “Joe Patti’s Experimental Group” (2014) con Franco Battiato alla voce e sintetizzatore, Pino Pischetola, live electronics e Carlo Guaitoli al pianoforte. Diventa interessante pensare come quella critica alla musica contemporanea si sovrapponga al ritorno per il suo grande amore per l’elettronica sperimentale, dimostrando quanto, alla fine, l’anima del catanese sia quanto mai un trittico di fiori dai petali multicolore.
Tutta questa spinta sperimentale si è sopita del tutto oggi? Battiato davvero non si è mai stancato di fare pop? In effetti, qualche parentesi c’è stata. Nel 2000, ad esempio, con “Campi Magnetici” e nel 2004 in “Dieci Stratagemmi”; ma c’è un esempio anche in tempi più recenti. Nello stesso anno della conferenza stampa di Meeting al Mare esce “Joe Patti’s Experimental Group” (2014) con Franco Battiato alla voce e sintetizzatore, Pino Pischetola, live electronics e Carlo Guaitoli al pianoforte. Diventa interessante pensare come quella critica alla musica contemporanea si sovrapponga al ritorno per il suo grande amore per l’elettronica sperimentale, dimostrando quanto, alla fine, l’anima del catanese sia quanto mai un trittico di fiori dai petali multicolore.











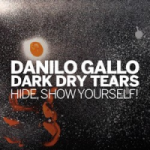











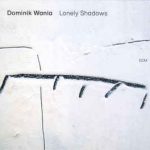





















 “El intocable” Nicolino Locche, mostro sacro, assieme a Monzon, della noble art in Argentina (ma la famiglia era di origini sarde), era un vero e proprio grillo, maestro della schivata e molto incline alla trasgressione (fumava continuamente, anche un minuto prima di salire sul ring!) Morì a 66 anni – i polmoni… ça va sans dire – con un palmares di 136 incontri, di cui 117 vinti, 5 persi e 14 pareggi. Aquino, in scena da solo, ci mette momentaneamente in knock-down con la sua tromba midi e una loop machine con cui crea un tappeto di suoni sui quali ricama con flicorno, djembè, egg shaker… un’azione sonora totale e un’interazione molto ben calibrata tra acustico ed elettronico.
“El intocable” Nicolino Locche, mostro sacro, assieme a Monzon, della noble art in Argentina (ma la famiglia era di origini sarde), era un vero e proprio grillo, maestro della schivata e molto incline alla trasgressione (fumava continuamente, anche un minuto prima di salire sul ring!) Morì a 66 anni – i polmoni… ça va sans dire – con un palmares di 136 incontri, di cui 117 vinti, 5 persi e 14 pareggi. Aquino, in scena da solo, ci mette momentaneamente in knock-down con la sua tromba midi e una loop machine con cui crea un tappeto di suoni sui quali ricama con flicorno, djembè, egg shaker… un’azione sonora totale e un’interazione molto ben calibrata tra acustico ed elettronico. Iron Mike si porta dietro la nomea di essere il più pericoloso e violento pugile della storia: un cattivo soggetto, per nascita, ceto, destinazione… tante le sue vittorie ma anche squalifiche, accuse di stupro, carcere, botte, morsi (ricordate l’orecchio di Evander Holyfield che Tyson quasi mozzò, sputandone un pezzo sul tappeto e che gli costò la sospensione della licenza da pugile?), una vera e propria Gigantomachia la sua, un gigante solo contro tutti. L’opinione pubblica contro, pronta a giudicare, ad etichettarlo come un animale, senza chiedersi mai quali demoni interiori abbiano albergato in lui che, al contrario del dàimon socratico, lo hanno fatto sprofondare in una spirale distruttiva. E dopo tre mogli e otto figli (una di essi, Exodus, morta a 4 anni) Mike si rialza un’altra volta, forse dopo aver finalmente imparato il valore di una carezza.
Iron Mike si porta dietro la nomea di essere il più pericoloso e violento pugile della storia: un cattivo soggetto, per nascita, ceto, destinazione… tante le sue vittorie ma anche squalifiche, accuse di stupro, carcere, botte, morsi (ricordate l’orecchio di Evander Holyfield che Tyson quasi mozzò, sputandone un pezzo sul tappeto e che gli costò la sospensione della licenza da pugile?), una vera e propria Gigantomachia la sua, un gigante solo contro tutti. L’opinione pubblica contro, pronta a giudicare, ad etichettarlo come un animale, senza chiedersi mai quali demoni interiori abbiano albergato in lui che, al contrario del dàimon socratico, lo hanno fatto sprofondare in una spirale distruttiva. E dopo tre mogli e otto figli (una di essi, Exodus, morta a 4 anni) Mike si rialza un’altra volta, forse dopo aver finalmente imparato il valore di una carezza. Nel corso dei saluti finali, Luca ammette quanto non sia facile suonare senza lasciarsi condizionare da file e file di poltrone vuote, in una dimensione quasi irreale.
Nel corso dei saluti finali, Luca ammette quanto non sia facile suonare senza lasciarsi condizionare da file e file di poltrone vuote, in una dimensione quasi irreale.






















