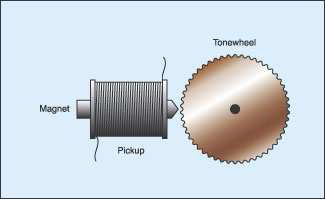Tempo di lettura stimato: 5 minuti
di Paolo Veronesi – Organo Hammond, capolavoro e paradosso. Capolavoro d’ingegneria elettromeccanica applicata al suono, l’Hammond, nato nel 1935 a Chicago per surrogare l’organo a canne. La perfezione costruttiva del suo generatore a ruote foniche, la bellezza ineguagliata della sua voce carnosa e rotonda e, non ultima, l’eleganza biedermeier delle sue forme ne hanno fatto un’icona del ‘900 (approfondisci l’argomento). Paradossale, la storia dell’Hammond, lo è stata in vita, post mortem e tale continua ad essere oggi, in una vivace fase postuma che non accenna ad esaurirsi: nato clone dell’organo classico, s’impone subito in tutt’altro ambito (jazz, gospel, musica di consumo), entra di prepotenza nel blues, tocca l’apice del prestigio nel rock e nel pop a un passo dalla fine, esce di produzione nel 1975 perché costa troppo e si ritrova – lui nato clone – a venir clonato dall’elettronica, prima analogica e poi digitale. Quarant’anni di splendore e continue deviazioni dal solco d’origine, con lo strumento che sfugge di mano al costruttore, obbligato a rincorrerlo come Silvestro rincorre Titti nel noto e coevo cartoon: pensato per le aule battiste e per le case della buona società wasp, diventa roba da neri e in chiesa si associa ai loro cori ritmati. Per quasi quarant’anni Laurens Hammond, il creatore del nostro, cercherà di far fuori il keyclick, lo “sputo” meccanico dei contatti sotto i tasti, e di levarsi di torno il leslie, l’amplificatore a elementi rotanti (inventato e costruito dalla concorrenza) divenuto inseparabile spalla dell’organo. Quando nel 1973 Laurens lascia il mondo, sono almeno tre le generazioni di esecutori che hanno colto la valenza espressiva di quel rumore di contatti e ne hanno fatto un potente ausilio all’articolazione del fraseggio, la cifra peculiare dello strumento, come il colpo di lingua all’attacco del suono di tromba. Tanto impensabile, un Hammond che non “sputi”, da far dannare l’anima ancora oggi, a chi progetta le sue repliche digitali, dietro all’inafferrabile colore di quel nanosecondo di pronuncia elettrica, sempre diversa a ogni nota. Quanto al leslie, l’inimicizia di Laurens ha vissuto ed è morta con lui, neanche sfiorando il successo universale di un sistema di diffusione sonora che si continua a costruire e usare, oggi come nei decenni dai ’50 in poi.
Ma il paradosso più ghiotto è quello della vita oltre la vita. Un caso unico nella storia industriale e sociale degli strumenti musicali e della tecnologia in genere: grosso modo dal secondo dopoguerra, il destino delle macchine che vanno in pensione è l’oblio, caso mai il museo. Non per l’Hammond: a quarant’anni dallo stop alla produzione sono migliaia e migliaia i musicisti – di ogni genere e d’ogni età – che ovunque nel mondo lo impiegano per fare musica. Non per operazioni nostalgia, non come si guida un’Isotta Fraschini al raduno delle auto d’antan, ma per fare la propria musica, quella che nasce adesso. Certo è un gran bel pezzo di modernariato e chi lo ama deve gestirsi, oltre ai quasi due quintali di peso, l’insidioso fantasma del feticismo. Ma il piacere della vista è un’inezia al paragone con quello delle mani e dell’orecchio quando il generatore elettromagnetico ha preso giri e quella voce è sotto le dita, pronta a rivestire della sua duttile pasta idee armonico-melodiche. Si può rinunciare allo Steinway in sala o al mezzacoda Yamaha sul palco? Lo stesso vale per l’Hammond, tornato dopo l’eclisse degli anni ’80 (la stagione elettronico-minimalista dei primi vitrei sintetizzatori figli dell’informatica) in triplice veste: di totem di un’epoca, di medium sonoro, di modello da replicare con le tecnologie attuali. Unica sorte, quest’ultima, possibile per un monstrum che costerebbe oggi, se rifatto com’era, come un gran coda Fazioli. E’ andata meglio al Minimoog e al piano elettrico Rhodes, altri evergreen, oggi nuovamente in produzione (limitata) perché più semplici e dai costi relativamente più abbordabili. Per l’Hammond niente da fare: nessuno, con ogni ragionevole probabilità, riuscirà a lanciare sul mercato un nuovo generatore elettromagnetico, mentre proseguirà la corsa d’avvicinamento a quel suono per via digitale.

L’organo Hammond oggi, dunque. Lasciamo stare il rock e la canzone d’autore, dove pure abbonda (qualche caso italiano: Zucchero, De Gregori, Alex Britti, Ligabue, i Nomadi…), lasciamo sullo sfondo certi mostri sacri ancora in piena salute come Brian Auger, e parliamo di jazz: scomparso nel 2005 Jimmy Smith, The Master, il padre della concezione moderna dell’organo nella musica afroamericana (l’altro grande padre, il bopper Larry Young, se n’era andato precocemente nel 1978; e il “nonno”, Jack McDuff, nel 2001 ), l’attuale vicenda jazzistica dello strumento è affidata in parte minore alla vecchia generazione (Lonnie Smith, Larry Goldings, Richard Holmes, Rhoda Scott…) e in misura maggiore a quella dei quarantenni (o poco più o poco meno): solisti giovani e maturi come i due italo-americani Joey De Francesco e Tony Monaco ; diversissimi tra loro, ambedue provvisti di eccezionali qualità tecniche come si conviene a due eredi diretti di Jimmy “The Cat” Smith, la tigre di Norristown. Come la tedesca Barbara Dennerlein, sperimentatrice del trattamento elettronico via midi del suono Hammond e dotata d’una sbalorditiva fluidità alla pedaliera. Come l’acido John Medeski, l’enfant terrible sotto le cui mani la voce tonda dell’organo si fa carta vetrata. Gente che ha cominciato a suonare quando l’Hammond era divenuto un ricordo, così come il resto della lista, centinaia di nomi d’assoluto rispetto tra Usa, Sudamerica, Inghilterra, Francia, Olanda, Belgio, Giappone…

E Italia. L’Italia è la seconda patria hammondistica dopo gli States, seguita per numero di adepti e di strumenti circolanti da Francia e Germania. L’Italia, che raccoglie nel forum nazionale dei cultori dell’Hammond (https://it.groups.yahoo.com/neo/groups/Hammond-Italia/info) oltre 1.300 tra musicisti e appassionati, è piena di organisti jazz: un caleidoscopio di stili, linguaggi, ascendenze, predilezioni, umori, abilità tecniche, inclinazioni formali. Si va dal pirotecnico, caldo, divertente Max Tempia, in grado di improvvisare per ore su Georgia come sulla fusion alla Tom Coster, al nerissimo Alberto Marsico intriso di gospel; dal bluesman Pippo Guarnera, essenziale quanto raffinato nella ricerca timbrica, al giovane Bruno Erminero dal fraseggio di velluto con zampata a sorpresa; dal veloce, scorrevole Vito Di Modugno a quell’elegante signore della doppia tastiera che è Gianni Giudici, sodale di Renzo Arbore. Tutti crooner di gran razza e preparazione inossidabile. Del resto l’Hammond o lo suoni da virtuoso o è meglio che cambi strumento: affermazione tranchante, forse un po’ eccessiva ma sostanzialmente vera. E virtuosi a pieno, pienissimo titolo sono due organisti che costituiscono due casi limite, per diverse ragioni: il primo è l’appena ventenne Leonardo Corradi da La Spezia, uno che se senti un suo disco pensi d’avere a che fare con un jazzista al vertice della carriera, giunto ad esiti che solo una lunga stagionatura può determinare; e invece è solo all’alba d’una giornata che potrà – catastrofe cultural-musicale italica permettendo – riservare più d’una sorpresa. Corradi, umile e dimesso all’aspetto, è già alla seconda o terza fase della sua evoluzione stilistica: ora suona nella scia di Joey De Francesco, robusta radice bop e sovrana agilità, e svela profondità di pensiero musicale e grande fantasia nel rimaneggiare gli standard facendo leva sui gangli armonici, sugli accenti, sul senso del prima e del dopo. Intanto ha fatto da alter ego strumentale alle tirate scat di Gegè Telesforo, prepara nuove collaborazioni blasonate e domani si vedrà. L’altro caso limite è il romano Ivan Vicari, tutt’altra storia: la storia di uno stile dai connotati maturi, inconfondibili, a loro modo unici. Vicari è tra i pochissimi jazz organists al mondo ad aver ereditato, di Jimmy Smith, non tanto e non solo i licks, gli stilemi, ma pure la pancia, il respiro, la “cavata”. In una chiave tutta sua: spogliata dalle ironie feline e dai tipici appoggi e slittamenti metrici del Grande Padre, quadrata e potente. Vicari smentisce il luogo comune dell’organista jazz giocoso e solare, per obbligo di scuola e per necessità sonora (la “grazia” della voce organistica). Vicari è cerebrale, drammatico, duro e passionale. Parte dal vertice rivoluzionario di Jimmy Smith, quel The Boss del ’68 che inventa intorno al suono dell’organo un jazz dionisiaco e stravinskijano (pieno di citazioni, jazz “al quadrato”), vi immette calore mediterraneo, echi davisiani, velocità parossistica. Risultato: un jazz all’organo come non l’avete mai sentito. E chiudiamo con un terzo caso limite, oltre il jazz ma in rotta d’avvicinamento al jazz: il friulano Daniele Toffolo, organista classico che ha inciso un geniale disco di pezzi bachiani suonati all’Hammond; e che ora ne prepara uno, sempre all’Hammond, che includerà esempi d’una letteratura organistica americana, liturgica ma intrisa di jazz, a noi finora ignota. Italia terra di hammondisti, di organisti jazz d’ogni sorta, dal mainstream alla sperimentazione. Ennesimo caso d’un problema tutto italiano: quello del patrimonio artistico da salvare.